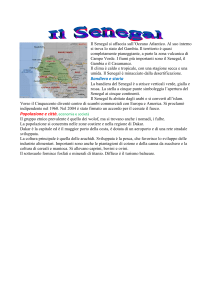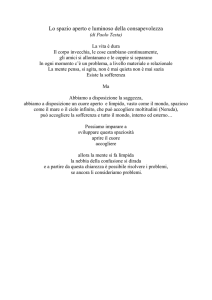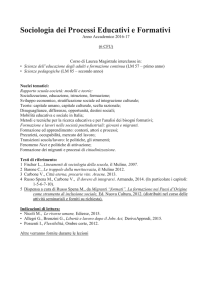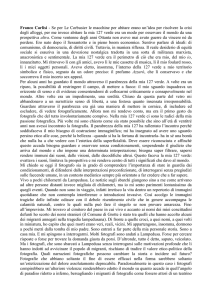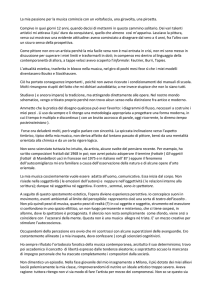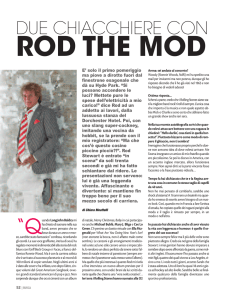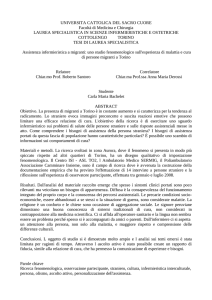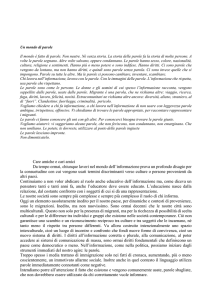Andrea Staid
Senza casa: come accogliere i migranti?
Terzo incontro in preparazione alla VI edizione di Pistoia - Dialoghi sull’uomo: Le
case dell’uomo. Abitare il mondo (22-23-24 maggio 2015)
Incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
mercoledì 15 aprile 2015, ore 11.00 - Teatro Manzoni, Pistoia
Andrea Staid è docente di antropologia culturale presso la NABA, ha tenuto lezioni presso l’università di
Urbino e La Sapienza di Roma, ha insegnato antropologia culturale nel dipartimento di antropologia ed
etnografia dell’Università degli studi di Genova; editor della casa editrice Elèuthera, collabora con diverse
testate giornalistiche. È autore de Gli arditi del popolo (Edizioni La Fiaccola, 2007), Le nostre braccia.
Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù (Agenzia X, 2011), Dannati della metropoli. Etnografie
migranti ai confini della legalità (Milieu, 2014), I Senza Stato. Potere, economia e debito nelle società
primitive. (Bebèrt, 2015).
Sull’argomento
In questo momento storico assume sempre più importanza rispondere alla domanda: come
accogliere i migranti, coloro che hanno lasciato la loro casa per sopravvivere? Dare una risposta
concreta non è facile, ma le possibilità di costruire un mondo migliore sono nelle nostre mani ed è
necessario ripensare e ricodificare le modalità dell’umana convivenza.
Troppo spesso accendendo la televisione o leggendo un quotidiano siamo sommersi da parole
quali “invasioni, clandestini, criminali” e dimentichiamo che prima di tutto questi “immigrati” sono
uomini come noi e dovrebbero avere la possibilità di godere dei nostri diritti. Non dobbiamo mai
dimenticare che l’accoglienza è un concetto molto importante per l’essere umano: indica quel
luogo che offriamo all’altro; vi confluiscono concetti basilari come: ospitalità, fraternità e umanità.
Al liceo studiamo Kant, che tratta la questione del diritto cosmopolitico, un diritto in grado di
varcare i confini degli stati e delle nazioni. Ci illustra il diritto universale all’ospitalità, cioè un diritto
di visita, senza condizioni, e un diritto dell’ospite, per cui è necessario accogliere lo straniero come
coabitante. È impensabile considerare un’umanità senza accoglienza: dalla nascita siamo accolti
in un luogo che non è il nostro, dove viviamo temporaneamente come ospiti e, anche il ventre
materno, non è che il nostro primo rifugio. Ognuno di noi è migrante nel suo microcosmo di
relazioni, accolto e invitato ad accogliere proprio in nome di una coabitazione con l’altro, che il
mondo contemporaneo rende imprescindibile. Il cosiddetto fenomeno della globalizzazione ha
portato con sé infatti diversi mutamenti, non solo sul piano economico e politico, ma anche e
soprattutto per ciò che concerne l’aspetto sociale e culturale. Mutamenti che per la loro portata
rendono difficile continuare ad appellarsi al ritorno di situazioni che si potrebbero definire pure, ma
di una purezza in realtà mai esistita. Grazie alla mobilità internazionale e, quindi, alle maggiori
possibilità di raggiungere in poco tempo parti diverse del globo e grazie alla naturale propensione
dell’uomo a viaggiare con il proprio inseparabile bagaglio culturale, le nostre società, le nostre
metropoli, sono sempre più comunità ibride e meticce. Per capire come accogliere e costruire il
nostro futuro in un momento delicato come quello che stiamo vivendo oggi è necessario fare
chiarezza sulle possibilità di interazione con le comunità di migranti in arrivo o già presenti in Italia.
Nella società attuale l’uso e l’abuso di determinati concetti porta a diversi problemi di
comprensione. Multietnico, multiculturale, meticcio, sono parole con significati complessi che
troppo spesso vengono usate come sinonimi, mentre veicolano significati tra loro differenti.
Il multiculturalismo imperante nella nostra società descrive fenomeni legati alla semplice
convivenza di culture diverse, in cui gruppi sociali di etnia e cultura dissimili occupano uno spazio
opposto e difficilmente si incontrano e dialogano. In questo caso le culture e le identità culturali
vengono considerate come date, fissate, rigide e non suscettibili di mutamento. Il ritorno in auge
dell’etnicità quale fonte di identificazione collettiva e spinta alle rivendicazioni, in seno alla
modernità e alla globalizzazione, ha aumentato il multiculturalismo radicale.
L’ideologia e le pratiche multiculturali – pensando alla società come un mosaico formato da
monoculture omogenee e dai confini ben definiti – hanno, di fatto, aumentato la frammentazione
(e il rischio di forme di apartheid, come possiamo notare nei fatti degli ultimi anni di Tor Sapienza
a Roma, via Padova a Milano, di Rosarno o di Castel Volturno) fra le componenti della società,
dimostrandosi validi strumenti per la costruzione di un’identità nazionale chiusa e incapace di
comunicare. Seguendo un movimento che può apparire paradossale il multiculturalismo si rivela,
dunque, come il lato oscuro della monocultura.
In contrapposizione al modello multiculturale si propone un modello anzi un pensiero “meticcio”,
un pensiero transculturale, dove ogni differenza non allude a privilegi né ad alcuna
discriminazione. La transcultura esige che gli uomini, migranti o meno, godano delle medesime
“universali” possibilità e scelgano privi di vincoli comunitari, dove, come e quando vivere. Ogni
persona ha il diritto di essere valorizzata nella sua unicità e irrepetibilità, nella sua continua
trasformazione e negazione della purezza originaria.
Immagino un mondo che sappia accogliere, ascoltare e capire le differenze e che tali differenze
siano la ricchezza della società, un mondo aperto, senza muri e pregiudizi, pronto al
mescolamento culturale, con al suo interno culture differenti pronte al cambiamento, all’ascolto e
all’incontro. Per accogliere i migranti e vivere meglio noi stessi la contemporaneità dobbiamo
creare una relazione sociale tesa a soddisfare un’esigenza, un interesse, dove sia importante
accettare di trasformarsi nell’interazione egualitaria con gli altri e prevedere la possibilità di
diventare una persona anche molto differente da quella originaria. Viviamo in un mondo fatto di
informazioni e immagini che ci sommergono continuamente, attraversiamo metropoli affollate, con
strade che sembrano fiumi in piena di umani delle etnie più differenti, che con il passare del
tempo si mescolano, si incontrano si scontrano e danno forma al processo meticcio: siamo
“umani al di là delle appartenenze”. L’insieme dell’umanità si sta interconnettendo attraverso una
rete di rapporti che si estende progressivamente all’interno delle nostre città, nelle nostre vite.
Nella società postmoderna assistiamo sempre di più a una rapida e profonda evoluzione dei modi
di vita quotidiani, determinata da un insieme di eventi, dal mescolarsi di culture, esperienze
diverse, fino alle sempre più veloci innovazioni tecnologiche che cambiano il nostro modo di
vivere e vedere la realtà. Assistiamo a trasformazioni culturali dovute all’interazione tra fattori
evolutivi, sociali, culturali, economici e tecnologici che raggiungono un’ampiezza senza
precedenti. I mutamenti in atto stanno modificando irreversibilmente il nostro vivere quotidiano, il
nostro modo di pensare e di percepire il mondo e la convivenza umana. Per questo è
fondamentale costruire un mondo che sappia accogliere, ascoltare e capire le differenze e che tali
differenze diventino la ricchezza della nostra società. Quindi è necessario prefigurare un mondo
aperto, senza muri e pregiudizi, dove donne e uomini siano pronti all’ibridazione culturale. Un
mondo che al suo interno ospita una miriade di culture differenti pronte al cambiamento,
all’ascolto e l’incontro. Una comunità che non entri in contrasto con la libertà del singolo. Per
accogliere e trovare una casa per tutta l’umanità dobbiamo impegnarci a costruire un mondo di
eguali per diritti ma differenti per culture, una società di donne e uomini liberi di creare la loro
specificità culturale. La cultura non è mai una conclusione, ma una dinamica costante alla ricerca
di domande inedite, di possibilità nuove, che non domina, ma si mette in relazione, che non
saccheggia, ma scambia, che rispetta.
Le voci dei migranti
Fra le molte interviste raccolte dall’antropologo Andrea Staid in Le nostre braccia. Meticciato e
antropologia delle nuove schiavitù, frutto di una lunga indagine di ricerca sul campo, si propone la
lettura di due storie molto significative, quella di Bic e quella di Ajene.
La storia di Bic
Vengo dal Senegal, ho trentaquattro anni e sono in Italia da dieci anni. Adesso vivo a Genova ma
ho vissuto in tante altre città: Cagliari, Roma e Torino. I primi anni sono stati belli, c’era lavoro e a
Cagliari mi trovavo bene. Mi piaceva il clima, il mare. Lì mi sono fatto tanti amici. Tutti mi
prendevano in giro per il mio accento sardo, vendevo sulla spiaggia del Poetto e urlare “ajo” era
divertente e poi la lingua sarda mi piaceva proprio. In quegli anni avevo un permesso per lavorare
durante la stagione estiva e a novembre me ne tornavo in Senegal dalla mia famiglia, dove
adesso ho una moglie e tre figli. Dopo sei anni tra Cagliari e il Senegal ero diventato un africano
sardo che si sentiva a casa sia qui sia là. I problemi sono iniziati quando mi hanno tolto il
permesso di vendere in spiaggia e i vigili hanno cominciato a rendermi la vita impossibile, in una
sola stagione avevo preso più multe di quello che avevo guadagnato. Quell’anno ero tornato in
Senegal disperato, non sapevo cosa fare. L’anno dopo ho deciso di andare a Roma con un mio
amico di Dakar che aveva un ristorante di cucina africana e che gestiva da anni con la sua
famiglia. Mi aveva proposto di fare il cameriere perché sua moglie era incinta e non poteva
lavorare, mi avrebbe pagato abbastanza, ma sicuramente non come quello che riuscivo a
guadagnare in Sardegna. La vita a Roma, a differenza di Cagliari, non mi è piaciuta per niente, ho
avuto un sacco di problemi e soprattutto non avevo le carte in regola, il mio amico non aveva i
soldi per regolarizzarmi. Il grave problema di cui mi sono reso conto troppo tardi è che senza
documenti in regola era difficile anche tornare in Senegal. Dopo otto mesi al ristorante avevo
deciso che non faceva per me, a quel punto o tornavo in Senegal dalla mia famiglia o mi cercavo
un lavoro migliore. Parlando con dei clienti del ristorante mi spiegarono che al nord c’era molto
più lavoro e che dovevo andare a lavorare in qualche fabbrica come metalmeccanico, o in Veneto
o in Piemonte. Io non avevo mai lavorato in fabbrica ma volevo andarmene da Roma e quindi ho
cominciato tramite internet a cercare lavori nelle fabbriche del nord. Il primo colloquio l’ho fatto
con una piccola fabbrica di contenitori di plastica vicino ad Alessandria, ma sono stato rifiutato
subito perché non ero in regola. Il secondo incontro invece è stato quello giusto, una fabbrica di
Torino che produce componenti elettriche. Il responsabile con cui ho parlato mi ha assicurato che
mi avrebbe fatto un contratto e che da lì a poco avrei ricevuto tutte le carte per il mio passaporto.
Per me era molto importante perché volevo tornare in Senegal dalla mia famiglia che ormai non
vedevo da un anno. Così ho accettato immediatamente quel lavoro. All’inizio sono stato ospite da
amici del Senegal e al primo stipendio sono riuscito a trovarmi una stanza in affitto. La paga era
buona, più di 1.000 euro al mese, solo che le carte non arrivavano mai. Io chiedevo e mi dicevano
che la procedura era lunga, mi hanno anche fatto firmare dei fogli ma alla fine non è andata a
finire bene. Dopo solo sei mesi che ero lì, la fabbrica è andata in crisi e gli operai hanno
cominciato a protestare perché il rischio di essere licenziati era veramente alto. Io sono stato il
primo a venire licenziato e solo pochi operai sono andati a protestare per come ero stato trattato,
io e altri tre ci siamo anche incatenati ai cancelli della fabbrica ma alla fine abbiamo ceduto
perché, soprattutto io, rischiavo di finire arrestato. Dopo questa breve esperienza torinese ho
deciso di andare via da Torino e grazie ad altri amici senegalesi ho trovato un altro lavoro ai
mercati qua a Genova. Gli affari non vanno tanto bene ma almeno, grazie a un’amica italiana con
cui mi sono sposato, posso tornare in Senegal ogni anno e non corro il rischio di essere portato in
carcere dalla polizia. Da quando ho il permesso m’impegno con una associazione di amici italiani
e africani per fare da interprete con i ragazzi senegalesi che sono appena arrivati, oltre a questo
organizziamo uno sportello legale e di ascolto per aiutare gli uomini e le donne che sono senza
permesso di soggiorno, che con le nuove leggi è praticamente impossibile ottenere. Penso che la
legge Bossi-Fini sia stata scritta apposta per non regolarizzare nessuno, in modo da poterli
sfruttare meglio. Nell’ultimo periodo ho cominciato a pensare di far trasferire in Italia la mia
famiglia ma con le nuove leggi è davvero dura. Se gli affari continuano così penso che tornerò in
Senegal, almeno i soldi saranno pochi ma potrò stare con i miei figli.
La storia di Ajene
Il mio viaggio per arrivare in Italia è iniziato nel deserto tra l’Africa subsahariana e i paesi del
Maghreb. Io abitavo in Ghana. Ho iniziato la mia traversata a bordo di un camion guidato da un
ragazzo di Tripoli. Durante il viaggio siamo stati fermati tante volte dalla polizia e ci hanno rubato
tutto quello che avevamo. Ho visto con i miei occhi persone costrette dai militari a bere acqua
sporca per provocare problemi intestinali, per costringere a espellere le palline con le banconote
arrotolate nel cellophane che avevano ingoiato per non farsi derubare. Due ragazzi sono stati
ammazzati come cani perché non volevano dargli tutto. Queste cose sono dure da sopportare e il
viaggio è stato lungo e difficile. Non abbiamo mangiato mai nulla e avevamo soltanto una bottiglia
d’acqua, siamo entrati in Libia nei pressi della frontiera di Toummo se non ricordo male anche
perché sono passati quasi dieci anni da quei giorni. Sono stato molto fortunato perché ero riuscito
a nascondere bene i miei soldi. Arrivato in Libia dalla frontiera sono riuscito a raggiungere in poco
tempo Tripoli e da li ho cominciato a capire cosa dovevo fare per imbarcarmi e per arrivare in
Italia. Non vedevo l’ora di iniziare la mia nuova vita. Sapevo che non sarebbe stato facile e che mi
sarebbe costato tanto, sia per i soldi sia per la mia testa, ma non pensavo così tanto. A Tripoli
sono riuscito a mettermi in contatto con alcuni ragazzi che volevano andare in Italia a lavorare e
che sapevano a chi chiedere, ma il prezzo per il “passaggio” era veramente troppo alto. Speravo
di trovare qualcosa di meglio ma alla fine ho capito che dovevo aspettare... trovarmi un lavoro in
Libia, mettere da parte i soldi e partire. A Tripoli ho lavorato tre mesi per accumulare soldi,
mangiavo il meno possibile, non uscivo mai e non conoscevo quasi nessuno, facevo una vita
orribile. Ma alla fine avevo i soldi che mi chiedevano e sono partito. Era una notte d’estate del
2002. Il viaggio in mare è stato se possibile ancora più duro di quello nel deserto, prima di tutto
perché io non avevo mai viaggiato in mare e poi perché la barca era piccola e noi eravamo tanti,
quasi tutti uomini africani, poche donne e solo due o tre bambini, se non ricordo male. Parlando
poi in Italia con tanti amici africani ho capito di essere stato fortunato perché nella nostra barca
non è morto nessuno, anche se in molti sono stati male. A Lampedusa la polizia ci ha consegnato
un numero, acqua e cibo e ci ha portato in una specie di carcere. Lì ho capito che dovevo lottare
ancora per riuscire a vivere libero e trovarmi un lavoro. All’epoca non parlavo italiano e anche
questo era un problema perché non capivo quello che mi dicevano. Da Lampedusa però sono
riuscito ad andarmene abbastanza in fretta, anche perché quasi tutte le sere arrivavano altre
barche e non ci stavamo più. Ci hanno spostato in Puglia ma non ne sono sicuro, in un centro che
sembrava meno carcere di quello a Lampedusa. C’era poca polizia e soltanto una rete all’entrata.
Dopo tre giorni in questo centro, conosco Labaan e con lui decidiamo di andarcene senza
aspettare il permesso perché avevamo capito che ci volevano rimandare a casa nostra e dopo
tutti i sacrifici fatti per arrivare e cambiare vita, era una cosa che non poteva proprio succedere.
Andiamo via di notte, non è stato difficile perché come ti dicevo c’era solo una rete e la polizia
sembrava non guardasse troppo quello che facevamo, infatti andò tutto bene. Una volta
scavalcata la rete nessuno ci fermò. Da lì abbiamo passato la notte a pochi chilometri dal centro,
ci siamo messi a dormire in un campo ben nascosti. Con la luce siamo andati alla ricerca di una
stazione per riuscire ad andare via dal sud Italia verso il nord che ci aspettavamo ricco e pieno di
lavoro. Troviamo la stazione dopo poche ore di cammino e decidiamo che è meglio separarci per
non dare nell’occhio anche perché il primo problema da affrontare era come pagare il treno, visto
che non avevamo soldi italiani. Mi presento alla biglietteria ma non concludo nulla, capisco che
però è impossibile prendere un solo treno per arrivare a Milano, ne devo prenderne almeno due.
Avevo venti dollari ma non li hanno voluti. Salgo sul treno per Roma senza biglietto. Anche
Labaan sale sullo stesso treno ma non ci mettiamo nello stesso vagone. Da lì non ci siamo più
rivisti e spero che anche per lui il viaggio sia continuato senza troppi problemi. A Roma riesco a
cambiare i miei dollari e a fare il biglietto per un treno fino a Modena, la città dove ho fatto il mio
primo lavoro italiano. A Modena scendo in stazione molto presto di mattina, sono totalmente
spaesato e anche se dentro di me sono felice, capisco che la mia situazione è complicata, non ho
nessuna carta che dice che posso stare in Italia. Per fortuna incontro dopo poche ore dei ragazzi
ghanesi che mi aiutano subito, mi invitano a mangiare nella loro casa e mi spiegano che è meglio
se non me ne vado in giro troppo senza il permesso di soggiorno. Questi ragazzi sono stati la mia
salvezza perché per un mese mi hanno fatto dormire sul loro divano, facendomi conoscere gli
italiani giusti che mi hanno aiutato a trovare lavoro. Sono stato nelle campagne per sei mesi,
venivo pagato poco ma almeno riuscivo a mangiare e a permettermi una stanza in affitto. Il
problema del permesso però rimaneva perché non lavoravo in regola. Dopo questo lavoro ne ho
trovato uno meno faticoso e pagato meglio, lavoravo da un benzinaio dove sono rimasto quasi un
anno, il padrone era tranquillo ma anche lui mi diceva che non aveva i soldi per regolarizzarmi. I
miei amici italiani mi dicevano che entro poco ci sarebbe stata una sanatoria per tutti i migranti e
di non preoccuparmi. Io ci speravo perché mi stavo trovando davvero bene. Nella mia testa c’era
ancora la voglia di andare a Milano, la città dove avrei potuto fare un vero lavoro e guadagnare
bene per mettere da parte dei soldi. Dopo cinque anni a Modena senza permesso di soggiorno e
altri due lavori, uno in un forno e uno in una cooperativa edile, ne trovo un altro vicino a Milano in
una fabbrica metalmeccanica come operaio. Questo impiego l’ho trovato grazie a un amico,
Mario, erano anni che cercavo una possibilità per la mia regolarizzazione. In questa fabbrica ho
lavorato duramente per due anni, mi hanno fatto subito il contratto, con varie difficoltà ma alla fine
ce la abbiamo fatta e ho ottenuto un permesso di soggiorno legato al mio contratto. Guadagnavo
più di 1.000 euro al mese, finalmente potevo avere una casa e una vita tutta mia. In quei due anni
2007 e 2008, ho conosciuto vari amici e amiche, uscivo la sera e mi occupavo insieme ad africani
e italiani di una scuola di italiano per migranti. È stata un’esperienza molto bella e soprattutto ho
conosciuto Monica, mia moglie, una ragazza toscana di Firenze ma che stava a Milano. Adesso
siamo sposati e io sono diventato italiano. Sinceramente non mi sento proprio italiano, ma
afritaliano, nel senso che non vivo più da ghanese ma non sono neanche un italiano al 100%.
Certo tante cose della cultura italiana ormai fanno parte di me, le ultime esperienze si sono
incontrate e mescolate con la mia parte africana. Anche se non è stato facile, adesso amo l’Italia,
mi piace la musica, la cucina, il cinema, ma amo anche l’Africa, il mio paese dove finalmente
posso tornare senza paura e stare con la mia famiglia. Quando vado in Ghana per i figli di mia
sorella sono un italiano con la faccia nera e che parla la loro lingua ma per gli italiani sono un
africano che lavora in Italia. Insomma è strano, ma finalmente sono felice. Anche se non finirò
mai di pensare a tutti i fratelli che non ce la fanno, che muoiono nel viaggio o che vengono
riportati a casa dalla polizia. Sono stato fortunato e adesso devo lottare per i diritti di tutti quelli
che non sono arrivati o che vogliono arrivare.