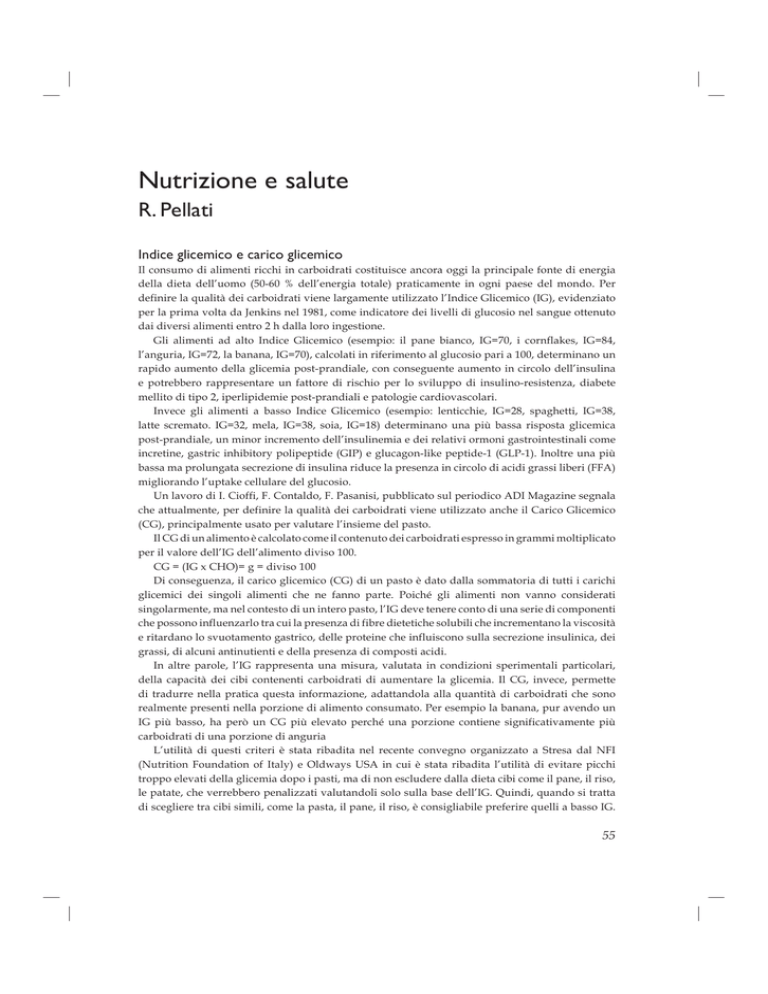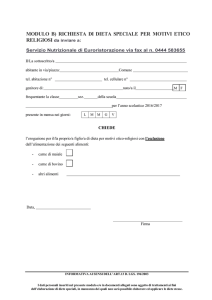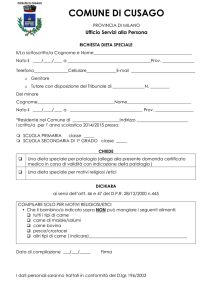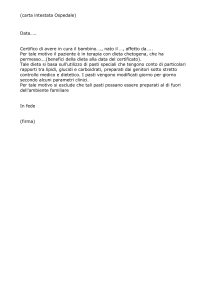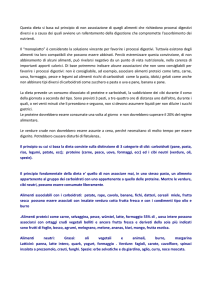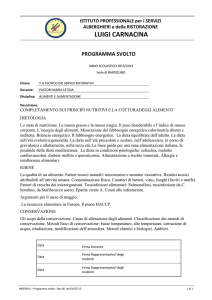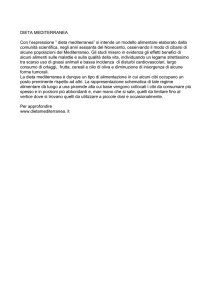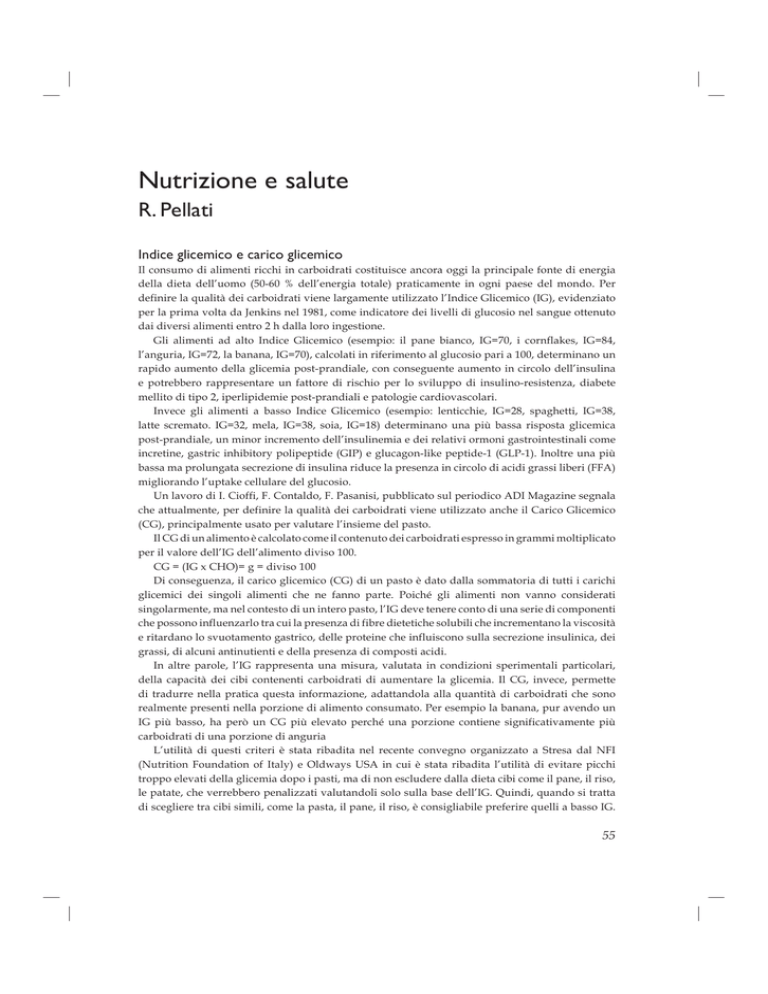
Nutrizione e salute
R. Pellati
Indice glicemico e carico glicemico
Il consumo di alimenti ricchi in carboidrati costituisce ancora oggi la principale fonte di energia
della dieta dell’uomo (50-60 % dell’energia totale) praticamente in ogni paese del mondo. Per
definire la qualità dei carboidrati viene largamente utilizzato l’Indice Glicemico (IG), evidenziato
per la prima volta da Jenkins nel 1981, come indicatore dei livelli di glucosio nel sangue ottenuto
dai diversi alimenti entro 2 h dalla loro ingestione.
Gli alimenti ad alto Indice Glicemico (esempio: il pane bianco, IG=70, i cornflakes, IG=84,
l’anguria, IG=72, la banana, IG=70), calcolati in riferimento al glucosio pari a 100, determinano un
rapido aumento della glicemia post-prandiale, con conseguente aumento in circolo dell’insulina
e potrebbero rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di insulino-resistenza, diabete
mellito di tipo 2, iperlipidemie post-prandiali e patologie cardiovascolari.
Invece gli alimenti a basso Indice Glicemico (esempio: lenticchie, IG=28, spaghetti, IG=38,
latte scremato. IG=32, mela, IG=38, soia, IG=18) determinano una più bassa risposta glicemica
post-prandiale, un minor incremento dell’insulinemia e dei relativi ormoni gastrointestinali come
incretine, gastric inhibitory polipeptide (GIP) e glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Inoltre una più
bassa ma prolungata secrezione di insulina riduce la presenza in circolo di acidi grassi liberi (FFA)
migliorando l’uptake cellulare del glucosio.
Un lavoro di I. Cioffi, F. Contaldo, F. Pasanisi, pubblicato sul periodico ADI Magazine segnala
che attualmente, per definire la qualità dei carboidrati viene utilizzato anche il Carico Glicemico
(CG), principalmente usato per valutare l’insieme del pasto.
Il CG di un alimento è calcolato come il contenuto dei carboidrati espresso in grammi moltiplicato
per il valore dell’IG dell’alimento diviso 100.
CG = (IG x CHO)= g = diviso 100
Di conseguenza, il carico glicemico (CG) di un pasto è dato dalla sommatoria di tutti i carichi
glicemici dei singoli alimenti che ne fanno parte. Poiché gli alimenti non vanno considerati
singolarmente, ma nel contesto di un intero pasto, l’IG deve tenere conto di una serie di componenti
che possono influenzarlo tra cui la presenza di fibre dietetiche solubili che incrementano la viscosità
e ritardano lo svuotamento gastrico, delle proteine che influiscono sulla secrezione insulinica, dei
grassi, di alcuni antinutienti e della presenza di composti acidi.
In altre parole, l’IG rappresenta una misura, valutata in condizioni sperimentali particolari,
della capacità dei cibi contenenti carboidrati di aumentare la glicemia. Il CG, invece, permette
di tradurre nella pratica questa informazione, adattandola alla quantità di carboidrati che sono
realmente presenti nella porzione di alimento consumato. Per esempio la banana, pur avendo un
IG più basso, ha però un CG più elevato perché una porzione contiene significativamente più
carboidrati di una porzione di anguria
L’utilità di questi criteri è stata ribadita nel recente convegno organizzato a Stresa dal NFI
(Nutrition Foundation of Italy) e Oldways USA in cui è stata ribadita l’utilità di evitare picchi
troppo elevati della glicemia dopo i pasti, ma di non escludere dalla dieta cibi come il pane, il riso,
le patate, che verrebbero penalizzati valutandoli solo sulla base dell’IG. Quindi, quando si tratta
di scegliere tra cibi simili, come la pasta, il pane, il riso, è consigliabile preferire quelli a basso IG.
55
La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 3, luglio-agosto 2013, ANNO 42
Qundo invece la scelta cade sugli altri, è sufficiente ridurre la porzione di consumo del 30-50 % (a
parità di consumo di carboidrati).
Cibi del futuro
Nei prossimi anni sentiremo sempre più parlare di “Quinoa” un vegetale che appartiene alla
famiglia degli spinaci e della barbabietola (chenopodiacee), ma produce semi simili ai chicchi dei
cereali e per questo viene definita uno pseudocereale. L’assemblea generale delle Nazioni Unite
(per valorizzare la biodiversità) ha dichiarato il 2013 anno internazionale della quinoa, perché
questo vegetale che si coltiva soprattutto in Perù e in Bolivia (rappresenta rispettivamente il 52 % e
il 47 % del prodotto agricolo nazionale secondo i dati FAO) ha delle caratteristiche eccezionali che
aiuteranno a produrre cibo sufficiente per la crescente popolazione che si prevede aumenterà di 2
miliardi di persone entro il 2050.
La pianta produce una spiga molto bella, più piccola di quella del grano e contiene dei semini
rotondi che sembrano quelli del miglio. Ne esistono molte varietà, ma la più sfruttata è la “Quinoa
Real”. Può essere coltivata dal livello del mare a 4000 metri di altitudine, può resistere a temperature
vicine allo zero sino a 38 gradi, sia con climi umidi che aridi e in una varietà di condizioni del
terreno.
La Quinoa contiene proteine complete nella misura del 13 % ma non contiene glutine. Presenta
un alto contenuto di lisina. Sono presenti circa il 60 % di carboidrati complessi di facile digeribilità
e assimilazione che non aumentano i picchi di glucosio nel sangue, inoltre contiene l’8 % di fibre
alimentari e il 7 % di grassi quasi tutti insaturi (con elevato contenuto di acido linolenico precursore
degli omega 3), oltre a vitamine e minerali.
La quinoa fritta è molto gustosa e si prepara come un banale piatto di pasta. Bisogna solamente
avere l’avvertenza di sciacquare i semi prima dell’utilizzo perché la parte esterna del seme contiene
delle saponine di gusto amaro. Oppure si può lasciare i semi in ammollo di acqua per un paio di
ore e poi sciacquarli. Si procede poi alla cottura (15-20 minuti). Si può successivamente mettere in
padella con olio, aggiungendo altre erbe fritte, spezie o volendo vari tipi di carne. Si può gustare
anche in insalata come il couscous o l’insalata di riso facendola cuocere nel latte, anziché nell’acqua,
si può gustare come dessert con zucchero, spolverata di cacao, vaniglia, cannella.
Non bisogna credere che la conoscenza e l’utilizzo della quinoa per i consumatori italiani sia un
discorso per “extraterrestri”. Se i cibi che possiamo gustare a tavola oggi sono migliori di quelli di
una volta (maggior salubrità, maggior sicurezza, maggiori varietà a disposizione) dobbiamo dire
grazie alle innumerevoli scoperte fatte da tutte le Scienze coinvolte con l’alimentazione. La storia
degli alimenti è ricca di queste testimonianze.
Fino al 1700, per esempio, le patate (arrivate in Europa nel 1500) non raccoglievano consensi
in cucina: erano sporche, brutte, crescevano nella terra (con possibili influssi demoniaci) e si
credevano tossiche (erroneamente si mangiavano le foglie e i germogli che contengono un veleno:
la solanina). Il farmacista francese Auguste Parmentier nel 1785, dimostrò che l’amido delle
patate presente nel tubero è un ottimo nutrimento e l’ortaggio era adatto ad una coltivazione
intensiva, aveva un costo irrisorio, poteva aiutare a vincere la fame: bastava saperlo cucinare.
Oggi in Europa ci sono Paesi (Belgio, Germania) che arrivano a consumare ogni anno 200 Kg di
patate pro-capite.
Un altro cibo trascurato dalla cucina per alcuni secoli dopo l’arrivo dal Nuovo Mondo, è anche
il pomodoro, che oggi riteniamo indispensabile per preparare gli spaghetti e preparare la pizza,
ma le nonne delle nostre nonne lo usavano solamente nei salotti e nelle verande unitamente ad altri
56
R. Pellati
Nutrizione e salute
vasi di fiori per fare “bella figura”, senza metterlo in padella perché temevano disturbi di vario
genere (il colore rosso destava preoccupazioni!). Oggi tutto il mondo parla di Dieta Mediterranea
e il pomodoro rappresenta l’ortaggio principe. Quindi possiamo dire che i cibi considerati
“tradizionali” derivano in buona parte da ”innovazioni” ben riuscite e la Quinoa ha le carte in
regola per diventare nel prossimo futuro un cibo di largo impiego e sarà senz’altro presente quanto
prima sulle nostre tavole.
Durante il 2014 la FAO e Slow Food lavoreranno nel recuperare la ricchezza delle ricette locali
in tema di “quinoa”custodite dalle comunità e sarà pubblicato un libro di ricette dedicato a questo
tema. Sin’ora la quinoa ha destato l’interesse degli Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, Germania,
Canadà, Israele, Brasile e Regno Unito e l’esplosione di notorietà ha favorito la diffusione delle
varietà più commerciali a discapito di quelle locali, che rischiano l’estinzione.
Al gruppo degli pseudo cereali appartengono anche l’Amaranto (originario dell’America
Centrale), ancora poco noto, e il grano saraceno originario dell’Asia, ma apprezzato anche in Italia
(per l’ottimo sapore e l’assenza di glutine) soprattutto in Valtellina che annovera fra i suoi piatti
tradizionali la famosa “polenta taragna” e i “pizzoccheri”.
Novità per l’intolleranza al lattosio
La predisposizione all’intolleranza al lattosio si può scoprire con un semplice test predittivo in
forma di tampone buccale disponibile in farmacia dal 2014. Il kit presentato a Milano (Lactease
DNA) contiene il tampone per eseguire l’auto-prelievo da parte del paziente e prevede l’invio del
campione di saliva al laboratorio di analisi, direttamente o tramite il farmacista.
Il team di genetisti della “G&life” (team multidisciplinare di Genetisti, Biologi, Nutrizionisti
che opera all’interno dell’Area Science Park di Trieste coordinato da Paolo Gasparini) effettua
l’analisi del gene della lattasi (l’enzima coinvolto nell’intolleranza al lattosio) e successivamente
consegna i risultati e l’interpretazione di un genetista.
La diagnosi di intolleranza al lattosio (i dati di letteratura indicano che circa il 50-60 % degli
italiani soffre di questo disturbo) si basa principalmente su metodi non invasivi: il test del respiro
all’idrogeno (breath test) è quello sin’ora più diffuso, ma presenta alcuni limiti perché solo
pochi bambini riescono ad eseguirlo. Il nuovo test invece consente di chiarire i casi dubbi in cui
sono presenti sintomi come gonfiore e crampi addominali, nausea, cefalea, brontolii intestinali,
flatulenza, stanchezza cronica, di solito attribuiti a colite da stress.
Edoardo Savarino (Università degli Studi di Padova) precisa che l’intolleranza al glucosio può
essere primitiva (deficit congenito di produzione di lattasi), o secondaria (età prescolare-scolare
di solito transitoria post-infettiva che regredisce in 3-4 mesi). Nell’Europa del Nord la prevalenza
è del 10-20 %, con aumento progressivo spostandosi verso il Sud, tanto che nel Sud Italia si può
arrivare anche al 10-20 %.
Elisa Marabotto (A.O. Universitaria San Martino di Genova dice che l’unica cura possibile
consiste nell’eliminazione o nella riduzione del lattosio dalla dieta. Ma una più pratica e semplice
alternativa è rappresentata dall’utilizzo di integratori alimentari a base di lattasi. Infatti eliminare il
lattosio dalla dieta non è semplice, dato che il lattosio è presente anche come additivo negli alimenti
e nei farmaci: addirittura in più del 20 % dei farmaci che richiedono ricetta medica e nel 6 % circa di
quelli da banco, oltre agli integratori.
Enrique Hausermann, Amministratore Delegato dell’azienda farmaceutica Crinos si è detto
orgoglioso di presentare un progetto che dimostra come questa punta di lancia della ricerca
consenta nuovi e approcci a disturbi che colpiscono milioni di persone. Di solito siamo abituati a
57
La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 3, luglio-agosto 2013, ANNO 42
considerare le ricerche in campo genetico come qualcosa di importante, ma quasi sempre distanti
dai bisogni di salute quotidiani.
Street food
La FAO stima che oggi circa 2,5 miliardi di persone si nutrano per strada e con il termine “Street
food” si indica un’ampia gamma di cibi pronti da mangiare e da bere venduti in locali pubblici,
ma soprattutto in strada: a Newyork ci sono i carrettini di Hod-dog, a Instabul i chioschi di Kebab,
a Parigi le creperie sui boulevard, In Italia si va dalla pizzeria ai carrettini di castagne arrosto.
Possiamo dire che lo street food rappresenti una valida alternativa al “fast-food”, ma in realtà
questa forma di ristorazione appartiene a civiltà ben più remote.
Le strade dell’antica Roma erano punteggiate dalle “tabernae” che offrivano ai clienti meno
abbienti: salsicce, carne bollita, lardo e prosciutto a prezzi diremo popolari. Nel Medio Evo la
ristorazione di strada si espanse conseguentemente all’incrementarsi dei pellegrinaggi e degli
scambi commerciali. Dalla ristorazione delle “stazioni di posta” nacquero le mense e i refettori, sino
alla ristorazione autostradale attuale finalizzata a soddisfare le richieste alimentari di breve durata.
Su questo tema legato alla storia della gastronomia, e alla storia della Scienza dell’Alimentazione,
Clara e Gigi Padovani hanno dato alla luce un volume interessante: “Street Food all’italiana”
(Giunti editore, 190 pagine, euro 14,90) ricco di notizie sui soggetti che mantengono vivo un
mestiere tramandato di generazione in generazione. Oggi anche la ristorazione mobile è soggetta
a controlli e pratiche (esiste l’obbligo SCIA - Segnalazione Certificata Inizio attività), e le Camere
di Commercio segnalano che nel 2009 erano scritte al registro delle imprese della ristorazione
ambulante ben 563 aziende che sono triplicate nel 2012, arrivando a quota 1665. Esiste anche
l’associazione culturale “Street food” (fondata da Massimiliano Ricciarini) che, oltre a valorizzare
il cibo di strada come elemento basilare della moderna civiltà alimentare intende organizzare
programmi di cultura per gli operatori del settore per ridurre i rischi degli alimenti venduti sulla
strada dal punto di vista igienico sanitario.
Il volume “Street Food all’italiana” consente di conoscere non solo la storia e le ricette
caratteristiche delle regioni italiane (dalla piadina romagnola al “pani ca’meusa palermitano, dal
lampredotto di Firenze ai “cicheti” veneti, dalla panissa genovese al castagnaccio toscano, alla
“schisceta milanese”, per citarne solo alcuni), ma anche le dosi degli ingredienti, per cui è possibile
una valutazione delle calorie e dei principi nutritivi.
Molte persone non tengono conto delle ingestioni fatte fuori casa durante il giorno per cui
alla sera ripetono dosi esagerate di cibi già gustati a mezzogiorno, senza variare la dieta in modo
equilibrato. I cibi di strada vanno conosciuti e considerati perché in futuro saranno sempre più
numerosi: lo impone il moderno stile di vita e i problemi di “low-cost” relativi alla situazione
economica attuale.
Sub-carenze sommerse
Un’indagine GfkEurisco rivela che più di 7 italiani su 10 (8 nella fascia over 50) reputano di
seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, e oltre l’80 % dichiara di aver adottato almeno un
comportamento salutistico nell’ultimo anno, ponendo, in particolare, attenzione al cibo: oltre il 50 %
si impegna a mangiare in modo vario ed equilibrato, mentre il 66 % (quota che sale al 73 % nella
popolazione over 50) cerca di evitare gli eccessi più rischiosi per la salute, per esempio riducendo
zuccheri solubili, sale, grassi, alcool.
58
R. Pellati
Nutrizione e salute
Approfondendo però l’intervista attraverso l’analisi della composizione del menù quotidiano,
si nota che la maggioranza non riesce a rispettare le dosi raccomandate necessarie per assicurare
all’organismo l’assunzione di tutti i nutrienti essenziali per la promozione della salute e del
benessere.
Per esempio la frutta e la verdura non mancano quasi mai dalla tavola degli italiani, ma il loro
consumo si attesta, nella maggioranza dei casi, su quantitativi minimi e spesso non sufficienti
a garantire l’apporto di vitamine e sali minerali. Solo il 15 % circa della popolazione riesce a
introdurre nella propria dieta giornaliera il corretto apporto consigliato dall’O.M.S., pari ad almeno
5 porzioni, mentre il consumo medio è limitato a 3 porzioni.
Esiste inoltre una scarsissima consapevolezza che queste abitudini alimentari siano inadeguate
rispetto al fabbisogno nutrizionale: il 70 % circa degli intervistati ritiene di non dover aumentare la
quantità di frutta e verdura assunta giornalmente perché la ritiene già sufficiente, quasi 7 italiani su
10 non sono a conoscenza di quale sia il consumo di frutta raccomandato e, tra coloro che dichiarano
di conoscerlo, solo poco più del 10 % indica correttamente le 5 porzioni. Questo basso livello di
percezione di un possibile problema di carenza, trova un riflesso anche nei dati di consumo degli
integratori alimentari. Ben 7 italiani su 10 dichiarano di non averli utilizzati nell’arco degli ultimi
12 mesi e oltre il 60 % di questi indica, tra le motivazioni del mancato consumo, di non ritenersi a
rischio di deficit nutrizionali.
Michele Carruba (Università degli Studi di Milano) sottolinea che, dietro a questa fotografia
della situazione, può profilarsi un problema di sub-carenze. Oggi le carenze nutrizionali gravi
e conclamate sono superate (xeroftalmia, scorbuto, pellagra, beri-beri) mentre sono attuali le
manifestazioni sub-cliniche dovute alle carenze suggerite dall’indagine. Livelli sub-ottimali di
micronutrienti essenziali come vitamine e minerali rientrerebbero nei fattori di rischio per alcune
malattie croniche nella popolazione adulta e anziana, quali obesità, ipertensione arteriosa, malattie
cardiovascolari e metaboliche, diabete di tipo 2, cataratta, degenerazione maculare senile, demenza
senile, osteoporosi, alcun e neoplasie.
Di conseguenza anche le carenze lievi, soprattutto se durature nel tempo, non devono essere
trascurate e vanno risolte prima che sfocino in disturbi più seri. Ed ecco perché l’integrazione
multivitaminica-multiminerale può offrire un aiuto importante specialmente in quei soggetti che,
anche inconsapevolmente, non riescono a seguire una dieta corretta e completa. Il dietologo, il
nutrizionista, il medico di medicina generale, il farmacista, l’oncologo, l’oculista, il geriatra, il
ginecologo, sono interlocutori chiave nella promozione dei messaggi di educazione alimentare per
un uso appropriato e consapevole degli integratori alimentari.
Rame e Alzheimer
24 milioni di individui nel mondo sono affetti da demenza, il 70 % dei quali è colpito dalla malattia
di Alzheimer. Una ricerca innovativa è stata presentata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, frutto di 10 anni di studi, sul ruolo del rame nello sviluppo della malattia suddetta.
I ricercatori dell’Associazione Fatebenefratelli per la ricerca (AFar) guidati da Rosanna Squitti,
hanno dimostrato che nella demenza di Alzheimer esiste una relazione tra declino cognitivo e
livelli di rame “libero” presente nel sangue, ossia quella quota di rame circolante non legato alla
proteina che normalmente lo trasporta, la cerulo plasmina (rame non ceruloplasminico). Livelli
eccessivi di questo tipo di rame sono tossici e aumentano il rischio di essere colpiti da Alzheimer.
Questo tipo di anomalia, se rilevata per tempo, aiuta anche a meglio identificare quei casi
pre-sintomatici (i cosidetti Mild Cognitive Impairment = MCI) che hanno un elevato rischio di
59
La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 3, luglio-agosto 2013, ANNO 42
sviluppare la malattia nei successivi 5-6 anni. Infatti nel gruppo preso in esame e seguito per 6 anni,
mentre gli MCI con rame normale avevano circa il 20 % di probabilità di progredire in Alzheimer,
in quelli con rame elevato tale probabilità saliva oltre il 50 %.
Il metodo messo a punto da Rosanna Squitti era però tipicamente un test di laboratorio, molto
utile per la ricerca, ma poco utilizzabile come test clinico su larga scala.
Di recente Canonx4drug (società Italiana di ricerca nel campo biomedico) in collaborazione
con l’AFaR ha sviluppato C4D, un test innovativo in grado di misurare la quantità di rame nonceruloplasminico in circolo, con rapidità, alta precisione, replicabilità, analizzato per mezzo di
una sonda fluorescente che emette dei segnali; il cambiamento di emissione è proporzionale alla
quantità di rame non cerulo-plasminico presente nel campione.
Tale test è già operativo presso il Policlinico Gemelli di Roma, ma sarà reso disponibile in molti
altri ospedali e centri che si occupano di Alzheimer. L’interesse verso questo nuovo “Killer” deriva
anche dal fatto che, a differenza di altri fattori di rischio, può essere normalizzato, grazie ad un
intervento terapeutico che i ricercatori stanno mettendo a punto.
Vegetarismo: aspetti nutrizionali
L’EUFIC (European Food Information Council) ha ricordato che le diete vegetariane, paragonate
alle diete onnivore, tendono ad essere più basse in grassi saturi e colesterolo, ma più alte in fibra,
vitamine C ed E, magnesio, potassio e fitochimici, flavonoidi e carotenoidi. Tali diete possono
conferire un effetto protettivo verso diverse malattie croniche e possono contribuire ad abbassare
i valori del BMI (specialmente nei vegani). Bisogna però notare che il BMI non è sempre un indice
di buona salute. Data la natura restrittiva delle diete vegane, la diminuzione del peso corporeo
potrebbe essere causata semplicemente da un apporto di cibo ridotto e/o monotono.
I benefici cardiovascolari per un basso contenuto di carne possono essere derivati da profili
lipemici migliori e da valori inferiori di pressione ematica, così come gli effetti benefici di certi
fitochimici sulla funzione cardiovascolare.
I vegetariani rischiano meno di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi mangia carne e in
particolare quella lavorata (pancetta, prosciutto, salame) e migliorano il controllo della glicemìa
nelle persone già colpite. Traggono beneficio anche le sindromi metaboliche.
Vale la pena sottolineare che il rischio di malattie correlate alla dieta è minimo con un apporto
ben bilanciato di cibo (con o senza carne). Pertanto gli studi sugli aumenti del rischio per una certa
malattia provocata dal mangiare alimenti di origine animale specifici devono essere considerati
con attenzione. Spesso sono presentati come “rischio relativo” (esempio: le persone che mangiano
100 g al giorno di carne rossa o 50 g di carne lavorata) quelli con circa il 20 % di rischio maggiore
di sviluppare tumori intestinali rispetto a chi non mangia alcun tipo di carne.
Se ipotizziamo che chi non mangia carne rossa o lavorata ha un “rischio assoluto” durante
l’arco della vita di contrarre tumori intestinali del 5 %, questo rischio aumenta al 6 % se questa
persona inizia a mangiare rispettivamente da 100 a g 50 g al giorno di carne rossa o lavorata.
Mentre una dieta totalmente priva di carne potrebbe non essere appropriata a chiunque,
rinunciare alla carne uno o più giorni alla settimana potrebbe essere un approccio per quelli che
desiderano semplicemente ridurre l’apporto totale.
Il World Cancer Research Fund raccomanda attualmente alle persone di mangiare meno di
500 g di carne rossa alla settimana. Mangiare pesce piuttosto che carne (nel contesto di modelli
alimentari ricchi di verdure, frutta e prodotti a base di cereali) potrebbe costituire un’altra opzione
associata a benefici per la salute (esempio: dieta mediterranea). I nutrienti più critici a tal riguardo
60
R. Pellati
Nutrizione e salute
sono la vitamina B12, vitamina D, il calcio, il ferro, lo zinco e gli acidi grassi omega-3 EPA e DHA.
Per chi vuole mangiare meno alimenti di origine animale o eliminarli del tutto, è necessaria
un’attenta pianificazione dei pasti per assicurarsi che le necessità nutrizionali non vengano
compromesse.
La vitamina B12 è uno dei nutrienti più critici per i vegani, per cui possono utilizzare gli
integratori o affidarsi ad estratti di lieviti di birra.
La soia, nelle sue varie forme (fagioli organici, tofu) è un’utile aggiunta alla dieta vegetariana
per l’apporto proteico e per il ferro coniugato alle proteine. Anche i legumi costituiscono fonti
altrettanto valide. Gli EPA possono essere sintetizzati anche in quantità sufficiente se il precursore
acido alfa-linolenico (ALA) viene fornito attraverso la dieta (frutta secca oleosa).
61