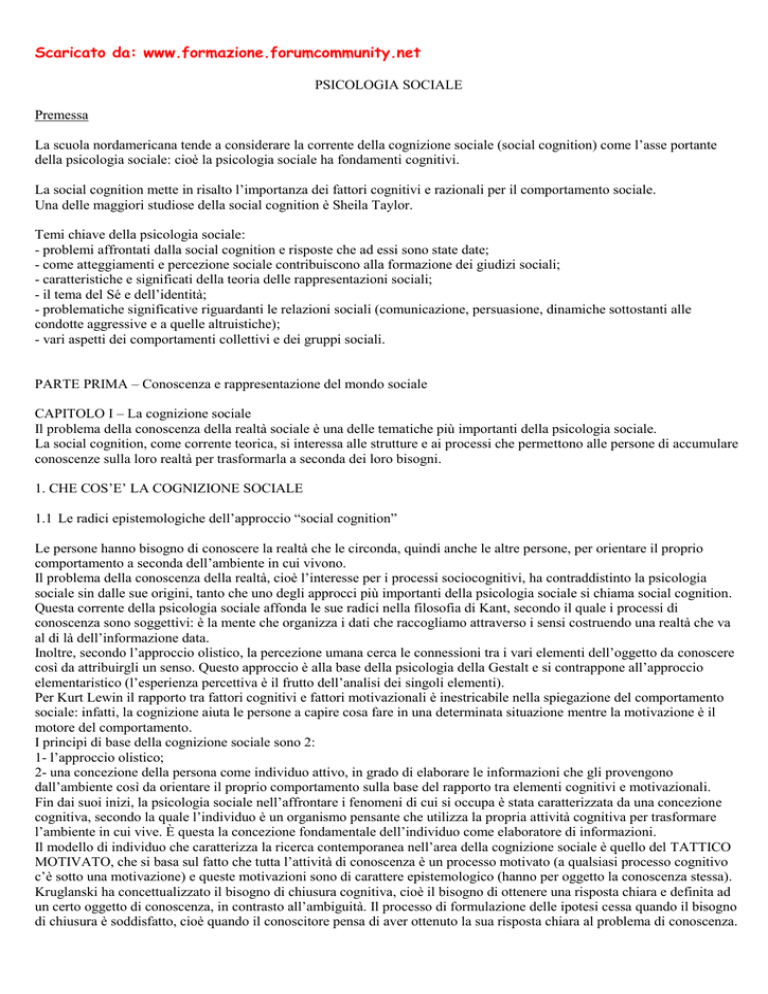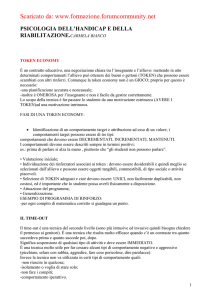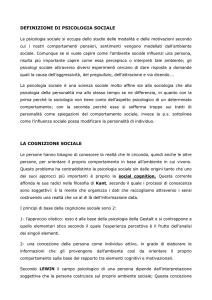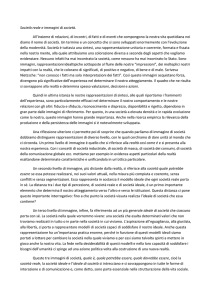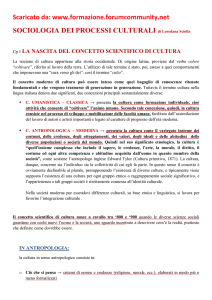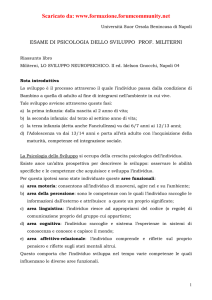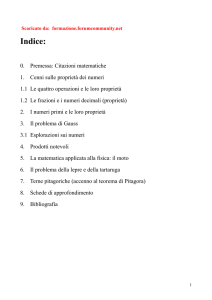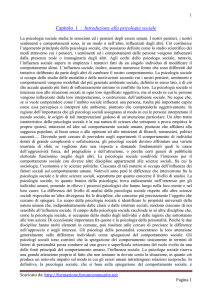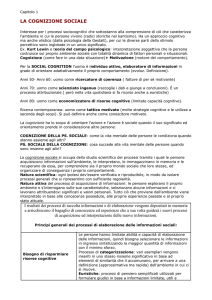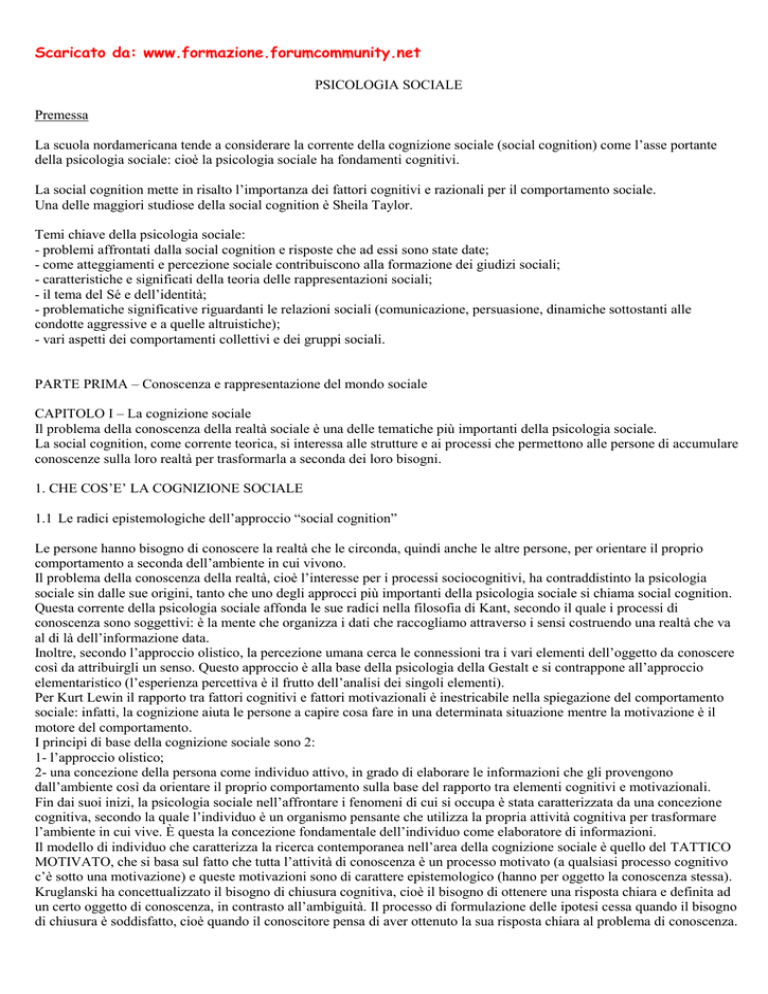
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
PSICOLOGIA SOCIALE
Premessa
La scuola nordamericana tende a considerare la corrente della cognizione sociale (social cognition) come l’asse portante
della psicologia sociale: cioè la psicologia sociale ha fondamenti cognitivi.
La social cognition mette in risalto l’importanza dei fattori cognitivi e razionali per il comportamento sociale.
Una delle maggiori studiose della social cognition è Sheila Taylor.
Temi chiave della psicologia sociale:
- problemi affrontati dalla social cognition e risposte che ad essi sono state date;
- come atteggiamenti e percezione sociale contribuiscono alla formazione dei giudizi sociali;
- caratteristiche e significati della teoria delle rappresentazioni sociali;
- il tema del Sé e dell’identità;
- problematiche significative riguardanti le relazioni sociali (comunicazione, persuasione, dinamiche sottostanti alle
condotte aggressive e a quelle altruistiche);
- vari aspetti dei comportamenti collettivi e dei gruppi sociali.
PARTE PRIMA – Conoscenza e rappresentazione del mondo sociale
CAPITOLO I – La cognizione sociale
Il problema della conoscenza della realtà sociale è una delle tematiche più importanti della psicologia sociale.
La social cognition, come corrente teorica, si interessa alle strutture e ai processi che permettono alle persone di accumulare
conoscenze sulla loro realtà per trasformarla a seconda dei loro bisogni.
1. CHE COS’E’ LA COGNIZIONE SOCIALE
1.1 Le radici epistemologiche dell’approccio “social cognition”
Le persone hanno bisogno di conoscere la realtà che le circonda, quindi anche le altre persone, per orientare il proprio
comportamento a seconda dell’ambiente in cui vivono.
Il problema della conoscenza della realtà, cioè l’interesse per i processi sociocognitivi, ha contraddistinto la psicologia
sociale sin dalle sue origini, tanto che uno degli approcci più importanti della psicologia sociale si chiama social cognition.
Questa corrente della psicologia sociale affonda le sue radici nella filosofia di Kant, secondo il quale i processi di
conoscenza sono soggettivi: è la mente che organizza i dati che raccogliamo attraverso i sensi costruendo una realtà che va
al di là dell’informazione data.
Inoltre, secondo l’approccio olistico, la percezione umana cerca le connessioni tra i vari elementi dell’oggetto da conoscere
così da attribuirgli un senso. Questo approccio è alla base della psicologia della Gestalt e si contrappone all’approccio
elementaristico (l’esperienza percettiva è il frutto dell’analisi dei singoli elementi).
Per Kurt Lewin il rapporto tra fattori cognitivi e fattori motivazionali è inestricabile nella spiegazione del comportamento
sociale: infatti, la cognizione aiuta le persone a capire cosa fare in una determinata situazione mentre la motivazione è il
motore del comportamento.
I principi di base della cognizione sociale sono 2:
1- l’approccio olistico;
2- una concezione della persona come individuo attivo, in grado di elaborare le informazioni che gli provengono
dall’ambiente così da orientare il proprio comportamento sulla base del rapporto tra elementi cognitivi e motivazionali.
Fin dai suoi inizi, la psicologia sociale nell’affrontare i fenomeni di cui si occupa è stata caratterizzata da una concezione
cognitiva, secondo la quale l’individuo è un organismo pensante che utilizza la propria attività cognitiva per trasformare
l’ambiente in cui vive. È questa la concezione fondamentale dell’individuo come elaboratore di informazioni.
Il modello di individuo che caratterizza la ricerca contemporanea nell’area della cognizione sociale è quello del TATTICO
MOTIVATO, che si basa sul fatto che tutta l’attività di conoscenza è un processo motivato (a qualsiasi processo cognitivo
c’è sotto una motivazione) e queste motivazioni sono di carattere epistemologico (hanno per oggetto la conoscenza stessa).
Kruglanski ha concettualizzato il bisogno di chiusura cognitiva, cioè il bisogno di ottenere una risposta chiara e definita ad
un certo oggetto di conoscenza, in contrasto all’ambiguità. Il processo di formulazione delle ipotesi cessa quando il bisogno
di chiusura è soddisfatto, cioè quando il conoscitore pensa di aver ottenuto la sua risposta chiara al problema di conoscenza.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Il bisogno di chiusura cognitiva è sia una caratteristica della personalità sia una motivazione causata da particolari situazioni
(fretta, rumore, affaticamento mentale).
Il rapporto fra cognizione e motivazione ha conosciuto fasi alterne nella recente storia della social cognition.
Nel modello del tattico-conoscitore motivato i fattori motivazionali riacquistano un ruolo da protagonisti.
1.2. A cosa serve la conoscenza sociale?
L’attività cognitiva è sempre motivata perché le persone hanno la necessità di conoscere la realtà in cui vivono per poterla
controllare, prevedere e trasformare.
La conoscenza sociale è un’attività motivata frutto dell’azione sociale e guida di essa; c’è infatti un legame fra pensiero e
azione, così come sostenne Fiske: THINKING IS FOR DOING, pensare è per agire, quindi la cognizione sociale è al
servizio dell’interazione sociale.
1.3. Fattori cognitivi e fattori sociali nella cognizione sociale.
Gli oggetti della cognizione sociale sono le persone che possono assumere due posizioni sociali fondamentali nel loro
mondo sociale:
- quella di attori del comportamento sociale;
- quella di osservatori del proprio comportamento e di quello degli altri.
La cognizione sociale ha quindi carattere:
- interpersonale;
- intersoggettivo;
- riflessivo,
che la distingue dalla cognizione non sociale.
Il carattere peculiare della cognizione sociale è il suo scopo di orientare l’azione e l’azione è sociale quando il suo
significato e orientamento prendono in considerazione altre persone.
Si dice COGNIZIONE poiché analizza a livelli cognitivo i fenomeni di cui si occupa e si dice SOCIALE in quanto
densamente popolata dalla presenza degli altri.
2. COME FACCIAMO A CONOSCERE LA REALTA’ SOCIALE
2.1. L’organizzazione delle conoscenze: gli schemi e le categorie sociali.
L’accumulazione della conoscenza sulla realtà sociale deriva da due fonti di informazioni:
1- la realtà oggettivamente data (che sta fuori di noi);
2- il nostro modo di percepire la realtà.
Il ruolo degli schemi nella ricostruzione della realtà è molto importante: infatti, la percezione umana è altamente costruttiva
rispetto agli stimoli che riceve dalla realtà esterna, e questo processo di costruzione della conoscenza avviene in base agli
schemi, strutture cognitive che contengono informazioni su di un particolare oggetto di conoscenza (stimolo).
Gli schemi facilitano i processi di conoscenza top-down (dall’alto in basso) cioè basati su concetti, conoscenze e teorie già
depositate nella memoria delle persone.
I processi di conoscenza di tipo schematico hanno il vantaggio di accorciare il lavoro cognitivo, ma possono originare una
serie di errori dovuti al fatto che le persone possono negare l’evidenza della realtà per conservare le proprie opinioni e
credenze.
I processi top-down si contrappongono a quelli bottom-up (dal basso verso l’alto), i quali sono invece basati sui dati appena
raccolti attraverso la percezione, ed hanno lo svantaggio di essere abbastanza dispendiosi sul piano temporale in quanto le
persone centrano la loro attenzione su ogni singolo elemento d’informazione attinente l’oggetto da conoscere.
Come utilizziamo gli schemi: quando incontriamo un nuovo stimolo di conoscenza dobbiamo prima di tutto riconoscerlo,
tramite la classificazione all’interno di una categoria familiare sulla base delle caratteristiche che possiede.
In questa fase si possono commettere errori per il fatto che alcune caratteristiche degli oggetti sociali possono essere
condivise da esemplari di altre categorie.
Perciò la questione fondamentale al riguardo della categorizzazione sociale è quella di identificare dei criteri di
classificazione che permettano di percepire le somiglianze fra i membri della stessa categoria sociale e le differenze tra
categorie differenti, tenendo conto che esistono attributi comuni a più categorie.
Secondo la concezione aristotelica le categorie sono definite da un numero ridotto di criteri necessari e sufficienti,
soddisfatti i quali ogni membro ha la piena appartenenza alla categoria in questione. Queste norme si applicano bene ad
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
oggetti con una struttura semplificata mentre invece la realtà sociale risulta più difficile da classificare in basi a criteri così
rigidi.
Infatti, le categorie naturali hanno confini sfuocati e non è sempre facile decidere se un esemplare appartiene a pieno titolo
ad una di esse. Ci sono però esemplari che possiedono gli attributi più tipici della categoria e quindi vengono definiti
PROTOTIPI.
2.2. Diversi tipi di schemi sociali.
Esistono diversi tipi di schemi sociali a seconda del tipo di informazioni contenute in essi (però tutti funzionano allo stesso
modo):
- schemi di persona;
- schemi di sé;
- schemi di ruolo;
- schemi di eventi.
Gli SCHEMI DI PERSONA contengono le informazioni che ci aiutano a descrivere le persone in base ai loro tratti di
personalità (socievole, aggressivo, simpatico) o ad altre caratteristiche che le contraddistinguono (scopi, finalità).
L’attivazione di schemi relativi ad una persona facilita il ricordo e la comprensione delle nuove informazioni.
Gli SCHEMI DI SE’ sono insiemi di strutture schematiche in cui sono contenute le informazioni che ci contraddistinguono.
Il Sé costituisce un filtro di conoscenza per molti altri oggetti sociali, nel senso che siamo particolarmente attenti a quegli
aspetti della realtà sociale che rimandano a noi stessi.
Gli SCHEMI DI RUOLO sono importanti perché definiscono le aspettative comportamentali in relazione alle posizioni che
le persone occupano in una data realtà sociale. I ruoli possono essere:
- acquisiti, cioè ottenuti tramite intenzione ed impegno (quelli professionali);
- ascritti, cioè acquisiti per nascita o per via automatica (età, appartenenza etnica, genere sessuale) → possono funzionare
come stereotipi sociali, delle facilitazioni che però possono condurre ad una serie di errori.
Gli SCHEMI DI EVENTI includono le conoscenze relative al modo in cui ci si comporta nelle diverse situazioni sociali, e
le aspettative che abbiamo sul modo in cui si comporteranno gli altri (che dipendono dai vari ruoli sociali).
Ovviamente i contenuti di alcuni schemi di eventi cambiano in base alle diverse culture, ma il loro funzionamento rimane
abbastanza stabile.
3. VANTAGGI E DISFUNZIONI DEL RAGIONAMENTO SOCIALE: LE EURISTICHE.
Le euristiche sono strategie di pensiero semplificate, strategie cognitive che accorciano il tempo dei percorsi cognitivi che
permettono di arrivare alla soluzione dei problemi.
Presentano il vantaggio di guadagnare tempo e risparmiare energia mentale, ma il rischio è di giungere a giudizi grossolani,
poco attendibili o errati.
Ce ne sono di diverse:
- euristica della rappresentatività;
- euristica della disponibilità;
- euristica della simulazione;
- l’ancoraggio e l’accomodamento.
3.1. L’euristica della rappresentatività
Viene utilizzata al fine di emettere dei giudizi circa la probabilità che un certo evento si verifichi: riguarda nello specifico
quei giudizi in cui le persone devono decidere se un certo esemplare appartiene ad una determinata categoria.
3.2. L’euristica della disponibilità
Strategia di pensiero utilizzata quando le persone devono giudicare la loro realtà sociale in base alla frequenza o probabilità
con cui un certo evento si verifica: in tal caso il giudizio sociale è basato sulla facilità e rapidità con cui vengono in mente
esempi associati alla categoria del giudizio in questione.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
3.3. L’euristica della simulazione
È un modo di elaborare le informazioni variante dell’euristica della disponibilità e viene utilizzata nella costruzione di
scenari ipotetici, cioè quando immaginiamo come potrebbero evolvere certi eventi o come sarebbero potuti evolvere
diversamente da come si sono verificati nella realtà.
La simulazione mentale di come certi eventi avrebbero potuto svolgersi si chiama anche PENSIERO
CONTROFATTUALE.
3.4. Ancoraggio e accomodamento
Quando le persone si trovano a dover emettere giudizi sulla base di informazioni incerte o ambigue cercano dei punti di
riferimento (una conoscenza nota) a cui ancorarsi e accomodare il giudizio sulla base di altre informazioni pertinenti.
La base per l’ancoraggio è fornita dall’esperienza personale: infatti, i propri tratti, le proprie credenze e i propri
comportamenti rappresentano frequentemente punti di ancoraggio per il giudizio sociale.
4. LA SPIEGAZIONE DELLA REALTA’ SOCIALE: L’ATTRIBUZIONE CAUSALE
Le persone hanno bisogno di trovare un significato per le esperienze che vivono o di cui sono spettatrici, di interpretare e
spiegare gli eventi sociali che le circondano.
Le attribuzioni possono quindi conferite:
- per via automatica, nel caso di molti eventi, che richiedono spiegazioni poco dispendiose dal punto di vista cognitivo, a
cui quindi le persone giungono per via quasi automatica, senza essere consapevoli che in quel momento stanno cercando
di capire le cause di ciò che accade;
- sulla base di processi accurati, nel caso di situazioni che richiedono elaborazioni più dispendiose ed accurate.
Uno degli scopi fondamentali dei processi di attribuzione causale è dato dal bisogno di spiegare gli eventi sociali al fine di
controllare e prevedere il modo in cui si verificano per poter attuare azioni ad essi congruenti.
Infatti, se siamo consapevoli del modo in cui le cose accadono possiamo creare le condizioni perché esse accadano o per
evitarle.
4.1. Il contributo di Fritz Heider
Per Heider le persone sentono il bisogno di anticipare che cosa succederà a se stessi e a coloro che li circondano, e lo
strumento più efficace per fare ciò è comprendere le cause del comportamento sociale.
L’origine (il locus) della causalità può essere dovuta a:
- fattori interni (personali);
- fattori esterni (situazionali).
I fattori personali riguardano:
- le motivazioni (volere o cercare di fare qualcosa);
- le abilità necessaria a raggiungere il proprio scopo.
4.2. La teoria dell’inferenza corrispondente
Jones e Davis hanno sviluppato la teoria dell’inferenza corrispondente, secondo la quale lo scopo dell’attribuzione causale è
quello di compiere delle inferenze corrispondenti su di un’altra persona, di giungere cioè alla conclusione che il
comportamento o l’interazione comportamentale corrispondono a delle qualità stabili della persona, vale a dire, delle
disposizioni.
E conoscere le disposizioni di una persona ci permette di prevederne il comportamento.
L’inferenza che l’intenzione di una persona che valutiamo dipende dalle sue disposizioni si basa su vari fattori come:
- l’analisi degli effetti non comuni;
- la desiderabilità sociale (al diminuire di questa è più probabile che il comportamento messo in atto sia realmente dovuto a
disposizioni interne);
- la libera scelta (i comportamenti messi in atto senza costrizione sono molto più informativi delle disposizioni delle
persone rispetto a quelli dettati da imposizioni o scelte altrui).
- le aspettative comportamentali legate ai ruoli che le persone ricoprono (infatti è più facile pensare che il comportamento
di una persona corrisponda alle sue disposizioni quando questo non deriva dalle norme di comportamento legate al ruolo).
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
4.3. Il modello della covariazione di Kelley
La teoria dell’inferenza corrispondente riguarda il modo in cui le persone cercano di capire quali sono le disposizioni delle
persone sulla base di una quantità di evidenza comportamentale limitata.
Per Heider, il comportamento sociale può essere spiegato non solo in base alle disposizioni personali, ma anche attraverso
l’ausilio di fattori situazionali.
Secondo il modello della covariazione di Kelley, l’individuo elaboratore attivo di informazioni, prima di giungere al
giudizio causale su un effetto, compie una serie di osservazioni, rileva la sua covariazione sulla base di 3 principi
informativi:
- distintività (l’effetto si produce solo quando l’entità è presente);
- coerenza nel tempo e nelle modalità (l’effetto si manifesta allo stesso modo tutte le volte in cui l’entità è presente);
- consenso (l’effetto viene percepito da tutte le altre persone come dipendente dalla presenza dell’entità).
Se siamo in grado di concludere che l’effetto che vogliamo spiegare si manifesta ogni volta (alta coerenza) che l’entità è
presente (alta distintività) e che ci sia un alto consenso, allora compiamo un’attribuzione causale disposizionale del tutto a
carico dell’entità in questione.
Però non tutti i tre fattori hanno lo stesso peso e lo stesso potere predittivo nelle spiegazioni causali: le persone preferiscono
avere informazioni circa la coerenza nel tempo con cui l’effetto si manifesta rispetto alla distintività e il consenso risulta
essere il fattore meno utilizzato.
4.4. Tendenze sistematiche nei processi di attribuzione
Nella realtà quotidiana la spiegazione degli eventi può risultare complessa e questo può portare a distorsioni nelle
attribuzioni causali dovuti al cosiddetto self-serving bias, cioè la tendenza ad attribuire le cause dei propri successi a fattori
interni.
Le spiegazioni possibili a questo fenomeno sono 2:
1- di carattere cognitivo, secondo la quale le persone hanno normalmente più esperienze di successi che di insuccessi ed
usano questa conoscenza personale come fondamento dei giudizi di causalità;
2- di carattere motivazionale, che si fonda sul fatto che le persone sono motivate ad autovalorizzarsi indipendentemente
dalla frequenza reale dei propri successi e insuccessi.
4.5. L’errore fondamentale di attribuzione (sovrastima dei fattori disposizionale e sottostima dei fattori situazionali)
Heider individua l’errore fondamentale di attribuzione, ossia la tendenza generale nelle spiegazioni causali a sovrastimare il
pensiero dei fattori disposizionale e a sottostimare il peso dei fattori situazionali.
Secondo Gilbert il processo attribuzionale avviene in 2 fasi:
1- identificazione del comportamento e rapida attribuzione disposizionale in maniera automatica;
2- nel caso in cui l’evidenza contrasta troppo con la conclusione si aggiusta il giudizio sulla base delle influenze
situazionali.
L’errore fondamentale deriva da una distorsione percettiva in base alla quale chi mette in atto il comportamento (l’attore)
viene percepito come una figura particolarmente importante per l’attenzione: la situazione rimane invece più in ombra
costituendo lo sfondo.
Secondo Taylor e Fiske, le persone attribuiscono le cause a fattori percettivamente consistenti o importanti (salienti).
4.6. La discrepanza attore-osservatore
L’effetto attore-osservatore è complementare all’errore fondamentale dell’attribuzione.
Infatti, le persone tendono ad attribuire le cause del proprio comportamento a fattori situazionali e ad attribuire le cause del
comportamento altrui a fattori disposizionale.
Questo perchè l’attore possiede una memoria autobiografica molto accurata e perciò dispone di una conoscenza dettagliata
sul modo in cui si è comportato nelle situazioni passate. Questo scoraggia le attribuzioni disposizionale verso se stesso.
L’osservatore non ha invece a disposizione informazioni precise su come le persone si comportano nelle diverse situazioni:
risulta così più semplice fare attribuzioni disposizionali.
Un’ulteriore spiegazione di questa discrepanza fa riferimento a fattori percettivi in base ai quali per l’attore la situazione
costituisce il fattore di maggiore salienza percettiva mentre per l’osservatore la persona costituisce l’elemento più saliente e
quindi più informativo.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
CAPITOLO 2 – IL GIUDIZIO SOCIALE
Le persone, oltre a conoscere il proprio mondo lo valutano percui gli atteggiamenti, le impressioni che ci si forma circa le
altre persone, la reputazione di cui esse godono sono elementi che possono aiutare a capire il giudizio sociale e quindi i
comportamenti dell’attore sociale.
1. GLI ATTEGGIAMENTI
Il termine atteggiamento è stato utilizzato per la prima volta nella ricerca di due sociologi, Thomas e Znaniecki, nel 1918, i
quali lo definirono come un processo della coscienza individuale che determina l’azione.
Gli atteggiamenti possono essere inclusi nei valori sociali: infatti, gli atteggiamenti vengono concepiti come relativi ad un
singolo oggetto mentre i sistemi di valore sono degli orientamenti verso intere classi di oggetti.
Gli atteggiamenti individuali sono spesso organizzati entro un sistema di valori.
La prima definizione di atteggiamento (piuttosto generica) fu quella di Gordon Allport, il quale lo considerava uno stato
mentale o neurologico di prontezza, organizzata attraverso l’esperienza, che esercita un’influenza direttiva o dinamica sulla
risposta dell’individuo nei confronti di ogni oggetto o situazione con cui entra in relazione.
Questa definizione mette in evidenza il fatto che si parla di uno stato non direttamente osservabile e che si tratta di una
variabile che interviene fra lo stimolo e la risposta.
La concezione tripartita degli atteggiamenti ha conosciuto una particolare diffusione e si basa sul concetto che
l’atteggiamento è un costrutto psicologico costituito da 3 componenti di natura diversa:
1- componente cognitiva (le informazioni e le credenze che gli individui possiedono a proposito dell’oggetto a cui si volge
l’attenzione);
2- componente affettiva (la reazione emotiva che l’oggetto suscita);
3- componente comportamentale (l’azione di avvicinamento o esitamento rispetto all’oggetto).
La componente più studiata è stata sicuramente quella affettiva.
Più di recente, nell’ottica della social cognition, si tende a considerare l’atteggiamento come una struttura cognitiva
costituita dall’associazione in memoria fra la rappresentazione dell’oggetto e la sua valutazione. In quanto struttura
cognitiva, è caratterizzata da disponibilità e accessibilità.
L’idea che l’atteggiamento sia una struttura cognitiva non si contrappone alla concezione propria del modello tripartito.
Il punto innovativo di questa concezione sta nel fatto di introdurre un ulteriore parametro che caratterizza gli atteggiamenti,
ovvero la forza dell’associazione fra oggetto e valutazione: infatti, un orientamento può essere lo stesso (più o meno
favorevole) ma avere un diverso grado di sicurezza.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Le principali modalità di formazione degli atteggiamenti, attraverso le quali arriviamo a definire un orientamento verso un
determinato oggetto, sono 3:
1- esperienza diretta (costituito da una forte associazione depositata in memoria fra la rappresentazione dell’oggetto stesso
e la sua valutazione; questo tipo di atteggiamento risulta completamente memory-based);
2- osservazione dell’esperienza altrui (minor forza lega la rappresentazione dell’oggetto e la sua valutazione);
3- comunicazione (forza ancora minore).
La formazione degli atteggiamenti attraverso gli ultimi due casi sono anche meno resistenti al cambiamento percui
l’esperienza diretta successiva può cambiare completamente la valutazione.
Un’altra modalità di formazione degli atteggiamenti è l’effetto di mera esposizione, cioè l’esposizione ripetuta ad uno
stimolo nuovo per l’individuo: infatti, quanto più le persone hanno la possibilità di osservare lo stimolo, tanto più lo
giudicano piacevole.
Anche se la prima reazione di fronte aduno stimolo nuovo sarebbe l’evitamento, le successive esposizioni farebbero
diminuire questa reazione negativa.
1.1.
Come si misurano gli atteggiamenti
A partire dagli anni ’20 alcuni studiosi si dedicarono alla messa a punto di metodi per la misurazione degli atteggiamenti,
come la scala Likert e il metodo del differenziale semantico).
Queste misurazioni partono dall’assunto che gli atteggiamenti non si osservano ma possono essere dedotti da alcuni
indicatori come le risposte manifeste delle persone o i loro comportamenti, i quali permettono di risalire alla posizione che
l’individuo occupa nella dimensione valutativa d un dato oggetto.
Nella scala Likert, vengono presentate delle affermazioni, ciascuna delle quali è seguita da una risposta a scelta multipla fra
opzioni che vanno da “fortemente daccordo” a “fortemente in disaccordo”; ad ognuna di queste opzioni viene attribuito un
codice numerico (da 5 a 1) che consente di effettuare varie operazioni.
Il metodo del differenziale semantico, invece, è costituito da un insieme di coppie di aggettivi opposti separati da (in genere)
7 spazi che rappresentano una gradazione da uno all’altro cosicché si possa scegliere lo spazio che rappresenta meglio la
propria valutazione dell’oggetto in questione.
Queste scale per la misurazione degli atteggiamenti possono essere considerate tecniche indirette in quanto il soggetto
riporta il proprio punto di vista rispondendo a delle domande che rimangono totalmente sotto il suo controllo quindi il
rischio è quello di raccogliere dati frutto della desiderabilità sociale piuttosto che della realtà del fenomeno.
Per queste ragioni a volte gli studiosi impiegano tecniche meno dirette di misurazione, come le reazioni fisiologiche (la
risposta elettrogalvanica della pelle o l’attività dei muscoli del viso) che l’oggetto di atteggiamento induce nel soggetto.
Questo genere di misure risolvono il problema della distorsione delle risposte sulla base della loro desiderabilità sociale però
rimangono molto intrusive (richiedono molta collaborazione da parte del soggetto) e complicate.
Recentemente si ricorre sempre più spesso alla misura del tempo di latenza nell’espressione della risposta stessa perchè la
velocità di risposta indica un alto livello di accessibilità dell’atteggiamento e anche un forte grado di coinvolgimento del
soggetto rispetto alla tematica.
1.2.
Prevedere il comportamento a partire dall’atteggiamento.
A partire dagli anni ’60 si capì che non sempre conoscere gli atteggiamenti delle persone (attraverso le risposte ai
questionari) serviva per prevedere i loro comportamenti. Il problema della coerenza fra atteggiamenti e comportamenti portò
a formulare la teoria dell’azione ragionata, che si proponeva di integrare gli atteggiamenti come un fattore del
comportamento con altri fattori, come l’intenzione.
L’intenzione, a sua volta, è il prodotto delle credenze che l’individuo ha circa le conseguenze del suo comportamento e delle
norme condivise sui comportamenti adeguati in determinate situazioni (fornite dall’ambiente circostante).
Quindi, i fattori causali del comportamento sono le norme sociali e la motivazione individuale ad aderire a tali aspettative
dei gruppi di riferimento.
Le prime critiche a questa proposta concettuale sono state all’assunto di controllabilità dei comportamenti, che non tutti
sono facilmente controllabili dall’individuo, come quelli che derivano da un’abitudine consolidata, da una dipendenza, da
stati emotivi acuti (arrossire).
1.3.
Il cambiamento degli atteggiamenti
Nonostante la tendenza al conservatorismo cognitivo, gli atteggiamento possono subire cambiamenti nel corso del tempo:
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
a causa dell’esposizione alla comunicazione persuasiva (un messaggio in cui si sostiene la validità di un’opinione
oppure l’opportunità di adottare un certo comportamento, metodo applicato soprattutto nel campo della propaganda
politica e della pubblicità);
- attraverso processi individuali, come la ripetuta esposizione allo stimolo;
- teoria della dissonanza cognitiva, secondo la quale l’individuo ha la necessità di mantenere la coerenza fra le cognizioni
che possiede circa se stesso, il proprio comportamento e l’ambiente; se non si verifica questa coerenza, l’individuo sente
un disagio emotivo che cerca di rimuovere riducendo la dissonanza attraverso varie strategie.
Il problema della formulazione di una teoria generale del cambiamento degli atteggiamenti è stato affrontato attraverso due
proposte teoriche formulate all’inizio degli anni ’80: si tratta dei modelli a 2 percorsi:
- il modello della probabilità di elaborazione;
- il modello euristico-sistematico.
Per entrambi il cambiamento degli atteggiamenti è l’esito di due processi di natura diversa.
Il modello della probabilità di elaborazione prevede che il cambiamento di atteggiamento che può derivare da un messaggio
persuasivo è l’esito di due possibili percorsi:
1- percorso centrale (processo di elaborazione attenta e di riflessione accurata sulle argomentazioni e sulle informazioni
contenute nel messaggio);
2- percorso periferico (basato su elementi che hanno a che vedere con il modo con cui le informazioni sono presentate,
come l’attrattività della fonte, l’associazione del messaggio con una musica piacevole o con colori vivaci).
I cambiamenti che risultano soprattutto da un percorso centrale sono più persistenti dal punto di vista temporale e mostrano
una maggior resistenza alla contropersuasione rispetto ai cambiamenti dovuti ai segnali periferici.
Il secondo modello duale, quello euristico-sistematico, prevede due processi di natura diversa:
1- processo sistematico, che coincide con il percorso centrale, cioè l’elaborazione approfondita delle informazioni
contenute nel messaggio;
2- processo euristico, che consiste nel raggiungimento di un’opinione finale attraverso la semplice applicazione di
un’euristica (regola di decisione); come il percorso periferico, si tratta di una strategia di risparmio di energie cognitive
resa possibile da precedenti esperienze.
Queste due modalità di elaborazione, però, non si escludono a vicenda.
-
2. LA FORMAZIONE DELLE IMPRESSIONI
Nella rappresentazione del mondo sociale un posto importantissimo è riservato alle altre persone.
Solomon Asch si è preoccupato del problema di individuare il processo attraverso il quale arriviamo ad una
rappresentazione delle persone, affermando che le persone si formano prima un’impressione globale entro la quale fanno poi
rientrare le ulteriori informazioni che li descrivono.
Concepiamo cioè le persone come unità psicologiche: è questa l’idea alla base del suo modello configurazionale, basato su
un approccio di tipo olistico che rimanda all’impostazione gestaltista di Asch.
Secondo l’effetto primacy, i primi tratti servono a formare la prima impressione ed hanno un effetto molto superiore rispetto
a quelli successivi; vengono quindi utilizzati per interpretare i tratti seguenti.
Infatti, i tratti negativi non sembrano poi tanto tali quando devono essere interpretati alla luce di una serie di qualità positive
gia considerate, e viceversa.
L’interpretazione che Anderson fa degli studi di Asch e dei suoi risultati arriva alla conclusione che l’effetto primacy è
dovuto semplicemente ad un calo di attenzione che si verifica man mano che l’individuo procede nella lettura dei tratti.
Per questo propone un modello algebrico secondo il quale l’impressione è il frutto dell’integrazione algebrica delle
connotazioni attribuite ai vari tratti, cioè della media ponderata delle informazioni a disposizione.
Alla fine degli anni ’80 il modello di Asch e quello di Anderson vengono integrati in una proposta concettuale secondo la
quale nella formazione delle impressioni intervengono diversi processi a seconda delle condizioni nelle quali si attuano.
La formazione delle impressioni è quindi vista come il prodotto di un continuum di elaborazione, suddiviso in vari stadi;
infatti, di fronte ad uno sconosciuto:
1- si formula un’impressione a partire dalle appartenenze categoriali più evidenti (sesso, fascia di età, razza, livello sociale
determinato in base a qualche stereotipo), il che richiede pochissimo sforzo di attenzione ed elaborazione in quanto
l’impressione è raggiunta più o meno automaticamente; questa prima formulazione risulta soddisfacente nel caso in cui
la persona in questione ha scarsa rilevanza rispetto agli scopi del soggetto;
2- se la persona è più rilevante, si procede ad una elaborazione più approfondita che richiede maggiore attenzione alle
informazioni disponibili; in questa fase:
a- se le informazioni formulate su base categoriale corrispondono ai dati della realtà, il soggetto continuerà ad
utilizzare prevalentemente un processo di categorizzazione confermativa;
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
b- se invece il soggetto percepisce una certa incongruenza fra la prima categorizzazione e le informazione acquisite
successivamente, procederà ad una ricategorizzazione.
Nella formulazione di impressioni vengono utilizzate anche le cosiddette teorie implicite di personalità, che consistono
nell’attribuire determinati tratti di personalità a partire da altre informazioni riguardanti i tratti o determinate caratteristiche
di un soggetto.
Queste teorie implicite di personalità possono risultare scorrette e comunque esiste la tendenza a non metterle in
discussione, a non verificarle. In esse sono sempre presenti idee fisse date per scontate e pregiudizi.
3. LA FORMAZIONE DELLA REPUTAZIONE
Le impressioni che le persone si formano le une delle altre costituiscono uno degli argomenti essenziali nella
comunicazione.
Le fonti delle informazioni sugli altri, cioè le modalità per conoscere gli altri sono 3:
1- l’osservazione diretta del comportamento
2- l’ascolto di ciò che gli altri vogliono rivelare di sé;
3- la ricezione di informazioni da terzi (che forma la reputazione).
Nicholas Emler definisce la reputazione come un giudizio formulato da una comunità su un individuo in particolare.
È dunque una forma di conoscenza del mondo sociale mediata dall’esperienza degli altri, che si costruisce nella
comunicazione fra i membri dei gruppi.
Infatti, perchè un individuo abbia una reputazione sono necessarie 3 condizioni:
1- che faccia parte di una comunità con membri relativamente stabili;
2- che questi parlino fra loro del comportamento e delle qualità altrui;
3- che le persone siano legate tra di loro in una rete di conoscenze anche indirette.
Funzioni della reputazione:
1- assicurare scambi cooperativi (in quanto l’organizzazione umana in sistemi sociali richiede la coordinazione e la
pianificazione degli sforzi) grazie ad una certa forma di controllo sociale sulle persone potenzialmente dannose
grazie all’anticipazione delle scelte altrui (informandoci da terzi circa le abitudini, i comportamenti passati, ecc.);
2- autocontrollo e gestione delle informazioni personali: infatti, anche l’individuo ha interesse a mantenere una
reputazione positiva e anzi, le opportunità di accesso alle interazioni di cui può godere sono in relazione al credito
morale che matura all’interno della propria comunità mettendo in atto comportamenti socialmente approvati.
La reputazione, inoltre, è specifica dei contesti, e questo e; dovuto non solo al fatto che ci si comporta in modo diverso a
seconda del contesto in cui ci troviamo, ma anche alle aspettative diverse e ai sistemi di norme e valori differenti per ogni
gruppo sociale.
Il singolo individuo, attraverso i suoi comportamenti, cerca di controllare e in qualche modo gestire la sua reputazione.
Infatti, la reputazione è il risultato del confronto fra le prime impressioni e quelle formate nel tempo in occasione delle
interazioni comunicative fra i membri di una comunità.
L’individuo non può controllare interamente l’esito finale di questo processo perché la reputazione, una volta stabilizzatasi,
diventa difficilmente modificabile.
Secondo i teorici dell’etichettamento, quando la reputazione di cui un individuo gode è negativa diventa una forma di
etichettamento morale che produce una sorta di circolo vizioso poiché l’individuo finirà per soddisfare le aspettative che gli
altri nutrono nei suoi confronti.
Infatti, la reputazione è una sorta di estensione del Sé.
4. PERCEPIRE LE PERSONE E I GRUPPI
Nella tradizione psicosociale, il modo in cui si formano le impressioni sulle persone e quello attraverso il quale si
percepiscono i gruppi sono stati affrontati in ambiti separati ma recentemente alcuni autori propongono la tesi secondo la
quale la percezione sociale sia degli individui che dei gruppi è dovuta agli stessi processi.
Spesso gli individui pensano che la personalità sia unitaria e quindi coerente. A partire da questo presupposta coerenza
operano inferenze sulla base di alcune informazioni a disposizione circa le caratteristiche personali degli altri.
Inoltre, si presuppone anche una certa coerenza nel tempo fra tratti e comportamenti, ciò che porta a risolvere eventuali
incongruenze attraverso attribuzioni causali.
La percezione configurazionale dei gruppi si basa sull’entitatività. Questo termine, coniato da Campbell, si riferisce al fatto
che le persone percepiscono un certo livello di unità anche nei grupp
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
CAPITOLO 3 – LE RAPPRESENTAZIONI SOCIALI
Gli attori sociali appartenenti ad uno stesso ambito culturale costruiscono attraverso gli scambi significati condivisi che permettono loro
di attribuire senso alla realtà e di rendersi reciprocamente comprensibili.
Riescono inoltre a trasmettere da una generazione alla successiva i significati che hanno fatto propri.
La possibilità di elaborare, attraverso la comunicazione, significati e valori condivisi esiste anche per soggetti e gruppi appartenenti a
culture diverse.
1. IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA SOCIALE EUROPEA
Ciò che definisce un gruppo è l’interdipendenza fra i membri di tipo mentale, ideale, materiale.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
È in questo senso che la psicologia sociale può essere considerata una scienza sociale il cui compito è quello di occuparsi del linguaggio,
della conversazione quotidiana che produce la realtà sociale.
2. DA DURKHEIM A MOSCOVICI
Serge Moscovici è colui che per primo impiega la nozione di rappresentazioni sociali, mutuata a sua volta da Durkheim.
Secondo Durkheim le rappresentazioni collettive vanno distinte dalle rappresentazioni individuali perché le rappresentazioni collettive
riguardano un vasto insieme di forme intellettuali che comprendono la religione, la morale, il diritto, la scienza, il mito.
Queste rappresentazioni sono collettive almeno in 3 sensi:
1- per le origini (sociali);
2- per l’oggetto (la società);
3- per essere comuni a tutti i membri di una società o gruppo.
Dalla distinzione fra rappresentazioni collettive e rappresentazioni individuali deriva anche la distinzione fra due discipline:
1- la psicologia, focalizzata sull’individuo;
2- la sociologia, focalizzata sulla società e sulle rappresentazioni collettive.
Successivamente, Durkheim auspicò la nascita di una branca della sociologia, cioè la psicologia sociale, che si occupasse esclusivamente
dello studio delle rappresentazioni collettive.
Moscovici fa propria la nozione di rappresentazioni collettive chiamandole però sociali riferendosi all’;elaborazione di un oggetto
sociale da parte di una comunità che permette ai suoi membri di comportarsi e comunicare in modo comprensibile.
Si tratta quindi di sistemi cognitivi con una logica e un linguaggio propri, teorie o branche di conoscenza vere e proprie, utili per la
scoperta e l’organizzazione della realtà.
Quindi le rappresentazioni sociali sono prima di tutto dei modi di ricostruzione (e non costruzione) sociale della realtà.
3. PROCESSI GENERATORI DELLE RAPPRESENTAZIONI SOCIALI
Compito della psicologia sociale è quindi quello di spiegare come gli individui ricostruiscono socialmente la realtà, cioè come le
interazioni fra individui danno corpo alle idee.
Moscovici si pone il problema di come un elemento socialmente rilevante viene fatto oggetto di rappresentazione sociale e prende quindi
in considerazione il modo in cui la psicoanalisi era entrata nella società francese, per capire come gli individui facciano proprie
informazioni nuove che mettono in discussione il pensiero tradizionale.
I processi generativi delle rappresentazioni sociali sono:
1- l’ancoraggio, che permette di incorporare qualcosa che non ci è familiare nella rete delle categorie già formate attraverso il confronto
con un membro tipico della categoria per poter interpretare l’oggetto nuovo, così da ridurre la paura o lo stupore che un oggetto o un
fenomeno nuovo produce;
2- l’oggettivazione, che fa entrare la realtà percepibile, concreta nei concetti e nei fenomeni che non sono familiari, così da permetterne
l’ancoraggio; ci sono varie forme di oggettivazione:
a- la naturalizzazione, una forma di oggettivazione che consiste nel far diventare il concetto una categoria sociale, da concetto astratto
a entità quasi tangibile;
b- la personificazione (associare teorie scientifiche, idee, avvenimenti ad una personalità di spicco che così diventa il simbolo
dell’oggetto sociale);
c- la figurazione (processo attraverso cui il senso comune sostituisce metafore ed immagini a nozioni complesse).
4.
A CHE COSA SERVONO LE RAPPRESENTAZIONI SOCIALI
Le rappresentazioni sociali sono elementi costituenti dell’ambiente psicologico in cui vivono individui e gruppi che li utilizzano per
dare senso comune a fenomeni che appaiono, in un primo momento, come estranei alla mentalità corrente.
Il fenomeno delle rappresentazioni sociali è dovuto al fatto che gli attori sociali e i gruppi hanno bisogno di costruire realtà
consensuali per affrontare la realtà con criteri e linguaggi dotati di senso, comprensibili non solo per chi compone il gruppo, ma anche
per i membri di altri gruppi.
Le rappresentazioni sociali permettono quindi di ricomporre la frammentazione della vita quotidiana.
Per Moscovici, la funzione di tutte le rappresentazioni sociali è prima di tutto quella di rendere familiare ciò che è estraneo, distante
rispetto all’esperienza delle persone che costituiscono il gruppo coinvolto nel rapporto con la realtà.
CAPITOLO 4 – IL SÉ E L’IDENTITÀ
L’attore sociale rappresenta se stesso sia come un oggetto fra gli altri e sia come iniziatore dei processi della conoscenza e
dell’azione.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
1. I CONTORNI E LA SOSTANZA DEL PROBLEMA
L’attore sociale è il protagonista che vive ed opera ad un momento dato nella realtà fisica, psicologica, sociale e culturale. È
in grado non solo di conoscere ma anche di riflettere su se stesso e di prendere l’iniziativa nel contesto in cui è inserito.
L’attore sociale è quindi quella persona che:
- entra in contatto con la realtà;
- se la rappresenta;
- conosce;
- agisce in modi diversi su di essa;
- nello stesso tempo riflettendo su se stessa;
- rappresentandosi i cambiamenti provocati su di sé dall’incontro con la realtà, dalle rappresentazioni di essa, da come si
modifica, anche per il suo intervento.
1.1 . La centralità dell’Io e del Sé nell’esperienza umana
Fu il filosofo William James ad introdurre la nozione di Sé, che consiste nel fatto che il pensiero è continuamente mobile e
proiettato sul mondo degli oggetti (esterno), ma allo stesso tempo è sempre di qualcuno, fa parte di una coscienza
individuale.
All’interno del Sé bisogna distinguere due componenti:
1- l’Io, che coincide con il soggetto consapevole, capace di conoscere ed intraprendere iniziative nei confronti della realtà
esterna, oltre che di riflettere su di sé;
2- il Me è quanto del Sé è conosciuto dall’Io, cioè quello che vedo di me, percepisco di me, il modo in cui mi vedo:
include le caratteristiche materiali (il corpo così com’è percepito), quelle sociali (come il soggetto si vede nel rapporto
con gli altri) e quelle spirituali (il sapersi capace di pensare e riflettere su di sé).
Le relazioni sociali hanno un ruolo importantissimo nella definizione del Sé, e in particolare nella componente del Me
sociale, e nello sviluppo della conoscenza di sé e del sentimento della propria identità.
Infatti, la consapevolezza di sé ha origine da come gli altri ci percepiscono e dall’opinione che hanno di noi, cioè da quanto
di noi stessi vediamo riflesso dagli altri. È per questo che si parla di Sé rispecchiato (looking glass self).
Secondo Mead, il Sé non esiste alla nascita ma si sviluppa con il linguaggio che permette di dare un nome agli oggetti del
proprio ambiente e quindi anche a Sé, che può essere così definito e differenziato come oggetto fra gli altri.
Per Mead la mente è prodotta dall’interazione sociale, che permette di assumere i ruoli e la prospettiva altrui, guardando
così se stesso da quel punto di vista.
L’interazione fra l’Io e il Me (riflesso della società) produce il Sé in quanto non potrebbe esistere un’esperienza di sé
semplicemente fornita da se stesso, quindi implica sempre la presenza di un altro.
1.2. L’Io e il Sé nella prospettiva gestaltista
Il Sé nella concezione gestaltista è l’Io fenomenico, cioè la rappresentazione fenomenica (psichica) dell’Io reale, nei suoi
aspetti fisici e psicologici.
Il Sé non comprende tutto quanto è proprio dell’Io, che è invece precedente e più ampio del Sé.
È la stessa differenza tra come una persona è descritta dalle scienze fisiche o biologiche e come percepisce se stessa.
Il Sé è allo stesso tempo soggetto e oggetto dell’esperienza: infatti, quando si parla con se stessi, si elabora un Sé ideale,
corrispondente a come l’individuo vorrebbe essere agli occhi propri e del suo mondo.
Secondo la concezione gestaltista, l’individuo diviene persona e attore sociale solo nel contesto delle sue relazioni con gli
altri e con le realtà fisiche e isituzionali.
1.2 L’Io è il centro del mondo?
Secondo una tesi comportamentista, i bisogni a cui ogni organismo tenta di rispondere sono sempre riferiti all’organismo
stesso perciò ogni individuo è il centro di tutte le cose, percepisce, sente e pensa solo in riferimento ai propri individuali
interessi.
Al contrario, gli autori che si rifanno alla tradizione gestaltista, sostengono che l’Io non è il centro del mondo.
Infatti, in contrasto con una concezione egocentrica dell’agire, essi pensano che non tutte le esperienze che viviamo si
riferiscono a noi stessi, anzi, queste ne sono solo una parte.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Perciò le motivazioni ad agire non sono soltanto utilitaristiche poiché vi sono situazioni in cui non sembra che l’azione sia
motivata dalla previsione di ricompense o punizioni, come quando ci si preoccupa per un lavoro ce interessa altri o ci si
indigna di fronte ad una palese ingiustizia e si tenta di farla cessare.
Perciò la ricerca del piacere o l’evitamento del dolore non sono le sole motivazioni alla base dell’azione umana.
2. FORME MOLTEPLICI DI CONOSCENZA DEL SÉ
La scuola gestaltista insiste nel sostenere che l’Io è segregato fra i vari aspetti del campo percettivo; il Sé (o Io fenomenico)
mostra confini variabili.
Infatti vestiti, giocattoli, amici possono essere considerati prolungamenti del Sé che viene percepito parzialmente in quanto
noi riusciamo a vedere soltanto parti del nostro organismo.
Ulric Neisser, uno dei padri fondatori del cognitivismo, distingue 5 tipi di conoscenza di sé:
1- il Sé ecologico, che ha origine dalla percezione che ogni individuo ha delle parti che può vedere del proprio organismo
(compreso tutto ciò che si muove col corpo, il quale viene percepito come parte del Sé) fra gli altri oggetti dello spazio
percettivo e anche dal fatto di sentirsi agire, quindi di percepirsi come attore;compare molto precocemente (dai 3 mesi
di età) ma non dà luogo a una vera e propria consapevolezza di sé;
2- il Sé interpersonale, di cui ci si rende conto fin dalla prima infanzia, viene individuato in quanto coinvolto in
un’interazione con un’altra persona; la sua caratteristica fondamentale è l’intersoggettività, quindi l’interattività; la
consapevolezza del Sé interpersonale quasi sempre si accompagna a quella del Sé ecologico (tranne quando il contatto
interpersonale si fa intenso ed intimo, come fra amanti);
3- il Sé esteso è il Sé com’era nel passato e come ci aspettiamo che sarà nel futuro, è la consapevolezza dell’esistenza al di
fuori del momento presente, dunque è basato principalmente su quanto ricordiamo e quanto anticipiamo; non tutti i
ricordi però implicano il Sé esteso: si tratta della memoria procedurale (sapere come);
4- il Sé privato, che si manifesta quando il bambino si accorge che alcune sue esperienze (sentimenti come la gioia, il
dolore, la paura) non sono condivise con gli altri; è verso i 4 anni e mezzo che il bambino si rende conto che la sua vita
mentale è esclusivamente sua; inoltre, le esperienze private, potendo essere ricordate, vanno ad arricchire il Sé esteso;
5- il Sé concettuale o concetto di sé (è una teoria su se stessi), che ognuno ha come persona particolare in un mondo
familiare; ogni concetto di sé si forma nella vita sociale perciò in ogni società e cultura ci sono concetti di sé diversi; il
concetto di sé si basa prima di tutto su quanto è stato detto dagli altri e questo, a sua volta, tende guidare ciò che
ciascuno rivela di se stesso; il concetto di sé si compone di varie parti che riguardano il ruolo all’interno della società, il
corpo (bello o brutto) e la mente (intelligente o stupido); queste dimensioni sono assai importanti poiché ad esempio, la
credenza di un bambino sulla propria intelligenza può influenzare il suo rendimento scolastico; i quattro tipi di
conoscenza di Sé sono tutti rappresentati nel Sé concettuale.
Nonostante la presenza delle sue varie dimensioni, non si può parlare di molteplicità del Sé, bensì di unità poiché ci
sentiamo considerati dalla società come uno (e non più di uno), e questo costituisce un fattore essenziale del nostro
sentimento di identità.
L’origine dei vari Sé è dovuta proprio all’interazione con l’ambiente; inoltre, tutti i Sé sono caricati di valore.
È in rapporto a questa centralità cognitiva e di valore che il Sé ha per ogni individuo, il quale cerca di mantenere unite le
varie componenti di se stesso, che il Sé diviene il punto di riferimento a cui ogni esperienza viene ricondotta.
Neisser assegna al Sé concettuale la funzione di mettere in relazione il mondo interno dell’individuo e il mondo esterno.
3. LA PROSPETTIVA DELLA SOCIAL COGNITION
L’affermarsi della corrente della social cognition a partire dalla fine degli anni ’60 dà il via ad una serie di studi sul Sé
concepito come struttura cognitiva che organizza in memoria tutte le informazioni che compongono la rappresentazione
mentale che la persona ha dei propri attributi, dei propri ruoli, dell’esperienza passata e delle prospettive future.
Come Neisser, anche la social cognition riconosce l’esistenza di molteplici componenti del concetto di sé, si tratta di
concezioni parziali, attivate a seconda dei vari contesti in cui l’attore sociale è di volta in volta inserito. Esiste quindi un
rapporto fra contesto e concezioni di sé.
Secondo Markus, il concetto di sé è costituito da un insieme si schemi si sé, fine di recuperare rapidamente le informazioni
dalla memoria grazie alle quali identificare ciò che è e ciò che non è, nonché prevedere ed orientare il proprio
comportamento.
Gli schemi di sé variano profondamente da persona a persona, possono essere sia positivi che negativi e non sono facilmente
modificabili poiché collegati al sentimento d’identità.
Gli schemi di sé permettono di elaborare anche altre informazioni, in particolare quelle riferite ad altre persone: infatti, il
riferimento a sé ne migliora il ricordo.
Differenze fra conoscenza di sé e conoscenza degli altri:
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
-
gli schemi di sé sono più immediatamente accessibili in memoria (poiché utilizzati più spesso), più ricchi e complessi di
quelli degli altri (l’effetto però si attenua nel caso di persone e noi familiari);
la conoscenza di sé è memorizzata in forma verbale mentre quella degli altri prevalentemente in forma visuale (perché
l’esperienza che abbiamo degli altri è prima di tutto visiva, mentre la stessa cosa non è possibile per noi stessi);
la conoscenza di sé è più intensa dal punto di vista emotivo;
le informazioni su di sé vengono utilizzate per interpretare quelle sugli altri.
3.1. Il concetto di Sé operativo
I teorici della social cognition si sono occupati anche della funzioni regolatrici del Sé, cioè il modo in cui i soggetti
assumono il proprio Sé come riferimento principale per controllare e dirigere le proprie azioni.
Non tutta la conoscenza di sé è sempre accessibile: quello che è accessibile è uno specifico sottoinsieme che deriva dalle
caratteristiche della situazione contingente e costituisce il Sé operativo.
Si tratta in sintesi di quella parte del concetto di sé che è attivata in una situazione precisa: per questo, il Sé operativo è
sempre attivo e si modifica in base alla situazione.
3.2 Altri elementi della funzione regolatrice del Sé
Altre componenti del Sé che assumono una funzione regolatrice sono:
- il sentimento di efficacia del Sé, che riguarda l’aspettativa che ciascuno di noi ha di essere in grado di affrontare e
superare certi compiti; infatti, l’attore sociale si impegna soltanto se pensa di poterlo fare con successo; quanto più si
sentirà efficace in un ambito problematico, tanto più si sforzerà di farcela; in caso contrario abbandonerà ben presto
l’impegno considerando inutile ogni sforzo;
- la presentazione di sé e la gestione dell’impressione che si fa sugli altri; ciascuno di noi, infatti cerca di fare buona
impressione assumendo il comportamento appropriato alla situazione; per evitare di fare una cattiva impressione sugli
altri si può giungere persino a crearsi degli handicap: è la tattica del self-handicapping, attraverso la quale ci si crea un
alibi per l’insuccesso; inoltre, il comportamento in pubblico è orientato a fare una buona impressone anche su di sé, nel
senso che il soggetto, attraverso le interazioni sociali desidera confermare il sentimento positivo che ha di se stesso.
3.3. Sé possibili e discrepanze del Sé
Nel concetto di sé sono presenti anche concezioni ipotetiche di sé che il soggetto percepisce come realizzabili in futuro.
Alcune di queste immagini possono riguardare scopi e ruoli a cui il soggetto aspira o Sé potenziali che il soggetto vuole
evitare, perché ciascuno ha le proprie ansie, paure, angosce, ma anche attese, aspirazioni ed entusiasmi per il proprio futuro.
I Sé possibili rappresentano quindi le idee degli individui circa quello che possono o che vorrebbero o che temono di
diventare, e costituiscono delle guide e degli incentivi per l’azione.
In genere il contenuto dei Sé attesi è positivo, si parla quindi di un ottimismo irrealistico, cioè una distorsione sistematica di
giudizio che implica la tendenza di ogni persona a pensare che certi eventi negativi non accadranno proprio a lei: è dovuta al
bisogno di ridurre l’ansia del rischio e mantenere un buon livello di autostima grazie all’illusione di poter controllare gli
eventi.
Ovviamente, aver avuto in passato esperienze negative diminuisce il grado di ottimismo irrealistico.
Quest’ultimo è funzionale all’individuo, al quale permette di non rimanere paralizzato dalla paura del rischio, ma può anche
essere dannoso in quanto non ne permette una valutazione obiettiva.
Higgins individua le discrepanze del Sé dovute al fatto che ogni individuo ha una rappresentazione di come è (Sé reale), di
come gli piacerebbe essere (Sé ideale) e di come dovrebbe essere (Sé normativo).
Se la discrepanza fra Sé reale e Sé ideale o fra Sé reale e Sé normativo non sono risolte, il soggetto potrà provare senso di
insoddisfazione, tristezza, delusione o di agitazione (paura, irrequietezza, ansia) o addirittura di depressione (senso di
scoraggiamento e di incapacità).
4. IL SÉ NELLE CULTURE
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
La risposta alla domanda “chi sono io?” non viene formulata su base esclusivamente individuale in quanto lo sviluppo del
senso di sé è un processo non solo interpersonale, ma anche strettamente connesso alle idee condivise nei gruppi e nelle
culture circa cosa significhi essere una persona come si deve, appropriata e morale.
Le rappresentazioni sociali del Sé sono quindi quell’insieme di caratteristiche che in una data cultura sono ritenute
appropriate, positive e morali, e che forniscono una struttura primaria per il Sé di coloro che vivono in un determinato
contesto.
Si differenziano a seconda che si tratti di culture individualiste (prevalentemente occidentali) o collettiviste (per lo più
quelle orientali).
Nelle culture individualiste il Sé è l’unità di base della società, che è vista come un insieme di individui autonomi e
indipendenti. Il principale compito di sviluppo individuale è la realizzazione personale, e in quest’ottica l’identità si
costruisce attraverso l’elaborazione della propria differenza e unicità. Inoltre, si tende ad attribuire le cause degli eventi
all’attore piuttosto che alle circostanze.
Al contrario, le culture collettiviste pongono il gruppo come unità di base della società, che è vista come un insieme di
gruppi sociali. Il compito di sviluppo dell’individuo è quindi quello di raggiungere l’armonia con gli altri appartenenti al
gruppo, oltre a rispettare le norme e i doveri per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del successo collettivo.
Perciò, a seconda del tipo di cultura, i giudizi su di sé e sugli altri sono formulati in riferimento a diversi standard:
- per le culture individualiste è il raggiungimento del successo personale, quindi esse tendono a valorizzare caratteristiche
come l’intelligenza e la competenza personale; le culture individualiste sono per lo più centrate sull’idea
dell’indipendenza e dell’autonomia (la timidezza viene vista come un handicap);
- per le culture collettiviste è l’appartenenza ad un determinato gruppo (o famiglia) e il posto che questo occupa nel
tessuto sociale, cosicché queste valorizzano maggiormente la costanza, la persistenza nel compito, lo sforzo; le culture
collettiviste sono più protese verso interdipendenza (è la solitudine ad essere vissuta come un handicap).
Perciò, nella società occidentale, una persona che raggiunge un obiettivo facilmente viene giudicata meglio di una che
raggiunge lo stesso con impegno e fatica; il contrario accade invece nelle società collettiviste, nelle quali la distinzione più
importante è quella fra ingroups e outgroups (nelle società individualiste è quella fra Sé e non Sé), che si accompagna ad un
atteggiamento di sospetto ed ostilità a priori nei confronti dei secondi.
Nel passaggio da una cultura ad un’altra si incontrano molte difficoltà in quanto c’è l’esigenza di riconcettualizzare il senso
di sé in relazione a nuove domande.
5. L’IDENTITÀ COME QUALITÀ RELAZIONALE E TEMPORALE DEL SÉ
L’identità è fatta di componenti individuali e collettive, cioè da quanto è personale e quanto deriva da una cultura condivisa.
La diffusione del Sé è l’incapacità dell’individuo di impegnarsi in un ruolo preciso.
Infatti, Marcia sostiene che gli stati dell’identità sono 4:
1- acquisizione dell’identità (assunzione di un impegno in base ad un ruolo sociale dopo l’esplorazione delle possibili
alternative);
2- blocco dell’identità (i ruoli e i valori sono stati adottati evitando la fase di incertezza esplorativa e assumendo quelli
ispirati dalle figure di identificazione infantile: è ciò che accade spesso ai figli di professionisti);
3- moratoria dell’identità (sforzo di esplorazione che però non conduce all’assunzione di un impegno preciso verso la
realtà);
4- diffusione dell’identità (evitare lo sforzo di esplorazione e vagare da un’identificazione momentanea all’altra senza
sviluppare alcun vero interesse).
5.1. Sentimento di identità e identità tipizzate
Il sentimento di identità è l’esperienza che l’attore sociale vive circa la continuità nel tempo e nello spazio del proprio Sé,
nonché la propria possibilità di intervenire sull’ambiente e sugli avvenimenti.
Il sentimento di identità, quindi non equivale all’identità tipizzata, cioè quella che corrisponde alla sua immagine pubblica
ed è il prodotto di una specifica struttura sociale: infatti, un americano ha un’identità diversa da quella di un francese, ecc.
I tipi di identità, quindi, delineano degli stereotipi che semplificano e facilitano la conoscenza e la spiegazione degli eventi
sociali e sono dovuti; inoltre, l’attore conosce quasi sempre come è definito socialmente e utilizza tale informazione come
uno dei componenti del proprio sentimento di identità.
L’identità sociale è quindi quella data dall’interdipendenza con gli altri membri del suo gruppo, mentre l’identità personale è
caratterizzata dall’esigenza di autonomia, di fedeltà a se stesso, di indipendenza dal contesto.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
PARTE SECONDA – INTERAZIONI SOCIALI
CAPITOLO 5 – LE RELAZIONI SOCIALI
Le interazioni sociali danno origine a strutture di relazioni che si caratterizzano per diversa:
- rilevanza;
- stabilità;
- per un diverso grado di soddisfazione che gli individui ricavano da esse.
1. LE RELAZIONI SIGNIFICATIVE
Il modo in cui l’individuo si rappresenta gli altri è centrale per capire il suo comportamento nel mondo sociale.
Dalla formazione delle impressioni si giunge alla rappresentazione degli altri, in special modo gli altri significativi (non
estranei ma persone che intrattengono relazioni vitali con l’attore sociale).
Per Lewin le relazioni non possono essere studiate a partire dagli individui che le intrattengono, ma dall’interazione fra le
proprietà dei partner e quelle della situazione (ambiente fisico e sociale). Questi formano un sistema interdipendente nel
quale un cambiamento si riflette su tutte le parti del sistema.
L’ambito di studio delle relazioni affettive è attualmente governato da due prospettive teoriche apparentemente diverse ma
che in realtà possono essere viste in maniera integrata:
1- la prospettiva derivante dalla teoria dell’interdipendenza, che considera l’interdipendenza come la caratteristica
fondamentale di ogni relazione sociale;
2- l’approccio cognitivo alle relazione, che pone l’accento sugli schemi di relazione e sugli script di relazione (nelle
relazioni significative vengono attivati in maniera automatica, non richiedono un’elaborazione consapevole delle
informazioni disponibili di volta in volta).
1.2. Tipologia delle relazioni
Kelley propone una definizione di relazione significativa affermando che una relazione è tale se si basa su una forte
interdipendenza fra i partner (influenzano i comportamenti reciproci) non solo in qualche ambito ma in molti contesti e per
lungo tempo.
Le scale di rilevazione dei sentimenti mettere a punto scale con l’obiettivo di quantificare i diversi tipi di sentimenti.
Uno dei primi tentativi in questo senso è stato quello di Rubin il quale ha messo a punto due scale:
1- la Liking scale, che si propone di cogliere il grado di piacevolezza attribuito al partner, in termini di affetto e rispetto;
2- la Love scale, che intende mettere in luce tre aspetti: l’attaccamento, il prendersi cura e l’intimità.
Una delle classificazioni che ha conosciuto maggiore considerazione è quella chiamata Triangolo dell’amore, formato da tre
componenti:
1- intimità (implica la comprensione reciproca, la complicità e il sostegno emotivo);
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
2- passione (comprende l’attrazione fisica, il desiderio sessuale, la sensazione di essere innamorati);
3- livello di impegno/decisione nei riguardi del partner.
Queste tre componenti entrano in varia misura nei vari tipi di relazioni, combinandosi dando origine a 7 classi di sentimenti:
1- attrazione;
2- infatuazione;
3- amore abitudinario;
4- amore romantico;
5- amicizia profonda;
6- amore fatuo;
7- amore completo.
Gli stili di relazione sono il prodotto del tipo di legame di attaccamento che i bambini formano con gli adulti (in primo
luogo con i genitori).
1.2. La formazione delle relazioni
I fattori che favoriscono la nascita delle relazioni (in quanto portano all’interazione fra persone) vanno individuati fra le
caratteristiche fisiche e sociali dell’ambiente in cui si trovano le persone, e sono:
- la prossimità: non si tratta banalmente di un problema di distanza fisica, quanto piuttosto di distanza funzionale, cioè di
probabilità di avere contatti.
La prossimità fisica agisce anche attraverso l’aumento della familiarità dei potenziali partner: infatti, un atteggiamento
positivo può essere generato anche grazie alla semplice esposizione ripetuta allo stimolo;
- la percezione di somiglianza, considerato il fattore principale di attrazione (somiglianza di opinioni, non di personalità,
che minaccia il senso di unicità dell’individuo!);
- l’aspetto fisico, secondo lo stereotipo che associa la bellezza ad altre qualità positive;
- la rivelazione di sé, cioè l’apertura all’altro (self-disclosure): infatti, non solo le persone tendono ad aprirsi maggiormente
con coloro dai quali sono più attratte, ma questa apertura viene anche recepita dall’altro come segno di apprezzamento.
1.3. Stabilità e soddisfazione nelle relazioni
Fattori che rendono una relazione soddisfacente e stabile
Riguardo alla soddisfazione, la teoria dello scambio di Homans formula un principio applicabile a qualsiasi tipo di relazione
sociale: un individuo rimane in una relazione finché il partner gli assicura il massimo dei benefici al minimo costo (si tratta
di un modello economico del comportamento umano). Finché è soddisfatto rimane nella relazione, altrimenti ne esce.
Tre fattori influenzano la percezione di soddisfazione:
- i profitti (materiali e simbolici), che derivano dalla sottrazione dei costi (tutto ciò che nella relazione o nel partner viene
valutato negativamente) ai benefici oppure dal confronto con uno standard (frutto di norme sociali e aspettative personali)
o dal livello di autostima;
- le alternative possibili alla relazione;
- gli investimenti in termini di tempo, sforzo e risorse posti sulla relazione stessa (amici, patrimonio, progetti).
Le critiche fatte alla teoria dello scambio si riferiscono soprattutto al fatto che un principio economico venga applicato ad un
fenomeno così complesso come il mantenimento di una relazione fra persone.
La considerazione del ruolo dell’equità fra i benefici propri ed altrui deriva da uno sviluppo della teoria dello scambio e
afferma che un individuo valuta soddisfacente una relazione se ricava benefici (di natura simbolica oltre che materiale) pari
ai costi che essa comporta: infatti, se in una relazione uno dei due membri riceve più di quanto offre, la stabilità è
fortemente a rischio.
Il principio dello scambio si applica solo alle relazioni di scambio (di lavoro e fra estranei), mentre nelle relazioni di
condivisione (quelle intime) prevale l’interesse per il benessere dell’altro (il prototipo è quello della relazione madre-figlio).
Inoltre, il principio dell’equità è tipico delle società individualiste (quelle occidentali) mentre spesso non vale per le società
collettiviste (orientali).
Queste teorie, per di più, sottovalutano il ruolo delle abitudini consolidate, la resistenza al cambiamento, il senso di
incertezza riguardo al futuro e le pressioni sociali e culturali a mantenere relazioni di coppia anche quando queste diventano
svantaggiose.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
1.4. Influenze culturali
La dicotomia individualismo/collettivismo è stata individuata da Hofstede e individua il modo di concepire le relazioni
come uno dei criteri fondamentali di differenza fra culture.
Le culture individualiste sono caratterizzate dal fatto che riconoscono una forte importanza all’indipendenza e alla
realizzazione personale, mentre quelle collettiviste danno maggior importanza all’interdipendenza fra le persone e
considerano le esigenze del gruppo più importanti di quelle del singolo.
Le relazioni in diversi contesti culturali:
-
-
CULTURE INDIVIDUALISTE
la scelta del partner è tesa al
soddisfacimento dei bisogni personali dei
membri della coppia;
l’amore romantico è visto come prerequisito
necessario e sufficiente per la formazione di
una coppia.
CULTURE COLLETTIVISTE
- tale scelta è effettuata dalla famiglia in relazione
alle proprie esigenze.
Nella realtà queste differenze sono un po’ attenuate; inoltre, anche in Europa fino al 1700 i matrimoni erano celebrati sulla
base di criteri di opportunità sociale e politica.
2. LA COMUNICAZIONE
I fenomeni sociali si originano nel corso delle interazioni comunicative fra le persone, nei gruppi. Le rappresentazioni
sociali, la reputazione, gli stereotipi e i pregiudizi sono solo i prodotti più evidenti di questo lavoro di costruzione sociale
della realtà in riferimento alla quale le persone si muovono.
Tutta la vita pubblica, le istituzioni democratiche e i sistemi economici prendono vita negli scambi comunicativi.
La comunicazione è un processo dinamico e circolare che richiede la condivisione di codici astratti (il linguaggio e i
significati dei segnali non verbali): non si tratta di un comportamento intenzionale in quanto non si può non comunicare,
dato che in una interazione ogni comportamento veicola un qualche genere di informazione che produce conseguenze sui
comportamenti successivi.
2.1. La struttura e le funzioni della comunicazione
L’idea che si possa parlare di comunicazione come di un processo che lega alcuni elementi strutturali ci viene da Aristotele,
mentre Shannon e Weaver propongono un modello di comunicazione che ha conosciuto un forte diffusione grazie
all’introduzione dell’idea di rumore, l’elemento che impedisce una perfetta simmetria fra il processo di codifica da parte
dell’emittente e quello di decodifica da parte del ricevente.
Infatti, nella comunicazione, una fonte traduce il suo pensiero in un codice che lo rende messaggio veicolato da un canale
verso il ricevente il quale ritraduce il codice in pensiero.
Oltre al rumore di tipo fisico, c’è anche il rumore psicologico, cioè quegli stati mentali, sentimenti e pensieri che
interferiscono con l’attività di decodifica, oltre al fatto che i parlanti possono fare riferimento a mondi simbolici diversi (per
capirsi non è sufficiente esprimersi con lo stesso linguaggio) e frutto delle specifiche esperienze personali.
Il modello delle categorie linguistiche considera il linguaggio (sistema verbale e sistema non verbale) come mediatore fra
cognizione e realtà sociale, uno strumento per trasformare la realtà veicolando significato.
I sistemi della comunicazione verbale sono:
- fonemi;
- morfemi;
- parole;
- frasi, ecc.
I sistemi della comunicazione non verbale sono:
- segnali paralinguistici (intonazione, volume di voce, vocalizzazioni per la regolazione dell’avvicendarsi dei turni di
parola);
- le espressioni del volto (tra cui il contatto visivo, cioè gli sguardi), che forniscono anche informazioni sull’attività de
decodifica del messaggio da parte dell’ascoltatore;
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
- il comportamento spaziale [posizione del corpo, gesti, la distanza e il contatto fisico fra i parlanti (per il quale vanno
distinte le culture da contatto dalle culture di non contatto)].
Le espressioni non verbali variano da persona a persona ma soprattutto da cultura a cultura percui questi aspetti acquistano
una particolare importanza nel caso in cui una persona si trovo in un ambiente diverso dal proprio.
3. LA COMUNICAZIONE COOPERATIVA
Partecipare ad una conversazione comporta un’azione cooperativa nella quale gli attori sociali riconoscono almeno uno
scopo comune o un insieme di scopi comuni.
La conversazione come azione sociale di tipo cooperativo è governata da regole implicitamente riconosciute dai
partecipanti. Se uno degli interlocutore viola una di queste massime può venir meno il principio di cooperazione e può
quindi esserci l’interruzione dello scambio.
Secondo il modello del contratto di comunicazione, ogni interazione comunicativa può essere pensata come una situazione
in cui gli interlocutori stabiliscono implicitamente un contratto fondato su un certo numero di regole. Si tratta dell’insieme
di diritti e doveri di ciascuno, degli obblighi di natura sociale ai quali gli interlocutori sono vincolati.
La comunicazione è quindi un’attività congiunta e coordinata che presuppone lo sviluppo da parte dei potenziali
interlocutori di una certa competenza comunicativa, cioè di quelle capacità che rendono la partecipazione dell’individuo
all’interazione comunicativa efficace ed appropriata al contesto in cui avviene.
Oltre alle abilità di linguaggio, c’è bisogno di altre abilità più propriamente sociali (dato che esprimersi è in primo luogo
un’attività sociale), come:
- la competenza performativa (saper usare il linguaggio per agire nel proprio ambiente fisico e sociale);
- saper riconoscere le norme specifiche al contesto che regolano le espressioni verbali e non verbali;
- saper riconoscere le regole che governano l’interazione (presa di parola, aspettative di ruolo) ne contesto;
- saper influenzare l’interlocutore.
CAPITOLO 6 – L’AGGRESSIVITÀ E L’ALTRUISMO
I comportamenti aggressivi e violenti possono essere spiegati non solo sulla base delle inclinazioni caratteriali degli
individui, ma anche del modo in cui questi interpretano le situazioni contingenti, delle caratteristiche dei legami sociali,
delle norme e aspettative che caratterizzano le culture.
1. GLI ESSERI UMANI SONO “NATURALMENTE” BUONI O CATTIVI?
Per Hobbes, le persone sarebbero inclini all’aggressività verso i propri simili, quindi necessitano di istituzioni sociali in
grado di reprimere le tendenze antisociali in funzione delle esigenze della convivenza civile.
Al contrario, Rousseau sostiene la concezione di una natura fondamentalmente buona, corrotta proprio dalle esigenze della
civiltà.
Secondo Freud, invece, l’aggressività umana è inevitabile e frutto della tensione fra due istinti primari, quello di
autoconservazione (Eros) e quello di autodistruzione (Thanatos), che emana un’energia distruttiva che dev’essere indirizzata
verso l’esterno, ad esempio attraverso il comportamento aggressivo.
L’approccio etologico condivide con quello freudiano l’idea della naturalità dell’aggressività umana, in quanto funzionale
alla conservazione della specie.
Perciò dovrebbe essere la società ad indirizzare le energie negative dei singoli verso forme di scaricamento socialmente
accettabili (come le competizioni sportive) anche se non sempre dare la possibilità di manifestare comportamenti aggressivi
diminuisce la carica di aggressività.
E anzi, essere esposti a comportamenti violenti aumenta la probabilità di una risposta di tipo aggressivo da parte
dell’individuo.
2. I LIVELLI DI SPIEGAZIONE DEL COMPORTAMENTO ANTISOCIALE
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
2.1. La frustrazione
La frustrazione può essere la causa di un comportamento aggressivo, cioè quando degli ostacoli si frappongono fra
l’individuo e il raggiungimento dei suoi fini. Tuttavia, l’aggressività può anche non essere rivolta alla causa della
frustrazione, in quanto nel corso dell’esperienza impariamo ad associare un determinato comportamento ad una
conseguenza (ricompensa o punizione).
In questo caso, l’azione aggressiva non è vista come il prodotto di un istinto innato ma è pur sempre una modalità di
scaricare pulsioni negative prodotte dalla frustrazione.
Le critiche all’approccio frustrazione-aggressività si appoggia sul fatto che ci sono casi in cui la frustrazione trova sfogo in
forme di risposta non aggressive, come il pianto, la fuga, l’apatia.
Perciò Berkowitz propone la teoria dell’apprendimento sociale, secondo la quale ogni sentimento negativo può produrre
aggressività, ma questa diventa la risposta dominante solo a determinate condizioni.
2.2. L’imitazione
All’inizio del ‘900 la psicologia delle folle introduce l’idea che l’aggressività prenda il via dall’imitazione, all’interno di
vasti gruppi sociali: infatti, la situazione collettiva, inibirebbe le capacità critiche individuali percui le persone sarebbero
facilmente manipolabili da qualcuno dotato di particolare carisma e prestigio.
Secondo la teoria dell’apprendimento sociale (formulata negli anni ‘60) l’aggressività sarebbe un comportamento sociale
come gli altri, che viene acquisito e mantenuto a determinate condizioni.
Le condizioni per l’apprendimento di comportamenti aggressivi sono:
- l’esperienza diretta;
- l’osservazione di qualcuno che attua un comportamento in una determinata situazione e delle conseguenze che ne
ricava (in quanto una delle principali fonti di informazioni su ciò che è appropriato oppure no in una situazione poco
o per nulla familiare).
C’è sicuramente una relazione fra programmi televisivi a contenuto violento e livello di aggressività manifesto però non si
sa se sono le persone violente a preferire quel tipo di programmi oppure sono i programmi violenti a causare comportamenti
imitativi.
2.3. Le norme sociali
Comportamenti degli attori sociali inspiegabili sulla base della personalità o in termini di frustrazione possono essere dovuti
a pressioni situazionali e a condizioni del contesto: infatti, in ogni cultura sono presenti varie norme sociali che hanno lo
scopo di definire qual è il comportamento appropriato in determinate situazioni, ma non tutte sono orientate alla limitazione
dell’aggressività. Per esempio, la norma del machismo prevede la necessità di una reazione aggressiva come autodifesa e
ripristino dei diritti individuali violati.
Inoltre, se si considera che comportarsi in maniera appropriata è una condizione necessaria per essere accettati dal gruppo, si
possono meglio comprendere fenomeno collettivi distruttivi di ampie dimensioni.
3. LA DINAMICA DEL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO
Sono molti i fattori che concorrono a far variare la probabilità che una persona in una data circostanza agisca in modo
aggressivo verso qualcun altro.
Il processo che lo porta a fare questo è stato sintetizzato in uno schema la cui prima fase è la definizione dell’evento, cioè
l’interpretazione che l’attore dà della situazione in cui si trova e dell’evento. In questa fase, un ruolo importantissimo è
giocato dall’attribuzione di intenzionalità di ciò che sta avvenendo. La scelta della risposta che viene attuata è influenzata
anche dalla percezione delle conseguenze, dal livello di attivazione emotiva negativa provocato e dalle norme che sembrano
pertinenti al contesto.
Da questi fattori derivano la motivazione ad adottare una risposta aggressiva o neutra e la percezione della necessità di una
risposta, che a loro volta influenzano la decisione finale circa il comportamento da mettere in atto.
4. LIVELLI DI SPIEGAZIONE DEI COMPORTAMENTI PROSOCIALI
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
4.1. L’altruismo è una caratteristica individuale?
Forse secondo l’opinione pubblica l’essere umano sarebbe egoista e distruttivo soltanto per ragioni di autosalvaguardia, così
spesso si sottovaluta il ruolo dei fattori sociali e situazionali nella determinazione dei comportamenti di questo tipo.
L’interesse per lo studio dell’altruismo, invece, è molto più recente e parte dall’ipotesi che la probabilità di attuazione di
comportamenti altruistici sia governata non solo da fattori sociali (presenza o mancanza di valori) o individuali (come la
tendenza personale all’aiuto o alla violenza), ma anche da fattori relativi alla situazione.
Nel caso in cui, in una situazione di emergenza non si attui un comportamento altruistico, una spiegazione (alternativa a
quella che chiama in causa il disinteresse delle persone per la sofferenza altrui) può essere data facendo ricorso alla
diffusione di responsabilità, cioè le persone pensano che qualcun altro abbia già provveduto al soccorso.
Al contrario, quando il soggetto sa di essere l’unica possibilità della vittima di ricevere aiuto, nella grande maggioranza dei
casi, interviene.
Così come alcuni etologi hanno sostenuto che l’aggressività è funzionale alla conservazione della specie, altri hanno messo
in evidenza che i comportamenti prosociali servono allo stesso scopo (basti pensare alle formiche e alle api, specie nelle
quali gli individui sterili spendono la loro vita nell’aiuto e nella protezione di quelli fecondi, oppure agli animali che,
avvistando un pericolo, emettono segnali per allertare gli altri individui della stessa specie), cioè alla sopravvivenza degli
individui della stessa famiglia.
Questa osservazione però non è sufficiente a spiegare i comportamenti altruistici che gli umani attuano a favore di persone
non consanguinee.
Si potrebbe quindi pensare che l’altruismo sia una dimensione della personalità, anche se in questo caso il fattore più
importante sarebbe la percezione della propria efficacia (la credenza di essere in grado di agire positivamente nelle
situazioni) ma in realtà questa non è sufficiente a prevedere la messa in atto di comportamenti altruistici.
4.2. Il ruolo dell’empatia
L’empatia è un’attivazione emotiva fatta di compassione, tenerezza, simpatia, da parte di una persona che osservi un’altra in
difficoltà, grazie al fatto che l’osservatore assume la prospettiva della persona in difficoltà e prova uno stato emotivo simile
al suo. È questa capacità a rendere probabile un intervento di aiuto.
Quindi la percezione di somiglianza, o anche di appartenenza allo stesso gruppo, favorisce l’assunzione della prospettiva
altrui e quindi l’insorgere dell’empatia.
Infatti, le persone sono più disposte ad aiutare qualcuno che percepiscono simile a sé o che appartiene allo stesso gruppo.
Emozioni legate all’esperienza di empatia sono il disagio personale e la reale preoccupazione per la sorte dell’altra persona:
entrambe possono motivare l’individuo ad agire, ma lo stato d’animo negativo può essere rimosso anche attraverso la fuga o
l’evitamento della situazione. Quando l’evitamento non è possibile, l’aiuto può anche non essere il frutto di puro altruismo
ma essere motivato dalla necessità di rimuovere il disagio personale. È questa la cosiddetta ipotesi del sollievo dallo stato
negativo, la quale mette in evidenza che i rapporti prosociali derivano da una motivazione fondamentalmente egoistica: il
desiderio di rimuovere l’angoscia che provoca la vista della sofferenza altrui. È per questo che gli individui non
intervengono quando la situazione permette vie di fuga, per esempio nel caso in cui gli osservatori siano numerosi
(diffusione di responsabilità).
Anche in situazioni in cui la fuga è possibile ci sono individui che scelgono di prestare il proprio aiuto, e sono i casi in cui il
reale interesse per la sorte dell’altro prevale ed è il prodotto della capacità empatica vera e propria.
Infatti, secondo il modello dell’empatia-altruismo, la preoccupazione per le sofferenze altrui è una motivazione sufficiente
per spiegare comportamenti prosociali.
Recentemente è stata ripresa la concezione dell’essere umano come fondamentalmente egoista, cercando di dimostrare che
il fattore motivante non è tanto l’empatia e il genuino interesse per la sorte altrui, quanto il senso di unità interpersonale,
cioè il fatto che, per la percezione di somiglianza, il Sé non è distinto dall’altro, quindi aiutare l’altro ha ripercussioni
positive anche per il Sé.
4.3. Le norme sociali
Per la convivenza civile sono necessarie alcune norme che prescrivono aiuto e solidarietà verso chi si trovi in difficoltà e
che sono apprese nel corso del processo di socializzazione, attraverso il quale l’individuo impara a riconoscere e distinguere
quali sono i comportamenti socialmente adeguati ai vari contesti.
Nelle relazioni interpersonali, quindi, una delle norme principali è quella di reciprocità, secondo la quale bisogna restituire
l’aiuto a chi lo ha offerto in passato o potrà farlo in futuro. Questa norma ha carattere universale, nel senso che in tutte le
società umane è uno dei criteri fondanti della moralità e della vita collettiva.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Questo perché si tratta di una norma evolutivamente vincente poiché gli individui incondizionatamente altruisti sono
destinati a soccombere a favore di individui incondizionatamente egoisti che ugualmente non potranno sopravvive una volta
rimasti senza i primi.
Un’altra norma è quella della responsabilità sociale, secondo la quale ci sentiamo in obbligo di agire in favore di chi dipende
da noi. Questa regola vige innanzitutto nella famiglia: i membri che non sono in grado di prendersi cura del proprio
benessere (bambini, anziani, malati) sono accuditi e assistiti. Ma lo stesso obbligo può essere sentito, in generale, nei
confronti dei membri deboli della società (i poveri).
Una norma che, al contrario, prescrive di non intervenire è la norma di protezione della privacy familiare: basta che
l’osservatore interpreti un litigio come un conflitto fra coniugi o fidanzati per rendere l’intervento poco probabile.
Secondo Moscovici Tre forme di altruismo:
1- altruismo partecipativo, cioè i comportamenti che favoriscono la vita collettiva dei membri di una stessa comunità
(famiglia, Chiesa, Patria), come il volontariato, i cui benefici si riflettono sull’intera collettività;
2- altruismo fiduciario, è il sacrificio finalizzato a stabilire un legame di fiducia e confidenza con l’altro, ad esempio
nelle relazioni di vicinato;
3- altruismo normativo, basato sul principio di responsabilità e solidarietà, è quello garantito dalle istituzioni che
ricoprono in modo esplicito la funzione di aiutare le persone in difficoltà, attraverso la cassa integrazione, la
pensione sociale, il sussidio di disoccupazione.
5. LA DINAMICA DEL COMPORTAMENTO ALTRUISTICO
Le fasi del processo che porta al comportamento altruistico iniziano con la definizione dell’evento che ovviamente presenta
un margine più o meno ampio di ambiguità, quindi svolge un ruolo molto importante il modo in cui l’osservatore si
rappresenta una persona come bisognosa di aiuto.
Questa è strettamente connessa con le attribuzioni di causa: infatti, a parità di azione richiesta per aiutare, le persone sono
più disponibili ad attuarla se attribuiscono la causa della situazione di bisogno a fattori non controllabili dalla vittima.
Questo avviene perché le persone desiderano impegnarsi nell’aiuto solo se lo si merita.
Però possono verificarsi distorsioni nella formulazione delle attribuzioni causali: uno di questi è l’errore fondamentale di
attribuzione, cioè la tendenza diffusa a sopravvalutare le cause interne nella spiegazione dei comportamenti altrui.
A questa distorsione si aggiunge la credenza in un mondo giusto: si tende a pensare che gli eventi negativi succedano agli
altri perché in qualche modo se li sono meritati, il che rende meno probabile l’attuazione di comportamenti d’aiuto.
Mentre offrire il proprio aiuto aumenta la stima di sé, riceverlo genera un senso di debolezza e inferiorità: per questo colui il
quale riceve aiuto può tendere a sottostimare l’intervento altrui. Se poi il fatto di ricevere aiuto viene percepito come una
minaccia al Sé, il beneficiato può reagire negativamente verso colui che è intervenuto.
Quindi la definizione dell’evento che si sta osservando è un fattore fondamentale nell’attivazione dell’intero processo che
porterà o meno all’intervento di aiuto.
Inoltre, di fronte ad un evento ambiguo le persone osservano il comportamento di eventuali altre persone che stanno
assistendo alla stessa scena per darne una corretta interpretazione, senza considerare che anche gli altri fanno lo stesso. È
l’effetto chiamato ignoranza pluralistica: ciascuno pensa che gli altri abbiano più informazioni di loro sulla situazione e
questo porta ad un’alta probabilità di inazione.
Una volta definito un evento come un’emergenza, prima di decidere se intervenire o meno si ha una fase di valutazione del
costo attribuito all’aiuto, influenzato da fattori relativi al contesto specifico, dall’empatia, dalle norme sociali e dalle
tendenze di personalità.
PARTE TERZA – PROCESSI COLLETTIVI
CAPITOLO 7 – L’INTERAZIONE NEI GRUPPI
Il gruppo è un’entità psicologica formata non dalla somma dei suoi componenti ma dalle relazioni dinamiche fra di essi.
1. KURT LEWIN E LO STUDIO DEI FENOMENI DI GRUPPO IN PSICOLOGIA SOCIALE
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
La definizione del concetto di gruppo continua ad essere difficile perché viene utilizzato da diverse discipline nell’ambito
delle scienze sociali.
Il concetto di gruppo in sociologia si distingue da quello di:
- aggregato (insieme di individui che si trovano nello stesso luogo allo stesso momento senza condividere alcun preciso
legame);
- categoria sociale (raggruppamento statistico, insieme di individui classificati nella stessa categoria in base ad una
particolare caratteristica comune che non interagiscono fra loro, né si ritrovano insieme nello stesso luogo).
Infatti, un gruppo sociale è costituito da un certo numero di individui che interagiscono l’uno con l’altro con regolarità: si
tratta quindi di una distinta unità con una propria complessiva identità sociale.
I membri di un gruppo si aspettano determinate forme di comportamento l’uno dall’altro, non sono richieste invece ai non
appartenenti.
Riguardo alle dimensioni, i gruppi vanno dalle associazioni intime (famiglia) alle collettività più ampie (circolo sportivo).
In sociologia è ancora ampiamente utilizzata (nonostante troppo schematica) la distinzione fra:
- gruppi primari, insiemi di persone che interagiscono direttamente e sono legate da vincoli di natura emotiva;
- gruppi secondari, formati da persone che hanno rapporti più o meno frequenti ma di tipo prevalentemente impersonale, in
quanto determinati principalmente da scopi pratici.
Incontri ripetuti di un gruppo secondario possono ovviamente creare legami fra i suoi membri trasformandolo in un gruppo
primario.
Secondo la prospettiva sociopsicologica di Lewin, ogni gruppo è una totalità dinamica diversa dalla somma delle sue parti in
quanto si basa sull’interdipendenza (e non sulla somiglianza) dei suoi membri, che condividono uno scopo ed hanno delle
attese in comune.
Lo stesso Lewin introduce la nozione di destino comune come espressione dell’interdipendenza tra individui.
Per Lewin i processi che governano la vita dei gruppi, anche molto grandi, possono essere studiati e compresi attraverso lo
studio di gruppi di piccole dimensioni.
La prima generazione di allievi di Lewin, dopo la sua morte, realizzò delle ricerche sulla dinamica di gruppo nel Research
Center for Groups Dynamics.
2. I TEMI CLASSICI DELLA DINAMICA DI GRUPPO
Gli argomenti più importanti concernenti la vita dei gruppi sono stati individuati e studiati prevalentemente dalla prima
generazione degli allievi di Lewin.
2.1. Il sistema di status
Lo status è la posizione che una persona occupa in un gruppo sociale e la valutazione di tale posizione in una scala di
prestigio.
Gli indicatori dello status sono 2:
1- la tendenza da parte di chi occupa uno status elevato a promuovere iniziative (proporre idee ed attività) che vengono poi
continuate dal gruppo;
2- una valutazione consensuale del prestigio connesso ad un certo status.
Nei gruppi, anche in quelli informali di adolescenti, le differenze di status formano una gerarchia.
Le differenze di status possono essere colte anche osservando il comportamento non verbale; infatti, coloro che occupano
uno status elevato tendono a:
- avere più degli altri una postura eretta;
- parlare con voce ferma;
- mantenere il contatto visivo.
Riguardo al comportamento verbale, invece:
- parlano più delle altre;
- più probabilmente esprimono critiche, comandi;
- interrompono gli altri;
- ricevono un maggior numero di comunicazioni da parte degli altri membri del gruppo.
Studi simili degli anni ’50 portarono agli stessi risultati.
Ovviamente, la gerarchia di status all’interno di un gruppo non è immutabile.
Un sistema di status si produce rapidamente, già poco tempo dopo che il gruppo si è formato; le principali spiegazioni a ciò
sono 2:
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
1- gli stati d’aspettativa basati sulle caratteristiche personali reciprocamente esibite che rendono possibile attribuire le varie
posizioni ai membri del gruppo (già dai primi incontri!) soprattutto in relazione al possibile contributo di ognuno al
raggiungimento degli obiettivi di gruppo;
2- una spiegazione etologica, la quale afferma che fin dai primi approcci i membri del gruppo valutino la forza di ciascuno
a partire da caratteristiche personali esteriori come la statura, la muscolatura, l’espressione facciale.
Le differenziazioni di status nei gruppi esistono per soddisfare un bisogno di necessità e di ordine.
2.2.
Il ruolo
Il ruolo è quell’insieme di aspettative condivise circa il modo in cui dovrebbe comportarsi un individuo che occupa una
determinata posizione nel gruppo.
I ruoli permettono che la vita di un gruppo sia più prevedibile e quindi più ordinata; inoltre essi sono funzionali al
conseguimento degli scopi di gruppo poiché implicano una divisione del lavoro al suo interno.
I ruoli principali in un gruppo sono:
- il leader;
- il nuovo arrivato;
- il capro espiatorio, funzionale alla vita del gruppo poiché permette ai suoi membri di liberarsi di parti negative della
propria immagine di sé proiettandole su chi detiene tale ruolo.
Vari conflitti sono connessi alle differenziazioni di ruolo nei piccoli gruppi: per esempio quelli relativi all’assegnazione di
un determinato ruolo ad una certa persona.
L’insorgere di conflitti di ruolo all’interno di un gruppo di lavoro non comporta solo un aumento della tensione fra i
membri, ma anche una diminuzione della produttività.
Uno dei modi per risolvere tali conflitti può essere quello della transizione di ruolo, anche se il passaggio da un ruolo
all’altro può essere a sua volta fonte di conflitti.
2.3.
Le norme di gruppo
Nei gruppi formali è riconosciuto il diritto di esercitare legittimamente delle pressioni che spingono i membri verso una
certa uniformità di comportamenti e di atteggiamenti tramite norme, ma questo è ugualmente osservabile nei gruppi
informali.
Anche nei gruppi naturali, infatti, è presente una notevole quantità di prodotti collettivi (il nome del gruppo) che
acquisiscono un valore per i suoi membri: sono le cosiddette norme sociali (o consensuali), cioè delle aspettative condivise
su come dovrebbero comportarsi i membri del gruppo, la trasgressione delle quali può comportare sanzioni per coloro che
deviano.
C’è però da dire che nella vita reale dei gruppi esiste lo spazio per l’espressione delle differenze individuali, per opinioni
personali, per attività e comportamenti non programmati collettivamente.
L’insieme di norme consensualmente accettate differisce a seconda del gruppo preso in considerazione e stabilisce i limiti
entro i quali la diversità di opinioni o comportamenti individuali può essere giudicata accettabile.
Un membro deviante riceve un maggior numero di comunicazioni dagli altri membri che tentano di ricondurlo entro le
norme del gruppo fino a che si avvicina all’opinione della maggioranza oppure resiste alle pressioni: in questo caso viene
abbandonato a se stesso e poi espulso in quanto diventato impopolare ed antipatico al gruppo.
Le norme non sono vincolanti per tutti i membri allo stesso modo: infatti, coloro i quali godono di uno status elevato sono
più vincolati al rispetto delle norme fondamentali per la sopravvivenza del gruppo e delle norme che regolano i rapporti con
l’esterno. Al contrario, sono molto più liberi degli altri se si parla di norme riguardanti questioni interne al gruppo.
Le norme hanno 4 funzioni principali:
1- l’avanzamento del gruppo verso il raggiungimento dei propri obiettivi;
2- il mantenimento del gruppo, la sua sopravvivenza in quanto entità;
3- la costruzione della realtà sociale, condivisa dai vari membri i quali trovano in essa un punto di riferimento in caso di
situazioni non familiari;
4- la definizione dei rapporti con l’ambiente sociale, composto di gruppi, organizzazioni, istituzioni (ad esempio definire
quali gruppi siano alleati e quali nemici).
Le norme di gruppo, una volta formate, sono resistenti al cambiamento, anche se esiste questa possibilità.
2.4.
Le reti di comunicazione
La comunicazione come scambio di significati è essenziale alla vita del gruppo poiché collega e determina al suo interno le
relazioni interpersonali, le amicizie o le inimicizie, gli accordi e i disaccordi, la collaborazione o la competizione.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Dalla quantità di collaborazioni date e ricevute si può dedurre la gerarchia di status: infatti, il deviante riceve più
comunicazioni degli altri almeno fino al momento in cui o si uniforma alle opinioni degli altri o viene abbandonato al suo
destino (in entrambi i casi cessano le comunicazioni nei suoi confronti).
2.5.
Il potere nel gruppo
Le posizioni dei vari membri possono essere più o meno centrali o periferiche: infatti, il rapporto dominanza-sottomissione
è uno degli aspetti strutturali della vita di gruppo.
Il potere è la capacità di influenzare o controllare altre persone.
Le fonti di potere particolarmente comuni e importanti sono 5:
1- il potere di ricompensa, che aumenta con l’ampiezza della ricompensa (di tipo materiale o simbolico); può indurre
comportamenti di conformismo esteriore ma non adesione autentica;
2- il potere coercitivo, cioè di influire attraverso sanzioni punitive, effettivamente comminate o minacciate; deve essere
accompagnato da forze restrittive che limitino la possibilità di fuga; può indurre comportamenti di conformismo
esteriore ma non adesione autentica;
3- il potere legittimo, proviene da norme interiorizzate che stabiliscono il diritto legittimo di influenzare in base a certe
caratteristiche possedute (anzianità, appartenenza ad una casta, essere maschio o femmina, ecc.) oppure ad una
designazione sociale legittima (elezione);
4- il potere d’esempio o potere di riferimento;
5- il potere di competenza, che riguarda la struttura cognitiva.
Inoltre, anche il denaro o la capacità di persuasione possono essere fonti di potere.
2.6.
La leadership
La leadership implica un processo di influenza fra un leader e i suoi seguaci al fine di raggiungere gli obiettivi di un gruppo,
di un’organizzazione o di una società.
Anche nei gruppi informali è considerato leader colui che mostra il più elevato livello di influenza.
Il ruolo di leader implica anche una maggiore iniziativa, una posizione elevata nella gerarchia di status e centrale nella rete
di comunicazioni del gruppo.
Moscovici distingue fra influenza e potere in quanto processi alternativi di modificazione dei comportamenti degli altri.
È dunque l’influenza il tratto distintivo del leader, e il leader naturale è il cosiddetto grande uomo, colui che si distingue
dagli altri per le sue caratteristiche o i suoi tratti di personalità, come:
- propensione alla responsabilità e all’esecuzione del compito;
- forza e tenacia nel perseguire gli obiettivi prescelti;
- temerarietà e originalità nell’affrontare e risolvere i problemi;
- tendenza a prendere l’iniziativa;
- disponibilità ad accettare le conseguenze di decisioni ed azioni;
- prontezza nell’assorbire lo stress e capacità di tollerare frustrazioni;
- abilità nell’influenzare gli altri;
- capacità di strutturare il sistema di interazioni sociali in vista del risultato.
I limiti del modello grande uomo, dell’idea di leader naturale che è tale indipendentemente dalla situazione sta nel fatto che i
comportamenti delle persone tendono a variare a seconda delle situazioni e che i tratti di personalità non sono statici ma
dinamici.
I leader servono essenzialmente a due tipi di funzioni:
1- assicurare che il clima di gruppo sia armonioso mostrando considerazione nei confronti dei membri (leader
socioemozionale);
2- realizzare il compito, mostrando le migliori idee e organizzando il lavoro di gruppo (leader centrato sul compito).
Difficilmente queste due funzioni della leadership si ritrovano nella stessa persona.
Da questi due tipi di leader si possono ricavare due dei principali stili di leadership:
1- democratico, rappresentato dal leader socioemozionale;
2- autoritario, rappresentato dal leader centrato sul compito.
Un terzo stile di leadership è quello laissez faire.
Ognuno di questi stili ha conseguenze diverse sulla produttività e sul morale del gruppo.
Esiste una relazione bidirezionale fra leader e membri del gruppo in quanto, se è vero che il leader può influenzare i membri
del gruppo, anche questi lo influenzano con le loro aspettative e richieste (esplicite o non).
Questo aspetto è stato completamente trascurato dall’ottica tradizionale che vede il leader come unica fonte di influenza.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
3.
I PROCESSI DI PRESA DI DECISIONE NEI GRUPPI: DALL’ASSUNZIONE DI RISCHIO ALLA
POLARIZZAZIONE
All’inizio degli anni ’60 si arrivò comprendere le dinamiche sottostanti alle decisioni in situazioni di gruppo arrivando alla
conclusione che a volte i gruppi che devono prendere una decisione non giungono a nessuna conclusione.
Infatti, molti pensano che le decisioni importanti non possano essere lasciate a nessun gruppo: al massimo, certi gruppi di
lavoro o di consulenza possono offrire al responsabile una riflessione più accurata sui fattori in gioco nel problema che si
affronta ma non sono in grado di decidere perché tutti i membri tengono troppo a far valere il proprio punto di vista.
Per questo nel gruppo si cerca un compromesso che possa andar bene a tutti e in tal modo non si decide nulla.
Quindi il gruppo è luogo di mediazione e non di decisione.
Inoltre, secondo Stoner le decisioni prese in gruppo sono decisamente più rischiose delle decisioni prese individualmente dai
singoli membri dello stesso gruppo sullo stesso argomento.
Questo perché la discussione di gruppo incrementa la familiarità dei singoli rispetto ai problemi, il che porta ad un
incremento dell’assunzione di rischio; o anche in base al concetto di rischio come valore, tipico della cultura americana,
cioè l’apprezzamento per chi sa correre dei rischi.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
CAPITOLO 8 – LE RELAZIONI FRA I GRUPPI SOCIALI
Le persone si pongono in modo diverso di fronte ai membri del proprio gruppo rispetto a quelli degli altri gruppi: infatti,
attuano comportamenti di discriminazione positiva nei confronti del gruppo a cui appartengono, a scapito degli altri, e non
solo in contesti di competizione, ma anche in situazioni di semplice compresenza.
1. GLI STUDI SULLE RELAZIONI INTERGRUPPI
Esistono delle specificità nel comportamento intergruppi di un attore sociale, cioè delle particolari caratteristiche che
distinguono il comportamento che un individuo assume in quanto entità unica e originale in un contesto di relazioni
interpersonali dal comportamento assunto dallo stesso individuo (in circostanze diverse) in quanto membro di un gruppo.
Infatti, i due tipi di comportamento possono essere posti su un continuum teorico: ad un estremo ci sarebbe il
comportamento genuinamente interpersonale (incontro diretto tra due o più persone) e all’altro estremo il comportamento
genuinamente intergruppi (tra due o più persone in cui ogni interazione reciproca è determinata dalla loro appartenenza a
diversi gruppi o categorie sociali). Tutte le situazioni sociali si pongono ad un qualche punto tra i due estremi di questo
continuum che sono però solo teorici in quanto è impossibile che in un incontro fra due (o più) persone non entrino in gioco
anche fattori sociali di appartenenza: sono però possibili incontri che si avvicinano all’estremo interpersonale (tra
innamorati o fra amici del cuore).
Una prima differenza sta nel fatto che chi è in posizione dominante agisce in termini di contrapposizione di gruppo, mentre
chi è vittima tenta di stabilire, in genere invano, un contatto da persona a persona.
Come si distingue un incontro intergruppi da un incontro interpersonale: la condizione essenziale per la comparsa di forme
estreme di comportamento intergruppi è la credenza secondo cui i confini tra i due gruppi sono definiti in modo rigido e
immutabile, percui non è possibile passare da un gruppo all’altro. Per contro, la condizione essenziale per la comparsa di un
comportamento interpersonale tra individui che si considerano membri di gruppi diversi è la credenza secondo cui non ci
sono ostacoli tanto forti da impedire l’eventuale passaggio di un individuo da un gruppo all’altro.
Gli atteggiamenti verso un outgroup possono essere positivi, neutri o negativi, ma per spiegare perché i membri di un
gruppo tendono a svalutare i membri di altri gruppi (outgroups), Sumner introduce il termine etnocentrismo.
Inoltre, è sorprendentemente facile creare le condizioni perché si generi ostilità fra i gruppi: basta un po’ di competizione e
si ottiene un rapido e grave deterioramento delle relazioni intergruppi, con la conseguente formazione di stereotipi negativi,
e fino ad atti aperti di ostilità.
Così al loro interno i gruppi risultano solidi e coesi, ma è presente una distanza molto grande dagli altri gruppi.
Ciò che permette di superare i conflitti intergruppi è il desiderio di raggiungere uno scopo sovraordinato, uno scopo che ha
un forte potere di richiamo per i membri di ognuno dei gruppi ma che nessuno può raggiungere senza la partecipazione
dell’altro.
Sono quindi situazioni in cui si devono combinare gli sforzi per ottenere dei risultati desiderati da tutti.
Quindi se due gruppi che sono in rapporto fra loro si pongono degli scopi competitivi giungeranno rapidamente ad un
conflitto intergruppi, mentre se si pongono scopi sovraordinato giungeranno ad una cooperazione reciproca.
L’antagonismo, però si genera anche in situazioni prive di interessi oggettivi e questo a causa del cosiddetto destino comune
di Lewin: il solo fatto di condividere la stessa sorte (sia essa positiva o negativa) suscita una discriminazione a favore del
proprio gruppo di appartenenza.
L’esperienza della guerra, dell’antisemitismo, del razzismo, del fascismo, insegnano che forme apparentemente innocenti di
pregiudizio possono facilmente trasformarsi in forme aperte e crudeli di ostilità.
Una rete di categorizzazione intergruppi è onnipresente nell’ambiente sociale: influenza la nostra socializzazione ed
educazione grazie a tutte le forme di team con cui veniamo a contatto sin da piccoli, a causa dell’organizzazione in classi in
ambito scolastico e della percezione di gruppi di tipo sociali, nazionale, razziale, etnico o religioso.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
La categorizzazione in gruppi diventa quindi una guida per la condotta, anche perché un ambiente sociale indifferenziato
avrebbe poco senso, non fornirebbe linee guida per l’azione.
In conclusione, secondo Tajfel, per spiegare le discriminazioni intergruppi non è necessario chiamare in causa né i conflitti
oggettivi né il destino comune, in quanto sarebbe la semplice categorizzazione sociale la condizione sufficiente per la
discriminazione intergruppi.
2. SVILUPPI E LIMITI DELLA TEORIA INTERGRUPPI
2.1. Evoluzione della concettualizzazione di Tajfel
Tajfel giunse dunque alla conclusione che la categorizzazione sociale (la percezione di far parte di un gruppo in rapporto
con un altro) è sufficiente per produrre una discriminazione intergruppi in cui è favorito il gruppo di appartenenza rispetto
all’altro.
Doise propone quindi un ampliamento della nozione di categorizzazione, la quale non permette soltanto agli individui di
organizzare e semplificare il proprio mondo sociale, ma fornisce ad ognuno, in quanto membro di determinati gruppi, uno
strumento per differenziare gruppi e categorie sociali.
In questa prospettiva, Doise elabora la nozione di processo di differenziazione categoriale: vale a dire che i comportamenti
di differenziazione sociale si svolgono partendo dal processo di categorizzazione.
Inoltre, sempre secondo Doise, l’incrocio delle appartenenze categoriali provocherebbe una diminuzione della
differenziazione categoriale.
Tajfel aveva rilevato che nel confronto del proprio gruppo con altri gruppi, si tende a valutare meglio il proprio gruppo di
appartenenza: questo è proprio il contrario di quanto sostenuto dalla teoria del confronto sociale di Festinger, secondo la
quale, gli individui si confrontano con altri, ma per evitare di mettere a rischio la propria stima di sé, realizzano il confronto
con altri appartenenti al proprio gruppo e con abilità non troppo diverse dalle proprie.
Moscovici un gruppo diventa un gruppo nel senso che è percepito come caratterizzato da aspetti comuni e da un destino
comune solo se nell’ambiente sono presenti altri gruppi, perciò il confronto sociale a livello individuale consiste
nell’avvicinarci a chi ci assomiglia, i confronti sociali fra i gruppi sono volti, invece, a stabilire distinzioni fra il gruppo di
appartenenza e gli altri gruppi.
Secondo la teoria dell’identità sociale (SIT) di Tajfel, l’identità sociale di un individuo è legata alla conoscenza della sua
appartenenza a certi gruppi sociali e all’emozioni e alle valutazioni che gli derivano da tale appartenenza. In pratica,
l’identità sociale di un individuo consiste nella sua concezione di sé in quanto membro di un gruppo e spiega i fenomeni di
favoritismo per l’ingroup e di discriminazione per l’outgroup.
Dal momento che un bisogno fondamentale degli attori sociali è quello di avere un concetto di sé soddisfacente, questo vale
per loro anche in quanto membri di un gruppo.
A questo punto, Turner e Tajfel svilupparono la nozione di competizione sociale fra i gruppi al fine di difendere o acquisire
un certo status.
Nella competizione sociale entrano in gioco tre fattori:
1- la categorizzazione sociale, per la quale le differenze fra categorie sono accentuate mentre quelle all’interno della
stessa categoria sono ridotte; inoltre, caratteristiche, valori o stereotipi assegnati alla categoria possono essere
assegnati anche ai singoli membri del gruppo;
2- l’identificazione sociale, per la quale gli individui si definiscono e sono percepiti dagli altri come membri di una
certa categoria sociale;
3- il confronto sociale con altri gruppi, che se positivo, fornisce un contributo importante alla creazione di un’identità
sociale positiva.
Quando un gruppo può essere distinto positivamente da altri gruppi ha uno status alto, mentre uno status basso è
probabilmente conseguenza di confronti intergruppi prevalentemente negativi.
Quindi per mantenere un’identità sociale positiva si attiva una vera e propria lotta in quanto, se è possibile una mobilità
sociale, chi appartiene ad un gruppo dallo status basso cercherà di uscire dal proprio per inserirsi in uno più prestigioso; se,
invece, la mobilità non è possibile si tenderà al cambiamento sociale alleandosi con altri dello stesso status al fine di
cambiare il significato delle caratteristiche del proprio gruppo o addirittura gli equilibri di potere fra i gruppi.
Al contrario, chi appartiene ad un gruppo dallo status alto dovrà difendere la propria posizione.
2.2. I processi cognitivi che sottostanno ai fenomeni intergruppi
La teoria della categorizzazione del Sé (SCT) è stata elaborata da un gruppo di studiosi raccolti intorno a John Turner e
cerca di spiegare i rapporti fra identità sociale e fenomeni di gruppo: infatti, pone l’identità sociale quale base sociocognitiva
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
del comportamento di gruppo e meccanismo che lo rende possibile, non considerandola soltanto un aspetto del Sé derivante
dall’appartenenza di gruppo.
La teoria della categorizzazione del Sé cerca di chiarire in particolare attraverso quali processi chi è inserito in un insieme di
persone giunge a definire e sentire se stesso come appartenente ad una determinata categoria sociale.
Il processo di base è quello cognitivo della categorizzazione, che comporta un’accentuazione delle somiglianze
intracategoriali e delle differenze intercategoriali.
La categorizzazione di sé e degli altri (ingroups e outgroups) accentua il carattere prototipico e stereotipico del gruppo: ciò
comporta un incremento della somiglianza percepita tra sé e i membri del proprio gruppo, una sorta di omogeneità
intragruppo, per la quale un individuo percepisce se stesso più come un esemplare intercambiabile di una categoria sociale
che come una persona unica.
Questo non significa però né deumanizzazione né deindividuazione, e nemmeno una perdita di identità.
Infine, il concetto di sé dipende dal contesto, nel senso che è l’ambiente sociale ad attivare le diverse categorizzazioni
sociali del Sé.
2.3. Interazione sociale e relazioni intergruppi
Le dinamiche sociali a livello interindividuale e intergruppi sono, per molti aspetti, simili e interdipendenti. Le tensioni fra
cooperazione e competizione intergruppi sono simili alle tensioni fra fusione ed individuazione a livello interpersonale.
Dominanti e dominati nelle relazioni fra gruppi i membri dei gruppi dominanti considerano se stessi come individui unici e
non sentono l’esigenza di definire se stessi in quanto appartenenti ad un determinato gruppo; al contrario, rappresentano un
punto di riferimento per gli altri.
L’impegno a differenziarsi dagli altri sarebbe dunque una caratteristica dei membri dei gruppi dominanti: quindi una forte
differenza fra i gruppi corrisponde ad una forte somiglianza interindividuale entro lo stesso gruppo.
Quando ci sono conflitti intergruppi la solidarietà intragruppo aumenta perché secondo Freud esiste la necessità di
individuare un nemico al di fuori del proprio gruppo perché questo sia libero da conflitti.
Lewin afferma, infatti, che è tipico dei dittatori inventare un nemico esterno per convogliare su di esso l’aggressività che si
genera all’interno del paese da essi governato.
Ma la competizione fra gruppi non sempre rafforza la solidarietà intragruppo, come avviene in caso di sconfitta.
La differenziazione intragruppo, non avviene solo all’interno di gruppi perdenti e frustrati: anzi, il cosiddetto effetto pecora
nera dimostra che anche i gruppi dominanti, al fine di mostrare la loro superiorità nei confronti di altri outgroups
significativi i membri devianti marginali dell’ingroup (quelli che non dispongono delle caratteristiche positive dei membri
più prototipici) vengono svalutati.
Le differenziazioni intragruppo non è detto che scompaiano nel caso in cui le differenziazioni intergruppi acquistino
maggiore importanza.
I componenti di gruppi appena costituiti hanno la tendenza a percepire l’ingroup più omogeneo dell’outgroup perché si
sentono coinvolti nell’elaborazione di una nuova identità; quando però l’identità è stata definita, gli stessi soggetti non
hanno più difficoltà a soffermarsi sulle diversità presenti nel loro gruppo.
In conclusione, la teoria della categorizzazione sociale si fonda sulla differenziazione intergruppi e sulla omogeneità
intragruppo.
2.4. Individualismo e collettivismo nella dinamica intergruppi
Nei rapporti di status fra gruppi si evidenzia un favoritismo nei confronti dell’outgroup da parte dei gruppi di status inferiore
ma su dimensioni che non sono importanti per il soggetto, mentre il favoritismo verso l’ingroup si verifica su dimensioni
che i soggetti ritengono importanti per il proprio gruppo.
Per questo, il favoritismo verso l’outgroup non mette in pericolo l’identità sociale del soggetto.
Individualismo e collettivismo sono fattori che influenzano i processi intergruppi:
INDIVIDUALISMO
- cultura che enfatizza la competizione, le
conquiste individuali e l’indipendenza del
soggetto dal proprio ingroup;
- l’individuo, i suoi bisogni e la sua
soddisfazione sono gli obiettivi principali;
- l’individuo è quindi più indipendente, ha
idee, credenze, obiettivi, valori suoi, che
COLLETTIVISMO
- cultura che enfatizza la cooperazione tra i
membri del gruppo, i risultati collettivi e la
compattezza dei legami che uniscono ogni
individuo agli altri;
- il gruppo e la sua sopravvivenza sono gli
obiettivi di queste società;
- nei casi estremi di collettivismo gli individui
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
possono anche differenziarsi da quelli del
gruppo.
non hanno obiettivi personali, atteggiamenti,
credenze e valori che non riflettano quelli
del gruppo.
Individualismo e collettivismo costituiscono anche delle caratteristiche di personalità: idiocentriche e allocentriche.
Esistono gruppi che, pur essendo collettivisti, non sono interessati a confrontarsi con altri gruppi, come i gruppi di terapia e
quelli uniti dalla passione per un hobby.
Al contrario, i gruppi come i team sportivi o i partiti politici hanno la tendenza a confrontarsi con altri gruppi: anzi, la loro
stessa esistenza dipende dalla presenza di uno o più outgroups con cui competere.
Da ciò si deduce una seconda dimensione regolatrice, definita autonomo-relazionale, che si riferisce al tipo di ideologia o di
orientamento adottato da un gruppo:
- i componenti di un gruppo con orientamento relazionale valuteranno il proprio ingroup e i propri risultati
confrontandosi con gli altri gruppi e con i loro risultati;
- i componenti di un gruppo con orientamento autonomo non avvertiranno tale esigenza, ma metteranno in atto
confronti con standard astratti o con risultati precedentemente ottenuti dal gruppo stesso.
3. GLI EFFETTI DELLA DISCRIMINAZIONE INTERGRUPPI. STEREOTIPI SOCIALI E PREGIUDIZI
Nei processi intergruppi, come conseguenza della discriminazione, si verifica il costituirsi di uno o più stereotipi nei
confronti dell’outgroup.
Gli stereotipi si distinguono in:
- cognitivi, cioè generalizzazioni diventate patrimonio degli individui, in gran parte derivati del processo cognitivo
della categorizzazione, la cui funzione principale è quella di semplificare e sistematizzare l'abbondanza e la
complessità dell’informazione che l’organismo umano riceve dal suo ambiente;
- sociali, trasformazione degli stereotipi cognitivi nel momento in cui vengono condivisi da grandi masse di persone
all’interno di gruppi e istituzioni sociali; in definitiva, lo stereotipo sociale è un’immagine mentale semplificata al
massimo riguardante (solitamente) una categoria di persone.
Gli stereotipi si accompagnano comunemente, ma non necessariamente, al pregiudizio, cioè ad una predisposizione
favorevole o sfavorevole verso tutti i membri della categoria in questione.
Tutti i processi intergruppi possono dare luogo a stereotipi sociali, simili ai miti sociali, cioè rappresentazioni collettive.
Anche se il pregiudizio è qualcosa di concettualmente diverso dallo stereotipo sociale, in quanto è un giudizio dato prima di
conoscere a fondo l’oggetto in questione; nonostante possa anche essere positivo, il termine pregiudizio possiede
essenzialmente una connotazione negativa.
Il pregiudizio è quindi un giudizio negativo a priori, un sentimento di antipatia (verso gruppi etnici, religiosi, professionali)
fondato su una generalizzazione falsa e mantenuto a dispetto di eventuali fattori che lo contraddicono (in quanto, in caso
contrario, porterebbe una minaccia radicale al sistema di valori a cui il giudizio è ancorato); può essere diretto verso un
gruppo nel suo complesso o verso un individuo in quanto membro di quel gruppo.
Bauman sostiene la necessità di distinguere il razzismo da altre forme di discriminazione (eterofobia): infatti, perché ci sia
razzismo, devono essere presenti, insieme all’atteggiamento discriminatorio, anche una teoria sull’impossibilità di
modificare (o correggere) le qualità negative ed una giustificazione in chiave biologica e genetica di tale inferiorità, che
viene invocata dai razzisti per considerare e trattare da non uomini gli appartenenti a determinati gruppi umani.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
CAPITOLO 9 – L’INFLUENZA SOCIALE
Per molto tempo gli studiosi hanno considerato i processi di influenza determinati in modo esclusivo dall’esercizio del
potere e si dava per scontato che l’influenza sociale conducesse necessariamente al conformismo.
Attualmente, invece, si distingue fra l’influenza esercitata da una maggioranza (numerica o di potere) e quella esercitata da
minoranze che adottano stili di comportamento coerenti: la prima genera conformismo, la seconda può innescare processi di
innovazione.
1. CONFORMISMO E FORZA DELLA MAGGIORANZA
Il giudizio degli individui (e la norma che ne deriva) è diverso dalla norma che il gruppo si dà.
Nelle situazioni individuali il soggetto elabora un proprio campo di giudizio, mentre nella situazione di gruppo i soggetti
tendono a convergere nei loro giudizi verso una norma comune principalmente perché colui che diverge si sente incerto ed
insicuro, nella posizione deviante.
Asch ha condotto alcune ricerche per affermare radicalmente la tesi secondo cui sono fattori razionali quelli che fanno
elaborare ai soggetti di un gruppo, di fronte ad un compito comune, risposte che tendono a convergere.
L’influenza sociale è data dalle pressioni esercitate sulle persone per farle agire in modo contrario alle loro convinzioni e ai
loro valori.
L’individuo o, più generalmente, la minoranza, appare sia come colui che resiste al gruppo, sia come colui che devia.
in quanto resiste, l’individuo si sottrae alla pressione sociale quando in essa viene espresso un giudizio che diverge
dal suo e contrario a ciò che ognuno vede e pensa; questo individuo giunge così a ridurre l’effetto di conformismo e
ad evitare l’errore collettivo;
in quanto devia, l’individuo si allontana dai giudizi e dagli scopi del gruppo costituendo un ostacolo
all’adattamento del gruppo stesso: gli altri membri del gruppo tendono a far pressione su di lui per riavvicinarlo
alla norma comune, o ad escluderlo dal gruppo se la pressione fallisce; può derivare da ciò un eccesso di
conformismo.
2. IL MODELLO GENETICO DELL’INFLUENZA SOCIALE
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Secondo il modello genetico, tutti i membri di un gruppo possono sia subire che portare influenza: è infatti scorretto dare per
scontato che l’influenza vada necessariamente dalla maggioranza alla minoranza.
Per Moscovici, lo scopo dell’influenza è il cambiamento sociale e non il conformismo, tanto più che, se lo scopo di ogni
entità sociale maggioritaria è quello di esercitare un controllo sociale, le minoranze hanno interesse ad innovare, cioè
cambiare le norme maggioritarie e sostituirle con altre più rispondenti alla loro prospettiva.
Il negoziato è la caratteristica che distingue il processo di influenza minoritario da quello maggioritario: infatti, l’influenza
maggioritaria può realizzarsi nel quadro di una almeno apparente collaborazione fra chi riceve influenza e chi la esprime;
invece una minoranza, per esercitare influenza, deve definire una propria posizione antagonista ed alternativa a quella della
maggioranza. Tale antagonismo provoca un conflitto fra le due parti in causa che può essere regolato tramite un negoziato.
La maggioranza e la minoranza sono entità maggioritarie o minoritarie non in senso esclusivamente quantitativo: un gruppo
è definito minoritario se si batte per norme in contrasto con quelle maggioritarie, mentre maggioritario è il gruppo che
assume e diffonde le norme e l’ideologia dominanti.
Anche un’entità sociale priva di potere può, sul piano teorico, esercitare un’influenza, perché ciò che è importante non sono
i contenuti delle proposte alternative ma l’organizzazione e la struttura di questi contenuti.
Percui lo stile di comportamento svolge un ruolo decisivo in tale processo poiché può dare ad un individuo o ad un gruppo
un particolare prestigio che attrae e suscita ammirazione quindi influenza.
Importantissimo risulta quindi anche lo stile di negoziato, che può essere:
- rigido, quando la minoranza è intransigente in modo estremo e rifiuta ogni compromesso; in quanto
percepita come estremista e chiusa in se stessa, fatica moltissimo ad esercitare un’influenza anche minima;
- flessibile, quando c’è la disponibilità a fare alcune concessioni.
Quindi, la tesi minoritaria ottiene un’influenza rilevante e diretta quando adotta uno stile flessibile mentre posizioni estreme
come quelle rigide tendono a creare un conflitto profondissimo.
La naturalizzazione della minoranza è uno dei meccanismi con cui il sistema sociale si immunizza contro i devianti,
svuotando di significato la loro credibilità: consiste nel considerare come causa di comportamenti o di discorsi devianti delle
proprietà personali stabili (donna, tarato, carattere, intelligenza limitata, comunista, politico).
L’innovazione indotta da una minoranza attiva non va confusa con la devianza pura e semplice, perché:
- la devianza è la trasgressione delle norme senza mettere in discussione la loro validità e il contesto che le
sostiene;
- l’innovazione perseguita da una minoranza attiva, invece, mette in discussione una o più norme per trovare
un nuovo rapporto tra sistema sociale e norme.
3. CONDISCENDENZA E CONVERSIONE
Se si parla di maggioranza, il meccanismo dell’influenza dev’essere spiegato tramite lo stile di comportamento dell’entità
sociale (gruppo o individuo) portatore potenziale di influenza.
Esistono due livelli di risposta con cui viene espresso il cambiamento prodotto:
- risposte manifeste (o sociali);
- risposte latenti (o a livello del codice percettivo).
Fra le forme d’influenza maggioritaria minoritaria si possono evidenziare delle differenze che appaiono a livello delle
risposte:
se la minoranza è percepita come rigida non ha quasi nessuna influenza rilevante a livello diretto, ma un impatto
rilevante a livello indiretto (relativamente a contenuti non espliciti ma correlati al messaggio); invece, i mutamenti
prodotti dalle minoranze consistenti e attive possono non sempre essere immediatamente evidenti a livello sociale,
ma nascosti e più solidi;
i mutamenti prodotti dalle maggioranze consistenti sono evidenti a livello sociale, ma più superficiali perché non
radicati nei soggetti.
La conversione (o comportamento di conversione) è l’effetto prodotto, frequentemente in modo latente o indiretto,
dall’influenza minoritaria e consiste in un cambiamento di giudizio che tocca i livelli profondi (e non solo quelli
superficiali) dell’esperienza psicologica del soggetto.
3.1. Il conflitto nel processo di influenza
Di fronte ad una maggioranza consistente che invia un messaggio in contrasto con le opinioni fino a quel momento
condivise, gli individui, o i membri di un gruppo, si sentono spinti a considerare il messaggio come vero poiché legittimato
dal prestigio, o dal potere, o dalla numerosità della fonte.
Scaricato da: www.formazione.forumcommunity.net
Chi si pone in contrasto con tale messaggio si sente immediatamente deviante, perciò avverte l’esigenza di adeguare la
propria risposta a quella maggioritaria per non essere più diverso.
Quindi il soggetto inizia un’attività di confronto sociale con la maggioranza e:
si adegua alla definizione di realtà da essa sostenuta, tanto più se non ha alcuna ragione per differenziarsene;
se ha invece ragioni rilevanti per resistere ma si adegua, si realizza una situazione di condiscendenza;
se tiene duro ed esprime il proprio dissenso andrà incontro a tutte le pressioni che la maggioranza è in grado di
esercitare.
Quando invece la fonte d’influenza è minoritaria, l’informazione espressa è considerata falsa, illegittima, sbagliata: la fonte
stessa appare deviante in quanto i soggetti si identificano con la norma maggioritaria; dunque la risposta è di rifiuto
immediato.
Se la minoranza però è consistente, il conflitto continua, ancor più se la minoranza non cede di fronte alle pressioni della
maggioranza: in questo caso, lascia pensare di avere una qualche ragione per agire e pensare in quel modo.
La maggioranza è così costretta a focalizzare la propria attenzione sull’oggetto della disputa, cercando di cogliere meglio il
punto di vista minoritario.
Quando compare una tesi minoritaria, il gruppo maggioritario cercano di rinsaldare la coesione (in quanto minacciata) fra i
suoi membri.
Il processo di validazione del punto di vista minoritario si attiva nei soggetti che si confrontano con una minoranza
consistente e risulta da un’attività cognitiva di elaborazione attraverso la quale si può giungere al riconoscimento delle
ragioni della minoranza (validazione) e all’esternazione, almeno parziale, dell’accettazione delle sue tesi.
In conclusione, è possibile che punti di vista minoritari riescano a diffondersi ed estendersi nel tessuto sociale, sormontando
i rifiuti e le discriminazioni iniziali.