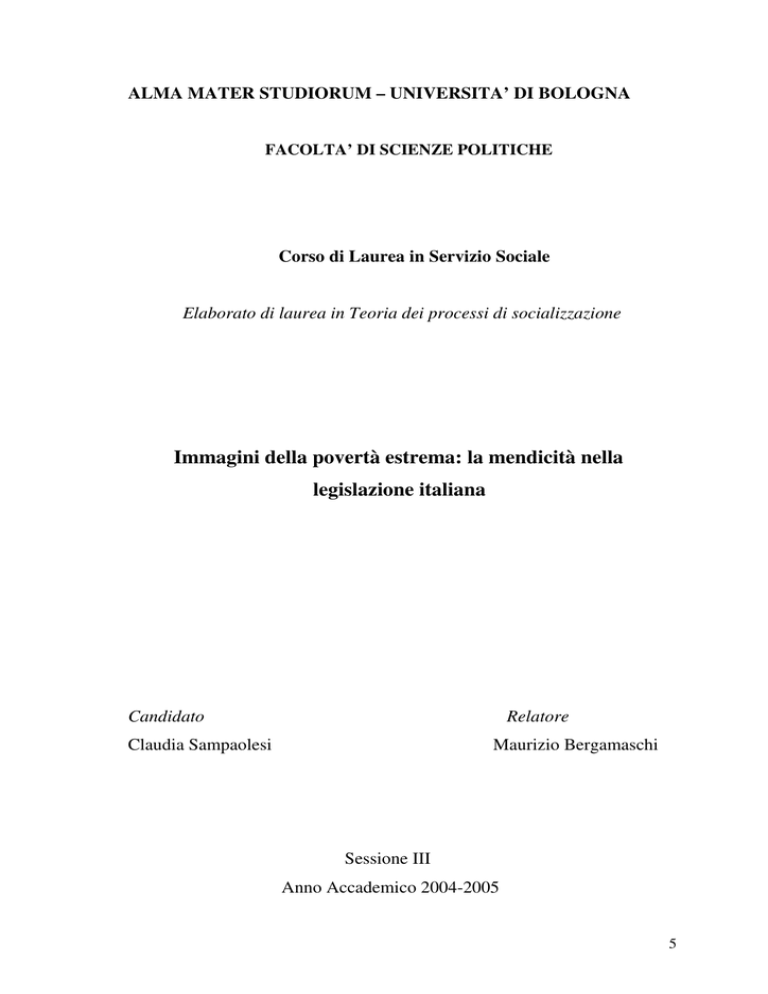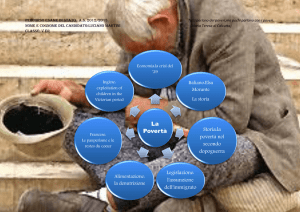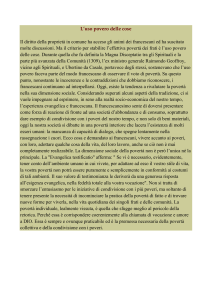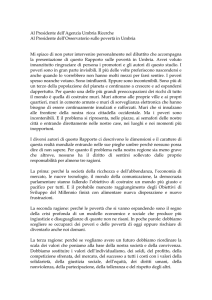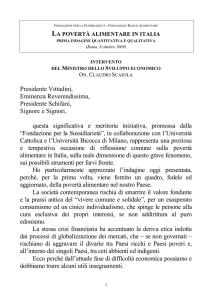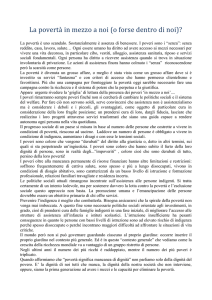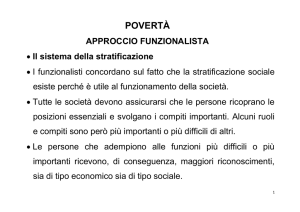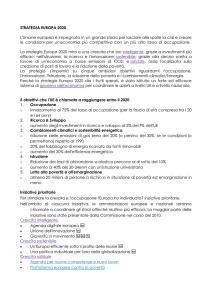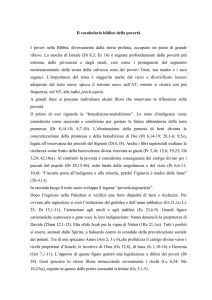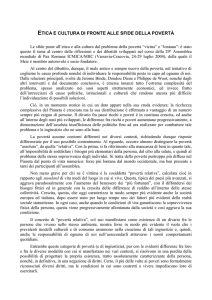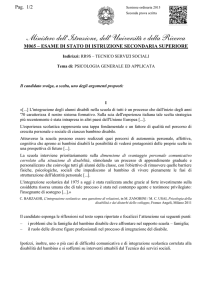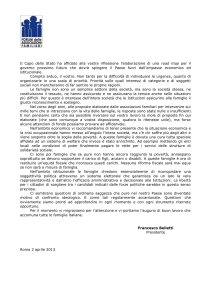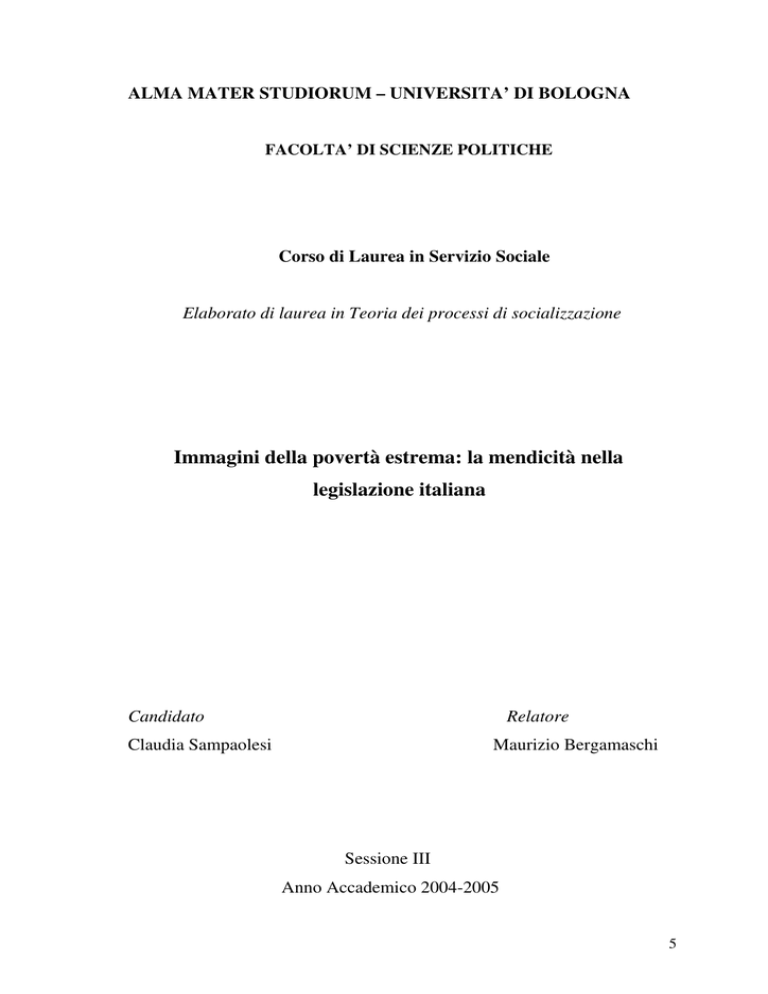
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea in Servizio Sociale
Elaborato di laurea in Teoria dei processi di socializzazione
Immagini della povertà estrema: la mendicità nella
legislazione italiana
Candidato
Relatore
Claudia Sampaolesi
Maurizio Bergamaschi
Sessione III
Anno Accademico 2004-2005
5
INDICE
Introduzione
p. 7
1. Il problema dell’insicurezza: le forme storiche
di trattamento della mendicità
p. 14
1.1.Le leggi sui poveri tra il XVI e il XVII secolo
p. 16
1.2. I cambiamenti del XIX e del XX secolo
p. 22
2. La mendicità nella legislazione italiana nel XIX e XX secolo
p. 28
2.1. Il codice Rocco: fine delle distinzioni
p. 32
2.2. Sentenza della corte costituzionale del 28-12-1995, n. 519
p. 39
3. La mendicità nell’immaginario collettivo
p. 43
Considerazioni conclusive
p. 56
Fonti legislative
p. 58
Bibliografia
p. 59
6
Si pensa sempre che l’esclusione possa essere combattuta con le
leggi e i decreti, con una volontà politica o con un programma
sociale, ma non è così. L’esclusione è prima di tutto nelle nostre
teste, nei nostri cuori, nel nostro modo di pensare. E’ per questo
che è così difficile da cogliere e soprattutto da combattere. (…)
Se in un comune si aprisse un centro per i senza casa, i cittadini
sicuramente insorgerebbero contro il sindaco chiedendogli di
non svalutare il loro quartiere. E il sindaco, che desidera essere
rieletto, cederebbe alle loro ingiunzioni. Ai centri di
accoglienza, sono tutti favorevoli. A condizione che si trovino
nel comune accanto, lontano dalle proprie abitazioni. (…) Da
che mondo è mondo si educano i bambini a soccorrere i poveri,
dicendo loro: “Forse è il Cristo che viene tra noi e si nasconde
sotto i loro abiti per metterci alla prova”, ma da che mondo è
mondo abbiamo paura degli uomini vestiti di stracci, così simili
tra loro eppure così differenti, che celano non si sa quale
minaccia, forse un coltello nascosto sotto gli stracci. E le porte
si chiudono. E Cristo prosegue oltre.
Xavier Emmanuelli
7
INTRODUZIONE
Lo specifico di questo lavoro è nel considerare le varie immagini della povertà estrema
“prodotte” dalla legislazione sulla mendicità, in particolare nel contesto italiano dal XIX
secolo ad oggi. In primo luogo è necessario ricordare che la nozione di “povertà urbana
estrema” appartiene al lessico contemporaneo, mentre per quanto concerne il passato
dovremo parlare di mendicità, vagabondaggio, ozio, accattonaggio; termini che
comunque, nel tempo e nello spazio, hanno costantemente provocato preoccupazione in
quanto indicano una realtà sociale e umana che appare priva di contorni, imprevedibile,
caratteristiche che le permettono di sfuggire alle rigide e rassicuranti categorizzazioni
amministrative e che la rendono per questo inquietante. Il mendicante ha rappresentato
per molto tempo una minaccia all’ordine costituito, un nemico interno, da controllare,
da isolare, da nascondere; La carità, l’internamento, l’assistenza, nonostante siano
“pratiche”in apparenza molto differenti tra loro, hanno tutte avuto in comune la
medesima preoccupazione, quella di istituzionalizzare e regolamentare questo mondo a
parte, scomodo. Il vagabondo è l’individuo asociale per eccellenza, che vive al tempo
stesso fuori da ogni inscrizione territoriale e fuori dalla realtà del lavoro. La questione
del vagabondaggio, ci dice Castel, è stata la grande questione sociale di queste società,
“essa ha mobilitato un numero impressionante di misure prevalentemente repressive,
per tentare – invano, d’altra parte – di sradicare questa minaccia di sovversione interna e
di insicurezza quotidiana, che si riteneva fosse rappresentata dai vagabondi. Se si
volesse scrivere una storia dell’insicurezza e della lotta contro l’insicurezza nelle società
preindustriali, il personaggio principale sarebbe il vagabondo – sempre vissuto come
potenzialmente minaccioso – assieme alle sue varianti scopertamente pericolose come il
brigante, il bandito, il fuorilegge: tutti individui senza legami, che rappresentano un
rischio di aggressione fisica e di disgregazione sociale poiché esistono e agiscono al di
fuori di ogni sistema di regolazioni collettive.”1
E’ da questa specie di inquietudine che la vista della persona in strada provoca, un’
inquietudine che ha una sua storia, un suo perché, per cui è dalla necessità di dare
un’origine storica, un senso a questa mescolanza di sentimenti e atteggiamenti ora di
compassione, ora di paura, di disprezzo…nei confronti del “mendicante” che parte il
mio discorso. Tutte le immagini che oggi “descrivono” la persona senza dimora hanno
1
R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004, p. 9.
8
una loro “memoria storica” e dall’età moderna in poi, il sistema legislativo ha avuto un
ruolo molto importante nella “costruzione” di alcune di queste.
Per quanto riguarda la mia personale esperienza poi, posso dire che, paradossalmente, il
mio interesse verso questo tipo di problematica è nato dal mio disinteresse, inteso come
indifferenza: fino a poco tempo fa non avevo mai riflettuto sulla condizione del
“barbone”, avevo degli stereotipi ben precisi e andavano bene così. Sono nata e vissuta
in un piccolo paese, Loreto, in provincia di Ancona, dove è molto difficile incontrare
per strada chi ti chiede l’elemosina, capita poche volte, nel periodo natalizio, fuori dal
portone della chiesa…E’ molto difficile sentirsi coinvolti da problematiche che non
pensiamo, anche lontanamente, che ci possano toccare…ma dal momento in cui si
allarga, anche solo un po’ l’orizzonte, tutto cambia, le certezze diventano incertezze e
ogni cosa attorno acquisisce un nuovo significato. Un po’ questo mi è capitato andando
a Genova per la prima volta nel 2002 e venendo a contatto con l’Associazione S.
Marcellino che si occupa appunto di persone senza dimora. Un mondo nuovo che avevo
sempre vissuto come altro rispetto al mio e che invece ho scoperto essermi così vicino,
familiare. Ho sempre pensato al “barbone”, con finta ammirazione, come ad una figura
particolare che si trova in quella situazione perché sceglie la libertà, non accetta nessuna
regola sociale uscendo fuori da tutte quelle costruzioni e convenzioni che noi “bravi
borghesi” ci siamo fatti, oppure e in questo caso provando pena mescolata alla paura, ad
una persona che si trova in quelle condizioni perché abbandonata a se stessa a causa di
problemi psichici o problemi di tossicodipendenza, alcolismo…comunque persone fuori
dal mio mondo, dalla mia normalità. Stereotipi, che annullano completamente la
persona alla quale li indossiamo e con i quali riusciamo a semplificarci, e non di poco,
la vita, il mondo che viviamo. Lo “stare fuori” di queste persone, mi ha portato però a
riflettere…in seguito ho imparato che l’uscita non è istantanea e non avviene totalmente
e, se avviene, si arriva presto alla morte: le persone senza dimora sono persone che
hanno perso ogni legame comunitario, il loro sistema psichico è deluso, vuole ritirarsi,
fino a lasciarsi morire; ma il percorso di “degrado” è lungo ed è costituito da piccole
rotture e ogni rottura ha bisogno di un suo assestamento. Ciò mi ha portato alla mia
realtà e agli sforzi spesso compiuti per rimanere “affiliata” ad un sistema che troppe
volte diventa stretto, insopportabile, agli sforzi per sentirmi adeguata, per combattere i
momenti di sfiducia nelle proprie “capacità”…La società in cui si vive è sempre più una
società senza regolamentazione e normatività, una società in cui ogni individuo vive
isolato nel suo “delirio”. Nel parlare del problema della povertà estrema, non possiamo
9
fare a meno di affrontarlo senza intrecciarlo con la nostra normalità, perché si tratta di
un disagio, certo favorito da alcuni fattori quali la mancanza di un alloggio, una
condizione economica precaria, ma gli elementi che maggiormente lo connotano e lo
definiscono, sono l’inadeguatezza della persona di fronte alla complessità attuale e una
“tempesta” relazionale che coinvolge affetti, fiducia, autostima…che destabilizza la
persona stessa2. Un disagio che non possiamo più negare come comune ad ognuno di
noi, un disagio “diffuso” che spezza le variabili tradizionali e che spazza via quei luoghi
comuni a cui siamo abituati. Per questo “nuovo” disagio non valgono più i classici
criteri dell’età, dell’appartenenza ad un ceto sociale o ad una certa famiglia, della
struttura della famiglia, dell’ambiente urbano in cui si abita e tutta un’altra serie di cose
che non riescono più a spiegare quello che sta succedendo oggi.
Questo mio lavoro, non consiste in una ricerca di territorio, ma è una ricerca, per così
dire, di tipo giuridico-sociologico, per cui tutto il materiale di cui mi sono servita è di
tipo bibliografico, ma mi rendo perfettamente conto che senza quella, se pur breve,
esperienza a Genova, tutto avrebbe avuto un diverso valore, un diverso significato…
Tornando allo specifico del mio lavoro, esso nasce dall’intento di analizzare le varie
immagini che hanno descritto e caratterizzato la persona senza dimora nel tempo
attraverso l’analisi della legislazione che si è occupata della mendicità. Ho suddiviso il
mio lavoro in tre capitoli (che possiamo chiamare anche tre parti); nella prima parte
vengono considerate le varie forme storiche di trattamento della mendicità dal XVI al
XX secolo in un quadro generico, europeo, mettendo in evidenza come queste nel
tempo si siano modificate, strutturate in relazione alle trasformazioni più generali della
società, producendo sempre nuove immagini della povertà estrema che si sono
stratificate l’una sull’altra. Le difficoltà che incontriamo oggi nella lettura della povertà
urbana estrema “sono in gran parte da attribuire a questa stratificazione di immagini. La
figura della povertà urbana estrema ancora oggi rimanda contemporaneamente alla
prossimità con Gesù, alla decomposizione delle relazioni sociali, ad una residualità, alla
minaccia del ritorno di situazioni di altri tempi.”3
Nel medioevo, ad esempio, non vi erano delle “politiche” di lotta alla povertà nel vero
senso della parola, il povero aveva una funzione ben precisa : permetteva l’accesso al
Paradiso a colui che faceva la carità. La carità quindi non era un “dovere sociale” ma
2
G. Pieretti, “La negazione dei diritti nel percorso di vita della persone senza dimora”, Genova, 2001
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico- sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi ( a cura di ), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 49.
3
10
consisteva in un rapporto personalizzato tra colui che dava e colui che riceveva. In
questo scambio, il povero spariva completamente in quanto lo scopo finale era la
salvezza del donatore, il destinatario era irrilevante.
Per le società moderne invece, una questione di primaria importanza fu di improntare
dei meccanismi di controllo idonei a governare dinamiche sociali dirompenti come ad
esempio la nascente industrializzazione e l’urbanizzazione di masse di contadini.
Meccanismi di controllo che costituirono uno dei tratti peculiari della modernità e che
erano mossi dall’esigenza di liberarsi dalla paura che incutevano masse di miserabili e
nullatenenti pronti ad infestare con le loro scorribande le vie cittadine. Foucault ci dice
che tali meccanismi di controllo sarebbero nel tempo venuti a creare la così detta
“società disciplinare”. Un tipo di società basata su una forma di controllo sociale che
prende in carico l’esistenza individuale in ogni dettaglio più minuto, determinandone
un’ “oggettivazione” progressiva. L’imponente tentativo di disciplinare e mettere al
lavoro gli “oziosi e i vagabondi”, o comunque di neutralizzarne il potenziale eversivo,
avviatosi in tutta Europa, è potuto proseguire infatti, in evo moderno, solo grazie a
determinate costruzioni
concettuali che consentissero, in un quadro giuridico
formalmente egalitario, di “stigmatizzare” come socialmente pericolose le esistenze e
gli stili di vita non sufficientemente “ordinati” e “ laboriosi” delle classi marginali. Il
compito principale del sistema di controllo penale, ad esempio, fu ben aldilà della
semplice risposta alla criminalità, esso fu soprattutto il governo delle classi subalterne
dotandosi di un insieme di meccanismi polizieschi che, anziché colpire l’infrazione di
una norma o la lesione di un bene giuridico, erano in grado di sanzionare un
complessivo stile di vita, sul presupposto che l’ozio, il vagabondaggio, la
disoccupazione e la povertà, fossero in sostanza il luogo di coltura di tutti i peggiori
mali per una società civile ed ordinata.
Tutte queste immagini che hanno “descritto” e “identificato” la persona senza dimora
dal medioevo in poi, sono oggi compresenti. Il sistema legislativo da un lato ha
contribuito a crearle, ma allo stesso tempo, ne è stato influenzato.
Nel secondo capitolo, invece, si parla del caso specifico dell’Italia: la mendicità nella
legislazione italiana nel XIX e XX secolo. Nell’Ottocento la mendicità era vista quale
piaga schifosa del corpo sociale, produttrice di un insieme enorme di mali. Il
mendicante era un essere utile a nessuno, in quanto viveva in quelle condizioni proprio
perché preferiva l’ozio al lavoro, a questa concezione non c’era via di scampo, non vi
erano alternative e nel Codice Penale sardo-italiano del 1859 si ritrovavano richiami ad
11
una lettura punitiva della mendicità proprio secondo criteri di equità e di umanità. Il
ricovero coatto divenne l’auspicato rimedio: il mendicante non doveva essere
controllato e punito in quanto essere vizioso, attentatore di un ordine, diremmo noi
meglio, auspicato piuttosto che esistente. Comunque fino al codice Rocco del 1930, la
legge distingueva il povero meritevole e il povero non meritevole, per cui il povero non
abile al lavoro a causa di problemi fisici o psichici e quindi non per propria scelta, era
appunto “meritevole” di compassione e di aiuto, il povero abile al lavoro, quindi
inoccupato per propria scelta invece doveva essere recluso, allontanato, punito. Non vi
erano possibilità di comprendere e giustificare un simile comportamento. La
distinzione, ai fini della punibilità, venne abbandonata dal codice Rocco del 1930:
l’articolo 670 del nostro codice penale, abrogato definitivamente solo nel 1999,
prevedeva che chiunque mendicasse in luogo pubblico o aperto al pubblico fosse punito
con l’arresto fino a tre mesi; esso contribuì maggiormente a criminalizzare e a
considerare pericolosa la figura del mendicante e soprattutto contribuì a categorizzare,
come criminale appunto, una realtà sociale e umana che tendeva a sfuggire a rigide
categorizzazioni amministrative. E’ come se dall’età moderna in poi la forca abbia steso
la sua ombra sul sentimento di carità, sull’aiuto ai poveri, sulla pietà verso gli infelici4.
Negli anni sessanta – settanta, anche l’Italia viene attraversata da profondi mutamenti.
L’idea che la povertà e l’emarginazione fossero il frutto di una deficienza
dell’individuo, immagine che soprattutto la scienza psichiatrica contribuì a creare ai
primi del ‘900, venne mano a mano a decadere. Soprattutto decadde la necessità di
rispondere a questa problematica severamente per mezzo dell’intervento penale, per cui
il ruolo riservato alle agenzie penali venne progressivamente restringendosi. Nel corso
degli anni ottanta la povertà
tornò
ed essere considerata come una condizione
socialmente riconosciuta tanto che il Welfare dovette assumere tutte quelle funzioni che
un tempo erano riservate al sistema penale. La sentenza della Corte Costituzionale del
28-12-1995, n. 519, dichiarando l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art.
670 c. p., in teoria segnò una tappa importante, in sostanza seguì questa scia di
cambiamenti sociali. La sentenza infatti considera, in primo luogo che nonostante
nell’art. del c. p. la mendicità sia considerata un reato, esso era ormai scarsamente
perseguito, in quanto sono per primo gli organi statali preposti alla repressione di questo
e di altri simili reati, a manifestare un aperto disagio; in secondo luogo, la sentenza
4
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 264.
12
riconosce le attività autonome, quali ad esempio le organizzazioni di volontariato della
società civile che, mossa da sentimenti di solidarietà, è consapevole dell’insufficienza
dell’azione dello Stato. Con l’’art. 18 della legge del 25 giugno del 1999, n. 205,
entrambi i comma dell’art. 670 c. p., vengono abrogati, per cui la mendicità cessa di
essere un reato.
Se nel secondo capitolo, ho dato maggiore importanza all’aspetto giuridico, passando in
rassegna le varie leggi che dall’Ottocento ad oggi si sono occupate di mendicità,
contribuendo a trasformare o creare nuove immagini della persona senza dimora, nel
terzo ed ultimo capitolo, che ha per titolo “la mendicità nell’immaginario collettivo”, ho
dato maggiore spazio ad una lettura sociologica del problema. Ho cercato infatti di
analizzare le varie immagini che il sistema legislativo ha contribuito a creare mettendo
in evidenza il fatto che ancora oggi le difficoltà nella lettura della povertà urbana
estrema, sono in gran parte da attribuire a questa stratificazione di immagini. Allo stesso
tempo è molto difficile stabilire quali siano i “sentimenti” che prevalgono nei confronti
della persona senza dimora. Certo è, e questo ce lo dimostra anche la sentenza del 1995,
che oggi, il pensare alla persona senza dimora come un vero e proprio criminale è assai
poco diffuso. Oggi possiamo dire che il sentimento che prevale è la compassione o la
pura indifferenza, ma non è possibile affermare che questi sentimenti abbiamo
completamente cancellato le immagini che dall’età moderna in poi si sono venute a
creare. “Gli atteggiamenti socio – psicologici cambiano molto lentamente, sembrano
radicati nella natura umana e nelle basi biologiche della vita sociale. E’ molto più facile
individuare un cambiamento nelle tecniche di procurarsi il cibo, nei mezzi di trasporto,
nel modo di combattere, nelle forma di governo, che non nei sentimenti delle persone,
nella loro sensibilità e immaginazione. (…) Il gesto caritatevole di dare l’elemosina non
è stato sostituito con una minaccia di impiccagione per i mendicanti: tale minaccia e tale
gesto coesistevano attraversando periodi di debolezza e di forza, di ascesa e di caduta.”5
Purtroppo però non si tratta solo di sentimenti, è necessario soprattutto, per dare una
reale visibilità alle persone senza dimora, parlarne come persone aventi in primo luogo
dei diritti, diritti che invece sono spesso negati, nascosti, violati. Per fare questo ,
dobbiamo in primo luogo comprendere altri sistemi di senso, andando oltre la nostra
realtà, la nostra idea di normalità, dobbiamo liberarci dai nostri orpelli sociali quali il
mondo dei ruoli e delle prestazioni, gli oggetti di consumo, i nomi, le categorie, le
5
Ibidem, p. 13.
13
aspettative, le ambizioni… e concentrarci sulla vita stessa che è il fondo comune che sta
in ognuno di noi6. Purtroppo è ancora molto lunga la strada da percorrere!
6
“La vita non è una distinzione fra le altre. La vita è l’unica, vera, distinzione. Non ci sono distinzioni
tranne quella che stabilisce lo scarto di esistenza fra la vita e la non vita. In particolare, non ci sono
distinzioni interne alla vita stessa. Le distinzioni interne alla vita che crediamo di osservare sono solo
apparenze, metafore, simulazioni.” G. Piazzi, La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995, p.
39.
14
1. IL PROBLEMA DELL’INSICUREZZA: LE FORME STORICHE
DI TRATTAMENTO DELLA MENDICITA’
Collocata
nell’ambito delle “contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la
tranquillità pubblica” di cui al Capo I, Titolo I, Libro III del nostro codice penale, la
mendicità trova la sua configurazione (art.670-671) quale previsione normativa volta
alla “prevenzione dell’accattonaggio”, intendendo questo ultimo come “il fatto di chi
domanda…elemosina e ne fa professione abituale”7. Il mendicare, nell’interpretazione
più diffusa, viene definito come l’azione del chiedere denaro o altra utilità, ovvero
“richiesta personale e diretta di elemosina” e nel contempo la mendicità qualifica
nell’etimologia la condizione di “persona estremamente povera”, inducendo l’analisi di
tale fenomeno nell’ambito di quello, storicamente più complesso che va sotto il nome di
pauperismo. Il nucleo originario del termine “mendico”, quale derivazione da
“mendu(m)”, aiuta invece a chiarire il significato più letterale ad esso attribuito
nell’espressione “con un difetto fisico”; nel tempo, il medesimo termine, ha assunto il
significato più diffuso di “povero”, ad indicare, nel linguaggio sociale, colui che vive ai
margini della collettività. Ed è sulla mendicità intesa come povertà che in un primo
tempo ci soffermeremo: nell’Ottocento poi, come vedremo, il divario che in epoca
moderna era di grado ma non di natura, si farà sempre più profondo. Dal punto di vista
sociologico comunque, i termini quali mendicità, ozio, accattonaggio, vagabondaggio,
pauperismo, povertà urbana estrema, nonostante abbiano ognuno uno specifico
significato, indicano una realtà simile la realtà della désaffiliation, ovvero di una
popolazione priva di uno statuto definito e socialmente accettato, una realtà sociale che
appare imprevedibile e priva di contorni e quindi nella sua essenza inquietante. Essendo
l’assillo della sicurezza una preoccupazione popolare, nel senso forte del termine,8 il
problema che la povertà pone alle istituzioni deputate al suo trattamento è comunque
sempre il medesimo nel tempo: definirla da un lato e dall’altro prenderla in carico.
Pertanto l’oggetto di questo lavoro non è costituito dalla povertà in sé ma dalla sua
amministrazione e regolamentazione; come scrive lo storico B. Geremek, “nella
documentazione storica, gli emarginati lasciano poche tracce: non stabiliscono rapporti,
non ereditano, non sono eroi di grandi imprese che possono passare alla storia. Sono
presenti anzitutto negli archivi della repressione, quindi in un’immagine riflessa dove
7
Così Saredo, “Accattonaggio o mendicità (Dir.amm., dir. pen.)”, in D. I., parte I, Torino, 1884, 250.
R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004
8
15
non appare soltanto la giustizia della società organizzata, ma anche il suo timore e il suo
odio. Per questo le informazioni riguardano per primo la società stessa, e solo su un
secondo piano quelli che sono oggetti di repressione”9. La regolamentazione e
l’amministrazione della povertà non fanno altro che descrivere e mettere in pratica le
varie concezioni della povertà e le reazioni collettive che, nel corso dei secoli, si sono
trasformate; ma i cambiamenti e le trasformazioni non vanno in una sola direzione. Gli
atteggiamenti socio-psicologici cambiano molto lentamente, tanto da sembrare radicati
nella natura umana e nelle basi biologiche della vita sociale10. Per cui il gesto
caritatevole di dare l’elemosina non è stato sostituito con una minaccia di impiccagione
per i mendicanti: tale minaccia e tale gesto coesistevano attraverso periodi di debolezza
e di forza, di ascesa e di caduta; ad esempio se è soprattutto in epoca moderna, periodo
in cui le città iniziano a popolarsi di mendicanti, vagabondi, prostitute, poveri, che viene
applicata una legislazione repressiva contro il vagabondaggio, in età medioevale,
nonostante non vi siano state delle vere e proprie “politiche” di lotta alla povertà nel
vero senso della parola, in quanto la carità cristiana costruiva un rapporto personalizzato
tra colui che dava e colui che riceveva11, è da mettere in evidenza l’ambivalenza degli
atteggiamenti verso i poveri determinata dalla predicazione cristiana stessa. Infatti nel
medioevo, nei confronti del povero la compassione si accompagnava all’odio, il
disprezzo alla paura, l’assistenza caritativa alla repressione. In questa epoca la Chiesa
ispirò atteggiamenti molto diversi: dalla condanna della miseria all’esaltazione della
povertà, dall’elogio della misera vita fatta di elemosina al richiamo dell’ethos del
lavoro. Nonostante ciò il povero aveva comunque una propria funzione sociale:
l’elemosina costituiva uno strumento per la redenzione dei peccati e la presenza dei
poveri nella “società cristiana” determinava la realizzazione del progetto della salvezza.
Tuttavia alle soglie dell’età moderna , nei modelli e nella pratica sociale, si verificò un
sostanziale cambiamento nei confronti della miseria. Tale cambiamento veniva
presentato dai vari studiosi in modi diversi a seconda del modo di concepire l’essenza
9
B. Geremek, “L’emarginato”, in J. Le Goff (a cura di), L’uomo medioevale, Laterza, Bari, 1987, pp.391421.
10
Cosi in B. Geremek: “E’ molto più facile individuare un cambiamento nelle tecniche di procurarsi il
cibo, nei mezzi di trasporto, nel modo di combattere, nelle forme di governo, che non nei sentimenti delle
persone, nella loro sensibilità e immaginazione. Non è un problema d’indagine, di documentazione
adeguata o di tecniche di ricerca: è una questione propria della materia di indagine, in cui le divisioni
cronologiche si confondono, le differenze risultano sfumate e i cambiamenti non vanno in una sola
direzione.” B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, 1995, Bari, p. 13.
11
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico- sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi ( a cura di ), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995.
16
della “svolta moderna”, per cui esso veniva collegato alle trasformazioni religiose
dell’epoca, alla cultura del Rinascimento, oppure ai processi della nascita della società
capitalista. La nascita dello stato moderno, come vedremo, segnò anche l’inizio di una
nuova fase della politica sociale.
1.1. Le “leggi sui poveri” tra il XVI e il XVIII secolo
Le trasformazioni del sistema rurale, cui modello più noto è quello inglese, il così detto
fenomeno delle recinzioni (enclosures), portarono ad uno spostamento massiccio dalle
campagne verso le città: qui le possibilità di un lavoro saltuario furono molto grandi;
per cui i poveri provenienti dalla campagna, quale prodotto della decomposizione dei
vecchi rapporti, costituirono una riserva potenziale di formazione del proletariato.12 Tra
il XV e il XVI secolo però le città furono incapaci di disciplinare il massiccio afflusso
di persone prive di qualifiche professionali e non abituate alla vita urbana. In particolare
gli anni venti del XVI secolo furono molto critici: la carestia tra il 1526 e il 1535
accentuò il conflitto fra l’incremento demografico e la penuria di cibo e fu proprio in
questo periodo che iniziarono le distinzioni all’interno della “categoria” povertà,
distinzioni tra poveri abili al lavoro e non; per cui vennero adottate misure per ripulire le
città dalle folle dei miserabili, i vagabondi vennero puniti con frustate. In questa
situazione così complessa, il problema dei poveri si presentava sotto due aspetti: da un
lato le città dovevano fronteggiare le masse di miseri affamati che arrivavano dai
dintorni, dall’altro si pose la necessità di mettere ordine nell’organizzazione
dell’assistenza ai mendicanti, di fissare le regole e le istituzioni di assistenza sociale.
Anche L’Italia,
non venne risparmiata dalla crisi: la fame, il morbo e la guerra
devastarono l’Italia settentrionale e centrale e anche qui, come in tutta Europa, la fame
spinse la popolazione dalle campagne verso le città. Questo a Venezia : “è immensa la
folla dei poveri; a causa della gran fame che regna nel paese, molti vagabondi si sono
decisi di giungere qui, insieme ai bambini, in cerca di cibo. (…) Non si può assistere in
pace ad una messa, senza che una dozzina di mendicanti non ti circondi e chieda aiuto,
12
In città quindi la “povertà” non è indice della destrutturazione del tradizionale sistema di vita urbana,
quanto della formazione di un sistema nuovo. A tal proposito si veda B. Geremek, La pietà e la forca,
Laterza, Bari, 1995.
17
non si può aprire la borsa, senza che subito un poveraccio non ti si avvicini, chiedendo
un denaro.”13
La minaccia di epidemie portarono ad adottare misure per isolare i poveri. Le autorità
cittadine ordinarono che l’elemosina dovesse essere concessa solo a coloro che avevano
una speciale licenza di mendicare, concessa dalle parrocchie. Senza di questa si
rischiava la prigione e la frusta. Continuando a descrivere la situazione nella città di
Venezia, nel 1528 si decise, grazie a varie proposte
preparate da un’apposita
commissione, di costruire tre o quattro ospizi provvisori o ricoveri per i poveri dato che
veniva vietato l’accattonaggio per le strade e per le case, pena la prigione, la frusta e
l’espulsione dalla città. La medesima situazione troviamo in altre città italiane: a Roma,
ad esempio, nella seconda metà del XVI secolo, i pontefici intrapresero misure allo
scopo di sanare la situazione della città, per cui oltre all’espulsione dei vagabondi, vi fu
il divieto di mendicità pubblica per le strade, pena la reclusione o l’invio sulle galere per
chi commetteva infrazioni del divieto. A Venezia, per mantenere gli ospedali-ospizi
volti ad accogliere i mendicanti14, venne istituita un’apposita tassa , raccolta nelle
parrocchie dal parroco e da due assessori laici e consegnata poi nelle mani dei
Provveditori alla sanità. Questo provvedimento, che può essere considerato la prima
“legge sui poveri”, mette in luce i primi interventi del potere pubblico nei confronti di
una problematica considerata e consegnata “da sempre” nelle mani della Chiesa. Un
anno dopo la prima “legge sui poveri” venne promulgata a Venezia un’altra normativa.
“Nell’aprile 1529 il Senato emana un provvedimento che spiega, nel preambolo i
principali intenti del governo: assicurare un’assistenza ai poveri, aiutare i malati, dare il
pane agli affamati, ma al tempo stesso non favorire il parassitismo di coloro che sono in
grado di guadagnarsi da vivere con il sudore della fronte.”15 I mendicanti furono quindi
distinti tra abili al lavoro, malati e inabili: i primi dovevano essere indirizzati al lavoro,
gli altri dovevano ottenere i regolari aiuti ma non era permesso loro chiedere
l’elemosina per le vie della città. Il nuovo provvedimento non attuò una
riorganizzazione delle istituzioni caritative: i monasteri, gli ospedali e le confraternite
continuavano a svolgere le attività di beneficenza in favore dei poveri ma significativo
fu che, per quanto riguardava le autorità municipali, il problema dei poveri venne
gestito dagli ufficiali sanitari, ciò confermava “il perdurare di un legame fra la politica
13
Ibidem, p.137.
In seguito in alcuni ospizi non vennero più accolti i mendicanti provenienti da altre località.
15
Ibidem, p.140.
14
18
sociale nei confronti dei poveri e le preoccupazioni per l’igiene pubblica.”16
Sicuramente però, l’elemento che qui più ci interessa sottolineare, è che le iniziative che
nelle varie città europee vennero intraprese nel corso della crisi tra il 1527 e il 1529,
furono di carattere repressivo piuttosto che caritativo. Ritornando in Italia e in
particolare al caso specifico di Venezia, quando la crisi passò, la operatività dei
provvedimenti si affievolì; nel corso delle successive annate difficili vennero adottate
misure analoghe. “Tuttavia proprio nel corso della crisi 1527-29 è avvenuto un
sostanziale mutamento
negli atteggiamenti
psicologici,
che,
senza
intaccare
minimamente la tradizionale dottrina cristiana della carità, e conservando pienamente il
principio dell’atto di carità individuale con il suo valore volontario, ha permesso al
tempo stesso di mettere in moto un insieme di mezzi di carattere repressivo nei
confronti dei poveri.”17 Le decisioni degli anni Venti del XVI secolo in merito alla
riorganizzazione dell’assistenza dei poveri, possono essere considerate come il punto di
partenza di una nuova politica sociale caratterizzata da livelli di sistematicità e
pervasività dell’intervento pubblico del tutto inediti rispetto al passato. Le “leggi sui
poveri” costituivano il banco di prova delle capacità politiche e amministrative degli
stati di recente formazione nell’affrontare una povertà che non era più un fenomeno
endemico o congiunturale, ma affondava le radici nelle trasformazioni stesse
dell’economia.18 Per molti aspetti il dato più saliente è da ravvisare nelle condizioni di
necessità che imposero ai pubblici poteri di attivare comunque, accanto alle azioni
repressive nei confronti delle “classi pericolose”, forme nuove di protezione, pena il
collasso dell’ordine sociale; le cause dell’insicurezza erano cambiate: ai fattori naturali
e politici della dipendenza si erano aggiunti, ben più temibili, quelli economici e sociali.
Come abbiamo in precedenza sottolineato, l’idea che i poveri dovessero essere
rinchiusi, separati dalla società era sorta già alla metà-fine del XVI secolo, ma è
soprattutto nel XVII secolo che si diffuse. Fu in questo periodo che in tutta Europa
iniziò “la reclusione dei poveri in istituti che sono a un tempo ospedali, case di
correzione e talvolta opifici.”19
Nel 1601 venne approvata in Inghilterra la prima Poor Law che, seppure sottoposta a
continui emendamenti, rimase in vigore fino al 1834. Carità e ordine pubblico furono i
16
Ibidem, p.142.
Ibidem, p.142.
18
A tal proposito si veda F. Girotti, Welfare state, Carocci, Roma, 2000.
19
J. P. Gutton, La società e i poveri, Mondatori, Verona, 1977, pp. 99-100.
17
19
principi guida di questa legge;20 essa manifestava il punto di riferimento dal quale far
partire effettivamente le basi dell’assistenza pubblica: la chiesa e le istituzioni private
caritatevoli non furono più le sole ad occuparsi della miseria e della povertà. Con questo
non dobbiamo pensare che la beneficenza individuale fosse sparita, essa perdurò e
perdurerà ininterrottamente fino ai nostri giorni. A partire dalla Riforma però,
soprattutto nei territori a dominanza protestante, troveremo un predominio
tendenzialmente crescente del settore pubblico e laico nella gestione della povertà. “La
necessità che si impone in Europa in epoca moderna è quella di separare il povero dalla
società, in quanto elemento asociale e pericoloso. La segregazione risponde anche ad
una esigenza di tipo correttivo, tende a creare le condizioni del reinserimento del
povero nella società. Il lavoro coatto, oltre ad una funzione sussidiaria di tipo
economico, ha in primo luogo un significato morale. La severità con cui il lavoro viene
imposto ai segregati mira a creare una nuova disciplina in coloro che ne erano
completamente privi. Sembra che questa nuova politica si trovi in sintonia con l’etica
protestante del lavoro sempre più diffusa nelle regioni in via di industrializzazione”.21
Anche in Italia, fortemente cattolica invece, si levarono atteggiamenti di ostilità nei
confronti dei mendicanti, tanto che verso questi e i vagabondi venne adottata
prevalentemente una politica repressiva influenzata, per la maggior parte, dal
programma controriformista di miglioramento della vita cristiana. Il vagabondaggio e la
mendicità violavano l’ordine interno della divisione dei ruoli sociali, creavano aree che
sfuggivano alla “polizia”, generavano inquietudini, incertezze e minacce per l’ordine
pubblico. La mendicità si presentava come una condizione contraria ai costumi cristiani
ma anche come una violazione delle norme di convivenza sociali, come un elemento di
pericolo sociale.22 Soprattutto però, nei paesi che imboccavano la via dello sviluppo
capitalistico, la reclusione dei poveri in generale e dei mendicanti in particolare, era
legata ad una affermazione dimostrativa dell’ethos del lavoro ma anche all’evoluzione
della moderna dottrina penale.23
20
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di ), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 38.
21
Ibidem, p. 41.
22
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 220.
23
Anche se già alla fine del medioevo si osservano le condanne alla prigione, è solo alla fine del secolo
XIX che in Europa si comincia a trattare la prigione come pena, o persino come base di tutto il sistema
penale. M. Foucault in Sorvegliare e punire (1975), ha dimostrato quanta importanza ebbe questo
mutamento nella tecnologia del potere e nella concezione della “pena” e dell’”espiazione” all’interno
della coscienza sociale. Prima però che la prigione diventasse un mezzo su vasta scala per la punizione
20
“La privazione della libertà e il lavoro coatto si uniscono in un embrione di politica
socializzante e si rivolgono sia verso i delinquenti che verso i miserabili senza
lavoro.”24
Ritorniamo ora a parlare della Poor Law del 1601 in Inghilterra: quest’ultima ebbe
molta importanza non solo perché diede l’avvio dell’intervento pubblico, ma soprattutto
perché diede sistematicità a quell’intervento. Imposto il divieto assoluto di mendicare e
intensificando l’azione repressiva, anche attraverso la creazione di appositi corpi di
polizia, questa legge prevedeva un ambizioso piano di istituzionalizzazione dei poveri.
Agli indigenti privi di lavoro era fatto obbligo di sottoporsi ad un test di povertà,
consistente nella verifica della disponibilità all’internamento in strutture residenziali,
quale condizione per la fruizione dei soccorsi previsti, ma ciò che soprattutto interessa
al nostro discorso è che l’intento di questa legge era anche di stabilire, con rigido
metodo classificatorio, l’origine del bisogno assistenziale, in modo da consentire lo
smistamento verso tre tipi diversi di istituzione. Per i poveri impossibilitati al lavoro,
perché anziani, malati o disabili, era previsto il soccorso domiciliare con sussidi in
denaro o il ricovero in ospizi di mendicità. I poveri validi dovevano essere avviati al
lavoro per iniziativa delle workhouses, strutture che in assenza di lavoro esterno
avevano il compito di organizzarlo all’interno, assumendo così tutti i tratti, più ancora
che dell’opificio, di istituzioni totali dai severi caratteri disciplinari. Infine e qui
torniamo al tema della nostra ricerca, i poveri cosiddetti “oziosi” che avessero opposto
un rifiuto al lavoro erano destinati alla reclusione in case di correzione. Questa
alternanza di punizione ed educazione dei poveri attraverso il lavoro proveniva dalla
contemporanea riforma della carità; la costrizione al lavoro doveva realizzare i compiti
di educazione socio-religiosa, si trattava di un’educazione al rispetto del lavoro,
affermare l’ethos del lavoro e assicurarne la diffusione attraverso la paura, la minaccia e
la violenza25; per cui il carattere spettacolarmente repressivo, assunto dall’assistenza
dei delinquenti, L’Europa moderna l’aveva adoperata come strumento di realizzazione della politica
sociale nei confronti dei mendicanti.
24
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 227.
25
Costringere i miserabili e gli oziosi a lavorare non era tanto una necessità economica, quanto
soprattutto un dovere. La reclusione negli ospizi non solo permetteva l’insegnamento dell’ethos del
lavoro, ma soprattutto permetteva di distinguere, in questo modo, i “veri poveri” da quelli che si
fingevano tali per scansare la fatica di un lavoro regolare. “Solo i primi avrebbero accettato di finire in un
ospizio, se le condizioni di vita al suo interno fossero state abbastanza raccapriccianti. Limitando così
l’assistenza entro le mura di questi squallidi luoghi, non vi era più bisogno di alcun accertamento del reale
stato di necessità. I poveri stessi avrebbero provveduto ad autoselezionarsi, giacchè soltanto coloro che
non avevano altro mezzo per sopravvivere potevano rassegnarsi ad essere rinchiusi in questi istituti.”
Zygmunt Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta, Troina, 2004, p. 30.
21
sociale nei tempi moderni, ebbe una sua funzione ideologica. Nel corso del XVIII
secolo l’unione di repressione e carità, realizzata nel XVII secolo, divenne oggetto di
una diffusa critica. La nuova “Legge sui Poveri” del XVIII secolo infatti, non solo ebbe
come primo obbiettivo la diffusione dell’etica del lavoro, essa tracciava una netta linea
di demarcazione “oggettiva” fra chi poteva essere convertito al rispetto dei principi
dell’etica del lavoro e chi invece era assolutamente irrecuperabile e non poteva rendere
alcun servizio alla società.26 L’assistenza sociale doveva isolare i vagabondi di mestiere,
punirli come delinquenti con la prigione e separarli dai poveri che avrebbero dovuto
ricevere invece aiuti organizzati e occupazione. Di qui la “reclusione dei mendicanti,
nell’animo della gente dell’epoca, si associava alle iniziative carcerarie di vario genere:
i mendicanti figuravano anche fra i delinquenti, deportati nelle galere.”27
Nonostante la tendenza nei confronti dei ceti “pericolosi” fosse stata prevalentemente di
tipo repressivo, non dobbiamo pensare che il sentimento caritativo fosse del tutto
sparito: infatti essa coesistette con un atteggiamento di attiva compassione verso i
poveri che trovò un nuovo impulso nelle idee umanitarie dello stesso XVIII secolo.
L’illuminismo, che stabiliva un legame fra progresso sociale e sentimento di solidarietà
umana e che considerava l’istruzione di fondamentale importanza per superare gli
ostacoli al progresso, vedeva la miseria come il risultato dell’ignoranza dei poveri e
della mancanza di solidarietà dei ricchi28. La promozione di atteggiamenti protettivi si
esprimeva soprattutto nello sviluppo delle scuole per bambini poveri. Si poneva
l’accento soprattutto su una forma di beneficenza privata per il funzionamento delle
scuole caritative e di altre forme di aiuto ai poveri. Questa coesistenza tra atteggiamento
repressivo e atteggiamento caritativo la troveremo anche nei secoli successivi, fino ai
nostri giorni29.
26
Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta, Troina, 2004, p. 30.
Ibidem, p. 240.
28
Thomas Paine a tal proposito scriveva: “C’è qualcosa di sbagliato nel sistema di governo quando
vediamo che i vecchi vengono mandati nelle case di lavoro ed i giovani sulle forche. Le apparenze
sembrano attestare in quei paesi una felicità completa, ma davanti agli occhi di un osservatore medio
rimane celata una massa alla quale non rimane altro che morire di fame e di infamia. I miserabili entrano
nella vita già marchiati dal preannuncio del loro destino; non si deve punirli, finchè non verranno adottate
misure preventive contro la miseria.”
29
“Studiando (…) le motivazioni dei comportamenti umani e le manifestazioni dei sentimenti (e non i
sentimenti stessi), lo storico può constatare che certi comportamenti e sentimenti riscuotono in alcuni
periodi un maggiore consenso sociale degli altri, che esistono cioè <addensamenti> e <diluizioni> sui
generis nelle loro manifestazioni. (…) Il sentimento di carità, l’aiuto ai poveri, la pietà verso gli infelici
ed i bisognosi, sembrano essere valutati positivamente in modo duraturo nella civiltà europea. Malgrado
questo, alle soglie dell’età moderna la forca ha steso la sua ombra su quei sentimenti.” In B. Geremek, La
pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, pp. 263-264.
27
22
1. 2. I cambiamenti del XIX e del XX secolo
Nell’Ottocento il divario che già cominciava a istaurarsi tra povertà e mendicità si fece
sempre più profondo. La povertà continuava a rimanere una dimensione costitutiva
delle classi popolari, ma certi suoi attributi (volontarietà, abitualità a condotte
antisociali) saranno specifici solamente delle sue forme estreme: ozio, vagabondaggio,
accattonaggio. La linea di confine tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli, tra
classi lavoratrici e classi pericolose, tra povertà operose e povertà oziose, ereditata
dall’epoca moderna, si venne quindi ad approfondire.30
Se la presa di coscienza della società civile nei confronti della miseria aveva portato nel
XVIII secolo alla formazione di una politica sociale dello stato che si realizzava come
tendenza a formare un sistema statale dell’assistenza oppure come controllo dello stato
sulle istituzioni caritative, nel XIX secolo esso venne limitato nel nome della dottrina
del liberalismo. Un atto deliberato nel 1834 dal parlamento inglese ad esempio,
denominato “nuova legge sui poveri”, manifestò la piena vittoria del principio di
assoggettamento dell’assistenza sociale agli interessi del mercato del lavoro: gli aiuti ai
poveri erano considerati controproducenti, se offrivano la possibilità di vivere senza
lavorare, per cui nelle case di lavoro vigeva una disciplina carceraria, quale strumento di
intimidazione. La politica dell’assistenza sociale doveva essere limitata al minimo. Il
povero accettato socialmente era l’individuo che lavorava e, se privo di lavoro, lo
doveva essere temporaneamente e non per propria scelta. “Lavorare o perire”31!
L’assistenza pubblica si occuperà, attraverso i vari ricoveri di mendicità, soltanto di
coloro inabili al lavoro, gli abili al lavoro verranno destinati al carcere.
Istituzionalizzazione e criminalizzazione. Una società che fondava le sue radici sul
lavoro non poteva permettere la vista dell’ozioso, del vagabondo, di colui che vive di
elemosina, oltre ciò chi non lavorava sfuggiva al controllo, non era sorvegliato né
soggetto a una routine meccanica imposta attraverso sanzioni: la fabbrica.
Il collegamento fra miseria e questione operaia venne sempre più specializzandosi o
meglio, all’interno della categoria dei miserabili si vennero sempre più a creare delle
sotto-categorie. Il mendicante, il vagabondo non poteva più essere equiparato
all’operaio. Sempre più si venne delineando un modello di cittadinanza fondato sulla
30
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 43.
31
Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta, Troina, 2004, p.28.
23
quasi totale coincidenza dello status di lavoratore con quello di cittadino. Nell’Europa
Occidentale, dopo la seconda guerra mondiale, quasi tutti gli individui arrivarono ad
essere coperti da sistemi di protezione la cui storia sociale mostra che nella maggior
parte dei casi
furono costruiti a partire dal lavoro32 (pensiamo ad esempio alla
pensione). Le prime leggi sulla previdenza sociale per i lavoratori che furono varate in
Germania da Bismark tra il 1883 e il 1889, diedero infatti il via ad un sistema di
protezione in cui l’accesso era permesso solo ai lavoratori salariati, sistema che nel
corso del ‘900, si estenderà a sempre più vaste categorie di bisogni e di rischi.
L’assistenza invece divenne sempre più residuale: essa doveva essere circoscritta a
quanto rappresentava un puro “stato di bisogno” e comunque suppletiva ed ausiliaria
rispetto ad altre forme di intervento (privato-caritativo, famiglia). Una persona veniva
assistita quindi solamente se poteva provare il suo “stato di “bisogno” e se non vi era
altra persona della famiglia o istituzione privata che la poteva soccorrere. Per
determinare lo “stato di bisogno” del soggetto, venne istituita una complessa rete di
controllo finalizzata a distinguere il vero indigente da colui che non era ritenuto tale, il
povero invalido dal povero valido, quello meritevole da quello non meritevole.33 Se da
un lato si andava sempre più sviluppando una forte coscienza di classe degli operai,
dall’altra i mendicanti, i vagabondi, coloro che non vivevano del lavoro salariato,
divennero sempre più “esclusi”34, tanto che le organizzazioni caritative stesse vennero
sempre più trattate con crescente ostilità. Il mendicante venne sempre più visto come il
responsabile della propria condizione anteponendo l’ozio al lavoro, rifiutando i valori
comuni, assumendo comportamenti anti-sociali, pertanto venne ritenuto inutile e per di
più pericoloso.
Ritornando alla seconda metà dell’800, ricordiamo l’importanza che ebbe il contributo
della scienza medica, e di quella psichiatrica in particolare, per classificare e definire i
poveri oziosi: una diversità nei e dei comportamenti, rivelava una diversità organica.
“Poveri, folli, vecchi e degenerati presentano tutti dunque uno sviluppo organico minore
di quello degli agiati, dei normali, dei sani”35. L’instabilità, l’irrequietezza, l’incapacità
32
R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004, p.29.
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 48.
34
“ < Gli esclusi> non sono collettivi, ma collezioni di individui, i quali non hanno in comune nient’altro
che la condivisione di una stessa mancanza. Essi sono definiti su una base unicamente negativa, come se
si trattasse di elettroni liberi, completamente desocializzati.” In R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi,
Torino, 2004, p. 48.
35
A. Niceforo, Antropologia delle classi povere, Vallardi, Milano, 1908, p. 211.
33
24
nei confronti di qualsiasi attività di tipo continuativo e metodico, caratteristiche che
spesso erano presenti nel vagabondo, rivelavano anche una deficienza organica.
L’antropologia criminale e la sociologia criminale di impronta positivista, favorirono
l’emergenza dell’immagine di un mondo a parte cui vennero riservati un trattamento a
parte e delle istituzioni separate (manicomi, carceri…). In questo senso la scuola
positiva italiana darà un importante contributo: non era sufficiente studiare il “delitto”
quale l’ozio, il vagabondaggio, l’accattonaggio, ma occorreva prendere in esame il
“delinquente”, quindi l’ozioso, il vagabondo, l’accattone in quanto nell’individuo
medesimo venivano individuati “i caratteri biopsichici” del delitto36; l’esigenza di
definire una realtà sociale all’apparenza imprevedibile e priva di contorni, trovava
quindi nell’approccio della scuola positivista importanti risposte, in particolare che i
segni della pericolosità sociale erano iscritti nel corpo e nella mente della persona e che
determinate condotte di vita di tipo antisociali, quali l’ozio o vagabondaggio, erano
l’espressione di uno stato patologico. “Ciò che informa in Europa l’istituzione di nuove
forme di trattamento della povertà nel corso del XIX secolo, e la relativa legislazione, è
il concetto di <pericolosità sociale>, la minaccia all’ordine. (…) Il vagabondaggio, la
mendicità, l’ozio, sono ancora la metafora di un mondo capovolto che vagando di luogo
in luogo minaccia di contaminare l’intero territorio.”37Da qui l’imposizione al
vagabondo di “fissare stabilmente la propria dimora”, l’internamento del mendico nel
ricovero di mendicità, l’imposizione all’ozioso di un lavoro. Alla fine dell’800, si
assistette ad una sempre maggiore ingerenza dello Stato nella beneficenza , ad un
rafforzamento della responsabilità degli amministratori locali, ad un accrescersi di
controlli. La distinzione tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli, da tempo
presente nella normativa di tutti i paesi europei, divenne sempre più rigida e venne
perseguita nelle pratiche di intervento istituzionali.38 Il lavoro che nell’arco di tutto
l’800 occupava un posto centrale ed era la base delle pratiche di intervento assistenziale,
costituiva un elemento moralizzatore, ma nel corso del ‘900, questa volontà di
ricostruire un “ordine morale” venne abbandonata e gli istituti di ricovero e accoglienza
36
“Gli antropologi e gli alienisti si accordano nel notare che degenerati d’ogni sorta sono numerosissimi
tra i vagabondi e i mendicanti e che l’inferiorità fisica e mentale di costoro non è soltanto l’effetto
dell’ambiente in cui essi vivono od hanno vissuto, ma anche, o assai spesso, l’espressione di tare
congenite.” In A. Niceforo, Antropologia delle classi povere, Vallardi, Milano, 1908.
37
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, pp. 52-53.
38
Ibidem, p. 53.
25
rimasero sempre più solamente luoghi di contenimento per sottrarre allo sguardo
pubblico l’indigenza.
Dunque, l’imponente tentativo di disciplinare e di mettere al lavoro gli “oziosi e
vagabondi”, o comunque di neutralizzare il potenziale eversivo, avviatosi in tutta
Europa, è potuto proseguire in evo moderno, solo grazie a determinate costruzioni
concettuali che consentissero, in un quadro giuridico formalmente egalitario, di
stigmatizzare come pericolose socialmente le esistenze e gli stili di vita non
sufficientemente “ordinati” e “laboriosi” delle classi marginali. Infatti è possibile
sostenere che il principale compito del sistema di controllo penale moderno fu non una
semplice risposta alla criminalità, bensì il governo delle classi subalterne, proprio
perché esso fu dotato, sin dalla sua origine, di un insieme di meccanismi polizieschi che,
anziché colpire l’infrazione di una norma o la lesione di un bene giuridico, erano in
grado di sanzionare un complesso stile di vita. In questo contesto, i flussi di forza lavoro
diretti verso i nuovi agglomerati industriali, poterono essere disciplinati e costretti ad
accettare le condizioni di lavoro e di vita che la struttura sociale offriva loro. Quanti
manifestavano una conflittualità più o meno esplicita, rifiutando la rigida disciplina
impostagli, potevano essere sanzionati anche del tutto indipendentemente dalla
commissione di un reato, sul presupposto che l’ozio, il vagabondaggio, la
disoccupazione e la povertà, fossero in sostanza il luogo di coltura di tutti i peggiori
mali per una società civile ed ordinata. Grazie quindi ai pervasivi strumenti di
criminalizzazione della miseria, sorretti da una concezione stigmatizzante della povertà,
si riuscì a disciplinare e governare il proletariato in formazione. Questa realtà perdurò
fino a tutto il XIX secolo ed ancora nei primi decenni del XX secolo, fintanto che
prevalse una certa visione liberista dello Stato e dei rapporti sociali. A metà Novecento,
con il diffondersi invece dell’idea che lo Stato avrebbe dovuto farsi carico di tutta una
serie di funzioni di assistenza nei confronti del mondo della “marginalità sociale” ed, in
particolare, dell’idea che la povertà e l’emarginazione non fossero tanto il frutto di una
deficienza dell’individuo cui rispondere severamente per mezzo dell’intervento penale,
ma piuttosto il portato di ragioni strutturali su cui si aveva il dovere di intervenire con
adeguati strumenti di compensazione degli squilibri sociali, il ruolo riservato alle
agenzie penali venne progressivamente restringendosi. La struttura delle società del XX
secolo fu progressivamente più aperta rispetto all’integrazione politica e sociale delle
masse popolari, anche perché tanto il livello di benessere, che le capacità del sistema
produttivo di assorbire manodopera si andarono amplificando notevolmente. In tutto ciò
26
anche l’immagine del povero venne mano a mano modificandosi: da pericoloso
attentatore dell’ordine sociale, divenne sempre più un soggetto bisognoso di aiuto.
Ad oggi però, possiamo ipotizzare che la nostra struttura sociale possa assomigliare
sempre più pericolosamente alle società del XIX secolo. Lo Stato abbandona le sue
funzioni di assistenza, pretendendo di rendersi più “snello”, mentre quella cittadinanza
sociale “conquistata” nel corso del XX secolo crolla sempre più rapidamente facendo
ricomparire livelli di disuguaglianza sociale che si credevano scomparsi. “Studi recenti
evidenziano le correlazioni sussistenti tra l’esclusione sociale e le profonde
trasformazioni economiche che attraversano le società industriali. (…) Nella seconda
metà degli anni settanta la società salariale, che ha conosciuto il suo apogeo nei
trent’anni consecutivi alla seconda guerra mondiale, entra in crisi nel momento in cui si
affacciano e si diffondono nuove forme di precarietà e aumenta massicciamente la
disoccupazione di lunga durata. Il lavoro risulta sempre meno protetto e un numero
crescente di persone perde i supporti che ad esso erano tradizionalmente legati (…).
Queste stesse persone perdono simultaneamente anche una posizione sociale e i punti di
riferimento per la costruzione della propria identità.”39 Nascono, nelle nostre metropoli,
nuove forme di povertà40 che non necessariamente rappresentano la fascia più bassa di
povertà. La povertà urbana estrema può essere definita come “Una sequenza di rotture
biografiche che interessano sia la personalità che il tessuto sociale”41 e la
“decomposizione ed abbandono del sé, cioè il carattere distintivo della povertà urbana
estrema, è connessa con il decisivo, ma progressivo, ritiro che l’individuo estremamente
povero porta a termine nei confronti del mondo esterno, della propria famiglia, degli
amici.”42
E’ da questa definizione che bisogna partire per poter “comprendere”. E’ da questa
definizione che dovrebbe muoversi il sistema assistenziale. Oggi la risposta alla
domanda “perché un individuo è povero , nelle società occidentali, sembra dunque
richiedere una nuova prospettiva, poiché non è esauriente rispondere : perché nasce
povero; e neppure pare adeguata la risposta : perché ha meno chance. Il problema (…) è
che dare chance a chi non le sa usare o non le vuole usare è una risposta, tutta borghese
e welfaristica, che presuppone che l’omologazione abbia penetrato la barriera del
39
M. Bergamaschi, “Emergenza di una nozione: l’esclusione come paradigma della coesione sociale.
Dalla povertà alla società duale”, in TRA, n. 3, 1999.
40
“(…) pluralità di forme differenziate di povertà distribuite sul territorio”, P. Guidicini, G. Pieretti, M.
Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 12.
41
Ibidem, p. 12.
42
Ibidem, p. 13-14.
27
sistema della personalità di tutti e che tutti siano pronti a correre”43. Occorre quindi per
primo osservare e poi affrontare il problema da un’altra prospettiva.
43
G. Pieretti, “Dalla povertà ai poveri: processi culturali e implicazioni di senso”, in P. Guidicini, G.
Pieretti (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, p. 38.
28
2. LA MENDICITA’ NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA NEL XIX
E XX SECOLO
Nell’Italia della prima metà del secolo XIX mancavano le condizioni per una drastica
rottura del sistema assistenziale ereditato dalla società tradizionale. Al ritardo nel
processo di sviluppo e di industrializzazione, faceva riscontro un più generale ritardo
delle dinamiche di modernizzazione, a cominciare dalla sfera religiosa e culturale. Un
paese che non aveva conosciuto la Riforma protestante, sperimentando piuttosto la
continua azione di contrasto condotta dalla Controriforma per neutralizzare le valenze
politicamente più dure del processo di secolarizzazione, non poteva che disporsi, in
ambito assistenziale, ad una lunga convivenza con il privato-religioso. Anche in Italia
però, la “linea di confine tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli, tra classi
lavoratrici e classi pericolose, tra povertà operose e povertà oziose, ereditata dall’epoca
moderna”44 venne ad approfondirsi. Già in uno scritto del 1834, dal titolo “Qualche
cenno sulla mendicità e sui mezzi per estirparla”45, l’autore dopo aver descritto la
mendicità “quale piaga schifosa del corpo sociale, produttrice di una enorme congerie di
mali” 46 e il mendicante quale “essere utile a nessuno”47, citando un economista italiano
del tempo, provò ad identificare le cause della povertà. Il fatto che le cause fossero tra
loro diverse, portò necessariamente a creare delle categorie di poveri differenti tra loro.
Le ragioni della povertà vennero attribuite:
1. alla mancanza di forze fisiche o intellettuali;
2. al difetto d’impiego delle forze per mancanza di lavoro, di capitali o di credito;
3. alla mancata corrispondenza tra lavoro e guadagno;
4. alla mancanza di volontà.
Accanto alle cause di tipo strutturale-sociale, quali la mancanza di lavoro che a sua
volta creava (e crea ancora) una mancanza di capitale e di credito, e la mancata
corrispondenza tra lavoro e guadagno, troviamo due cause di tipo strettamente
personali: l’inabilità fisica e intellettuale che non permetteva l’accesso al mondo del
lavoro e quindi metteva la persona in uno stato di povertà e la mancanza di volontà,
44
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 43.
45
G. Pomba, Qualche cenno sulla mendicità e sui mezzi per estirparla, Torino, 1834.
46
Ibidem, p.7.
47
Ibidem, p.20.
29
volontà di lavorare per preferire una vita dedita all’ozio. Fu proprio questa causa a
definire la “categoria”48 dei poveri oziosi, quali vagabondi, accattoni, mendicanti;
sostantivi che avevano quindi tutti un’accezione profondamente negativa. Pensiamo
quanto sia distante ormai questa immagine da quella presente nella civiltà medioevale
che aveva celebrato la povertà come una virtù e il povero che concorreva alla
redenzione degli uomini ricchi che facevano l’elemosina, come vicarius christi.
L’elemosina stessa, dall’età moderna in poi venne fortemente criticata: essa non faceva
altro che fomentare l’ozio. Nel “Codice Penale sardo-italiano” del 1859 si ritrovavano
richiami ad una lettura punitiva della mendicità secondo criteri di equità ed umanità.
Difatti, dalla considerazione che la mendicità punibile “non si fonda su una necessità
flagrante”, ma è tale in quanto “conseguenza dell’infingardaggine e della scioperatezza”
si perviene ad interpretare successivamente anche le disposizioni contenute nel codice
Zanardelli dove si enunciava che la legge voleva punire “la mendicità colpevole e
viziosa” e non “quella che un estremo bisogno autorizza e la pietà assolve”. La
distinzione tra mendicanti validi ed invalidi, ai fini della punibilità, nonostante venga
abbandonata, come vedremo, nel codice Rocco, sarà presente anche in legislazioni più
recenti. Ritornando al codice del 1859, è significativa la collocazione data alla
mendicità, nell’abito del Tit. VIII, Lib. II, “Dei reati contro la pubblica tranquillità”, il
cui Capo III era così formulato: “Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone
sospette”. Seguiva conseguentemente, ai sensi dell’art. 447, la considerazione dei
mendicanti validi, al pari degli oziosi e vagabondi, quali “persone sospette”, mentre la
punibilità della condotta veniva espressamente prevista agli artt. 442 s., secondo
l’enunciato: “Niuno potrà andare pubblicamente questuando… salve le speciali
disposizioni della legge di Pubblica sicurezza”. Queste ultime, oggetto della legge 20-31865, agli artt. 67 s., prevedevano tra l’altro che gli individui “non validi al lavoro” e
sprovvisti di mezzi di sussistenza, ricevessero dall’Autorità municipale un certificato di
indigenza ed inabilità al lavoro, certificato che, con il visto dell’Autorità politica,
sarebbe valso “come permesso di mendicare”; per cui la mendicità veniva sì tollerata
(solo per coloro però inabili al lavoro), ma diventò oggetto di una licenza specifica, per
cui divenne oggetto di controllo. Controllo che costituiva una forma di tutela dell’ordine
e allo stesso tempo un segno visibile del degrado della persona, un’etichetta. Con la
legge N. 5888 del 23/12/1888 sulla Pubblica sicurezza invece si arrivò alla generale
48
“Sono finalmente poveri per volontà tutti coloro che preferiscono scroccare accettando e fingendo
malattie o disgrazie immaginarie anziché faticare onoratamente per guadagnarsi il pane”. In Ibidem p. 13.
30
proibizione della mendicità e quindi all’abolizione del permesso di mendicare.
Attraverso questa legge si imponeva all’autorità di pubblica sicurezza l’invio
dell’indigente, inabile al lavoro, al ricovero di mendicità49. Il ricovero obbligatorio, per
ordine dell’autorità pubblica, divenne l’auspicato rimedio contro la mendicità. Gli
inabili al lavoro erano considerati coloro che, per infermità cronica o per gravi difetti
fisici o intellettuali, non potevano provvedere alla propria sussistenza. Era l’ autorità
amministrativa di polizia che, mediante visita medica, si accertava ufficialmente delle
infermità e dei difetti gravi. Negli stessi anni veniva pubblicato il Nuovo Codice Penale
secondo il quale le persone abili al lavoro sorprese a mendicare dovevano essere punite
con l’arresto; essa in particolare mirava a punire, così si legge nella Relazione
Ministeriale del 22-11-1887, l’ “improba mendicità, poiché in essa l’ozio non solo
costituisce un fatto concreto (…) ma riesce colpevole e dannoso”. Nell’ambito della
dottrina si era così configurata come mendicità punibile l’ “abito di mendicare”, ossia il
vizio della mendicità in chi fosse “abile al lavoro”. Per cui in questa prospettiva, pur se
sulla base della norma citata era sufficiente l’essere colto a mendicare, si poteva
sostenere, anche attraverso l’integrazione delle disposizioni presenti negli art. 80 e
seguenti della legge di pubblica sicurezza n. 6144 del 30-6-1889, che lo scopo del
legislatore fosse la repressione dell’ “accattonaggio di professione” esercitato in
pubblico50. L’abilità al lavoro dunque definiva un diverso trattamento: il carcere per gli
abili, il ricovero di mendicità per gli inabili. Si cominciò così a delineare un nuovo
profilo delle politiche di intervento: “l’istituzione di strutture di accoglienza
specializzate quali luoghi di ricovero obbligatorio per quella popolazione sospetta di
turbare l’ordine.”51 Ciò che informò quindi l’istituzione di nuove forme di trattamento
della povertà e la relativa legislazione, era il concetto di “pericolosità sociale”, la
minaccia all’ordine. Con il nuovo codice penale del 1889, che rimarrà in vigore fino al
1930, non si attribuì più rilevanza penale al vagabondaggio. Il fenomeno venne relegato
49
“Se il comune o l’Istituto non sono in grado di provvedere in tutto o in parte, le spese saranno a carico
dello Stato. La medesima legge stabilì che, ove non esistesse un ricovero di mendicità, era comunque
illecito mendicare ed il ricovero doveva compiersi in un altro comune e la spesa era da accollarsi ad enti
vari. La legge poi prevedeva che coloro i quali non abbiamo nessuno che a loro provveda, o che non
abbiano mezzi propri di sussistenza, non siano abili o capaci di svolgere un lavoro proficuo, dovranno
essere ricoverati in un istituto di assistenza.” M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà
estreme in una prospettiva storico-sociale”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di),
Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 44.
50
Digesto – Discipline penalistiche, vol. VII, Utet, Torino, 1993.
51
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 44.
31
fra i cosiddetti “illeciti di polizia” e non riceverà più una considerazione unitaria, infatti
accanto alla condotta pura e semplice del vagabondare, il legislatore individuò una più
grave ipotesi di vagabondaggio sulla quale sarebbe scattata l’applicazione di più gravi
misure di prevenzione, essa si esplicava nel momento in cui venisse accertata la
“pericolosità” del soggetto vagabondo “per la sicurezza pubblica e per la pubblica
moralità”. Il vagabondaggio, quindi, divenendo materia di polizia, venne affrontato con
provvedimenti differenziati e differenzianti52: i vagabondi, quando non incorrevano in
un reato, ad esempio la mendicità, potevano essere colpiti come persone socialmente,
ma non criminalmente, pericolose. La pericolosità poteva essere criminale quando al
fatto del vagabondaggio si aggiungeva qualche reato. Il sistema di polizia aveva
comunque una “funzione di governo delle classi pericolose”53. L’intervento preventivo
sui “pericolosi”, sui sospetti, costituirà come già in passato una tecnica di controllo
sociale tutt’altro che marginale e varrà a distinguere un duplice livello di legalità al suo
interno: un codice per “galantuomini” e uno per “birbanti”54. L’efficacia dei meccanismi
preventivi non è quindi da sottovalutare in quanto, se pure rinunciano ad uno intervento
diretto attraverso la reclusione, l’insieme di prescrizioni connesse all’adozione di un
provvedimento di polizia come l’ammonizione, può essere stringente a tal punto da
rendere impossibile al soggetto colpito l’evitare la contravvenzione. Il giudice
disponente poteva, per esempio, ordinare “all’ozioso e vagabondo il darsi in un termine
conveniente al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora facendola conoscere nel
termine stesso alla locale Autorità di P.S. che dovrà pure essere preventivamente
avvisata se la dimora sia per essere abbandonata o mutata. Dovrà inoltre l’ammonito
non associarsi a persone pregiudicate, non ritirarsi la sera più tardi e non uscire al
mattino prima dell’ora prescritta, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o
case di prostituzione”55. Come si può notare si spazia da precetti generalmente morali,
quasi dei comandamenti, come quello di non frequentare “osterie, bettole o case di
prostituzione”, a prescrizioni che impongono un inquadramento disciplinare all’ “ozioso
e vagabondo”. Al centro dell’intervento vi era comunque la minaccia di turbamento di
un ordine; ordine che poteva essere mantenuto attraverso la reclusione ,
52
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 52.
53
M. Sbriccoli, “Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano”, in Storia d’Italia,
annale n.14, 1997, Torino, p. 490.
54
Ibidem, p. 489.
55
M. Rebora, “Oziosi e vagabondi”, in Enciclopedia Giuridica italiana, XII, 1915, p. 1301.
32
l’istituzionalizzazione, il controllo totale. Negli ultimi decenni dell’800 infatti, si
assistette ad una continua e maggiore ingerenza dello Stato nella beneficenza in quanto
la beneficenza privata, laica o legata alla Chiesa (quest’ultima maggioritaria rispetto alla
prima), che cercava di provvedere ai bisogni dei “poveri” in generale, con numerose
istituzioni di soccorso, non si poneva il quesito delle riforme necessarie per eliminare o
almeno comprimere il “problema”; di pari passo all’accentuarsi dell’ingerenza dello
Stato nelle Istituzioni di beneficenza si intensificò e si espandette una collaterale attività
dello stesso in ambiti in precedenza coperti da istituzioni religiose. Così se da una parte
le funzioni di assistenza furono accentrate tutte nelle mani dello Stato, dall’altra
l’assistenza si decentrò a livello comunale: la legge n. 6972 del 17-7-1890 infatti, sancì
un controllo dello Stato su tutte le attività assistenziali, un tempo private, definendole
“istituzioni pubbliche di assistenza” e sottoponendole alla sorveglianza del Ministero
dell’Interno; la stessa legge però istituì in ogni Comune una “Congregazione di carità”
cui spettava il compito di curare gli interessi dei poveri. La distinzione tra poveri
meritevoli e poveri non meritevoli, presente da tempo nella normativa di tutti i paesi
europei, divenne sempre più rigida e venne perseguita nelle pratiche di intervento
istituzionali.56
Dunque, nella legislazione italiana di fine Ottocento e inizio Novecento gli elementi che
concorrevano a definire l’immagine del mendicante erano l’ozio, l’abitudine all’ozio, la
mancanza di mezzi leciti di sussistenza, l’assenza di una dimora fissa: una condotta di
vita quindi asociale o antisociale, condotta che minacciava e turbava un ordine esistente
(?), diremmo meglio, auspicato.
2.1. Il Codice Rocco: fine delle distinzioni
La scuola positiva, durante il dibattito sulla preparazione del nuovo codice, criticò le
leggi che avevano preceduto il codice Rocco, in quanto nonostante la mendicità, il
vagabondaggio e l’ozio, siano stati fenomeni sociologici-giuridici che hanno interessato
tutte le legislazioni, “sono mancati dei criteri scientifici, universalmente accettati, tali da
creare un provvido sistema di intervento delle leggi dello Stato, a prevedere e,
soprattutto, a prevenire simili forme di attività e di inerzia individuale. L’empirismo più
56
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995 , p. 52-53.
33
assurdo ed un preteso relativismo ambientale, il più inopportuno ed ignaro, hanno
portato i legislatori o all’indifferenza o alla confusione repressiva, o ad artificiose
distinzioni, sottoponendo, come in Italia si è costumato, la sola mendicità improba o
non legale al codice penale, l’ozio e il vagabondaggio al codice di polizia.”57
La distinzione tra gli abili e gli inabili al lavoro ai fini della punibilità venne infatti
abbandonata nel codice Rocco, in quanto, lasciando alle leggi di pubblica sicurezza di
provvedere agli inabili, il legislatore nel 1930 operò la scelta di reprimere comunque la
mendicità “in luogo pubblico o aperto al pubblico”, così l’articolo 670 del codice penale
prevede che “chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con
l’arresto fino a tre mesi.” La norma di cui all’articolo 670 quindi non richiede più, ai
fini della sussistenza del reato, l’abitualità nell’accattonaggio: essa punisce anche chi
mendica una sola volta. “Il mendicare consiste nell’eccitare, in luogo pubblico o aperto
al pubblico, con fatti concludenti o con dichiarazioni, l’altrui sentimento di carità, cioè
come si legge dal comma 2 dell’art. 670, l’altrui pietà. Non occorre perché il reato si
consumi ottenere l’elemosina, è sufficiente, invece, una condotta diretta a questo scopo,
caratterizzata dal fine ultimo di provvedere ai bisogni propri ed eventualmente a quelli
della propria famiglia.”58 Proprio considerando il fine, alcuni autori distinguono la
mendicità dalla questua e dalla colletta; distinzione che è ben precisa nel vigente diritto
canonico, nel quale invece la mendicità non è considerata un illecito penale; in questo
sistema normativo, infatti, si puniscono la questua e la colletta quando esse sono state
poste in essere senza il consenso della Santa Sede perché, a differenza della mendicità
che viene realizzata per un fine esclusivamente privato, esse sono realizzate pro
quolibet pio aut ecclesiastico fine.59 Nell’articolo 154 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza viene ribadito il divieto di mendicare in luogo pubblico o aperto al
pubblico senza eccezione alcuna, per nessun motivo. La stessa legge invece ammette la
legittimità delle questue organizzate dalla Chiesa ( non è mendicante nemmeno il
religioso appartenente ad un ordine “mendicante” che va in giro chiedendo l’elemosina
per il mantenimento dei religiosi o per le opere dell’ordine) e l’autorizzazione
amministrativa per la raccolta di fondi o di oggetti per scopi patriottici o scientifici o di
beneficenza e sollievo dei pubblici infortuni (soprattutto in queste parole possiamo
intravedere una matrice di solidarietà popolare). Quindi si può organizzare una questua
57
S. Cicala, “Mendicità, vagabondaggio ed ozio nel diritto pubblico italiano ed estero”, in La scuola
positiva, vol. X, 1930.
58
Così Salvatore Panaria in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Giuffrè.
59
Sul punto si veda Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, Milano, 1970, 427.
34
pubblica per i poveri, chiedere l’elemosina per impedire che esistano i mendicanti, ma
non si può mendicare per se stessi! Rimane anche esclusa dal divieto di mendicare la
richiesta di aiuto in stato di necessità imperioso e, per questo, considerato temporaneo.
Lo “stato di necessità imperioso” viene inteso come momentanea e urgente mancanza
dei mezzi primari di sopravvivenza : cibo; necessità quindi urgente ma che non può
protrarsi per un lungo periodo. Lungo periodo che non può essere accettato in quanto lo
Stato, con la sua presenza sempre più massiccia, sembra che sia riuscito ad “includere”
una quantità sempre maggiore di “categorie” di bisognosi, per cui chi è escluso lo è
perché si auto-esclude con stili di vita non idonei alla “moralità “ dello Stato stesso. La
legge infatti prevede poi che coloro i quali non abbiano nessuno che a loro provveda
(nella legge: “i parenti tenuti agli alimenti”), non abbiano mezzi propri di sussistenza,
non siano abili o capaci per nessun lavoro, debbono essere ricoverati in un istituto di
assistenza o di beneficenza: il ricovero di mendicità o qualsiasi altro istituto per gli
invalidi. E’ la stessa autorità amministrativa di polizia che, mediante visita medica
dell’ufficiale sanitario comunale, si accerta ufficialmente dell’infermità e dei difetti
gravi (fisici o intellettuali) che non permettono di “procacciarsi i mezzi di sussistenza”.
Il ricovero obbligatorio in un istituto per ordine dell’autorità pubblica è considerato
quindi il rimedio contro la mendicità. Quindi ancora reclusione, quindi ancora controllo.
Coloro invece che, non avendo né infermità, né difetti gravi, non potendo essere
dichiarati inabili al lavoro, debbono procacciarsi i mezzi di sussistenza con il lavoro, o
con altre misure assistenziali quali il sussidio di disoccupazione che comunque dipende
dall’aver svolto un lavoro, l’assegno di invalidità civile, la pensione di invalidità o la
pensione di vecchiaia. O si lavora, o si appartiene ad una “categoria” ben precisa per
poter avere assistenza. E se non si appartiene a nessuna “categoria” di bisogno, perché
non si lavora? Il mendicante abile al lavoro viene quindi in primo luogo visto come
colui che preferisce l’ozio al lavoro e per questo pericoloso60 in quanto anti-sociale
soprattutto nel momento in cui il lavoro diviene il fattore principale di integrazione61 (
in particolare dal secondo dopoguerra). L’ozioso quindi è un désaffilié, fa parte di
60
Ricordiamo il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel quale è contenuto
l’articolo 154 sui mendicanti è “Disposizioni relative alle persone pericolose per la società” di cui al Capo
I “Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti”.
61
R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004.
35
quella categoria che Castel definisce dei “soprannumerari”62, ovvero individui ai quali
non viene riconosciuto alcun posto nella struttura sociale.
Il mendicante è una persona pericolosa per la società, lo è al pari del malato di mente,
del tossicodipendente, dell’alcolista (così nel titolo IV del t.u.l.p.s.)63 e proprio per
questo non può essere tollerato. La sua pericolosità è insita nella sua diversità, diversità
che fa paura in quanto mette in crisi l’ordine esistente, rappresenta un punto
interrogativo, ci dice che, nonostante tutto sembra andare bene, forse non è così.
Istituzionalizzando queste persone, si ha la possibilità di controllarle, di prevedere ciò
che poteva sembrare imprevedibile. Il ricovero obbligatorio per il mendicante quindi
permette la separazione tra il così detto mondo dei “normali” e un mondo altro,
tremendamente negativo. Il ricovero è necessario per non rendere visibile un fenomeno
scomodo, sconcertante. Le istituzioni infatti “sono artifici, protesi, puntelli esterni,
macchine per pensare e prendere decisioni, cui gli uomini affidano il compito
d’esonerarli/alleggerirli dal peso dell’apertura al mondo (…).Esse producono
securizzazione definendo il giusto e l’ingiusto, l’amico e il nemico, presidiando il
dentro rispetto al fuori, l’ordine rispetto al disordine, il normale rispetto al mostruoso.
Creando una benefica assenza di domande, (…)- le istituzioni sono risposte
precodificate a domande poste una volta per tutte, rese implicite e non più formulate
dagli individui-, consentono agli uomini di sfuggire ai rischi dello stupore e di godere i
vantaggi della certezza dell’ovvio.”64
All’inizio del novecento, in Italia,
il bisogno di istituzionalizzare e categorizzare
divenne molto forte: bisogno di “creare” e mantenere un ordine. Il mendicante, con la
sua presenza metteva in discussione la centralità del lavoro, l’importanza della proprietà
e soprattutto rendeva visibile la povertà, fenomeno ancora molto presente; questo tipo di
62
R. Castel, “Reddito minimo di inserimento e politiche di integrazione”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a
cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 275-282.
63
Può interessare il rilievo dato da alcune norme alla condizione di indigenza o mendicità ad esempio
l’art. 159 t.u.p.s.: “Il Ministro dell’interno o per sua delegazione le autorità di p.s. possono, per motivi di
pubblica sicurezza, o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio
gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio”. L’art. 298 reg. p.s. preciserà poi che il viaggio gratuito potrà
avvenire “esclusivamente all’interno della Repubblica e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per
avviamento al lavoro”. Ancora l’art. 152 t.u. p.s. stabilisce che i prefetti possono respingere alla frontiera
gli stranieri che “siano sprovvisti di mezzi”. Mentre l’art. 232 reg. p.s. dispone che le iscrizioni presso le
autorità locali di pubblica sicurezza per ottenere il certificato per l’ esercizio dei mestieri ambulanti (art.
121 t.u. p.s.) “deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la
mendicità”. Per quanto attiene invece all’esercizio di diritti si può notare che l’art. 77 t.u. fin. loc.
stabiliva che non potevano diventare appaltatori delle imposte di consumo “i condannati per mendicità”;
mentre l’art. 8 t.u. com. prov. 1934 prevedeva “non possono essere nominati agli uffici previsti nella
presente legge: … i condannati per mendicità.
64
R. Escobar, Metamorfosi della paura, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 88.
36
povertà però non poteva essere accettata, in quanto causata dalla preferenza dell’ozio al
lavoro. Nella “Carta del Lavoro” emanata nell’aprile del 1927 si dice che “Il lavoro,
sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un
dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.” Il lavoro
quindi viene considerato e richiesto come un dovere, un dovere sociale. L’ozio e il
vagabondaggio abituale si presentano allora come stati di fatto in profondo urto con
quel principio, “sicchè le persone che si mantengono abitualmente nella condizione di
oziosi e vagabondi, per il danno che arrecano alla economia pubblica, per il pericolo che
rappresentano, sono da considerare come esseri che contrastano la politica dello Stato,
che si pongono in aperto dissidio con le leggi più alte che reggono il consorzio
nazionale, e pertanto come dei veri e propri delinquenti.”65 Ritornando all’art. 670 del
codice penale possiamo affermare che esso intende tutelare la “pubblica moralità”; la
mendicità è un reato, reato che si può far rientrare tra i così detti reati contro il
sentimento,66 nei quali cioè la condotta offende un determinato sentimento; nel reato di
mendicità, come si desume dal comma 2 dell’art. 670 il sentimento offeso è la pietà
altrui cioè la pubblica carità e a maggior ragione “la pena è dell’arresto da uno a sei
mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando
deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”. In
particolare, nel “modo ripugnante” sono compresi quegli atteggiamenti atti a suscitare
sentimenti di disgusto, repulsione, quali l’esibire piaghe, deformità o condizioni
personali o altrui deplorevoli, mentre nel modo “vessatorio” rientrano le molestie,
l’insistenza ed ogni altra condotta di turbamento atta a sollecitare l’altrui pietà; la
mendicità poi è aggravata nella simulazione di deformità o malattie fisiche o psichiche;
infine, nella più generica espressione relativa agli “altri mezzi fraudolenti”, si indicano
quelle condotte, diverse dalle precedenti, volte a trarre in inganno e ad indurre
all’elemosina. Allo stesso modo, è in vista della tutela della pubblica tranquillità che
nel t.u.l.p.s.: “disposizioni relative alle persone pericolose per la società” e nel
regolamento per l’esecuzione dello stesso, che viene ad assumere rilevanza la punibilità
della condotta67 di mendicità, in quanto quest’ultima viene automaticamente collegata
all’ozio quale forma di vita che potrebbe ingenerare condizioni di pericolo per la
65
S. Cicala, “Mendicità, vagabondaggio ed ozio nel diritto pubblico italiano ed estero”, La scuola
positiva, vol.X, 1930.
66
Falzea, “I fatti di sentimento”, in Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, Napoli, 1972, p. 356.
67
E’ la pubblicità del luogo a qualificare la condotta, infatti la mendicità che si vuol punire è quella che
“si manifesta e opera in modo palese, evidente”. (F. Lucifero, I mendicanti, RIDP, 1931, p.420).
37
società. Come tutti i reati contro il sentimento, anche il reato di mendicità presuppone
una situazione giuridica di dovere: la condotta di cui si parla nell’art. 670 del codice
penale rappresenta una palese violazione del dovere di svolgere un’attività o meglio, un
lavoro. E’ proprio la violazione di questo dovere, dal momento in cui si hanno tutte le
possibilità e capacità per adempierlo, che offende l’altrui sentimento di pietà. La pietà
quindi può manifestarsi solo nei confronti di coloro che non possono lavorare perché
sono inabili e quindi impossibilitati e di quest’ultimi se ne occupa lo Stato per cui non
dovrebbe più sussistere la possibilità di mendicare. Il reato di mendicità sussiste quindi
sia per gli abili che per gli inabili al lavoro, in teoria; in pratica la distinzione tra
mendicanti abili e mendicanti inabili, presente nel codice Zanardelli (art. 453), rimane.
Rimane la necessità di reprimere ad ogni costo una condotta di vita dedita all’ozio e allo
stesso tempo la necessità di coprire e proteggere quelle “categorie” di poveri che si
trovano in quello stato non per loro volontà ma per cause esterne che non permettono
loro di svolgere un lavoro. A tal proposito, nell’articolo 38 della nostra Carta
costituzionale si dice che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza” ma allo stesso tempo
nell’articolo 4, comma 2, che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società”. Per cui ritroviamo di nuovo la distinzione
tra coloro che hanno diritto ad un’assistenza e coloro che non ne hanno in quanto non
accettano e non sono partecipaci alle regole della società in cui comunque si trovano a
vivere e così facendo si auto-escludono. Ribadiamo quindi che la mendicità, nell’ipotesi
in cui si tratti di mendicanti capaci al lavoro, diviene espressione di ozio, perché chi
mendica pur potendo adempiere al dovere di lavorare è, in sostanza, un ozioso che
spinge il proprio vizio fino a mendicare, sfruttando il sentimento di carità pubblica pur
di non lavorare e proprio per questo è considerato un soggetto pericoloso rispetto agli
interessi concernenti la sicurezza pubblica e la pubblica moralità. Non ci possono essere
spiegazioni alternative, non è possibile cogliere le sfumature che si intermezzano tra due
“appartenenze”: o si appartiene ad una categoria così detta a “rappresentanza
consolidata e garantita”68 o si è “fuori”. Partendo dal presupposto che “tutti” abbiano la
stessa definizione della situazione, si è continuato a ragionare su categorie e gruppi e
non sulle persone e purtroppo oggi, in parte, è ancora così. Non c’è volontà di
68
P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), I volti della povertà urbana, FrancoAngeli, Milano, 1992 (2° ed.).
38
comprensione, tutto sembra filare liscio: se si è “sfortunati” alla nascita, allora si ha
diritto ad un aiuto, ma se si hanno tutte le caratteristiche per poter far parte del mondo
dei “normali”, perché “decidere” di starne fuori? Questa è una “scelta” che non riceve
alcuna comprensione e che non può essere tollerata.
Come abbiamo detto in precedenza, torniamo a ribadire che nonostante l’art. 670 del
codice penale risulti così tassativo nel punire la mendicità, quale essa sia, non sono
mancate innumerevoli discussioni sulla sussistenza reale del reato, su quali dovrebbero
essere realmente i soggetti punibili e la condotta punibile. Noi, tralasceremo, in parte, le
varie interpretazioni tecniche e ne prenderemo in esame soltanto alcune di maggior
interesse ai fini del nostro discorso. La Cassazione, ad esempio, interpellata in varie
circostanze, ha ribadito la differenza tra stato di bisogno e stato di necessità, di cui
all’art. 54 del codice penale. In tal senso, la sentenza del 7-5-1975, n. 102, ha segnato
una svolta: in essa la Corte costituzionale ha ritenuto di non accogliere l’orientamento
giurisprudenziale nel suo “rigido schematismo” rispetto a situazioni oggettive e
soggettive direttamente riconducibili agli articoli 4 e 38 della Costituzione, così che la
decisione, nell’interpretazione della norma, “non venga a trovarsi in conflitto con quei
principi dell’ordinamento costituzionale che consacrano veri e propri diritti primari
incomprimibili”. Si è quindi ritenuto opportuno che potesse rientrare nell’ambito
dell’art. 54 c.p.69 chi, fisicamente debilitato e privo di chi per legge debba provvedere ai
bisogni essenziali, si induca alla mendicità per non essere stato messo in condizioni di
poter usufruire dell’assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Gli estremi che
discriminano l’atto (mendicare), si possono trovare quindi nell’ “attualità del pericolo di
un danno grave alla persona”, quale è quello che può essere determinato da uno “stato
di bisogno non voluto”, che si profila “come una costante senza soluzione”, finchè non
ne siano rimosse le cause. In caso quindi di mancanza dei “mezzi necessari per
vivere”(art. 38, Cost.), si è più volte richiamato il “diritto alla vita”, “bisogno
insopprimibile”. Sarebbe pertanto possibile, “pur rimanendo nell’ambito del sistema,
contemperare il disposto della norma rispetto ad esigenze di equità, sia operando
all’interno della stessa interpretazione dell’art. 670 c.p., sia riconducendo quelle
situazioni, per le quali ed a diversi livelli si è richiesta un’ umana applicazione della
69
Così il primo comma dell’art.: “Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato
al pericolo.”
39
fattispecie di mendicità, ovvero se ne è invocata l’incostituzionalità, nell’ambito delle
previsioni normative vigenti, integrate le quali, resta esclusa la punibilità”70.
2.2. Sentenza della Corte Costituzionale del 28-12-1995, n. 519
Se gli interventi precedenti della Corte Costituzionale avevano confermato, in ragione
della tutela della pubblica tranquillità con riflessi sull’ordine pubblico la conformità
della norma al dettato costituzionale, la seguente pronuncia sul punto ha operato in
termini decisamente innovativi. L’intervento della Corte Costituzionale infatti, con la
sentenza del 28-12-1995, n. 519, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo
comma dell’art. 670 c.p. Per comprendere come si è arrivati a ciò, è necessario
ripercorrere brevemente le argomentazioni esposte nelle ordinanze, con cui si è rimessa
la questione di legittimità alla Corte Costituzionale, per iniziativa rispettivamente della
pretura di Firenze e del pretore di Modena, sezione distaccata di Carpi. La prima
ordinanza del 11-11-1994, n. 22, seguita, ad opera dello stesso giudice da un’altra
ordinanza il 3-2-1995, n. 320, sollevava la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 670, primo comma, per violazione degli artt. 2, 3 e 27 terzo comma, della
Costituzione, mantenendo invece il secondo comma del suddetto articolo riferito ad una
mendicità praticata con modalità vessatorie, ripugnanti, petulanti o altrimenti
fraudolente, ovvero ad una condotta che, secondo la formula oggetto dell’art. 671 c.p.,
si avvale dell’ “impiego di minori nell’accattonaggio”. Non vi è, invece, offesa della
morale e della tranquillità pubblica “quando l’accusato versi in una situazione di
bisogno non riconducibile a sua colpa, risolvendosi la mendicità in una legittima
richiesta di umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento della carità. “La previsione
incriminatrice di cui all’art. 670, primo comma, del codice penale, violerebbe ad avviso
del giudice a quo i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della finalità
rieducativi della pena contenuti negli artt. 3, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
giacchè sarebbe riservato lo stesso trattamento punitivo anche a soggetti che si trovino
in condizioni economiche-sociali del tutto diverse. Essa, infatti, prescinde dallo stato di
indigenza non ascrivibile alla condotta individuale: di qui, un trattamento inadeguato,
poiché non finalizzato a rieducare quanti, obbiettivamente incapaci di mantenersi
70
Digesto. Discipline penalistiche, vol VII, UTET, Torino, 1993.
40
autonomamente, siano perciò costretti a far ricorso all’altrui solidarietà.”71Per cui, l’
“eccezione” d’incostituzionalità si sollevava per violazione dei principi presenti negli
artt. 2 e 3 della Costituzione ritenendo che la condotta di mendicità del soggetto, che
involontariamente e, sottolineiamo involontariamente, si trovi in uno stato di bisogno,
fosse da interpretarsi “come semplice e legittima richiesta dell’altrui pietà”. A tali fini si
richiedeva altresì, quale fondamento della punibilità, la necessità della “prova concreta”
che potesse dimostrare il rifiuto volontario da parte della persona dei mezzi messi a sua
disposizione. L’incriminazione della condotta quindi non viene messa in discussione nei
confronti di chi mendichi “per propria colpa”. La netta distinzione tra poveri meritevoli
e non, viene palesemente riproposta: può essere assolto e quindi a sua volta aiutato solo
colui che mendica in situazione di bisogno, ma, fondamentale, è che non sia per sua
colpa. Come si può, oggettivamente, stabilire se sussista una colpa o meno? Forse è
necessario, per riuscire a comprendere alcune situazioni, uscire dal classico schema
utilitarista mezzi/fini. Evidentemente per alcune persone questo schema non è così
automatico e proprio per questo occorrerebbe osservare il fenomeno da un altro punto di
vista, ma di ciò parleremo in seguito. Altro elemento che venne preso in considerazione
nella sentenza era la finalità rieducativa della pena che, in questo caso specifico, veniva
a decadere: infatti quest’ultima poteva essere difficilmente configurabile per chi, non
per propria condotta dolosa o colposa, ma per carenze istituzionali, fosse indotto alla
mendicità, per non potersi garantire altrimenti le “condizioni minime e necessarie…per
vivere con dignità e decoro”.
Con altre motivazioni veniva invece sollevata l’analoga questione, questa volta con
particolare riguardo all’art. 670, secondo comma, c. p., da Modena, sezione distaccata di
Carpi, con l’ordinanza n. 67 del 21-10-1994 che lamentava l’eccessivo rigore del
trattamento sanzionatorio e la conseguente violazione dei principi di “proporzione” e di
“sussidiarietà”. Le argomentazioni addotte dal giudice muovevano dalla premessa di
ritenere “del tutto irragionevole, e sproporzionato per eccesso, tutelare il bene generico
della tranquillità pubblica mediante il sacrificio del diritto fondamentale e inviolabile
delle libertà personale”. Il parametro della “irragionevolezza”, improntato ad una logica
di “danni” per l’individuo “sproporzionatamente maggiori” rispetto ai “vantaggi” per la
società, veniva integrato, sotto lo stesso profilo, dalla violazione del principio di
sussidiarietà. Da un lato, argomentava il giudice, il fenomeno dell’accattonaggio può
71
Sentenza n. 519/1995.
41
essere sufficientemente controllato “con opportune sanzioni amministrative”, dall’altro,
sussisterebbe “la necessità pratica di non aggravare pericolosamente il fenomeno di
sovraffollamento delle carceri”. La scelta della depenalizzazione sembrava la più idonea
anche perché, ad avviso del giudice, “la fattispecie incriminatrice”, tutelava “un
interesse anacronistico”. La norma in esame venne considerata come estremamente
severa e come il prodotto di “concezioni autoritarie che connotavano la cultura del
legislatore del 1930”, una radicale inversione di tendenza rispetto all’impostazione del
codice Zanardelli, ispirato invece dalla tradizione del pensiero liberale. Il giudice
costituzionale ha comunque ritenuto, sulla base di due diversi “valori penalistici
coinvolti”, di poter mantenere fra loro nettamente distinte le due ipotesi criminose
presenti nell’art. 670 del c.p.72 tanto da considerare un’ipotesi di mendicità non invasiva
e un’ipotesi di mendicità invasiva. “L’ipotesi della mendicità non invasiva integra una
figura di reato ormai scarsamente perseguita in concreto, mentre nella vita quotidiana,
specie nelle città più ricche, non è raro il caso di coloro che senza arrecare alcun
disturbo domandino compostamente, se non con evidente imbarazzo, un aiuto ai
passanti. Di qui, il disagio degli organi statali preposti alla repressione di questo e di
altri reati consimili chiaramente avvertito e, talora, apertamente manifestato che è
sintomo, univoco, di un’abnorme utilizzazione dello strumento penale”. Il mendicante
diviene, in un certo senso di nuovo parte della società, in quanto, sempre nella sentenza,
si mette in evidenza come gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più
avanzate producono condizioni di emarginazione che non possono essere nascoste,
nonostante le tentazioni di farlo e allo stesso tempo non si può semplicemente seguire la
strada che considera le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli
della loro condizione. “Ma la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di
comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la
società civile consapevole dell’insufficienza dell’azione dello Stato ha attivato
autonome risposte , come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno
tratto la loro ragion d’essere, e le loro regole, dal valore costituzionale della solidarietà”.
La mendicità non invasiva, considerata già in concreto “scarsamente perseguita”, non
appariva quindi alla Corte dotata del carattere di offensività della tranquillità pubblica,
risolvendosi in una “semplice richiesta di aiuto”; essa appariva costituzionalmente
72
Ricordiamo che la prima (primo comma), punisce con la pena dell’arresto fino a tre mesi “chiunque
mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico”, mentre la seconda (secondo comma), sanziona più
gravemente, con l’arresto da uno a sei mesi, il fatto “commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero
simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”.
42
illegittima alla luce del “canone della ragionevolezza”, non potendosi in alcun modo
“necessitato il ricorso alla regola penale”. A riprova, si adduceva, come abbiamo detto
in precedenza, il ripensamento compiuto dalla “coscienza sociale”, in riferimento a
comportamenti assimilati un tempo a quelli pericolosi, ma rispetto ai quali oggi più viva
è la solidarietà. La mendicità invasiva invece, la si considerava volta alla tutela di beni
giuridici di rilievo, tra i quali “lo spontaneo adempimento del dovere di solidarietà”,
offeso dal ricorso a “mezzi fraudolenti”. Il primo comma dell’art. 670 venne quindi
dichiarato illegittimo costituzionalmente, mentre per il secondo comma la questione di
legittimità venne dichiarata non fondata. Con la legge del 25 giugno 1999, n. 205,
art.18, viene abrogato l’articolo 670. Attraverso questa legge quindi la differenza tra una
mendicità invasiva e una mendicità non invasiva decade, escludendo per entrambi la
possibilità di condanna al carcere. Nel disegno di legge 2893 del 2002 venne riproposto
di reintrodurre il reato di mendicità. Proposta che non ebbe seguito ma che ci mette in
evidenza come ogni tipo di governo, a seconda che sia più o meno legato all’importanza
della sicurezza, intesa come difesa da tutto ciò che possa destabilizzare dall’ordine
esistente, si accanisca più o meno nei confronti di quelle persone considerate
“pericolose”. Oggi quella paura, quelle costruzioni simboliche che criminalizzavano il
vagabondo e il mendicante, associandoli strettamente alla delinquenza e al disordine,
vengono trasportate direttamente nell’immigrato che viene visto come un “invasore”,
come un importatore di degrado e di disordine sociale, la causa principale dell’aumento
di criminalità e dell’esplodere del senso di insicurezza che pervade i maggiori centri
urbani. Nel governo di questa vera e propria underclass sembra che il sistema penale di
polizia tenda a recuperare il suo antico ruolo nel governo della miseria73.
73
Questo sistema viene chiamato da Luigi Ferrajoli “sotto-sistema penale di polizia”. L’esistenza di tale
sotto-sistema poliziesco ha consentito ai meccanismi di controllo sociale, in società marcatamente
stratificate, di gestire il segmento più basso di popolazione senza che l’ideologia dell’uguaglianza di
fronte alla legge andasse in frantumi. L’enorme selettività del sistema a scapito dei settori sociali più
marginali fu, appunto, giustificabile grazie al ricorso a quei concetti che costruivano come “classe
pericolosa” l’universo sociale che popolava la base della piramide sociale.
43
3. LA MENDICITA’ NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO
Come abbiamo potuto osservare, nei vari periodi storici, si sono venute a formare
diverse immagini intorno alla figura del mendicante e il sistema legislativo ha avuto una
parte fondamentale in questo. “La figura della povertà urbana estrema ancora oggi
rimanda contemporaneamente alla prossimità con Gesù, alla decomposizione delle
relazioni sociali ad una residualità, alla minaccia del ritorno di situazioni di altri
tempi”74.Tutte queste immagini sono compresenti in forma stratificata e ciò è uno dei
motivi più importanti della difficile lettura della povertà urbana estrema stessa. Infatti
queste immagini, che i vari periodi storici hanno contribuito a creare, sono oggi presenti
e si esplicitano in atteggiamenti ora positivi, ora negativi, o entrambi compresenti nei
confronti del fenomeno. Come osserva Geremek, il “gesto caritatevole di dare
l’elemosina non è stato sostituito con una minaccia di impiccagione per i mendicanti:
tale minaccia e tale gesto coesistevano attraversando periodi di debolezza e di forza, di
ascesa e di caduta”75. Se la civiltà medioevale aveva celebrato la povertà come una virtù
e il povero che concorreva alla redenzione degli uomini ricchi che facevano
l’elemosina, come vicarius christi , nell’età moderna questa immagine viene ad essere
sostituta da un insieme di connotazioni profondamente negative. In Italia, nonostante
fosse stato un paese che non aveva conosciuto la Riforma protestante, la distinzione tra
“povertà operose e povertà oziose” , nella seconda metà del XIX secolo viene ad
approfondirsi. La povertà non è più considerata un semplice status economico-sociale,
essa diviene sintomo di deficienza morale per cui da un lato si attua un processo di
restrizione dell’assistenza ai poveri, dall’altro ciò viene giustificato dall’esplicita
criminalizzazione dello stato di indigenza. In questo periodo, infatti, quando si afferma
di voler eliminare il pauperismo non s’intende voler eliminare l’esistenza della povertà
in generale (che è addirittura assunta quale indice della ricchezza delle nazioni76), bensì
si esprime l’intenzione di eliminare tutto un’insieme di elementi che fanno
del
pauperismo un “abitus” morale piuttosto che una condizione socio-economica77. La
povertà estrema prende ad essere assimilata al delitto e ciò si esprime nel progressivo
74
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995 , p. 49.
75
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. XIII.
76
K. Marx, Il Capitale, Torino, 1975, p. 798.
77
G. Procacci, “L’Economia sociale e governo della miseria”, in AUT/AUT, 167/168, 1978, p.73.
44
inasprimento del trattamento riservato agli indigenti, sempre più equiparati ai
delinquenti. Non è più la povertà in sé a consistere in una minaccia per l’ordine sociale,
ma le particolari “abitudini fisiche e morali”78 che la contraddistinguono:
1. Mobilità: la quale è in aperta contraddizione con le esigenze di stabilità
territoriale e di concentrazione della popolazione laddove necessiti. Il
vagabondaggio diviene definitivamente l’archetipo del disordine sociale.
2. Promiscuità: che, oltre a determinare un aumento di difficoltà nel controllo di
queste masse d’individui, che restano nell’indistinto, rende molto complesso
ogni controllo demografico sulla popolazione da parte del potere pubblico.
3. Indipendenza: che è sintomo di libertinaggio e disordine morale, poiché
impedisce che questi individui siano in grado di condurre una vita onesta e di
risparmio, accedendo magari ad una qualche proprietà
4. Ignoranza e insubordinazione: cioè la barbarie e la brutalità allo stato puro, da
cui consegue l’ignoranza dei propri doveri e, appunto, l’insofferenza alle
regole79.
Per ovviare a tali aspetti deteriori della povertà è considerata questione determinante l’
“educazione” di queste masse di immorali e queste misure “educative” e allo stesso
tempo “repressive” trovano la loro sintesi perfetta nel sistema penitenziario. Come
abbiamo visto in precedenza, non è solo nelle istituzioni chiuse che i meccanismi
disciplinari si esplicano: pensiamo al ruolo dell’istituzione poliziesca deputata appunto
all’estensione della disciplina al di fuori degli spazi disciplinari chiusi. Le prime norme
di polizia che colpiscono l’ozio, il vagabondaggio e la mendicità si rintracciano molto
indietro nel tempo : nel solo Regno Sabaudo già a partire dal XV secolo esistevano
disposizioni che colpivano, con provvedimenti preventivi personali, situazioni
soggettive, condizioni di vita o il semplice sospetto di un reato commesso: un
susseguirsi di provvedimenti che “intervengono indifferentemente contro oziosi,
vagabondi, zingari, questuanti forestieri, sospetti di furto, residenti o forestieri senza
reddito o professioni certi”80. Questo lungo processo avviatosi nel XVI secolo avrebbe
trasformato delle figure pensate per interventi polizieschi, extragiudiziari, in vere e
proprie fattispecie di reato, reati di status che resisteranno al trapasso fra vecchi e nuovi
78
Ibidem, p. 73.
79
Ibidem, p. 74.
D. Petrini, “Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione”, in Storia
d’Italia, annale n. 12, La criminalità, Torino, 1997, p. 897.
80
45
ordinamenti giuridici. La relazione al parlamento subalpino del ministro Galgano che
proponeva l’approvazione di un disegno di legge (destinato poi a diventare il
provvedimento del 1852), in materia di Pubblica Sicurezza, ad esempio considerava
l’ozioso e il vagabondo in “permanente reato, frodano la società dalla parte che da ogni
cittadino le si deve, e non si può concepire che possano, privi quali sono di mezzi,
esistere senza supporre una continua sequela di truffe, di ladronecci e simili (…) se
propongo una disposizione eccezionale egli è perché qui si tratta di un delitto
eccezionale. Il quale, come ho già detto, è occasione e fonte di tutti gli altri reati e
crimini… Essendo origine di tutti gli altri, richiede per speciale considerazione che
siano forniti al governo i mezzi necessari per reprimerli rigorosamente (…). All’ozioso
e vagabondo già indurito per lunga abitudine nel vizio vuolsi provvedere con pene
adeguate che, rendendolo intanto impotente al malaffare, giovino a richiamarlo sul retto
sentiero”81. Si commette reato quindi nel solo fatto di essere un vagabondo. L’ozio
diviene un reato e all’ozioso non spetta nessun tipo di libertà personale non venendo
riconosciuto in sé come persona, in quanto non adempie ad alcun dovere che il vivere
civile richiede. L’ozioso “è visto come una belva feroce di cui si deve, con il lavoro e
l’obbedienza, trattenere gli istinti”82. La mendicità viene punita in quanto “conseguenza
dell’infingardaggine e della scioperatezza”, così si enunciava nel Codice Penale sardoitaliano del 1859. Per cui non è in sé l’atto di chiedere del denaro che viene considerato
reato quanto lo stile di vita, è appunto l’ozio in sé ad essere reato, reato contro la
pubblica tranquillità, perché essendo l’ozioso privo di mezzi, è automatico che per
sopravvivere truffi. Se in epoca moderna quindi la differenza tra povertà e mendicità era
una differenza di grado, ma non di natura, nell’800 il divario si fece sempre più
profondo tanto che, se da un lato la povertà continuava a rimanere una dimensione
costitutiva delle classi popolari, certi suoi attributi, quali la volontarietà, l’abitualità a
condotte asociali, erano specifici solamente delle sue forme estreme83 che vengono
descritte attraverso l’immagine dell’accattone, dell’ozioso, del vagabondo. La
81
Il ministro specificherà, inoltre, che per i minori l’internamento conseguente all’atto di sottomissione
non rispettato “dovrà sempre aver luogo in una casa di lavoro, sia per tenerli lontani dal consorzio d’altri,
già troppo viziati e mal consigliati, sia per avviarli in avvenire ad una vita onesta”. (I brani sono riportati
in I. Mereu, “Cenni storici alle misure di prevenzione nell’Italia liberale”, in Le misure di prevenzione.
Atti del convegno Alghero. Milano).
82
D. Melossi, M. Patarini, Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario, Bologna, 1982, p.
106.
83
M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in
P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 1995, p. 43.
46
distinzione tra poveri meritevoli e non meritevoli, tra povertà e povertà estrema che il
sistema legislativo contribuì a creare, influenzò anche tutto il sistema assistenziale che
considererà la povertà estrema la peggiore e la più degradata forma di povertà
nell’ambito di una struttura continua che comprende la povertà nel suo complesso.
Ritornando al codice del 1859, fondamentale ai fini della punibilità era la distinzione tra
mendicante valido e mendicante invalido: il mendicante valido, considerato al pari del
vagabondo e dell’ozioso, doveva essere punito in quanto ozioso appunto ; la mendicità
per gli inabili veniva tollerata ma sottoposta a controllo, in quanto divenne oggetto di
una licenza specifica, licenza che costituì un vero e proprio marchio, stigmatizzando
definitivamente la persona, sia come persona inabile sia come povera, escludendola così
dalla possibilità di “riscatto”. Con la legge N. 5888 del 23/12/1888 sulla Pubblica
Sicurezza, come abbiamo affermato nelle pagine precedenti, si arriva invece alla
generale proibizione della mendicità e quindi all’abolizione del permesso di mendicare,
ritenendo il ricovero obbligatorio il possibile rimedio contro la mendicità. Per gli
inabili, in quanto incapaci di provvedere alla propria sussistenza, il ricovero diviene la
migliore soluzione. Attraverso la reclusione ciò che prima non poteva essere nascosto,
evitato, lo diviene. Il povero inabile è considerato quindi un “parassita” in quanto
incapace di lavorare e produrre, ma lo è non per sua colpa e per questo è “dovere” dello
“Stato” provvedere alla sua assistenza. Il mendicante abile al lavoro invece non può
essere tollerato e se nel ‘700 fino alla prima metà dell’800 si pensava che attraverso
una adeguata educazione al lavoro, poteva essere “redento”, dalla seconda metà
dell’800, anche grazie al contributo della scienza medica e di quella psichiatrica in
particolare, ciò non si ritenne più possibile. Il nascente positivismo criminologico fornì
nuove legittimazioni ai vari tipi di “istituti” di reclusione e contribuì ad una nuova
definizione della povertà urbana estrema : la criminalità in generale diviene espressione
di “anomalie” biologiche. Cesare Lombroso nel suo L’uomo delinquente, considera la
“diversità” cioè la follia, la delinquenza e la povertà come “l’effetto di una inferiorità
storico-biologica- è devianza naturale- come lo stato primitivo o animale”84. Il
mendicante quindi, viene considerato biologicamente diverso. Il concetto di pericolosità
che già esisteva in uno spazio semantico relativo alla sfera dell’immoralità, viene
“medicalizzato”, per cui alle considerazioni sulla diversità morale degli oziosi e dei
vagabondi, vengono sostituite considerazioni sulla loro diversità biologica e naturale. In
84
M. Patarini, “Le fattispecie soggettive di pericolosità”, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno
di Alghero, 1975, Milano
47
uno scritto del 1915 di un esponente positivista, vengono distinte diverse classi di
vagabondo ed ozioso: vi erano i vagabondi di città e i vagabondi di campagna; ma in
ogni caso essi, nelle loro varie categorie, “formano un mondo a sé stante (…) un
esercito sterminato nel quale le reclute destinate alla delinquenza si addestrano e si
preparano al triste cimento”85. Gli oziosi e i vagabondi sono distinguibili per un’innata
incapacità di darsi una stabile dimora, quindi una naturale propensione al
vagabondaggio: vagabondi per tendenza, ben distinti però dai vagabondi per necessità,
intesa come situazione momentanea alla quale si cerca il prima possibile di porre
rimedio. “Il vagabondaggio infatti nel senso più esatto della parola ha origine non tanto
da condizioni economiche o sociali che pure hanno la loro importanza, quanto da
condizioni ataviche individuali, da forme generative, da predisposizioni somatiche”86.
Essi pertanto “sono per predisposizione organica sulla quale opera l’ambiente, spinti
alla mendicità, condotti alla frode, posti, per la loro ripugnanza ad un lavoro
organizzato, stabile non di rado nella necessità di ricorrere al delitto: di qui la loro
pericolosità”87. Ma, ancora di più, essi sono legati al mondo della delinquenza perché è
carattere tipico dell’ “uomo delinquente amare l’ozio ed i facili piaceri (…).”88
Patologia sociale o patologia individuale, classi o individui criminali, il discorso sul
problema del delitto è così espropriato alla teoria giuridica. Le varie antropologie,
psicologie o sociologie criminali, sorte dall’entusiasmo positivista, da questo momento
in poi permeeranno dei loro postulati la pratica penale.
L’esigenza di ordine, e norme come salvaguardia dello stesso, che ovviamente si
manifesta in tutte le società, divenne molto forte tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.
L’ordine lo possiamo intendere come un tentativo (disperato) di imporre uniformità,
regolarità e prevedibilità al mondo umano. La prevedibilità in particolare diviene
garanzia di sicurezza. L’altra imposizione è costituita appunto dalla norma che indica,
85
M. Rèbora, “Oziosi e vagabondi”, in Enciclopedia giuridica italiana, 1915, p. 1202 e seg.
Ibidem, p. 1202 e seg.
87
Ibidem, p. 1202 e seg.
88
Ibidem, p. 1202 e seg. L'autore ci offre inoltre un saggio delle sue doti d'empirista, descrivendoci tutta
una fenomenologia del vagabondaggio e dell'accattonaggio: "li trovate ciechi sui gradini delle chiese con
il cagnolino ammaestrato che li guida e tiene in bocca il cappello del padrone, povera bestia impassibile e
incolpevole; li vedete donne vecchie lerce e cenciose nell'atrio del tempio vendere scapolari o medaglie, o
nell'interno volontarie custodi delle cassette delle elemosine che alleggeriscono dell'obolo con pieghevoli,
sottilissime bacchette spalmate di vischio, in un momento di profonda estasi e di raccoglimento intenso; li
trovate a frotte nell'interno della città, nelle vie popolose dei sobborghi, uomini e donne, adulti e fanciulli
con poche cartoline illustrate, o foglietti di una canzonetta oscena o stupida in mano, o un mazzolino di
fiori avvizziti, o due scatolette di cerini in una sgangherata cassetta appesa al collo, gobbi, storpi, guerci,
mutilati, piagati, mostri senza braccia e senza gambe, assillare spesso aiutati da un gemebondo organetto
delinquente, i passanti, importunarli, seguirli, insolentirli quando non esauditi”.
86
48
come proiezione del modello di ordine sulla nostra condotta, il giusto comportamento
da seguire. Ogni tipo di società sceglie il proprio grado di ordine e facendo ciò limita il
ventaglio di possibili sistemi (di ordine) alternativi. Per cui, in base al sistema di ordine
vigente, alcune forme
di condotta che non rientrano nella norma, in quanto si
discostano dal modello, vengono considerate anormali, fino a diventare devianti. La
linea di demarcazione tra la semplice anormalità e il concetto (più inquietante) di
devianza però non è mai così netta; ed è proprio in questa linea non chiara che possiamo
inserire la storia della persona senza dimora, perché se in alcuni periodi la figura del
mendicante, del vagabondo poteva essere accettata nonostante il comportamento fosse
considerato anormale, in altri periodi non era più tollerata89 in quanto deviante, quindi
punibile penalmente.
Come abbiamo accennato sopra, l’esigenza di controllo e di ordine, in Italia, si esplicitò
anche nel sistema assistenziale manifestandosi in una maggiore ingerenza dello Stato
nella beneficenza, ambito prima coperto da istituzioni religiose90 e, soprattutto, in una
più accentuata categorizzazione dell’utenza titolare del diritto di assistenza. E’ sempre
tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 che si definiscono con precisione i presupposti per
accedere nell’area dell’assistenza pubblica; essi sono lo stato di bisogno e la dimora. In
questo modo, coloro che non rientrano in una particolare categoria, cioè coloro che non
hanno una dimora e vivono uno stato di bisogno difficile da inquadrare, non possono
essere presi in carico dall’istituzione pubblica. Di queste persone, se ne occuperanno
quindi altri istituti. Se pensiamo ad esempio al codice penale del 1889, di liberale
impostazione, nonostante non attribuì più rilevanza penale al vagabondaggio,
quest’ultimo venne relegato fra i cosiddetti “illeciti di polizia”. Assistiamo ad un lieve
aumento dei requisiti richiesti, insomma, per poter essere sottoposti all’ammonizione, al
domicilio coatto o all’arresto, ma sostanzialmente il “nuovo” testo unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza varato dalla sinistra ricalca i precedenti provvedimenti dovuti ai
governi di destra, ridando nuova vita a misure di polizia (come il domicilio coatto) nate
per esigenze eccezionali. Vecchi arnesi polizieschi si trovarono rilegittimati dall’idea di
essere stati sottoposti a maggiori garanzie. Le figure soggettive sottoposte a controllo in
89
“La distinzione tra la semplice anormalità e il concetto ben più inquietante di devianza non viene mai
tracciata tuttavia chiaramente e di solito è ampiamente discussa, come nel caso dei limiti della tolleranza,
essendo l’atteggiamento che definisce la differenza fra di esse.” Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove
povertà, Città Aperta, Troina, 2004, p. 129.
90
Ricordiamo che con la legge n. 6972 del 17/07/1890, nascono le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e le
Congregazioni di Carità che avevano il compito di far fronte alle esigenze delle fasce marginali della
popolazione.
49
quanto pericolose resteranno sostanzialmente identiche, gli oziosi e vagabondi
rimarranno tra le più importanti. Con il codice Rocco del 1930, la distinzione tra
mendicità improba e non legale, ozio e vagabondaggio che, come abbiamo accennato,
spesso rimaneva solo sulla carta, decade: il legislatore operò la scelta di reprimere
comunque la mendicità “in luogo pubblico o aperto al pubblico” con la punizione
dell’arresto fino a tre mesi. Il carcere diviene così il principale strumento di controllo
nei confronti della persona senza dimora. Il reato (la mendicità) consiste nel suscitare
l’altrui sentimento di pietà , una pietà che non può esistere nei confronti di colui che
adotta un comportamento a-normale, a-sociale o addirittura anti-sociale, nei confronti
di colui che vive oziando in una società in cui il lavoro diviene un dovere, in quanto uno
dei valori fondamentali; è nel lavoro che la persona acquisisce un ruolo e una dignità. Il
mendicante quindi è assunto quale vero e proprio pericolo per la società al pari del
malato di mente, del tossicodipendente, dell’alcolista…L’unico rimedio al problema è
la reclusione totale, separare ciò che è normale, quindi buono da ciò che è anormale,
quindi fortemente negativo e pericoloso. Nel rapporto tra lavoro e vagabondaggio, è
sempre il vagabondaggio a spiegare il non lavoro che diviene una vera e propria scelta,
il vagabondaggio quindi è inteso come un fatto individuale e non un problema sociale.
Il sentimento di carità, l’aiuto ai poveri, la pietà verso i “bisognosi” e gli “infelici”
sembra così essersi eclissata; dall’età moderna in poi “la forca ha steso la sua ombra su
quei sentimenti”91. Nonostante ciò, anche nei periodi di grande repressione nei confronti
dei vagabondi, non possiamo pensare che le iniziative caritative individuali fossero
cessate. “L’ethos medioevale della povertà si indebolisce o si scompone alle soglie
dell’età moderna, ma fissa un’impronta fondamentale nella civiltà cristiana, e per questa
ragione perdura nella cultura europea come una delle possibilità, una delle proposte”92.
Negli anni sessanta –settanta anche l’ Italia viene toccata da “profondi” mutamenti.
L’idea che la povertà e l’emarginazione
fossero il frutto di una deficienza
dell’individuo cui rispondere severamente per mezzo dell’intervento penale, venne
mano a mano a decadere, per cui il ruolo riservato alle agenzie penali venne
progressivamente restringendosi. Nel corso degli anni ottanta si assiste alla cosiddetta
“riscoperta della povertà”93 tanto che si producono numerose ricerche sia su scala
nazionale che locale. La povertà è tornata ad essere una condizione socialmente
91
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 264.
Ibidem, p. 266.
93
G. Serpellon, “Dalla povertà nascosta alle nuove povertà”, in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le
residualità come valore. Povertà urbane e dignità umana, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 300-308.
92
50
riconosciuta94. Il Welfare deve assumere così quelle funzioni un tempo riservate al
sistema penale. Per quanto riguarda il sistema assistenziale, il forte bisogno di
istituzionalizzare, di categorizzare e di educare, comincia a venir meno così che, il
continuo proliferare e specializzarsi dei vari istituti di ricovero subisca una significativa
inversione95. Tra le persone che hanno diritto all’assistenza vi sono anche quelle “prive
di un regolare sistema di vita”; in questa “categoria” generica rientrano gli oziosi, i
vagabondi, gli alcolizzati, i mendicanti, coloro che non hanno una stabile occupazione e
una fissa dimora. In generale però, tutti i sistemi assistenziali considerano queste
persone come una massa oscura, pericolosa , da trattare prevalentemente sotto il profilo
della “difesa sociale”, della “pubblica sicurezza” e per la maggior parte vengono escluse
dalle forme di assistenza economica, in quanto ritenute incapaci di farne buon uso e in
ciò notiamo la forte influenza del sistema legislativo nel come trattare queste persone.
Vengono infatti apprestati dormitori notturni, dai quali questi “irregolari” escono al
mattino per vagabondare attraverso la città: sono allestite anche delle mense ad essi
riservate, le così dette “mense dei poveri” e, in altri casi vengono aggiunti altri
interventi quali la concessione di abiti, scarpe, attrezzi di lavoro96. Sempre più però
l’immagine del “povero” quale pericoloso attentatore dell’ordine sociale, viene ad
essere coperta di nuovo dall’immagine del bisognoso di aiuto.
La sentenza della Corte Costituzionale del 28-12-1995, n. 519, dichiarando
l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 670 c. p., non fa altro che dare
un peso legislativo a questo “sentire comune” che già le ordinanze della pretura di
Firenze e di Modena, sezione distaccata di Carpi, avevano espresso. La sentenza infatti
considera che la mendicità è già un reato ormai scarsamente perseguito in concreto, in
quanto “nella vita quotidiana, specie nelle città più ricche, non è raro il caso di coloro
che senza arrecare alcun disturbo domandino compostamente, se non con evidente
imbarazzo, un aiuto ai passanti”. In queste poche righe già possiamo notare il modo in
cui viene descritto colui che mendica. Avremmo fatto una grande difficoltà a trovare
una simile descrizione in uno scritto dell’800, se non anche dei primi del ‘900. Nella
sentenza si prosegue poi mettendo in evidenza anche il “disagio degli organi statali
94
G. Procacci, Governare la povertà. La società liberale e la nascita della questione sociale, Il Mulino,
Bologna, 1998, pp. 263-276.
95
“Ad esempio, sempre in Italia, nel 1971 vi erano 64 dormitori con 7394 posti letto, mentre nel 1988
sono solamente 37 con 2479 posti letto”. M. Bergamaschi, “Immagine e trattamento delle povertà estreme
in una prospettiva storico-sociale”, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà
urbane estreme in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 57.
96
Ibidem, p. 57- 58.
51
preposti alla repressione di questo e altri reati consimili chiaramente avvertito e, talora,
apertamente manifestato che è sintomo, univoco, di un’abnorme utilizzazione dello
strumento penale”. La povertà e l’emarginazione vengono di nuovo considerate come
conseguenze di problemi strutturali che riguardano quindi la società e gli atteggiamenti
atti a considerare le persone che versano in queste condizioni come pericolose e
colpevoli, vengono visti come dei tentativi di nascondere questi problemi nell’ottica
sociale appunto. Così nella sentenza: “Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano
le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che senza
indulgere in atteggiamenti di severo moralismo non si può non cogliere con preoccupata
inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la
miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli.
Quasi in una sorta di recupero della mendicità quale devianza, secondo linee che il
movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale,
preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione
di stabilimenti di ricovero (o getti?) per i mendicanti”. Anche in questa ultima parte si
evidenzia l’impossibilità e anche la disumanità nell’adottare forme di prevenzione in
stabilimenti di ricovero, o forse meglio detti ghetti, così come vengono viste inquietanti
e preoccupanti le tendenze che sono atte a reprimere, piuttosto che ad affrontare, una
problematica che è parte integrante del sistema sociale. Per cui è in primo luogo dovere
sociale prendersi delle responsabilità ed occuparsi di una problematica che per troppo
tempo è stata nascosta, annullata, disumanizzata. Di seguito vengono menzionate le
organizzazioni di volontariato che sono la voce della società civile mossa da sentimenti
di solidarietà, voce che lo Stato per primo e tutto il sistema legislativo, non possono fare
a meno di prendere in considerazione. Infatti ancora nella sentenza si dice che “la
coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo
ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la società civile
consapevole dell’insufficienza dell’azione dello Stato ha attivato autonome risposte,
come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion
d’essere , e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà. (…). In questo
quadro, la figura criminosa della mendicità (…) appare costituzionalmente
irragionevole alla luce del canone della ragionevolezza, non potendosi ritenere in alcun
modo necessitato il ricorso alla regola penale. Né la tutela dei beni giuridici della
tranquillità pubblica (…), può dirsi invero seriamente posta in pericolo dalla mera
mendicità che si risolve in una semplice richiesta d’aiuto”. In questa sentenza si parla
52
ancora di mendicità invasiva e mendicità non invasiva, distinzione che ritengo però, ai
fini del nostro discorso, di secondaria importanza, soprattutto se consideriamo che
anche il reato di mendicità invasiva, previsto nel secondo comma dell’art. 670 c. p., non
viene quasi mai perseguito e che con la legge del 25 giugno 1999, n. 205, art. 18 viene
cancellato in quanto attraverso questa legge viene abrogato tutto l’art. 670 del c. p.. Dal
1999 quindi la mendicità non è più un reato ma viene considerato una “semplice
richiesta di aiuto”.
Ora è molto difficile descrivere quali siano i “sentimenti” che la vista della persona
senza dimora innescano. Geremek ponendosi la domanda se i sentimenti avessero una
storia dice che è impossibile non riconoscere l’importanza degli studi sulla storia dei
sentimenti per la storia della società e della cultura, ma dice anche che in questo campo
è particolarmente alto il rischio di arbitrio. “Perché si può ritenere che una vera storia
dei sentimenti debba risalire fino ad una dimensione biologica della storia umana e
prendere in considerazione processi evolutivi talmente lenti da sfuggire all’osservazione
dello storico; processi che non si sottomettono alle tecniche d’indagine proprie del
mestiere dello storico”97. Nonostante ciò, analizzando le motivazioni dei comportamenti
umani e le manifestazioni dei sentimenti (da ben specificare: non i sentimenti stessi), si
può constatare che certi comportamenti e sentimenti, in alcuni periodi, riscuotono un
maggior consenso di altri, “che esistono cioè <addensamenti> e <diluizioni> sui generis
nelle loro manifestazioni”98. Dobbiamo comunque parlare di una coesistenza di alcuni
atteggiamenti e sentimenti che possono sembrare agli antipodi. Tornando allo specifico
del nostro discorso, vediamo che tutte le società hanno assunto verso i loro poveri un
atteggiamento tipicamente ambivalente, complessa mescolanza di due reazioni: la paura
e la ripugnanza da un lato, la pietà e la compassione dall’altro; e la sentenza in un certo
qual modo mette in evidenza questa ambivalenza: partendo dal presupposto o meglio,
dalla constatazione che la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento di fronte a
comportamenti che un tempo erano ritenuti pericolo incombente per una ordinata
convivenza, menziona il sentimento di solidarietà della società civile. Sentimento che
spesso può tradursi con il sentimento di compassione che viene esplicato dall’ “aiuto ai
bisognosi” di cui molte associazioni di volontariato si occupano. Sentimento che
97
98
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 263.
Ibidem, p. 263.
53
affonda le sue radici soprattutto nel cristianesimo99; non a caso molte associazioni in
Italia che si occupano di persone senza dimora sono di stampo cattolico. Geremek,
considera che il sentimento di solidarietà sia basato sulla reciprocità, ma aggiunge che
nell’aiuto ai poveri, è spesso presente una relazione fra il dono – ed i suoi riferimenti
antropologici – e la speranza di un valore escatologico dell’azione di aiuto, per cui
bisognerebbe dire che l’atto di carità – caritas intesa come amore –inizia soltanto
quando vengono esclusi quegli elementi di interesse. “Nei comportamenti sociali si
intrecciano notoriamente elementi di <interesse> e di semplice amore del prossimo, di
pietà piena di disprezzo e di aiuti veri”100.
L’approccio del “compassionevole” è
comunque di tipo restrittivo nel senso che la persona viene considerata in quanto
bisognosa o mancante di qualche cosa: è sempre il bicchiere mezzo vuoto che viene
preso in considerazione, per cui la prima cosa che ci viene in mente di fare è di colmare
quei determinati bisogni101. Non che questo sia per forza sbagliato ma dal momento che
ci poniamo di fronte ad una persona e la consideriamo mancante, automaticamente
stabiliamo una distanza e una differenza, differenza che può divenire ontologica se non
riusciamo nemmeno per un attimo a prendere in considerazione altre prospettive.
Considerare ad esempio la persona senza dimora dal punto di vista dei diritti (diritti che
in questo caso sono disattesi o violati), anziché dei bisogni è molto difficile, lo è
soprattutto nell’ottica dell’etica del lavoro, comunque ancora oggi presente con la
“vecchia” domanda “perché non vanno a lavorare”. L’attenuante è l’inabilità.
L’attenuante può essere quindi la mancanza dovuta ad un problema fisico o psicologico.
Oppure un altro attenuante potrebbe essere credere ad un evento traumatico o addirittura
ad un insieme di eventi traumatici che hanno portato la persona in strada, tipo la perdita
del lavoro, ovviamente non per cause personali, l’abbandono della famiglia, lo
sfratto…Altro attenuante ancora è credere nella scelta libera e autonoma di queste
persone di uno stile di vita all’insegna dell’anticonformismo, della rinuncia ai modelli di
99
“Durante il mio soggiorno tra i monaci, incontravo ogni giorno questi mendicanti vicino alla chiesa in
cui venivano celebrate le funzioni. Il loro volto e il loro destino mi perseguitavano, e alla loro vista
sorgeva in me un appello pressante a scendere più in basso nella sofferenza umana. Scorgevo in loro il
volto del Crocifisso. Se erano il Cristo e se volevo seguirlo, allora dovevo passare dalla loro parte,
cambiare sponda. Non potevo più restare là davanti e passare oltre.”, M. e C. Collard-Gambiez, Un uomo
che chiamano clochard, Edizioni Lavoro, Roma, 1999, p. 45.
100
B. Geremek, La pietà e la forca, Laterza, Bari, 1995, p. 265.
101
Scrive Mauss: “Donare, equivale a dimostrare la propria superiorità, valere di più, essere più in alto,
magister; accettare senza ricambiare o senza ricambiare in eccesso, equivale a subordinarsi, a diventare
cliente o servo, farsi più piccolo, cadere più in basso.” M. Mauss, “Saggio sul dono. Forma e motivo dello
scambio nelle società arcaiche”, in M. Mauss, Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino,
1991, pp. 153-292.
54
vita prevalenti. Basti dire che quest’ultima è una visione molto elementare e riduttiva di
una realtà, che è al contrario, molto eterogenea e dipendente dal contesto temporale102 e
soprattutto questa immagine del “barbone” è estremamente riduttiva se si considera che
queste persone hanno pressanti problemi nel soddisfacimento dei loro bisogni primari.
Altra immagine è quella del povero “buono”, questa, soprattutto, “è un’idea dei ricchi
che amano mantenere un’aureola romantica attorno ai poveri. Come se, in nome di
buoni sentimenti cristiani o per il loro senso di colpa, volessero salvare l’onore dei
poveri rivestendoli di virtù conservate grazie alla povertà, che loro ricchi invece
avrebbero perso per colpa delle proprie ricchezze!”103 O condanniamo il povero o lo
rivestiamo di tutte le virtù. E’ molto difficile pensare o soprattutto rendersi conto che
anche queste persone hanno fatto parte della nostra normalità, è molto difficile
abbandonare la barriera che spesso è il gesto stesso del dare l’elemosina a mantenerla.
Il misto di paura, rabbia e disapprovazione comunque rimane, soprattutto se il
“barbone” viene assimilato al tossico, al criminale all’immigrato…, tutti accumunati in
un’unica categoria come esempi di un generico comportamento “antisociale”; in questo
caso è soprattutto la paura a prevalere. Confondere la povertà con la criminalità ha
inoltre l’effetto di bandire i reietti dall’universo degli obblighi morali. “Se la moralità
consiste essenzialmente nel sentirsi responsabili dell’integrità e del benessere delle
persone più deboli, svantaggiate e sofferenti, la criminalizzazione della povertà tende ad
estinguere questo impulso”.104 Infatti quando i poveri vengono considerati criminali, in
potenza o in atto, cessano di costituire un problema morale e ci esimono dalle nostre
responsabilità sociali. In questo modo, non si pone più la questione morale di difenderli
dalla crudele realtà in cui versano, bensì quella di difendere la vita e i beni delle persone
normali dalle minacce che possono provenire dai quartieri degradati, dai ghetti e dalle
zone malfamate. L’importante è non cogliere mai ciò che ci può legare a queste
persone, l’importante è non cogliere la loro individualità, perché fare questo ci mette a
contatto con le nostre paure, con le nostre insicurezze. E’ molto più facile pensarle
come causa delle nostre paure, piuttosto che individui che condividono le nostre intime
incertezze, i nostri intimi disagi. “Questa è la stranezza più disorientante e spaesante che
ci capiti di leggere sul volto dell’altro: L’invito rivolto allo straniero in noi, al nostro
straniero interno, a guardare da lontano, per la prima volta, la luna su cui abbiamo
102
L. Berzano, “Il vagabondaggio nella metropoli”, in Sociologia urbana e rurale n. 35, FrancoAngeli,
Milano, 1991, pp. 162-163.
103
Michel, Colette Collard-Gambiez, Un uomo che chiamiamo Clochard, Edizioni Lavoro, Roma, 1999.
104
Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta, Troina, 2004, p. 119.
55
vissuto, e a porci domande mai poste, a sentire la felicità della loro familiarità
ritrovata.”105 Parlando invece di politiche sociali, perché è considerando il problema
della persona sena dimora sotto questo punto di vista che possiamo parlare di diritti
negati, sicuramente ad oggi la persona senza dimora ha acquisito una maggiore visibilità
in quanto il problema viene riconosciuto a livello nazionale: la legge 328, del 2000,
sull’assistenza, ad esempio, nell’articolo 27, istituì presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, una Commissione d’indagine sulla esclusione sociale, con il compito di
effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione
europea, indagini sulla povertà e sull’emarginazione in Italia. Allo scopo di potenziare
gli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni
di povertà estrema e ai senza dimora , nell’articolo 28 della stessa legge, si dispose di
incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali di una somma pari a venti
miliardi delle “vecchie” lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Peccato che con la
riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001) la
legge “quadro” del 2000 perda il potere di una legge “quadro” appunto. Uno degli
aspetti centrali della riforma è appunto rappresentato dal capovolgimento dell’originario
impianto costituzionale di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e
Regioni106. Non ci resta che concludere asserendo che è ancora molto lunga la strada da
percorrere per poter parlare della persona senza dimora come una persona portatrice dei
nostri stessi ed identici diritti e accorgerci che c’è un altro punto di vista: quello di
cogliere per primo che il bicchiere sia mezzo pieno!
105
R. Escobar, Metamorfosi della paura, Mulino, Bologna, 1997, p. 159.
Allo Stato è riservata la potestà esclusiva e quella concorrente con le Regioni, in un elenco espresso di
materie, mentre “aspetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. (ddlc. N. c. 4462 ed altri, art. 3). Per quanto
riguarda il settore dell’assistenza sociale, “tale materia non compare né fra le materie esclusive dello Stato
né fra quelle di competenza concorrente, dovendo quindi concludersi che, in base alla nuova disciplina
costituzionale, l’assistenza sociale appartenga oggi all’ambito delle materie di competenza legislativa
regionale primaria. Uno dei settori classici delle politiche sociali, quello socio-assistenziale, viene dunque
lasciato alle decisioni ed alle scelte dei governi e dei legislatori regionali i quali non saranno più vincolati
all’osservanza dei principi fondamentali e degli indirizzi indicati dallo Stato. (…) In tale sistema
rinnovato, la legge 328/2000 avrà forza vincolante fino a quando non intervenga il legislatore regionale
ad approvare una nuova normativa dai contenuti incompatibili con la preesistente disciplina statale.” In C.
Landuzzi, M. Corazza (a cura di), Minori in città, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 188-189.
106
56
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Vorrei concludere il mio discorso riprendendo le parole di Xavier Emmanuelli con le
quali ho aperto questo lavoro. Emmanuelli ci dice che l’esclusione è prima di tutto nelle
nostre teste, nei nostri cuori, nel nostro modo di pensare ed è proprio per questo che è
così difficile da cogliere e soprattutto da combattere. Gli atteggiamenti sociopsicologici nei confronti della persona senza dimora oggi non possono essere analizzati
e compresi, se non risaliamo alle loro radici storiche; come abbiamo visto essi cambiano
molto lentamente e spesso atteggiamenti tra loro in aperto contrasto sono compresenti o
si alternano attraverso periodi di debolezza e di forza. La nozione di “povertà urbana
estrema” fa parte del lessico contemporaneo; oggi dobbiamo capire che povertà e
povertà estreme sono due cose fortemente diverse. Quest’ultime non rappresentano la
fascia più bassa della povertà, non sono l’ultimo gradino di un percorso continuo ma
hanno ragioni specifiche, mentre, per quanto concerne il passato il concetto di povertà
estrema si associa al concetto di mendicità, vagabondaggio, ozio, accattonaggio.
Immagini che, in particolare da metà 800, vengono ad assumere una connotazione
estremamente negativa soprattutto grazie anche al sistema legislativo. Il vagabondo,
l’ozioso non può più essere tollerato in quanto stravolge tutto il sistema etico e morale
che ha come fondamento l’etica del lavoro, imperante in questo tipo di società; Il
mendicante non suscita pietà perché preferisce uno stile di vita dedito all’ozio, al
disordine, alla mancanza di valori e, oltre a ciò, è privo di una stabile dimora, sintomo
anch’esso di libertinaggio, di disordine morale poiché impedisce di condurre una vita
familiare, onesta, di risparmio, caratteristica in aperta contraddizione con le esigenze del
tempo di stabilità territoriale che è invece sinonimo di ordine e controllo allo stesso
tempo. La reclusione così diviene l’unica soluzione. Se per tutto il ‘700 fino alla prima
metà dell’800 si pensava che attraverso una adeguata educazione al lavoro l’ozioso
poteva essere “redento”, dalla seconda metà dell’800, ciò non si ritiene più possibile
grazie anche al contributo della scienza medica e di quella psichiatrica in particolare. Il
nascente positivismo criminologico fornisce nuove legittimazioni ai vari tipi di “istituti”
di reclusione e contribuisce ad una nuova definizione della povertà urbana estrema che
viene equiparata alla delinquenza vera e propria espressione di “anomalie” biologiche
che non possono essere cambiate ma soltanto essere arginate, soppresse. Il positivismo
avrà una forte influenza nel codice penale del 1930 (il codice Rocco) che considererà la
57
mendicità, senza distinzioni tra poveri meritevoli e non, un reato a tutti gli effetti; il
carcere diviene così il principale strumento di controllo nei confronti della persona
senza dimora. Oggi la povertà è tornata ad essere una condizione socialmente
riconosciuta, il mendicante piuttosto che suscitare paura, suscita compassione; la
sentenza della Corte Costituzionale infatti, proprio partendo dal presupposto che la
mendicità non sia più un pericolo e che il mendicante chiedendo l’elemosina in strada
non sia più portatore di disordine in quanto difficilmente con il proprio atteggiamento
suscita paura, disdegno, dichiara l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art.
670 c. p. La sentenza ci rimanda quindi all’immagine del mendicante “bisognoso di
aiuto”: potremmo dire che segna una svolta importante ma allo stesso tempo non
dobbiamo dimenticare che la sentenza, a sua volta, non fa altro che esplicitare e dare un
senso legislativo ad un sentire comune già presente. La presenza della persona senza
dimora oggi, difficilmente suscita paura quanto piuttosto compassione, sentimento che
pone comunque il soggetto verso cui si rivolge in un “mondo” altro privandolo di una
dignità soggettiva. Per cui ancora oggi la persona senza dimora è oggetto di stereotipi e
luoghi comuni che non permettono di considerare la vita reale di persone portatori dei
nostri stessi diritti.
58
FONTI LEGISLATIVE
Legge sarda 11-11 1859.
Legge 20- 3 1865.
Legge 23-12- 1888, n. 5888, legge sulla pubblica sicurezza.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 30-6-1889, n. 6144.
Regio decreto 19-11-1889, n. 6535.
Articoli 670-671 codice penale.
Articolo 154, t. u. l. p. s. (r. d. 18-6-1931, n. 773, approvazione del t. u. delle leggi di
pubblica sicurezza).
Articoli 277, 281, 283, regolamento per l’esecuzione del t. u. 18-6-1931, n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza (r. d. 6-5-1940, n. 635.
Legge 27-12-1956, n. 1423, misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (nel testo modificato dalla legge 3-81988, n. 327, norme in materia di misure di prevenzioni personali).
Articolo 38 Costituzione.
Sentenza 7-5-1975, n. 102.
Sentenza 28-12-1995, n. 519.
Articolo 18, legge 25-6-1999, n. 205.
Legge 8-11-2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
Legge costituzionale 18-10- 2001, n. 3, riforma del titolo V della Costituzione.
59
BIBLIOGRAFIA
Anderson N., The hobo. The sociology of the Homeless Man, The University Press,
Chicago, 1924, tr. It. Il Vagabondo. Sociologia dell’uomo senza dimora, Donzelli,
Roma, 1994.
Castel R., “Disuguaglianze e vulnerabilità sociale”, in Rassegna italiana di sociologia,
n. 1, 1997.
Castel R., L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004.
Cosseddu A., “Mendicità”, in Digesto, Discipline penalistiche, vol. VII, UTET, Torino,
1993.
Balocchi E., “Mendicità (dir. amm.)”, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Giuffrè.
Bauman Z., Lavoro, consumismo e nuove povertà, CittaAperta, 2004.
Becker H.S., Outsiders, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.
Bergamaschi M., Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, FrancoAngeli,
Milano, 1999.
Bergamaschi M., “Emergenza di una nozione: L’esclusione come paradigma della
coesione sociale. Dalla povertà alla società duale”, in TRA, n. 3, 1999.
Berzano L., “Il vagabondo nella metropoli”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991.
Berzano L., Prina F., Sociologia della devianza, Carocci, Roma, 1999.
Bonadonna F., Il nome del barbone, DeriveApprodi, Roma, 2001.
Bosi M., Le incerte povertà, FrancoAngeli, Milano, 1992.
Cicala S., “Mendicità, vagabondaggio ed ozio nel diritto pubblico italiano ed estero”, in
La scuola positiva italiana, vol. X, 1930.
Collard M., Gambiez C., Un uomo che chiamano clochard, Edizioni Lavoro, Roma,
1999.
De Luise D. (a cura di), San Marcellino: operare con le persone senza dimora,
FrancoAngeli, Milano, 2005.
Escobar R., Metamorfosi della paura, Mulino, Bologna, 1997.
Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1993.
Foucault M., Gli anormali, Feltrinelli, Milano, 2000.
60
Geremek B., La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Laterza,
Roma, 1998.
Girotti F., Welfare State, Carocci, Roma, 2000.
Goffman E., Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.
Goffman E., Stigma, Giuffrè, Milano, 1983.
Guidicini P., Pieretti G. (a cura di), Le residualità come valore, FrancoAngeli, Milano,
1993.
Guidicini P., Pieretti G., I volti della povertà urbana, FrancoAngeli, Milano, 1992.
Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M. (a cura di), Povertà urbane estreme in
Europa, FrancoAngeli, Milano, 1995.
Guidicini P., Pieretti G. (a cura di), Città globale e città degli esclusi, FrancoAngeli,
Milano, 1998.
Gutton J. P., La società e i poveri, Mondatori, Verona, 1977.
Landuzzi C., Corazza M. ( a cura di), Minori in città, FrancoAngeli, Milano, 2005.
Landuzzi C., Pieretti G. (a cura di), Servizio sociale e povertà estreme, FrancoAngeli,
Milano, 2003.
Luhmann N., Potere e codice politico, Feltrinelli, Milano, 1982.
Martinelli F., “Studi sulla povertà urbana nelle ricerche sociali e nell’intervento
sociale”, in Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991.
Melossi D., Patarini M., Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario,
Bologna, 1982.
Niceforo A., Antropologia delle classi povere, Vallardi, Milano, 1908.
Panagia S., “Mendicità (dir.pen.)”,in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Giuffrè.
Patarini M., “Le fattispecie soggettive di pericolosità”, in Le misure di prevenzione, atti
del convegno di Alghero, Milano, 1975.
Petrini D. “Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione”,
in Storia d’Italia , annale n. 12, La criminalità, Torino, 1997.
Piazzi G., La ragazza e il direttore, FrancoAngeli, Milano, 1995.
Pieretti G., “Povertà estreme e povertà silenziose: il ruolo dei processi urbani”, in
Sociologia urbana e rurale, n. 35, 1991.
61
Pomba G., Qualche cenno sulla mendicità e sui mezzi per estirparla, Torino, 1834.
Procacci G., “L’economia sociale e governo della miseria”, in AUT/AUT, 167/168,
1978.
Rauty R., Homeless. Povertà e solitudini contemporanee, Costa&Nolan, 1997.
Rèbora M., “Oziosi e vagabondi”, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. XII, 1915.
62