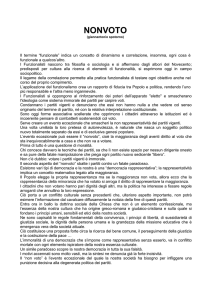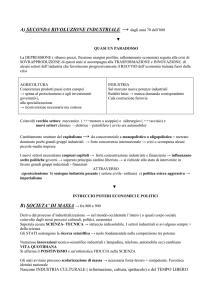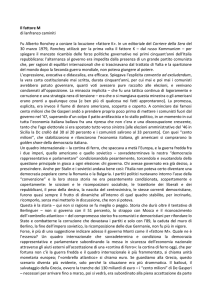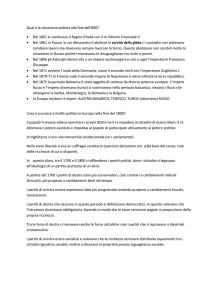LE LEVE DI UN NUOVO SVILUPPO
IL PATRIMONIO CULTURALE
Giorgio Ruffolo
Il possibile declino della cultura politica (e i modi per scongiurarlo)
Non intendo certo parlare della cultura in senso lato, ma di cultura politica. E più
propriamente delle radici culturali dell’attuale condizione politica italiana, delle
correnti profonde, storiche, che l’ attraversano, delle prospettive sulle quali il loro
corso si apre. Del nostro presente politico come storia, insomma. E certo non da
storico, che non sono, ma da politico che tenta di guardare un po’ al di là dell’agenda
quotidiana, per trarne qualche riflessione pratica.
1. Un giorno forse ci accorgeremo che nel primo quinquennio degli anni novanta c’è
stata, nel nostro paese, una vera e propria catastrofe politica, un terremoto che ha
fatto emergere strati profondi della nostra società, abbattuto strutture portanti, aperto
varchi inquietanti, ma anche promettenti, sul nostro futuro.
Forse non si coglie ancora, nel dibattito politico corrente, la radicalità di quella
svolta. O almeno, se ne colgono solo gli aspetti più immediatamente preoccupanti,
interpretandoli in senso tendenzialmente pessimistico. La nota predominante di quel
dibattito, negli ultimi anni, soprattutto a sinistra, ma non solo, è al pessimismo. E io
mi permetterei di suggerire qualche cautela nell’uso di certe categorie che hanno
tendenza a cristallizzarsi come slogan, come quella di “declino”. Senza negare i
vistosi sintomi di tendenze regressive preoccupanti, ci si deve guardare dal
considerarle irreversibili. Del resto, non sempre le catastrofi sono, necessariamente,
catastrofiche. Come nell’ideogramma cinese la parola crisi, anche la parola catastrofe
contiene ambiguamente il disastro e l’occasione. Troppo spesso poi, la necessità di
fare il punto a scadenze fisse sullo stato della nazione da parte degli ormai numerosi
osservatori sociali accreditati, e l’esigenza di farlo in modo da attirare l’attenzione del
pubblico, trasforma ogni evento in un avvento. Così i medioevi e i rinascimenti
appaiono e scompaiono sulla scena con ritmo semestrale. Gli umori quotidiani
generano annunci di decadenze e di miracoli.
1
E’ indicativa di questa volubilità l’improvvisa denuncia drammatica della crisi delle
istituzioni e della enorme inermità della società italiana, da parte di interpreti brillanti
delle nostre vicende, che fino a ieri ci avevano lusingato con la rappresentazione della
sua miracolosa creatività neurovegetativa. Là dove si sottolineavano, ieri, le virtù
della improvvisazione e quell’arte di arrangiarsi che – come dice Alfredo Reichlin non può più ormai compensare i mali antichi del paese, si denuncia oggi, da parte
degli stessi profeti di ieri, la carenza delle strutture. Dove si celebrava la
multiformità della società informale e la fecondità proteica delle piccole imprese, si
lamenta oggi il drammatico bisogno e la disperata carenza delle grandi; e alcuni di
quelli che indicavano come fattore di blocco della dinamica politica la presa dei
grandi partiti sulla società, lamentano oggi a gran voce il difetto di strutture
vertebrate della politica. Forse, un po’ più di pazienza e di coerenza non
guasterebbero.
2. Pure, una svolta epocale, alla vigilia della fine del secolo scorso, effettivamente,
c’è stata. Una svolta che ha chiuso la fase fondativa della nostra Repubblica (un
cinquantennio) aprendone un’altra, piena di incognite. Quella svolta mi pare
contrassegnata da una rivolta antipolitica che sottopone a un revisionismo radicale
valori e principi del cinquantennio repubblicano.
In quegli anni è tramontata la democrazia dei partiti. Ed è venuta alla ribalta una
democrazia impolitica Caratteristica essenziale, culturale, di questa emersione è il
privatismo. Sotto questo nome raccolgo tre principali correnti di quella che potremmo
chiamare, parafrasando Fabio Cusin, la vera antistoria d’Italia: (1) l’antistatalismo
(diffidenza, antipatia, odio verso lo Stato, verso la sua burocrazia, verso le sue tasse,
ma anche verso le sue regole, in generale); (2) il familismo e le formazioni
parafamiliari (clan, mafie,ecc.): la famiglia come perno della società e autentica sede
dell’aggregazione sociale; (3) il mercatismo consumistico, come supremo ideale
sociale.
Le due prime attraversano la storia d’Italia come tonalità minori ma tenaci e potenti:
una specie di basso continuo. La terza è nuova e recente: e dalla sua fusione con le
altre due nasce quella massa critica che, nel momento della crisi delle strutture
politiche della prima repubblica esplode nel fenomeno Berlusconi, portando
l’antistoria d’Italia alla ribalta della storia.
Anche negli altri paesi si riscontrano forze analoghe. Ma non con caratteristiche così
marcate come nel nostro. In nessun paese d’Europa la società civile ha partorito una
così potente forza revulsiva nei riguardi del proprio Stato. Certamente non in Francia,
paese colbertiano e statalista per antonomasia. Ma neppure in Inghilterra, dove pure
la società civile è potente soprattutto nelle sue strutture economiche, e in Germania,
dove si esprime soprattutto attraverso le sue autonomie regionali. In tutti e tre questi
paesi lo Stato gode di un rispetto indiscutibile. Ritornerò alla fine su quella che a me
2
pare la natura di queste forze, e la possibilità che esse si consolidino in un regime,
culturalmente e politicamente retrivo.
Ma intanto, è naturale che ci si debba chiedere come si sia aperto il varco a queste
forze, precipitando nella crisi epocale degli anni novanta. E’ naturale che ci si debba
rivolgere, facendo un passo indietro, alle caratteristiche della democrazia dei partiti
instaurata nel dopoguerra, alle sue virtù, che hanno assicurato la sua continuità e ai
suoi vizi, che ne hanno determinato la fine e aperto il varco alla democrazia
privatistica.
3. In estrema sintesi (questa mia è in senso tecnico una “caricatura” della realtà, un
modello semplificato che si offre alla falsificazione) la democrazia repubblicana dei
partiti poggiava su due grandi forze antagoniste che nella Costituzione trovarono un
punto di convergenza miracoloso. Il compromesso storico non è stato un’aspirazione.
E’ stato una realtà.
Questa convergenza è stata miracolosa perché, proprio nel pieno di una contesa
mondiale tra le due potenze cui quelle forze si riferivano, stabilì una convivenza che
ha permesso all’Italia di salvare la sua unità, di non precipitare in un mondo
balcanico, di non pagare l’avventura fascista con una definitiva esclusione
dall’Occidente capitalistico e democratico.
Questa convergenza ha permesso inoltre di assecondare le forze cariche di energia
delle quali la società italiana era ricca: contadine, operaie, intellettuali, nella vicenda
del miracolo economico italiano. Sono quelle forze che il fascismo, evocandole di
continuo retoricamente, non era mai riuscito a organizzare, e che dopo la sconfitta di
quello uscirono allo scoperto al sole, come i barboni di Miracolo a Milano.
Finalmente, questa convergenza ha permesso un dialogo tra due grandi culture, quella
marxista e quella cattolica, che ha dato nobiltà, in Italia, a un confronto altrimenti
rozzo.
Ma, a quale prezzo? Al prezzo, altissimo, di mancare, una volta ancora nella storia
d’Italia, la costruzione di un vero Stato nazionale.
Quelle due forze, quelle due culture, erano entrambe, per loro formazione, estranee
alla cultura liberale europea, allo Stato nazionale. Erano anomale, in Europa.
Entrambe si affidavano a una storia lunga (noi veniamo da molto lontano e andiamo
molto lontano, diceva Togliatti. Figurarsi quello che avrebbe potuto dire Moro!)
Entrambe detestavano quella che l’eterodossia minoritaria socialista definì, con
grande scandalo di cattolici e di comunisti, la democrazia conflittuale (cioè la
democrazia delle società moderne e complesse) aspirando ad una superiore unità
organica.
Non è dunque certo un caso che fin dall’inizio la democrazia dei grandi partiti
rifiutasse la ricetta del partito d’azione: rifare, da capo a piedi, lo Stato, lo Stato
politico, lo Stato amministrativo, lo Stato economico, e quindi aprire la via maestra
del riformismo, che passa attraverso l’egemonia efficiente di uno Stato moderno.
3
Rispetto allo Stato nazionale, entrambe le forze restavano fredde e indifferenti,
soddisfatte di adoperarlo ai loro fini trascendenti, non interessate per niente a
riformarlo. Il che significava abbandonare lo Stato nelle mani di una burocrazia
inefficiente e invadente.
4. Così, la democrazia dei partiti, che aveva permesso il miracolo, mancò di
consolidarlo attraverso la costruzione di uno Stato che lo gestisse. Il che rendeva
l’economia e la società priva di fondamenta salde. E rendeva vulnerabile la stessa
unità nazionale, faticosamente realizzata nel Risorgimento.
Il fatto è che quelle due grandi forze che gestirono la Repubblica dei partiti, l’una
sempre al governo, l’altra sempre all’opposizione, avevano ereditato una società
invertebrata e una nazione opaca a sé stessa. E qui dobbiamo fare ancora una
rapidissima carrellata all’indietro, molto indietro. L’incapacità di costituire, dopo
l’avventura fascista e il disastro della guerra, uno Stato moderno non era, infatti, che
in parte responsabilità delle due grandi forze storiche del dopoguerra. Era un lascito
della storia d’Italia, dei milletrecento anni trascorsi dopo la fine dell’unità romana:
storia di un paese disunito territorialmente, fin dal tempo della semiconquista
longobarda, con un eterno problema di contrapposizione tra il suo nord e il suo sud; e
quindi impotente a superare quell’altra fatale contrapposizione della nostra storia: tra
lo Stato, anzi gli Stati, prima italiani, poi addirittura stranieri, e la società. Colmare
quei due varchi era difficile assai, per i grandi partiti che, obbedendo a potenze
mondiali contrapposte, non potevano tradurre la loro potenziale convergenza
culturale in attuale alleanza politica. Colmare il primo, quello territoriale, fu la sforzo,
faticosissimo e
sempre frustrato a causa soprattutto dell’inefficienza
dell’amministrazione italiana. A colmare il secondo ci provò, per un breve tempo,
Enrico Berlinguer: e presto se ne ritrasse, come fosse stato scottato.
Le difficoltà, dunque, venivano dal presente. Ma anche, in parte notevole, dal
passato, dalla storia profonda d’Italia. Non c’è bisogno, certo, di evocare la grande
storiografia che per diversi sentieri ha tentato, attraverso opere di autori insigni, da
Machiavelli a Gramsci, di tracciare un sentiero interpretativo che potesse condurci
alle ragioni del fallimento dell’unificazione.
Uno dei modi più avvincenti, e secondo me fecondi, di ritentare l’impresa sarebbe
quello di raccontarci una storia italiana controfattuale. Di chiederci, per esempio,
quale sarebbe stato lo sbocco di un “incontro impossibile” tra il regno del Sud svevo
normanno di Federico II e le repubbliche italiane del nord. Oppure, più tardi, di una
Confederazione italiana dei cinque stati regionali del Rinascimento, da parte di un
Principe machiavelliano e non machiavellico (ma i principi italiani erano assai più
machiavellici che machiavelliani).
Divertimenti a parte, l’eredità storica della divisione italiana è tremendamente
pesante, non soltanto dal punto di vista economico e geopolitico, ma anche, e
soprattutto, dal punto di vista etico. Infatti, l’accettazione di quella realtà, della
divisione nella libertà, nel medioevo; e della divisione nella servitù, nell’età moderna,
4
ha gettato sulla cultura politica italiana il manto di piombo dell’ipocrisia, dell’intrigo
e del cinismo, mascherati da realismo politico.
Peggio: ha seminato quel tremendo retaggio del disprezzo verso noi stessi: quella che
Carlo Emilio Gadda chiamava con formula icastica “la porca rogna
dell’autodenigrazione italiana”. Io non conosco, almeno nell’Europa che frequento,
cittadini significativi di altri paesi sovrani, francesi o spagnoli, tedeschi o britannici,
che ci godano tanto nel rappresentare, specialmente quando parlano con stranieri, il
loro paese usando i toni più abietti: che è la peggior forma di servilismo possibile.
I tre secoli di servitù scavarono tra noi e gli altri grandi paesi europei quella distanza
che abbiamo sempre rappresentato con la categoria concettuale del ritardo: come se il
nostro problema fosse sempre quello di un’imitazione di modelli esterni e mai il
prodotto della nostra invenzione storica.
Quel ritardo, quella inferiorità, l’Italia sabauda e liberal autoritaria tentò di colmarlo
con le avventure coloniali, quella liberal nazionalista con la grande guerra, dopo
alcuni poco gloriosi giri di valzer; e il fascismo con la fondazione di una dittatura da
avanspettacolo travestita in panni imperiali: una forzatura caricaturale che finì per
ampliare il ritardo che voleva colmare a passo romano di parata. Era il prodotto di
una piccola borghesia megalomane e frustrata, di un fuoco artificiale che si spense
nelle macerie e nella vergogna.
Non ci sono però solo fallimenti, nella storia italiana, e in particolare in quella
dell’Italia unita, che abbraccia un periodo così breve della storia d’Italia:
centotrent’anni appena su millequattrocento.
Ci sono, anzi, fasi nelle quali sembra che essa attinga dal profondo le energie
necessarie, per colmare i ritardi.
Il Risorgimento non è certo uno di questi. Ha ragione Aldo Schiavone. L’unificazione
italiana si compie, un po’ avventurosamente, per il rotto della cuffia, in uno dei
momenti più depressi della nostra economia e della nostra vita civile. Altro che
Inghilterra della gloriosa rivoluzione! Altro che Francia della rivoluzione fatidica!
Altro che Germania della kultur bismarckiana! E’ invece, piuttosto, nell’era
giolittiana, alle soglie del Novecento, che l’Italia produce in un suo triangolo, limitato
ma carico di energie, uno sforzo di industrializzazione e di modernizzazione che
avrebbe potuto tradursi, se Turati fosse stato più coraggioso e i massimalisti socialisti
meno cretini, in un riformismo italiano moderno.
Quella fu la prima occasione di un riformismo italiano abortito. Poi ci fu l’occasione
del nostro dopoguerra. Questa volta la Resistenza offriva alle forze vive e vitali del
paese una base di lancio ben più potente e propulsiva del risorgimento. Ricostruzione,
partecipazione popolare, irruzione sulla scena di una migrazione contadina che,
invece di irradiarsi in una diaspora, offrendo le sue energie al mondo intero, si
riversava nel nord del paese, dando a un’industria rinascente l’arma di un costo del
lavoro competitivo: queste le carte che la classe dirigente del paese seppe giocare con
sapiente coraggio. Una volta ancora però l’Italia non è stata capace di consolidare
5
quel successo che l’aveva proiettata, davvero miracolosamente, nel gruppo di testa
dei paesi industriali; di costruire-ricostruire davvero uno Stato nazionale moderno,
con un suo progetto riformista. Le grandi forze politiche della Repubblica furono
capaci di assecondare la crescita dell’economia e della società, non di costruire le
strutture politiche, amministrative e tecnologiche che avrebbero potuto rafforzarla e
orientarla.
5. Una ipotesi non peregrina che ricaviamo da questo flash back, da questa
rapidissima incursione nel passato, è che il patrimonio culturale della politica italiana
è fortemente segnato da due caratteristiche strutturali di segno apparentemente
opposto: il particolarismo (che si esprime sia nelle glorie municipali sia nella
vergogna mafiosa) e l’universalismo (che si esprime nelle glorie e nelle nequizie
delle grandi correnti cosmopolitiche, quelle trascendenti del cattolicesimo e quelle
immanenti del comunismo).
Insomma, le tradizioni politiche italiane, secondo questa ipotesi, correrebbero
rispettivamente più in basso e più in alto del livello del nazionalismo statale, non
incontrando mai quella che è stata la grande creatura dell’Europa moderna: lo Stato
nazionale.
In questa divaricazione, che cerca la sua “convergenza parallela” da qualche parte, in
uno spazio metapolitico può essersi generata quella ferita, quel varco tra lo Stato e la
società civile che è certamente una nota dominante della nostra storia.
Quel varco, ripeto, deve essere ritenuto responsabile, in parte non piccola, del fatale
ritardo dell’Italia, nella storia moderna, rispetto ai grandi Stati nazionali europei.
Abbiamo già considerato le occasioni nelle quali si è tentato invano di colmarlo o di
forzarlo: quella mancata del Risorgimento e quella rovinosa del fascismo. E anche le
occasioni che si presentarono con premesse e promesse felici e positive, poi solo in
parte mantenute: l’industrializzazione alla vigilia, la Resistenza poco meno che a
metà del Novecento. Si potrebbe forse aggiungere a queste l’occasione rappresentata
dal miracoloso aggancio all’Europa monetaria, pochi anni fa: ma a quel tempo la
catastrofe di cui ho parlato all’inizio di questo discorso era già avvenuta, e la sorte
della prima repubblica era già segnata.
6. Vorrei ora tornare al punto da cui sono partito, sollevando un problema che mi sta
a cuore: le responsabilità della sinistra in questa crisi e nel suo, per ora, infelice esito.
Per poi chiudere sui pericoli che questa fase presenta e sulla svolta che si può
prospettare per scongiurarli.
Penso, non certo da oggi, che una risposta positiva a quella catastrofe, da parte della
sinistra italiana, avrebbe potuto darsi attraverso un abbandono definitivo del quadro
culturale della sua strategia: voglio dire, del paradigma del compromesso storico, che
aveva fiaccato la sua forza, in quanto potenziale alternativa di sinistra, al governo
“eterno” delle forze moderate; e aveva impedito l’elaborazione concreta di una
strategia laica riformista.
6
Questa opzione, culturale prima che politica, non ci fu: e se questo fu, come io
fermamente credo, un errore, fu compiuto simmetricamente e successivamente dalla
sua componente minoritaria, socialista, e dalla sua componente maggioritaria,
comunista.
I socialisti, per molto tempo ruota di scorta riluttante della strategia dei due grandi
partiti, in posizione subalterna prima all’uno e poi all’altro, si sottrassero a un certo
punto, con Craxi, con uno strappo, a quella condizione umiliante, riacquistando
un’autonomia che li poneva obiettivamente in conflitto con ambedue le grandi forze e
che sembrava dover essere investita, magari dall’opposizione, e finalmente, in una
nuova prospettiva, in un nuovo paradigma riformista e laico, occidentale ed europeo.
Sappiamo come andò a finire. Craxi giocò una grande carta su un tavolo angusto.
Anziché investire quel salutare riscatto nella strategia “lunga”, ma carica di futuro, di
una sfida unitaria e realmente, non propagandisticamente, riformista, la giocò in un
gioco stretto e opportunistico, nell’illusione di poter battere separatamente e
successivamente quelle forze, incuneandosi tra l’una e l’altra in una posizione di
potere acquisita, si deve proprio dire, a qualunque prezzo. Una di quelle forze, nel
momento della crisi del sistema, gli rovinò addosso. L’altra gli si parò contro. C’ è in
questo tragico errore molto di quel vizio storico della politica italiana che è il
tatticismo cinico: una intelligenza di breve termine che può diventare stupidità nel
periodo lungo.
Non furono più intelligenti e meno cinici i comunisti. Nel pieno di una crisi che
traeva origine dall’insofferenza di una società divenuta più esigente e ostile nei
confronti di governi inefficaci e di una classe politica parassitaria, pensarono di
potersi finalmente sbarazzare di un rivale odiato cavalcando l’orgia giustizialista.
Come se quella fosse l’espressione autentica di un grande popolo degli onesti: mentre
in essa si mischiava, alla innegabile e sacrosanta reazione di cittadini offesi dalla
corruzione generalizzata e sfacciata, una movida antipolitica e antipartitica profonda,
organicamente reazionaria. Questa, che alimentava allora il “popolo dei fax”, diventò
in pochi anni massa di manovra e di reclutamento scagliata contro la democrazia dei
partiti; ma anche delle regole, delle tasse: e delle sentenze della magistratura.
Così la sinistra comunista, mentre si adoperava a mascherare il fallimento storico del
comunismo dietro la crisi dei governi del CAF, produsse due capolavori: regalò alla
destra emergente milioni di elettori socialisti e contribuì ad allargare la breccia
attraverso la quale passò l’ondata qualunquista.
7. Ho tentato di individuare quelle che mi sembrano le componenti principali di
questo sisma privatistico e qualunquistico: l’antistato (dovrei dire l’antipolitica); il
familismo; il mercatismo. Per la prima volta nella storia del nostro paese queste
componenti sono state saldate in una combinazione populistico-liberistica dal genio,
onore al merito, di un Grande Combinatore.
7
Ci si chiede oggi se questa saldatura ha la resistenza necessaria per durare. Insomma,
se si tratta di un normale avvicendamento democratico al potere di una coalizione di
destra; o, come alcuni affermano, di un vero e proprio regime.
Il mio modesto parere è che non si possa parlare di regime, primo perché quella
coalizione ha nel suo seno componenti autenticamente democratiche, anche se
minoritarie; secondo, perché si tratta di una formazione ancora allo stato fluido. Ma è
indubbio che essa porta in sé una vocazione autentica allo stravolgimento del gioco
democratico in un nuovo gioco profondo, come lo definisce Paul Ginsborg: come
quel gioco del calcio che sembra la sua metafora più espressiva, dove al posto del
cittadino hai il tifoso delle curve e al posto dello Stato hai l’arbitro, appena tollerato e
sempre aborrito.
L’idea di società sottesa a questo paradigma non è una società vertebrata. E’ un
mucchio di granellini di sabbia secca, alla mercè di ogni vento mediatico. Una società
destrutturata. Una duna mobile e instabile. Niente a che fare con il fascismo, con il
regime dello Stato forte. Ma piuttosto con una condizione di Stato debole che non si
affida a un Duce dispotico, ma a uno Zelig proteiforme.
Questa è una società pericolosa. Una società alla deriva. Una società apolitica. Una
società asociale.
Io credo che siamo ancora in tempo per contrastare questa deriva; per ricondurla
entro un gioco democratico “normale”.
Ma credo anche che, almeno finora, non si sia profilato, nelle forze che oggi formano
l’opposizione, alcun disegno strategico capace di dare senso ad una grande riscossa
della politica e di raccogliere il consenso necessario per perseguirlo. Parlando con
molta franchezza, mi sembra che finora la condotta della opposizione sia orientata
molto più verso le formule tattiche combinatorie, che non producono valore aggiunto,
che verso un progetto di cambiamento. Tanto che si potrebbe amaramente
parafrasare così quel motto di Togliatti: veniamo da molto lontano, e non sappiamo
dove stiamo andando.
Nelle grandi mobilitazioni di massa che si svolgono in questi giorni, in tutto il
mondo, contro la prospettiva di una guerra insensata, non c’è, lo sappiamo, la risposta
ai problemi del mondo; ma cìè una immensa domanda di senso, che trascende i limiti
angusti della politica combinatoria; e chiede alla politica di produrre il progetto di
una società più decente e più giusta. Una domanda che chiede una risposta.
8. Quando parlo di progetto, non intendo una prospettiva utopistica. Intendo una
risposta culturale e politica, alta e pragmatica al tempo stesso, al disordine. Un
riformismo che sappia raccogliere e ordinare la speranza. Qualche cosa di simile a
quella grande risposta riformista che generò negli anni quaranta e cinquanta del
secolo scorso il welfare state: che era un film a regia socialista su sceneggiatura
liberale, e che non si può ripetere oggi per la semplice ragione che non c’è più lo
state, lo Stato nazionale in grado di contenerlo.
8
Dunque, una risposta che non può essere no global, deve anzi essere global, in tutto e
per tutto, in questo mondo globalizzato. O più propriamente, deve essere data da
soggetti politici che siano in grado – per dimensioni e potenza – di operare
efficacemente in un mondo “globalizzato”. Ecco la straordinaria importanza
dell’Europa.
Deve dispiegarsi su tutta la superficie segnata da due grandi assi, della qualità e della
struttura sociale.
Deve muoversi da un principio etico opposto e simmetrico rispetto a quello del
privatismo egoista. Lo definirei il principio dell’invidualismo socievole: con al centro
la figura dominante del cittadino, non del privato, né del tifoso. E cioè della persona
profondamente inserita nella società.
Le due dimensioni di una nuova proposta globale riguardano la natura della società
(la qualità sociale) e l’organizzazione istituzionale (la sua colonna vertebrale).
Il primo di questi due fattori comporta una critica fondamentale dell’idolatria della
crescita e del mercato. Si tratta di contrapporre al concetto di crescita un ideale più
vasto e complesso: quello dello sviluppo, armonicamente proporzionato, delle grandi
componenti sociali del benessere collettivo, in luogo dell’ipertrofia frankesteiniana e
distruttiva, di una sola di esse. Il che comporta soprattutto un riorientamento culturale
e la costruzione di una nuova bussola al posto di quella fuorviante del PIL.
Il secondo riguarda la ristrutturazione della rete istituzionale, internazionale e sociale.
Quella fondata sull’equilibrio delle potenze, degli Stati nazionali, battezzata dalla
veneranda coppia Metternich-Kissinger, è ormai un dagherrotipo sbiadito. Ci sta
pensando la Superpotenza solitaria a metterla in soffitta, con brutale disinvoltura. Ma
sostituire la regolazione dell’equilibrio delle potenze con la sregolatezza della
Superpotenza non sembra una innovazione rassicurante.
Si tratta invece di costruire, come faticosamente ma incoerentemente si sta già
facendo, al posto dell’assetto orizzontale degli Stati nazionali, una struttura verticale
di reti sovrapposte a vari livelli.
A livello mondiale la rete dell’ONU, il solo governo mondiale oggi possibile,
articolata in strutture funzionali democraticamente riformate, a partire da quelle della
regolazione monetaria, finanziaria e commerciale.
A livello “regionale”, la riorganizzazione della struttura orizzontale degli Stati nelle
macrostrutture sopranazionali già in formazione, prima fra tutte quella Europa che
rappresenta già potenzialmente un polo di riequilibrio.
A livello nazionale e sociale – qui De Rita ha ragione1 – si tratta di promuovere la
reistituzionalizzazione della società, non attorno a uno Stato monolitico, ma in un
nuovo paradigma, una nuova architettura policentrica di organizzazioni
rappresentative. Organizzazioni che si raggruppano attorno a tre sistemi
fondamentali: quello dell’amministrazione pubblica, fondato sul principio
dell’autorità; quello del mercato, fondato sul principio della competizione; quello
associativo, fondato sul principio della cooperazione.
1
V. G. De Rita, Il regno inerme, Einaudi, Torino, 2002.
9
Si tratta insomma di porre a fondamento di una proposta della sinistra una nuova
concezione dello sviluppo economico e un nuovo modello di organizzazione
istituzionale.
9. Questo paradigma offre all’Italia una nuova occasione storica di valorizzare
pienamente le grandi risorse della sua identità. Come diceva Benedetto Croce,
rifiutandosi all’idea di identità nazionale come impronta genetica, “l’identità di un
paese è la sua storia”. Come s’è detto, è proprio attraverso la storia d’Italia che
emergono le due principali caratteristiche della sua identità, il particolarismo e
l’universalismo. Declinate secondo il loro verso positivo - quello che ha fatto delle
repubbliche italiane esaltate da Sismondi e da Quinet la gloria del municipalismo
italiano e quello che ha illuminato il mondo con il cosmopolitismo della sua cultura e
della sua arte - queste caratteristiche, che non si sono cristallizzate nelle forme dello
Stato nazionale, possono trovare in una grande Europa il terreno fecondo per rifiorire.
Cito ancora una volta, concludendo, Aldo Schiavone2. Non saprei dire meglio di lui:
“Il destino dell’Italia e della sua unione dipende da come sapremo sottrarre la nostra
identità allo scacco dello Stato che avrebbe dovuto rappresentarla e proteggerla. Da
come sapremo impedire a un fallimento così grave – che ci appartiene, perché
esprime il lato debole e oscuro del nostro passato – di trascinare con sé anche la
parte migliore di noi, quella che è stata capace di imprese intellettuali e civili uniche
nell’itinerario dell’Occidente, e forse dell’intera umanità. In altri termini: se
riusciremo a utilizzare ancora una volta in modo vantaggioso quell’insuperata
asimmetria fra italiani e Italia, autentica croce della nostra storia….. Oggi si sta
profilando per l’Italia l’occasione di un salto di prospettiva: non più cercare di
costruire una nazione all’altezza dei tempi, ma semplicemente, per così dire,
oltrepassarla, aggirare la meta, e portare il nostro popolo – tutto intero – in una nuova
dimensione del suo sviluppo…. E’ l’idea dell’Europa – se vi crediamo – a obbligarci
a un viaggio mentale al di là dello Stato-nazione: un compito che non possiamo
eludere, per quanto imponga esercizi difficili.”
Dunque, l’Europa rappresenta per noi la grande occasione di recuperare il meglio
della nostra identità storica – il nostro municipalismo, il nostro cosmopolitismo e,
non da ultimo, la nostra inclinazione per la bellezze e per la vita buona - per investirla
in un progetto più vasto di quello che si è incarnato nello Stato nazionale. Dobbiamo
essere orgogliosi di quell’identità. Respingere una volta per sempre, da una parte la
“porca rogna dell’autodenigrazione”; e dall’altra, le pagliacciate del nazionalismo:
fascistico o calcistico che sia.
In una recensione di un recentissimo libro inglese sull’Italia l’Economist, con il tono
supponente che usa spesso quando parla dell’Italia e degli italiani, contrappone la
bravura degli inglesi di combattere in guerra all’arte italiana di vivere in pace. A me,
spero anche a voi, sta bene così.
2
A. Schiamone, Italiani senza Italia, Storia e identità, Einaudi, Torino, 1998.
10