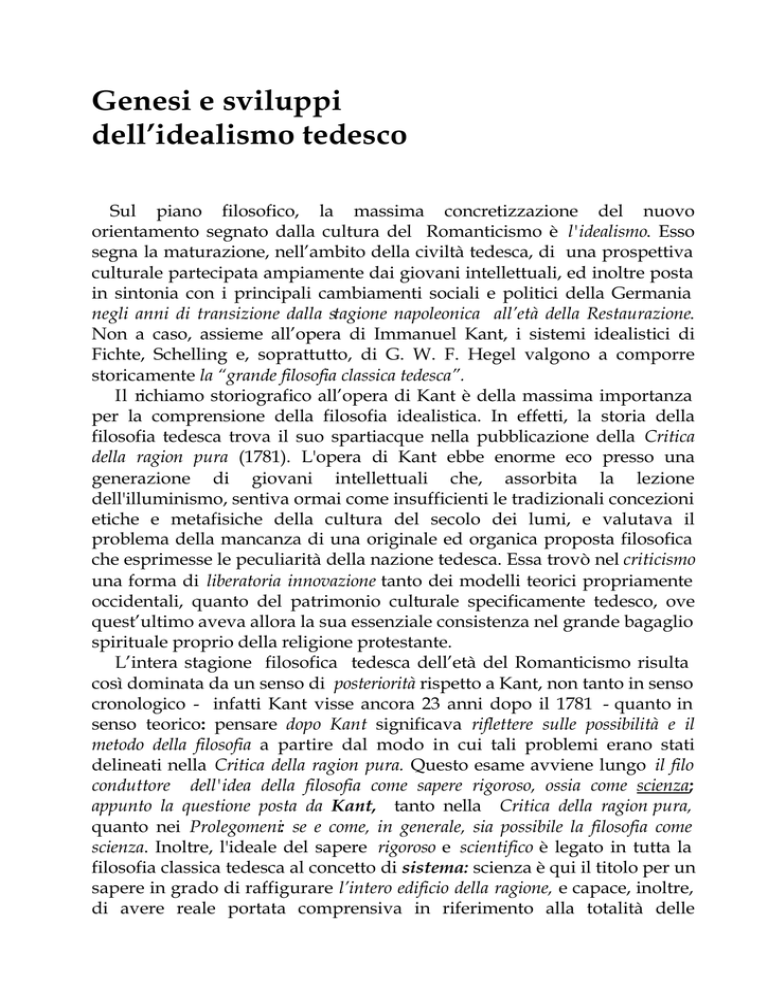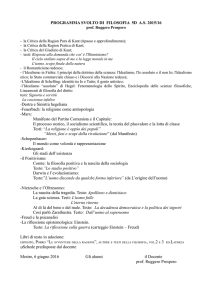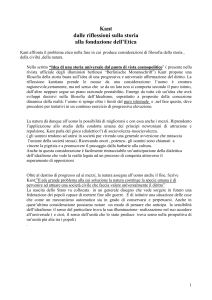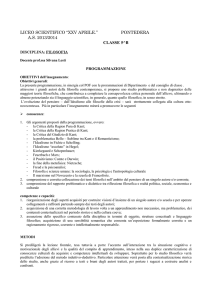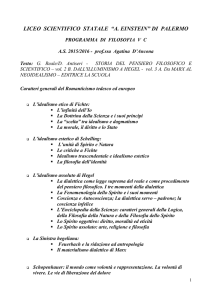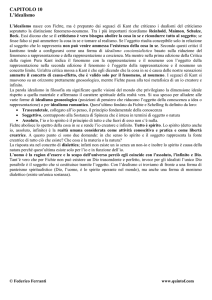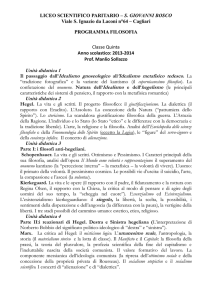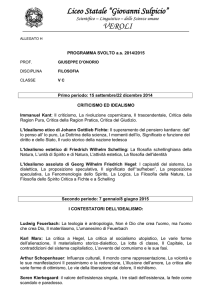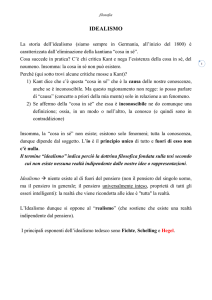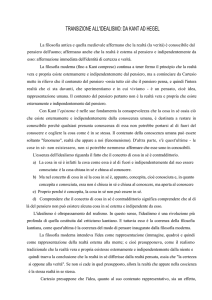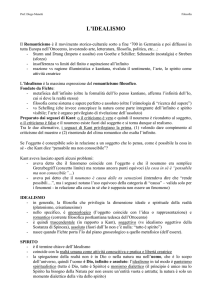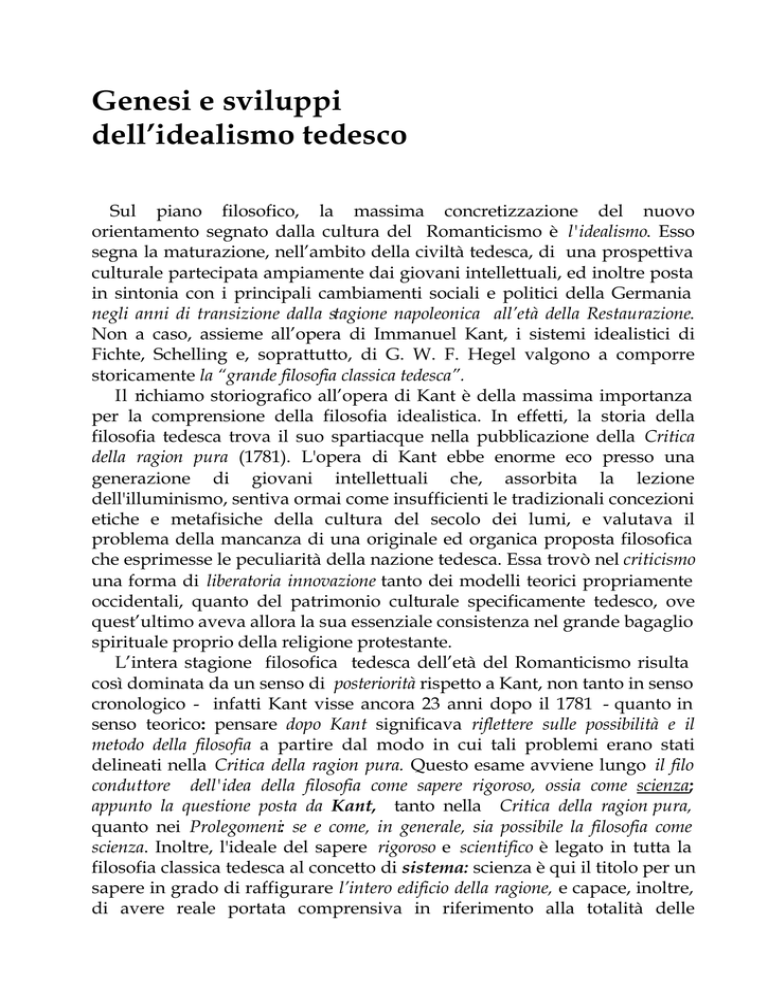
Genesi e sviluppi
dell’idealismo tedesco
Sul piano filosofico, la massima concretizzazione del nuovo
orientamento segnato dalla cultura del Romanticismo è l'idealismo. Esso
segna la maturazione, nell’ambito della civiltà tedesca, di una prospettiva
culturale partecipata ampiamente dai giovani intellettuali, ed inoltre posta
in sintonia con i principali cambiamenti sociali e politici della Germania
negli anni di transizione dalla stagione napoleonica all’età della Restaurazione.
Non a caso, assieme all’opera di Immanuel Kant, i sistemi idealistici di
Fichte, Schelling e, soprattutto, di G. W. F. Hegel valgono a comporre
storicamente la “grande filosofia classica tedesca”.
Il richiamo storiografico all’opera di Kant è della massima importanza
per la comprensione della filosofia idealistica. In effetti, la storia della
filosofia tedesca trova il suo spartiacque nella pubblicazione della Critica
della ragion pura (1781). L'opera di Kant ebbe enorme eco presso una
generazione di giovani intellettuali che, assorbita la lezione
dell'illuminismo, sentiva ormai come insufficienti le tradizionali concezioni
etiche e metafisiche della cultura del secolo dei lumi, e valutava il
problema della mancanza di una originale ed organica proposta filosofica
che esprimesse le peculiarità della nazione tedesca. Essa trovò nel criticismo
una forma di liberatoria innovazione tanto dei modelli teorici propriamente
occidentali, quanto del patrimonio culturale specificamente tedesco, ove
quest’ultimo aveva allora la sua essenziale consistenza nel grande bagaglio
spirituale proprio della religione protestante.
L’intera stagione filosofica tedesca dell’età del Romanticismo risulta
così dominata da un senso di posteriorità rispetto a Kant, non tanto in senso
cronologico - infatti Kant visse ancora 23 anni dopo il 1781 - quanto in
senso teorico: pensare dopo Kant significava riflettere sulle possibilità e il
metodo della filosofia a partire dal modo in cui tali problemi erano stati
delineati nella Critica della ragion pura. Questo esame avviene lungo il filo
conduttore dell'idea della filosofia come sapere rigoroso, ossia come scienza;
appunto la questione posta da Kant, tanto nella Critica della ragion pura,
quanto nei Prolegomeni: se e come, in generale, sia possibile la filosofia come
scienza. Inoltre, l'ideale del sapere rigoroso e scientifico è legato in tutta la
filosofia classica tedesca al concetto di sistema: scienza è qui il titolo per un
sapere in grado di raffigurare l’intero edificio della ragione, e capace, inoltre,
di avere reale portata comprensiva in riferimento alla totalità delle
problematiche umane. Come tale, deve essere una concatenazione logica
e coerente di proposizioni, derivanti da un principio primo incontrovertibile:
si intende perciò la possibilità che la filosofia idealistica privilegiasse del
kantismo i momenti teorici maggiormente attenti alla dimensione dell’opera
di fondazione dell’edificio del sapere scientifico (la deduzione trascendentale
culminante nella dottrina dell’Io penso, il primato dell’imperativo categorico sul
piano del sapere pratico, e il principio della considerazione teleologica della
natura elaborato nella “Critica del giudizio”).
In questa prospettiva, i diretti interlocutori di Kant si sentirono
sollecitati ad una definitiva sistemazione della filosofia critica. Questa
ricerca giunse, con l'idealismo trascendentale di Fichte e Schelling, e in
seguito con la grande sintesi filosofica di Hegel, alla elaborazione di sistemi
originali e autonomi: questi filosofi, prendendo spunto dal programma
kantiano di sistemare in un edificio organico il sapere umano, pur
salvaguardando sia l'autonomia della ragione scientifica, sia l'esperienza
della libertà morale, si pongono in primo luogo il problema della
riconciliazione tra il piano della libertà rivendicato da Kant per la ragion pura
in sede di attività pratica , e quello della necessità e del determinismo propri
delle scienze naturali.
Attraverso l’impegno teorico nella ricerca di un nuovo fondamento
razionale, capace di garantire una visione armonica e sistematica
dell’intero edificio umano del sapere, e che, per ciò stesso, superasse i limiti
che a quest’opera Kant aveva imposto, i filosofi idealisti del romanticismo
riformularono i problemi che l'illuminismo europeo già aveva trattato,
specialmente recuperando la denuncia roussoiana della condizione di alienazione
propria delle configurazioni sociali e politiche della modernità, elaborando una
nuova metafisica dell’infinito, ma anche attribuendo maggiore spazio alle
dimensioni pre-razionali e non strettamente scientifiche dell'esperienza
umana, senza però cadere mai nell'irrazionalismo. La filosofia classica
tedesca tentò così di andare al di là del razionalismo illuministico e di
interpretare in forma non riduttiva quegli aspetti della cultura (la
religione, la tradizione,
la cultura popolare), la cui importanza
l'illuminismo aveva fortemente ridimensionato.
Sebbene nasca solo con Fichte, l'idealismo risulta storicamente preparato
dai cosiddetti discepoli immediati di Kant, ossia da quel gruppo di
pensatori, da Reinhold (1758-1823) a Schulze (1761-1833), da Maimon
(1753-1800) a Beck (1761-1840), la cui opera consiste nell’esercizio di
vagliare criticamente i dualismi e le scissioni lasciati non solo come irrisolti,
ma ribaditi dal criticismo kantiano, cercando di trovare un principio unico
sulla cui base fondare una nuova, salda filosofia. In particolare, tali studiosi
appuntano le loro critiche su quel dualismo fondamentale che è il principio
di tutti i dualismi: la distinzione tra i piani del mondo fenomenico e
quello noumenico.
Partendo dalla presunta «contraddizione» di base di Kant, che avrebbe
dichiarato esistente, e al tempo stesso inconoscibile, la cosa in sé, essi
prendono di mira soprattutto quest'ultimo concetto, giudicandolo
filosoficamente inammissibile. Tant'è vero che Jacobi, sin dal saggio
Sull'idealismo trascendentale (1787), e in scritti successivi, insinua che quello
di noumeno è un presupposto «realistico», senza di cui non è possibile
entrare nel regno del criticismo, ma con il quale non è possibile rimanerci,
concludendo perciò che:
‘’o il criticismo è vero, e allora bisogna abolire la cosa in sé e ricondurre
tutto al soggetto, o il criticismo è falso, ed allora si deve ammettere la cosa
in sé e tornare al realismo‘’.
Significato del termine «idealismo»
La parola «idealismo» presenta nell’ambito del linguaggio ordinario
un’ampia varietà di significati. Nel linguaggio comune si denomina
idealista colui che è attratto da determinati «ideali» o «valori» - etici,
religiosi, conoscitivi, politici ecc. - e che sacrifica per essi la propria vita
(in questo senso si dice ad esempio che Mazzini ed i mazziniani erano
«idealisti»).
In filosofia, invece, si parla di «idealismo», in senso lato, a proposito di
quelle visioni del mondo, come ad esempio il platonismo e il cristianesimo,
che privilegiano la dimensione «ideale» su quella «materiale» e che
affermano il carattere «spirituale» della realtà «vera». In questa ultima
accezione il termine idealismo viene introdotto nel linguaggio filosofico
verso la metà del Seicento, e viene usato soprattutto in riferimento al
platonismo e alla sua teoria delle «idee».
Il riferimento al platonismo è molto importante per la comprensione
della filosofia tedesca postkantiana. Come progetto teorico che mette l’
“idea” al centro della costruzione del sistema, la filosofia di Fichte, Schelling
ed Hegel intese esplicitamente ricollegarsi all’indagine di Platone, per
richiamare allo specifico compito della filosofia di non modellarsi e di non
appiattirsi sul generale criterio empirico-sperimentale di ricerca, modello
che aveva invece trovato largo uso ed affermazione nelle moderne scienze
della natura. Nel testo della “Repubblica” è indicata chiaramente da Platone
la necessità di distinguere fra scienze dianoetiche da un lato, il cui modello è
la matematica, e il cui compito specifico è la ricerca delle “idee-criteri” per
la definizione ed il giudizio descrittivo delle cose naturali e dei loro
rapporti, e scienza dialettica dall’altro lato, il cui compito è invece la ricerca
delle “idee-causa” delle cose che esistono, e che sono le ragioni per le quali le
cose “si generano, si distruggono ed esistono”.
Nella “Critica della ragion pura” I. Kant aveva indicato nelle tre “idee
trascendentali” di anima, mondo e Dio gli “oggetti necessari della ragione”,
ossia della metafisica razionale, ed aveva definito col termine “idea” la
condizione assoluta ovvero l’incondizionato che, se potesse essere dimostrato,
consentirebbe la rappresentazione esplicativa totalizzante, senza limiti o
manchevolezze, di un campo di indagine possibile o di una serie possibile
di fenomeni.
Ora, si sa che per Kant la metafisica razionale è impossibilitata a
costituirsi come scienza, proprio in quanto alle idee della ragione “non è
data la possibilità di trovare corrispondenza nel campo dell’esperienza”. Alle idee
razionali resta pertanto, secondo Kant, il compito di valere esclusivamente
come “principi regolativi” per l’estensione della conoscenza, pur
dovendosi quest’ultima stabilmente confermarsi come limitata alla sfera
fenomenica, ossia del mondo finito descritto dall’intelletto.
Orbene, fu proprio della filosofia idealistica il tentativo costante di
superare la scissione fra i distinti piani della conoscenza fenomenica e della
istanza razionale noumenica che Kant aveva sancito mediante il concetto
della cosa-in-sé.
Fu inoltre proprio della filosofia idealistica il tentativo altrettanto costante
di mantenere la distinzione fra i piani della conoscenza empiricosperimentale della natura, e quello di una possibile filosofia della natura,
ove quest’ultima doveva condurre a più alti sviluppi il progetto di una
considerazione teleologica del mondo naturale avanzato da Kant stesso nella
Critica del Giudizio.
Come orientamento filosofico che mette al centro del proprio progetto l’
”idea”, la filosofia idealistica tedesca potè usare come sostantivi sinonimi
dell’antico termine platonico quelli di “infinito”, “Assoluto”, “Spirito”.
Nel modo più chiaro possono valere ai fini della comprensione del
significato dell’idealismo le seguenti note di Hegel:
«L’Idea è il vero in sé e per sé, l’unità assoluta del concetto [ovvero
la rappresentazione] e dell’oggetto».
«L’Assoluto è l’universale ed unica Idea che, con l’atto del giudicare, si
specifica nel sistema delle idee determinate, che però tornano nell’unica Idea,
che è la loro verità. In forza di questo atto di giudizio [cioè in quanto
pensata dal filosofo], l’Idea è dapprima l’unica ed universale
sostanza; ma nella forma vera e compiuta essa è altrettanto come
l’unico soggetto [perché è solo in quanto diviene], perciò come
Spirito ».
(Enciclopedia delle scienze filosofiche, 1817, § 213)
E’ chiaro che questa specificazione dell’Idea non è altro che una
traduzione in termini moderni dell’identità che nel platonismo dell’antica
Accademia era stata stabilita fra l’Idea come oggetto intellegibile e
l’Intelligenza come soggetto, ovvero ciò che sarà poi chiamato L’Uno nella
filosofia neoplatonica e Dio nella filosofia cristiana, ad esempio nelle
ricerche di Agostino d’Ippona. Questo raffronto è estremamente
importante, perché consente di cogliere la lunga persistenza nella cultura
occidentale della metafisica neoplatonica, e l’idealismo postkantiano come
una forma importante di essa.
«La proposizione che il finito è ideale [ossia “non reale”] costituisce
l'idealismo. L'Idealismo della filosofia consiste soltanto in questo: nel non
riconoscere il finito come un vero essere. Ogni filosofia è essenzialmente
Idealismo, o almeno ha l'Idealismo per suo principio e si tratta solo di
sapere sino a che punto questo principio vi si trovi effettivamente
realizzato. La filosofia è Idealismo, come è Idealismo la religione»
Hegel: Scienza della Logica, 1812, sez. 1, nota 2).
Caratteri generali dell'idealismo
Sorretto da istanze teoriche di questo tipo, risulta evidente che il
richiamo alla filosofia di Kant da parte dei primi, immediati discepoli, e poi
anche dei continuatori del criticismo, e, soprattutto, da parte dei filosofi
idealisti, non poteva avere lo scopo di mantenere il medesimo e generale
orientamento dottrinale del maestro di Königsberg.
In effetti ci si ricollegò a Kant ed alle sue tematiche, al fine di conseguire
orizzonti teorici nuovi e risultati autonomi. Come si è già detto, l’attività
prima di ricerca fu incentrata attorno al nodo della cosa-in-sé, il vero
baluardo criticista per il mantenimento di una configurazione limitata e
finita della capacità umana di conoscenza. Questo significa che ci si
ricollegò a Kant volendo vedere nei risultati della sua indagine un
orientamento filosofico che Kant stesso non sarebbe stato in grado di
esplicitare sino in fondo: così si cominciò a distinguere lo spirito della sua
filosofia (incompiuto e non realizzato) dalla lettera della sua opera. In
questo particolare genere di interpretazione si distinse il filosofo Fichte,
che più volte nelle sue lezioni a Jena e nel suo epistolario ritorna a
presentare il sistema kantiano come bisognoso di completamento, e più
volte precisa i termini del proprio operato come appartenenti allo sforzo di
conseguire alla filosofia critica risultati più ampi e fondati.
Vale la pena di sottolineare a questo riguardo come il conseguimento di
nuove prospettive da parte degli idealisti implichi un’altra rimozione di un
cardine altrettanto importante del kantismo: la dottrina delle facoltà.
E’ noto che per Kant l’intera problematica della ragione può essere
presentata richiamando le tre domande chiave che anche il senso comune
ben intende: che cosa posso sapere, che cosa debbo fare, che cosa posso
sperare: l’articolazione della ricerca filosofica per rispondere
concretamente a queste domande, mette capo, secondo Kant, alla dottrina
delle facoltà autonome, che sono: quella del giudizio (conoscenza), quella
della volontà (appetizione) e quella del sentimento (valutazione del senso
secondo la finalità). A queste tre facoltà corrispondono le tre “Critiche”
nelle quali si articola il sistema della ragione pura. Ebbene uno dei tratti
essenziali dell’idealismo può ben essere indicato nella ricerca di un punto
di vista fondamentale per il cominciamento della filosofia che faccia a meno
del principio kantiano dell’autonomia delle facoltà, oppure che le renda
quantomeno sfere distinte di una unica e medesima realtà che in esse
prenderebbe forma. La filosofia idealistica assolverà a questo compito per
lo più riconducendo le suddette distinte dimensioni della realtà umana a
forme di manifestazione di un’unica realtà sovrumana: l’Assoluto, Dio o
l’Infinito.
Storicamente l'idealismo sorge allorquando Fichte, abolisce lo «spettro»
della cosa in sé, ovvero la nozione di qualsivoglia realtà estranea all'io, per
istituire una nuova raffigurazione del rapporto del pensiero con la realtà
empirica, che può essere indicata dal termine “relazionale”, volta cioè a
mostrare la co-originaria appartenenza di entrambi, e del loro valere come
polarità interne ad una inscindibile relazione reciproca.
Da ciò la tesi tipica dell'idealismo tedesco, secondo cui "tutto è Spirito", che
implica la rivendicazione del diritto per una filosofia trascendentale di
determinare la natura dell’essere reale esterno all’Io.
Per comprendere adeguatamente tale affermazione, che rappresenta il
punto genetico e strutturale di tutto l'idealismo post-kantiano, bisogna
tener presente che con il termine «Spirito» (o con i sinonimi «Io»,
«Assoluto», «Infinito» ecc.), Fichte intende, in ultima istanza, la realtà
umana, considerata come attività tanto conoscitiva quanto pratica, ma
soprattutto come libertà creatrice . Questa puntualizzazione preliminare
lascia tuttavia irrisolti due quesiti di base, che tendono ad affacciarsi alla
mente di chi affronta per la prima volta lo studio dell'idealismo:
1) in che senso lo Spirito, e quindi il soggetto conoscente ed agente,
rappresenta il principio determinante di tutto ciò che esiste ?
2) Che cos'è dunque, per gli idealisti, la Natura o la materia ?
La risposta a questi due problemi interconnessi risiede innanzitutto
nella considerazione del recupero idealistico del principio dialettico, cioè di
quella concezione secondo cui non essendoci mai la possibilità per il
pensiero di determinare alcuna realtà come positiva senza la sua
interconnessione con il negativo ad essa riferita, ovvero la tesi senza
l'antitesi, si rende possibile comprendere come lo Spirito, proprio per
essere tale, abbia «bisogno» di quella sua antitesi vivente che è la Natura.
Infatti, argomenta l'idealismo, un soggetto senza oggetto, un io senza nonio, un'attività senza ostacolo, sarebbero entità vuote ed astratte, e quindi
impossibili. Di conseguenza, mentre le filosofie naturalistiche
e
materialistiche avevano sempre concepito la Natura come causa dello
spirito, asserendo che l'uomo è un prodotto o un effetto di essa, Fichte,
capovolgendo tale prospettiva, dichiara che è piuttosto lo Spirito ad essere
causa della natura, poiché quest'ultima esiste solo per l'io ed in funzione
dell'io, essendo semplicemente il materiale o la scena della sua attività, ossia
il polo dialettico del suo essere.
In altri termini, per Fichte:
1) lo Spirito pone la realtà, nel senso che l'uomo rappresenta la ragion
d'essere dell'universo, che in esso trova appunto il suo scopo;
2) la Natura esiste non come realtà a sé stante, ma come momento
dialettico necessario della vita dello Spirito. Queste due tesi di fondo
dell'intuizione idealistica del mondo trovano una sorta di
esemplificazione artistica nel racconto di Novalis “I discepoli di Sais”,
dove, nelle aggiunte finali, si dice che:
«Accadde ad uno di
alzare il velo della dea
di Sais. Ma cosa vide?
Egli vide— meraviglia
delle meraviglie — se
stesso».
Secondo l'interpretazione idealistica, la dea velata sarebbe il simbolo del
mistero dell'universo; quell'uno che giunge a scoprirla è il filosofo idealista,
che dopo una lunga ricerca si rende conto che la chiave di spiegazione di
ciò che esiste, vanamente cercata dai filosofi fuori dell'uomo, ad esempio in
un Dio trascendente o nella natura, si trova invece nell’uomo stesso,
ovvero nello Spirito. Ma se l'uomo è la ragion d'essere e lo scopo
dell'universo, che sono poi gli attributi fondamentali che la filosofia
occidentale ha riferito alla divinità, vuol dire che egli coincide con
l'Assoluto e con l'Infinito, cioè con Dio stesso, e questo ci serve a capire, tra
l'altro, perché gli idealisti scrivano le parole Io o Spirito con le lettere
maiuscole e perché l'idealismo romantico sia definito idealismo «assoluto».
A questo punto risultano evidenti anche i rapporti che uniscono e
dividono l'idealismo dalla tradizione ebraico-cristiana. Gli idealisti
pensano anch'essi, da un lato, che l'uomo sia il «re del creato», ossia, per
usare ancora una volta un'immagine di Novalis,
che la natura sia
«l'impietrita città magica, di cui l'uomo è il messia». Tuttavia l'idealismo
tedesco, laicizzando il biblico «Dio creò i cieli e la terra per l'uomo»,
conclude che l'uomo stesso è Dio. Tant'è vero che la figura classica di un
Dio trascendente e staticamente perfetto, per il primo Fichte, è solo una
«ciarla scolastica», ovvero una «chimera», in quanto presupporrebbe
l'esistenza di un positivo senza il negativo. Invece, per gli idealisti, l'unico
Dio possibile è lo Spirito dialetticamente inteso, ovvero il soggetto che si
costituisce tramite l'oggetto, la libertà che opera attraverso l'ostacolo, l'io
che si sviluppa attraverso il non-io. E’ attraverso questi generali rilievi
appartenenti all’idealismo che si è soliti sostenere che ci si trova di fronte,
per la prima volta nella storia del pensiero, ad una forma di panteismo
spiritualistico (= Dio è lo Spirito operante nel mondo, cioè l'uomo), che si
distingue sia dal panteismo naturalistico (=Dio è la Natura), sia dal principio
trascendente di tipo ebraico e cristiano (= Dio è una Persona esistente fuori
dell'universo). Come tale, l'idealismo è anche una forma di monismo
dialettico (= esiste un' unica sostanza: lo Spirito, inteso come realtà positiva
realizzante se medesimo attraverso il negativo: la natura, il non-io ecc.).
Monismo che si contrappone a tutti i dualismi metafisici e gnoseologici
della storia del pensiero, dai greci fino a Kant (Spirito e Natura, Dio e
mondo, soggetto ed oggetto, libertà e necessità, fenomeno e cosa in sé...).
Pur essendo d'accordo sull'interpretazione della realtà mediante le
categorie di Spirito e di Infinito, gli idealisti (Fichfe, Schelling ed Hegel) si
differenziano fra di loro, come vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli, per
la specifica maniera di intendere l'Infinito e i suoi rapporti con il finito (la
natura e la storia). L'incarnazione più tipica, coerente e storicamente
decisiva dell'idealismo tedesco, è comunque rappresentata da Hegel.