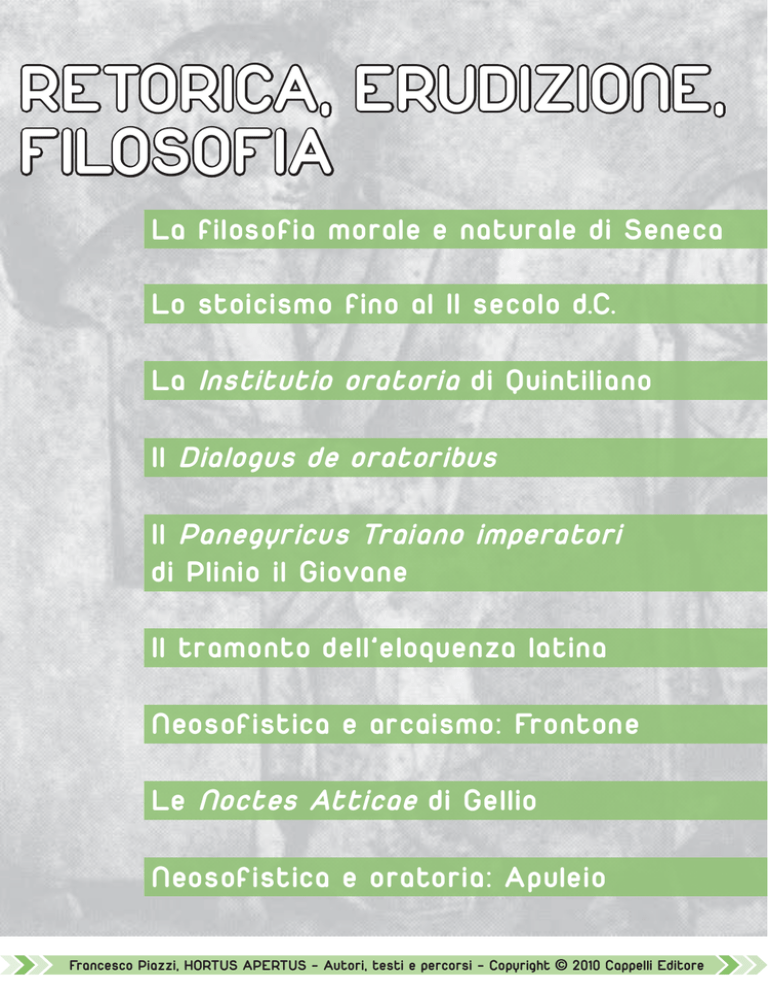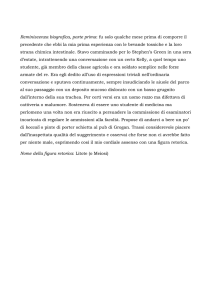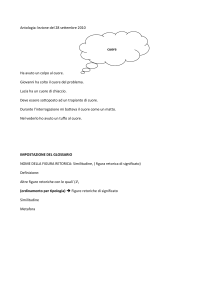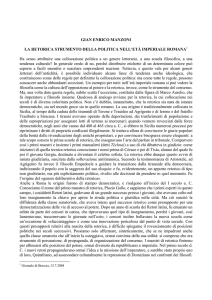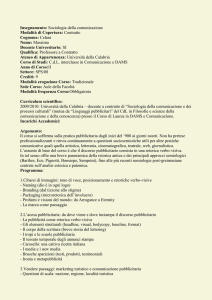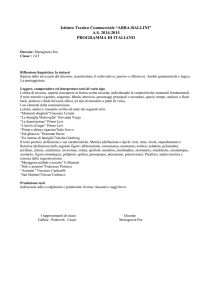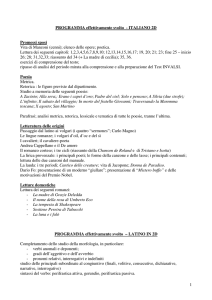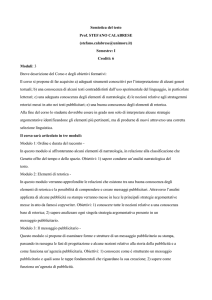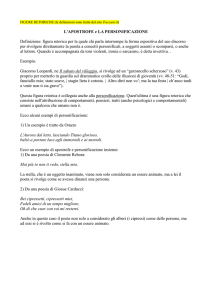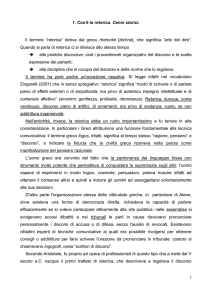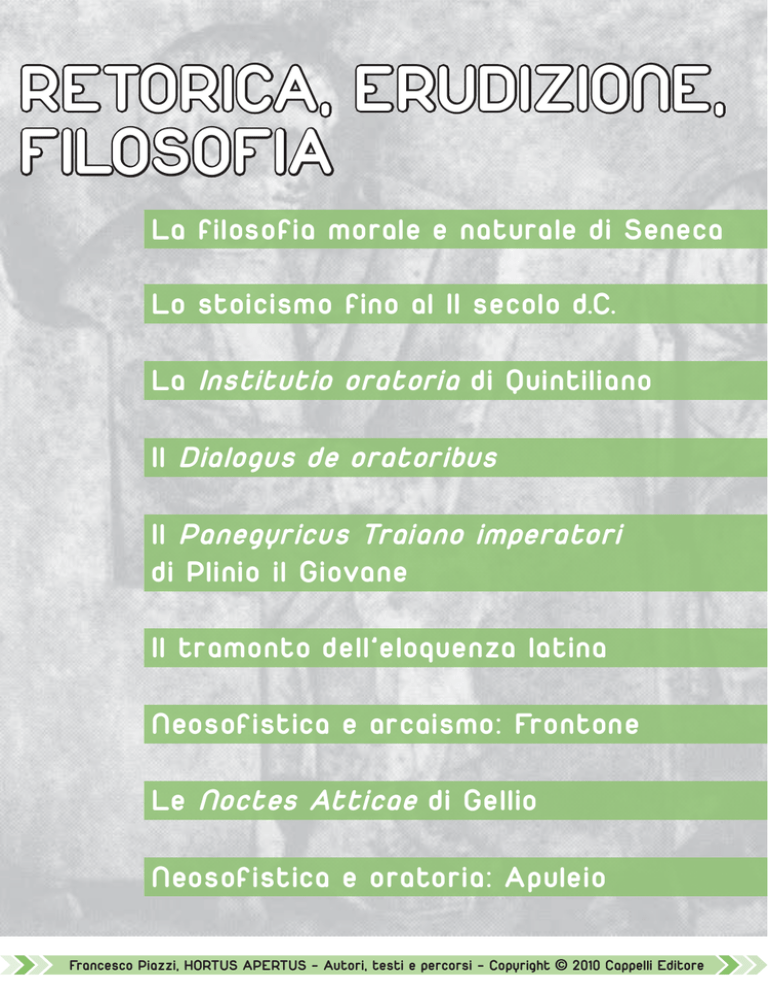
RETORICA, ERUDIZIONE,
FILOSOFIA
La filosofia morale e naturale di Seneca
Lo stoicismo fino al II secolo d.C.
La Institutio oratoria di Quintiliano
Il Dialogus de oratoribus
Il Panegyricus Traiano imperatori
di Plinio il Giovane
Il tramonto dell’eloquenza latina
Neosofistica e arcaismo: Frontone
Le Noctes Atticae di Gellio
Neosofistica e oratoria: Apuleio
Francesco Piazzi, HORTUS APERTUS - Autori, testi e percorsi - Copyright © 2010 Cappelli Editore
456
Retorica, erudizione, filosofia
La filosofia morale e naturale di Seneca
La vita
Le origini
La formazione
L’avvio alla carriera politica
L’esilio in Corsica
ALTO IMPERO
Il ritorno dalla Corsica
La monarchia illuminata
Il contrasto tra dottrina
e vita
Lucio Anneo Seneca nacque a Còrdova, in Spagna, intorno al 5 a.C. Era di famiglia ricchissima d’estrazione equestre. Il padre era M. Anneo Seneca il Retore e la
madre, Elvia, era donna di profonda cultura.
A Roma Seneca ricevette un’ottima educazione sia retorica sia filosofica. Seguì le
lezioni dello stoico Attalo, del neopitagorico Sozione e di Papirio Fabiano aderente
alla setta dei Sestii che prescriveva il vegetarismo, l’ascesi, l’isolamento dalla vita
politica e mondana in vista della libertà interiore. In seguito si recò in Egitto forse
per sfuggire alle persecuzioni ordinate da Tiberio nel 19 d.C., contro i seguaci di
pratiche ascetiche e straniere, vegetarismo incluso.
Ritornato a Roma dopo tre anni, iniziò la carriera politica e forense nella quale si
distinse come brillante oratore. Il giovane provinciale entrò nell’ordine senatorio, ricoprì anche la questura. Ma un suo discorso in senato offese Caligola, che
l’avrebbe messo a morte se una donna potente a corte non avesse convinto
l’imperatore che Seneca sarebbe morto presto comunque, malato com’era.
Sotto Claudio nel 41 fu relegato in Corsica, accusato di adulterio con Giulia Livilla,
sorella di Caligola e rivale di Messalina, moglie dell’imperatore. In Corsica Seneca
rimase otto anni, durante i quali ebbe modo di mettere in pratica i precetti stoici secondo i quali il bene del saggio non dipende dai luoghi, ma dall’equilibrio interiore.
Di questi anni è la Consolatio ad Polybium, dedicata al potente liberto imperiale
Polibio per consolarlo della morte del fratello, ma soprattutto per ottenere con adulazioni smaccate la revoca dell’esilio.
Caduta in disgrazia Messalina, la nuova imperatrice Agrippina fece tornare Seneca, per affidargli l’educazione del proprio figlio di primo letto, Nerone. Era
l’occasione per realizzare il sogno platonico di uno stato perfetto, illuminato dalla
sapienza filosofica, fondato sull’umanità, la filantropia, la clemenza. Morto Claudio
nel 54, effettivamente Seneca, di comune accordo col prefetto del pretorio Burro,
per cinque anni regnò in luogo del principe.
Secondo il programma senecano l’imperatore sarebbe dovuto apparire un modello
di virtù, un buon padre in grado di condurre alla felicità i sudditi, in una ritornata età
dell’oro. Di Nerone cercò di temperare l’enorme vanità prospettandogli la gloria derivante da un governo moderato, rispettoso delle prerogative tradizionali dell’aristocrazia senatoria. Anche se – come leggiamo nel De clementia, dedicato a Nerone
e «manifesto del nuovo regime» – queste prerogative non avevano più fondamento
costituzionale, ma erano da Seneca stesso viste come benigna concessione dell’imperatore.
Ma il sogno di trasformare il principe nel re-filosofo auspicato da Platone non urtava solo contro il corso della storia e contro la natura di Nerone, che di lì a poco
La filosofia morale e naturale di Seneca
avrebbe rivelato il suo volto illiberale e dispotico, attuando una politica antisenatoria e autocratica. Urtava anche contro l’incapacità di Seneca stesso di vivere coerentemente coi precetti enunciati. E questa incoerenza lo rendeva poco credibile agli
occhi dei detrattori, che gli rimproveravano non a torto l’avarizia, l’ambizione e finanche l’usura. Inoltre la necessità di preservare l’imperatore dagli intrighi dinastici
imponeva che Seneca stesso avesse parte in delitti che non potevano non ripugnare alla sua coscienza morale e filosofica. Così lasciò che Nerone uccidesse il fratellastro Britannico (55 d.C.) e finanche la madre Agrippina (59 d.C.).
Sul piano filosofico ed esistenziale il bilancio di quei cinque anni di reggenza non
doveva risultare positivo per Seneca. Alla morte (nel 62 d.C.) dell’alleato Burro, egli
non fu più disponibile ad avallare la politica antisenatoria e assolutistica di Nerone
e si ritirò allo studio e alla vita contemplativa, attendendo alla composizione delle
sue opere.
Ma la politica lo raggiunse anche in quest’isolamento: nel 65 d.C. il principe lo accusò – non si sa con quale fondamento – di fare parte della congiura dei Pisoni e
gli inviò l’ordine di tagliarsi le vene.
Con grande dignità Seneca affrontò quella morte alla quale si era lungamente preparato nella riflessione di un’intera vita.
Il ritiro dalla politica
La morte per ordine
di Nerone
Le opere
Le opere filosofiche furono riunite, dopo la morte di Seneca, nei 12 libri di Dialogi
(titolo che ricalca il greco diatribài ovvero dialèxeis), trattati brevi d’argomento etico
e psicologico: 1. Ad Lucilium de providentia; 2. Ad Serenum de constantia sapientis; 3-5. Ad Novatum de ira libri III; 6. Ad Marciam de consolatione; 7. Ad Gallionem
de vita beata; 8. Ad Serenum de otio; 9. Ad Serenum de tranquillitate animi; 10. Ad
Paulinum de brevitate vitae; 11. Ad Polybium de consolatione; 12. Ad Helviam matrem de consolatione.
Altre opere di argomento filosofico, tramandate separatamente dai Dialogi sono: il
De beneficiis, il De clementia dedicato a Nerone (in tre libri di cui restano il primo e
l’inizio del secondo), e le 124 Epistulae morales ad Lucilium riunite in 20 libri.
Sono opere di carattere scientifico le Naturales quaestiones (in 7 libri, forse in origine 8), dedicate a Lucilio. Ecco gli argomenti: 1. I fuochi celesti; 2. I tuoni, i fulmini,
i lampi; 3. Le acque terrestri; 4. La piena del Nilo, le nubi; 5. I venti; 6. Il terremoto;
7. Le comete.
Ci sono pervenute nove tragedie di argomento greco, tramandate in quest’ordine
(nel manoscritto Etruscus della Biblioteca Laurenziana): Hercules furens, Tròades, Phoenissae, Medèa, Phaedra, Oèdipus, Agamemnon, Thyestes, Hercules
Oetaeus. Un altro gruppo di manoscritti conserva una decima tragedia, l’Octavia,
di argomento romano, una praetexta probabilmente opera di un imitatore (vedi p.
528).
A parte va considerata l’operetta mista di prosa e versi che reca il titolo di Ludus
de morte Claudii (o Apokolokỳntosis, cioè «inzuccatura» o «apoteosi di un zuccone»), feroce parodia del processo di beatificazione del defunto imperatore. Fu
scritta nel 54, subito dopo la morte di Claudio, e inscenata a corte col consenso di
Agrippina.
Di dubbia attribuzione sono gli Epigrammi. Svariate le opere perdute (soprattutto filosofiche, riguardanti il matrimonio, l’amicizia, l’utilità della filosofia), ma anche
quelle sicuramente spurie.
Opere filosofiche
Opere di carattere
scientifico
Dieci tragedie
La Apokolokỳntosis
Epigrammi e opere perdute
457
458
Retorica, erudizione, filosofia
I Dialogi
Il genere
Le Consolationes
Il De ira
ALTO IMPERO
Il De vita beata:
il saggio e la ricchezza
18, 1;
trad. di G. Garbarino
I dieci Dialogi (in dodici libri: nove di un libro, il De ira di tre) furono scritti durante l’arco di vita che va dal regno di Caligola alla morte dell’autore. Nonostante il
titolo – dovuto al fatto che il dialogo era stato il genere tipico della letteratura filosofica – non hanno forma dialogica come quelli di Platone, ma sono una riflessione continuata, con rari interventi del dedicatario o di un interlocutore anonimo. Per la vivacità espressiva e l’informalità di registro risentono piuttosto dell’influenza della diàtriba stoico-cinica. In quanto non riflettono una precisa linea
di sviluppo della speculazione filosofica senecana, non si possono datare con
certezza.
Attorno al 40 d.C. può collocarsi la Consolatio ad Marciam, indirizzata alla figlia di
Cremuzio Cordo per consolarla della morte di un figlio. È il pretesto per esaltare la
nobile figura di Cremuzio, storico delle guerre civili. Il genere della consolatio, diffuso
in Grecia e a Roma, implica l’adozione di temi (l’effimero dell’esistenza, l’ineluttabilità
della morte, la morte come passaggio a una vita migliore, ecc.) che costituiranno il
nucleo della meditazione etico-filosofica di tutta la produzione di Seneca.
Della Consolatio ad Polybium e delle indecorose adulazioni per ottenere la revoca
dell’esilio, abbiamo già riferito nella «Vita». Si trattò di una caduta del filosofo, il
quale peraltro aveva altrove espresso la convinzione che il saggio «sa comprare
ciò che è posto in vendita» e, se per entrare in una porta deve dare una mancia,
la darà.
Con la Consolatio ad Helviam matrem, scritta forse nel 42 ai tempi della relegazione in Corsica, Seneca cerca di convincere la madre che l’esilio non è motivo
d’infelicità per il saggio, è solo una commutatio loci. La esorta a ritrovare la serenità accanto ai familiari, in particolare al nipotino Marco.
I tre libri del De ira, dedicati al fratello Novato, sono una «fenomenologia delle
passioni umane» (Conte) descritte nella natura e nei meccanismi generativi. Di
tali passioni – e specialmente dell’ira, studiata attraverso esempi storici e considerata una «malattia sociale» – si prescrivono i modi per arginarle, sedarle,
prevenirle. Il trattato fu scritto subito dopo la morte di Caligola, che nell’opera è
presentato come belva assetata di sangue, facile vittima della funesta passione
dell’ira.
Sempre a Novato, quando già aveva mutato il nome in quello di Gallione dopo
l’adozione da parte di Giunio Gallione, è dedicato anche il De vita beata, che affronta il tema della felicità, soprattutto in rapporto alle ricchezze: un tema scottante, che
il filosofo arcimilionario trattava anche nell’intento di confutare quanti (secondo Tacito) lo accusavano di vivere in modo difforme dai precetti stoici enunciati. Premesso
che la virtù, e non la ricchezza, è il fondamento della felicità, Seneca afferma che
nemo sapientiam paupertate damnavit, «nessuno ha mai condannato la sapienza
alla povertà». Ciò che conta per il saggio non è di non possedere ricchezze, ma di
non essere posseduto da esse. E poi egli non pretende di essere un saggio, ma uno
che cura i mali del proprio animo mediante la filosofia. Del resto l’accusa di incoerenza rispetto ai principi filosofici fu rivolta anche a illustri filosofi del passato:
Parli in un modo, tu mi dici, e vivi in un altro. Queste accuse… furono rivolte a Platone, a Epicuro, a Zenone. Tutti questi filosofi, infatti, parlavano
non come vivevano, ma come avrebbero dovuto vivere. Io non parlo di me,
ma della virtù, e se condanno i vizi, condanno innanzi tutto i miei. Quando
ne sarò capace, vivrò secondo virtù.
La filosofia morale e naturale di Seneca
Anche i tre dialoghi De constantia sapientis, De otio, De tranquillitate animi – il cui
comune dedicatario è Sereno, un amico epicureo convertitosi allo stoicismo e che
si rivolge a Seneca per essere guarito dai mali dell’anima – trattano dei temi, cari
alla filosofia ellenistica, dell’autonomia del saggio e del contrasto tra vita attiva e vita contemplativa.
Nel De constantia è affermato in sintonia con la dottrina stoica, qui presentata anche negli aspetti più paradossali, che il saggio, in quanto possiede la virtù, non può
ricevere offesa da parte degli uomini.
Il De tranquillitate animi, scritto ai tempi della collaborazione con Nerone, analizza
il rapporto tra saggio e politica. Al giovane interlocutore, combattuto tra il dovere di
una vita impegnata al servizio degli altri e gli allettamenti dell’otium, Seneca prospetta il comportamento flessibile del saggio che di volta in volta, in relazione alla
situazione, decide di scendere nell’agone politico o di rifugiarsi nel sicuro porto della contemplazione.
Nel De otio, scritto probabilmente dopo il ritiro coatto dalla politica, manca lo sforzo
di conciliazione tra le esigenze antitetiche dell’otium e quelle dell’impegno civile. La
preferenza è accordata alla difesa della vita contemplativa, che frutta la serenità
dell’animo.
Forse agli anni tra il 49 e il 52 risale la stesura del De brevitate vitae, che affronta il tema della durata della vita. Questa è lunga per chi sa come impiegarla (vita,
si uti scias, longa est, 2, 1) mentre è brevissima (fluit et praecipitatur, 10, 6) per
chi sciupa il tempo inseguendo vane chimere, come gli occupati oziosi rappresentati in una grottesca rassegna caricaturale. C’è chi passa il tempo dal parrucchiere a imbellettarsi, chi allestisce sempre banchetti, chi canta tutto il giorno
canzonette di moda, chi colleziona statue. La polemica contro gli indaffarati senza costrutto, che combattono quotidianamente la noia della vita inutile ripetendo
con «automatismo burattinesco» (Perelli) atti insensati, oppone nettamente il
saggio agli occupati.
Fu scritto forse negli ultimi anni il De providentia, che dibatte l’apparente contraddizione tra il provvidenzialismo stoico e il fatto che quasi sempre la sorte sembra punire i virtuosi e premiare i malvagi. In realtà, dice Seneca, Giove vuole mettere alla
prova il saggio perché egli tenga in esercizio e rafforzi la propria virtù. Le sventure
sono pertanto un segno della Provvidenza, che sa distinguere i saggi e, creando
ostacoli, consente loro di perfezionarsi.
Il De constantia sapientis,
il De otio,
il De tranquillitate animi
Il De brevitate vitae
Il De providentia
Politica e morale: il De clementia e il De beneficiis
Fuori della raccolta dei Dialogi ci sono giunti altri due trattati: Il De clementia e il De
beneficiis.
Il De clementia, dedicato al giovane Nerone, tratta delle virtù del principe ideale. È
il «manifesto della teoria politica», a cui Seneca si atterrà nella conduzione dello
stato in nome di Nerone (Stupazzini).
La struttura monarchica è fuori discussione in quanto, secondo la concezione stoica, uniforma l’ordine sociale all’ordine razionale dell’universo. La positività della
monarchia dipende solo dal principe, che può essere o non essere virtuoso. Parte
essenziale della sua virtù è la clementia, cioè l’atteggiamento di generale benevolenza verso i sudditi.
Evidentemente si tratta di una teoria paternalistica, in quanto legata alla buona
disposizione di chi esercita il potere. Dipende solo dal principe – e in misura mino-
Il De clementia
459
460
Retorica, erudizione, filosofia
Il De beneficiis
re, da chi presiede alla sua formazione filosofica e morale – che egli concepisca la
propria funzione come una «nobile servitù», un sacrificio (onus) cui egli si sottopone per il bene della collettività.
I sette libri del De beneficiis, terminati nel 64, trattano del legame tra beneficato e
benefattore, «il legame che più tiene coesa la società umana» (1, 4, 2). Chi è più
fortunato deve aiutare chi lo è meno. Rivolgendosi soprattutto agli esponenti della
sua stessa classe sociale, senatori e grandi ricchi, Seneca afferma il dovere della
beneficenza in nome di una comune dignità umana che ogni uomo possiede, anche se schiavo. È poi degno di nota che gli schiavi possano essi stessi divenire benefattori dei liberi (Pennaccini).
Si tratta di una «teoria della generosità» – sulla tradizione di analoghe elaborazioni
di autori greci (Pitagora, Crisippo) e del De officiis ciceroniano – che, in quanto mira anche a prevenire conflitti sociali, ha una sua rilevanza politica. Al di là della portata ideale e utopica, il De beneficiis è di fatto un corollario della teoria della clementia.
Le Epistulae ad Lucilium
Un epistolario fittizio?
Il genere
ALTO IMPERO
Il modello di Epicuro
Ep. 15
La polemica contro
Cicerone
L’opera maggiore e più celebre di Seneca è rappresentata dai 20 libri delle 124
Epistulae morales ad Lucilium, scritte dopo il ritiro dalla politica, pochi anni prima
della morte. La raccolta è forse incompleta. Sebbene il destinatario, Lucilio, sia un
personaggio reale (si tratta di un funzionario imperiale, intellettuale e amico di Seneca, di cui è un po’ più giovane), alcuni studiosi dubitano che sia realmente intercorso uno scambio epistolare.
Le lettere, assai varie per estensione (talune della dimensione di un trattato), fondano un genere nuovo, adatto a rendere il pensiero senecano, asistematico e incline a trattare separatamente singoli temi etici (Conte). Un antecedente latino erano
state le Epistole di Orazio, che pure si proponevano come il genere più adatto a chi
sente l’esigenza della filosofia intesa come ricerca morale, come quotidiana pratica
di saggezza. E certo con le epistole oraziane quelle di Seneca hanno in comune il
fatto d’essere destinate alla pubblicazione, la varietà e l’occasionalità dei temi, il legame stretto tra filosofia e vita vissuta, l’atteggiamento umile di chi non s’impanca
a maestro ma parla sottovoce (submissiora verba, 38, 1) considerando sé stesso
bisognoso di perfezionamento non meno del destinatario. Anche il tono colloquiale,
il registro informale, lo stile non elaborato e semplice (inlaboratus et facilis, 75, 12), adatto alla conversazione tra amici, fanno pensare ai sermones oraziani.
Ma il modello delle Epistulae ad Lucilium era piuttosto Epicuro, che istituiva coi discepoli un rapporto pedagogico e di direzione spirituale omologo a quello che Seneca stabilisce con Lucilio. Nel carattere filosofico, nell’essere veicolo di consigli
utili alla salute dello spirito, sta appunto la specificità delle lettere di Seneca, la loro
novità rispetto alla produzione epistolare precedente:
Gli antichi avevano l’abitudine, ancora in atto, di aggiungere alle prime parole della lettera: “se stai bene sono contento, io sto bene”. Meglio, noi diciamo: “se ti dedichi alla filosofia sono contento, io sto bene”. Stare bene
infatti, in definitiva, è questo. Senza questo l’animo soffre.
In questa critica dell’epistolografia precedente, considerata futile e superficiale,
era coinvolto anche l’epistolario ciceroniano, troppo legato alla cronaca e all’attualità spicciola e privata, lontano da un modello di scrittura volta a sondare
l’interiorità:
La filosofia morale e naturale di Seneca
Non farò certo quello che Cicerone … chiede ad Attico di fare, esortandolo, anche se non avrà notizie da dargli, a scrivergli qualunque cosa gli verrà in mente. … È meglio occuparsi dei propri mali che di quelli altrui, esaminare a fondo se stessi e vedere quante ambizioni sbagliate noi abbiamo,
e non assecondarle.
118, 1-3;
trad. di G. Garbarino
Intendiamoci: non è che nelle lettere di Seneca manchi il riferimento al privato. Anzi,
ci sono pagine intense di rievocazione dell’adolescenza e dei maestri di quegli anni
remoti, c’è il ricordo affettuoso del padre, ci sono espressioni di tenerezza per la giovane moglie Paolina. E neppure mancano i riferimenti alla quotidianità spicciola o il
resoconto dei fatti giornalieri. Ma da questi fatti, di per sé irrilevanti, l’autore sempre
trae spunto per una profonda riflessione morale: così un accesso d’asma che l’ha
colpito lo sospinge a meditare sulla morte, un soggiorno in una località balneare lussuosa lo induce a riflettere su come i luoghi possano condizionare la virtù.
Gli argomenti delle lettere sono assai vari, ma sempre riconducibili al nucleo essenziale dell’etica stoica e della predicazione diatribica: l’autonomia del saggio,
l’esortazione all’otium, il valore della virtù, il controllo delle passioni, la capacità di
sopportare le avversità, la serena accettazione della morte. La convinzione dell’uguaglianza naturale di tutti gli uomini (inclusi gli schiavi, per i quali Seneca trova
parole di grande solidarietà umana) e il dovere di amare gli altri sono affermati con
una passione che trascende i limiti della filantropia stoica. Questa accentuazione
della componente umanitaria ha indotto taluni a parlare di una carità cristiana. Ma
le analogie col cristianesimo si rivelano poco fondate, se si tiene conto del carattere fortemente aristocratico della filosofia di Seneca, il quale spesso dichiara il fastidio per la folla, il disprezzo per il volgo stolto, che si compiace dei turpi spettacoli
circensi.
Un motivo costantemente presente è quello della morte, vista non come oggetto di
paura o segno d’impotenza, ma come consolatoria liberazione, suprema affermazione della libertà del saggio, simbolo della sua indipendenza dalle cose: non sumus in ullius potestate, cum mors in nostra potestate sit (91, 21). A Lucilio Seneca
raccomanda: «Medita la morte: chi dice questo t’invita a meditare la libertà. Chi ha
imparato a morire ha disimparato ad essere servo» (26, 10).
Nella quotidiana, alacre ricerca del bene, nel viaggio sulla via del perfezionamento
interiore Seneca oscilla pendolarmente tra l’esigenza di isolarsi e quella di comunicare i risultati della propria riflessione spirituale agli altri, perché possano trarne
vantaggio. Il fatto è che spesso la risposta a una domanda dell’interlocutore funge
anche da chiarimento per l’autore a se stesso, con moto a un tempo centrifugo e
centripeto, riflesso dalla polarità tipica del linguaggio senecano, teso tra «predicazione» e «interiorità». Su questo punto ha scritto pagine illuminanti Alfonso Traina,
che avverte in Seneca «il dramma di un uomo perennemente oscillante fra la cella
e il pulpito», ovvero «il dramma della saggezza fra l’amore di sé e l’amore degli uomini». Ma questi due amori sono conciliabili, almeno sul piano ideale, anzi addirittura inscindibili: «bisogna che tu viva per gli altri, se vuoi vivere per te» (15, 3). E
anche l’isolamento per il saggio non è un atto di egoismo, ma un impegno per il bene dell’umanità, posteri inclusi:
La quotidianità in funzione
morale
Questo è lo scopo per cui mi sono ritirato ed ho chiuso le porte di casa: per
poter essere utile ad un maggior numero di persone … Mi sono isolato non
tanto dagli uomini quanto dalle cose, e prima di tutto dalle cose mie. Ora
agisco nell’interesse dei posteri. Scrivo qualcosa che possa recar loro aiuto.
8, 1-2;
trad. di G. Garbarino
I contenuti
La riflessione sulla morte
«Fra la cella e il pulpito»
461
462
Retorica, erudizione, filosofia
Le Naturales quaestiones
I contenuti e le fonti
La finalizzazione morale
Dedicati a Lucilio, i Naturalium quaestionum libri VII sono la sola opera scientifica
di Seneca pervenutaci. Scritti negli ultimi anni di vita dopo il ritiro dalla politica (il
periodo è confermato dagli accenni al terremoto di Pompei del 62 d.C.), tuttavia
rappresentano una sistemazione di materiali raccolti nell’arco di una vita.
Il trattato descrive i fenomeni atmosferici e celesti in una prospettiva dossografica,
cioè di mera raccolta di opinioni altrui, senza alcuna originalità di ricerca. È il frutto
di un vasto lavoro di compilazione, durato probabilmente lunghi anni, risultante da
manuali e repertori stoici (rilevante, l’influenza di Posidonio), ma anche epicurei e
platonici.
L’opera vuole probabilmente fornire il supporto «fisico» al pensiero di Seneca, cioè
costituire quello che era la «fisica» (una delle tre parti della filosofia, insieme alla
morale e alla logica) nei sistemi filosofici antichi (Garbarino). Ma si tratta di una fisica che – in piena coerenza con la visione stoica – appare fortemente subordinata
alla morale. Infatti la conoscenza dei fenomeni naturali mira, come già era stato per
Lucrezio, a liberare gli uomini dai falsi timori, a soddisfare l’esigenza di sapere, a
insegnare loro il corretto impiego dei doni della natura.
Il busto dello «Pseudo-Seneca». La figura riporta la replica bronzea di un ritratto di ignoto personaggio greco, detto
convenzionalmente «Pseudo-Seneca», da un ritratto noto in trentasei copie, creato intorno al 230 a.C. (Napoli, Museo
Nazionale).
ALTO IMPERO
Alla corrente veristica dell’arte ellenistica, cui appartengono altre opere celeberrime come
l’«Omero cieco» o il «Fanciullo a cavallo» di Capo Artemisio, va riferito anche il cosiddetto
«Pseudo-Seneca», «un virtuosistico studio anatomico che si compiace di rendere l’estremo decadimento fisico, … il risalto delle vene, l’acuto affiorare delle ossa, … il gioco delle rughe» (G. Beccatti).
Riportiamo il commento di R.V. Schoder, uno storico dell’arte classica:
«Un tipico esempio dell’implacabile realismo che distingue le correnti della produzione ellenistica
è dato da questo sconcertante ritratto, che offre uno spettacolo di sgomento e di disperazione. Un
vecchio sembra guardare terrorizzato l’avvicinarsi della
morte, il vuoto che gli si prepara col decadimento del suo
fisico un tempo si vigoroso da fargli affrontare le battaglie della vita con fiduciosa sicurezza. Perduta ogni speranza, amareggiato dall’incapacità di vincere la morte
inevitabile che presto lo avvolgerà nel suo manto, il vecchio pagano fissa con occhi sgomenti il suo destino con
una intensità che rivela in lui il sopravvivere di qualche
energia. È dubbio che sia mai stato raggiunto in arte uno
studio più perfetto.
Anche gli antichi ammiravano molto questo pezzo, affascinati dalla sua forza di espressione, poiché ben trentasei copie ne sopravvivono oggi, a dimostrare quanto esso
fosse apprezzato ai tempi di Roma. Una delle copie migliori è certamente questa, trovata a Ercolano nella villa
dei Pisoni. È forse l’originale, dal quale furono tratte le
copie, ma se al contrario si tratta di una copia, essa ha
tali caratteri di maestria da far collocare il suo scultore
fra i più abili, e modellato su una forma che ha colto ogni
particolare dell’originale. L’artista che per primo ha
scolpito questi tratti ci ha rivelato il logorio interno del
pensiero, le qualità psicologiche che ha poi magistralmente espresse nella materia. Il complesso della fisiono-
La filosofia morale e naturale di Seneca
mia è veramente interessante ma anche i particolari, presi singolarmente, hanno il loro significato, gli occhi smarriti, privi di speranza, le gote scavate, la barba incolta, le labbra cascanti e il
collo flaccido, tutto contribuisce a creare quella espressione tesa, disperata di chi ha perduto ogni
interesse alla propria persona esteriore. Un bronzo che è un frammento di tormentata umanità.
Fu questo un uomo veramente esistito? La risposta rimane incerta. Una vecchia teoria che riconosceva Seneca in questi tratti è del tutto tramontata, dato che si tratta di opera ellenistica assai precedente a lui (Seneca fu maestro di Nerone). Qualcuno ha voluto vedervi raffigurato Ipponatte o
Archiloco, Filemone, Aristofane, ma nessuna attribuzione è parsa convincente e la corona di alloro che si riscontra in talune copie non è necessariamente da attribuirsi alla qualità di poeta. Potrebbe essere un filosofo, benché i più famosi siano facilmente identificabili e non abbiano alcuna
rassomiglianza con questo»1.
Riflessioni assai diverse faceva, di fronte a questo singolare busto, H. Melville, l’autore di Moby
Dick:
«Nel busto di Seneca, la cui filosofia potrebbe essere il cristianesimo stesso, salvo la sua autenticità, le cui espressioni destarono tanto stupore in uno degli antichi padri che egli pensò che avesse
avuto contatto con S. Paolo, vediamo un volto che somiglia molto più a quello di un corrucciato
usuraio, pieno di rughe e di pensieri. È la sua apparenza esatta, poiché è ben noto che egli era
avaro ed avido, e che s’occupava volentieri d’ipoteche e di prestiti, e che conduceva affari spregiudicati anche per quei tempi. È ferreo e inflessibile e non sarebbe disdicevole neanche a un
agente di Wall Street»2.
1. R.V. Schoder, Capolavori di arte greca, Electa, Milano, 1963.
2. H. Melville, Diario italiano, Opere Nuove, Roma, 1964.
Lo stile di Seneca
Alla gerarchia e alla simmetria del periodo ciceroniano – specchio di una realtà ordinata, di un equilibrio politico e morale – si contrappone la sintassi di Seneca,
asimmetrica, spezzata e convulsa, riflesso di un rapporto conflittuale col mondo:
«è lo stile drammatico dell’anima umana che è in guerra con se stessa» (Marchesi), lacerata tra il bisogno d’interiorità e l’esigenza di predicazione, tra la ricerca
della libertà dell’io e l’ansia di liberare l’umanità. Si tratta di una scrittura concitata,
incalzante, nervosamente franta, che abolisce i rapporti di subordinazione conferendo alla singola frase il rilievo di una sentenza autonoma.
Alla sentenza, appunto, luminosa e di pregnanza epigrammatica, tende dichiaratamente Seneca: «I precetti hanno di per sé molto peso, soprattutto se … espressi in
una prosa che si condensi in sentenza» (prosa oratione in sententiam coartata, Ep.
94). L’asistematicità che è propria del pensiero di Seneca caratterizza anche il suo
stile, frantumato, omologo alla problematicità e complessità del reale: uno stile che
«con una sorta di tecnica “puntillistica” produce l’effetto di sfaccettare un’idea secondo tutte le angolazioni possibili» (Conte). Di qui il giudizio spregiativo di Caligola, che definì la prosa senecana harenam sine calce («sabbia senza calce»), cioè
un coacervo di parti giustapposte senza vera coesione.
In realtà la calce c’è, però non sta nei nessi subordinanti, ma nelle equivalenze ritmiche e semantiche (parallelismi, antitesi, ripresa e variazione del motivo precedente, ecc.). L’antitesi è il procedimento di stile più ricorrente: in forma di ossimoro
(inquietam inertiam, De tranq. 12, 2), con arguto concettismo (cum vitiis convicium
facio, De vita beata 18, 1), con chiasmo (petita relinquimus, relicta repetimus, De
otio 1, 2). All’intenzione pedagogica e alla necessità di ribadire in modo martellante
i precetti basilari si lega l’uso dell’anafora, che spesso scandisce la progressione
del discorso verso un punto cruciale: Hoc nempe ab homine exigitur: ut prosit homi-
L’opposto della
concinnitas ciceroniana
«Sabbia senza calce»
L’antitesi e l’anafora
463
464
Retorica, erudizione, filosofia
Delectare e prodesse
Il linguaggio dell’interiorità
nibus, si fieri potest, multis; si minus, paucis; si minus, proximis; si minus, sibi, «Questo si esige dall’uomo: che giovi all’umanità, se è possibile; o almeno a molti; o almeno a pochi; o almeno ai congiunti; o almeno a se stesso», dove il culmine della
climax è nel pronome riflessivo, ossia nell’invito a sondare la propria interiorità.
Certo questi procedimenti di stile – in particolare il ribattere il pensiero con tensione che culmina nella punta aguzza della minutissima sententia – derivano dalle
scuole di declamazione, dalla retorica asiana. Ma, almeno in linea di principio,
l’artificio retorico è funzionale all’espressione dei contenuti, si giustifica nella prospettiva psicagogica del fissare nella mente e nel cuore un precetto morale: non
delectent verba nostra sed prosint (Ep. 75, 5).
Al messaggio dell’interiorità – in cui consiste tutta la filosofia di Seneca (me prius
scrutor, deinde hunc mundum, Ep. 65, 15) – doveva corrispondere un linguaggio
che fosse strumento adeguato per l’ossessivo scavo dentro di sé. Ma un tale linguaggio era ignoto ai Romani, che non avevano conosciuto l’invito socratico all’autocoscienza. «Dunque, toccò a Seneca foggiare il linguaggio latino dell’interiorità»
(A. Traina).
La fortuna
L’antichità
ALTO IMPERO
«Seneca cristiano»
Già abbiamo accennato al giudizio non positivo di Caligola. Anche Quintiliano rimproverava a Seneca lo stile anticlassico, pur riconoscendo la validità del suo insegnamento morale: «Nei suoi scritti spiccano molte sentenze e molti passi sono degni
di lettura in virtù della loro moralità. Ma nello scrivere il suo stile si rivela quasi sempre guasto e per questo assai nocivo, perché abbonda di vizi seducenti» (Inst. or. X
1, 129). Nocivo a chi? Soprattutto ai giovani che, sempre a sentire Quintiliano, leggevano solo le sue opere: solus hic fere in manibus adulescentium fuit (Inst. or. X 1,
126). Poco favorevole fu anche il giudizio che Frontone e gli arcaizzanti del II secolo
pronunciarono sullo stile «moderno» dello scrittore. In particolare Frontone sconsiglia
all’imperatore Marco Aurelio la lettura di Seneca, le cui qualità non compensano i difetti, che consistono nell’eloquenza aggrovigliata (confusam … eloquentiam) e nella
tendenza a ripetere migliaia di volte la stessa idea sotto veste diversa. Gli aspetti positivi gli sembrano irrilevanti: anche nelle fogne si può trovare una lamina d’argento,
ma non per questo vale la pena di frequentare le fogne (Ep. de orat. 21, 6).
Non molto più benevolo è il giudizio di Gellio, che dedica a Seneca un intero capitolo delle Notti attiche (XII 2). Il filosofo è ritenuto ineptus et insubidus homo per le
critiche da lui espresse – nel XXII libro delle Epistole, che non ci è giunto – riguardo all’oratoria ciceroniana.
Il contenuto etico delle Epistole e dei Dialogi fu apprezzato dai cristiani, che, spesso fraintendendo il pensiero del nostro autore, lo considerarono uno degli spiriti
nobili del paganesimo più vicini al cristianesimo. Tertulliano usa l’espressione Seneca saepe noster (cioè, «Seneca ragiona spesso come un cristiano», Amin. 20,
1). Lattanzio lo considera omnium Stoicorum acutissimus e inoltre scrive, inaugurando la leggenda della cristianità del filosofo: quam multa alia de deo nostris (cioè
ai cristiani) similia locutus est! (Ist. 1, 5, 28). Girolamo lo nomina di frequente e cita
per primo un carteggio fra Seneca e S. Paolo, che è giunto fino a noi. In realtà i
punti di contatto tra la filosofia laica di Seneca e la teologia di Paolo di Tarso erano
pochi, e l’epistolario dev’essere parso credibile solo in virtù della circostanza esterna che questi due spiriti di diversa fede, all’incirca negli stessi anni (tra il 50 e il 67
d.C.), si avvalevano per la loro «predicazione» del mezzo delle lettere. Il carteggio
La filosofia morale e naturale di Seneca
ha contribuito alla fama del filosofo nel Medioevo, ma può anche essere vero il
contrario: che la fortuna delle quattordici lettere nel corso dei secoli è dipesa dalla
fortuna medioevale di Seneca e dalla diffusione della leggenda della sua conversione.
In età medioevale grande fu infatti la fortuna di «Seneca morale», come lo chiama
Dante (Inf. IV 141 ) con riferimento ai contenuti etici delle opere del filosofo1. La sua
morte fu letta come martirio cristiano secondo una leggenda che attraverso il Roman de la rose è riportata nel Novellino. Sempre il Novellino presenta aneddoti della vita di Seneca – tolti dai Fiori dei filosofi – come veri exempla, cioè testimonianze autorevoli di una virtù eroica, proposti come modello da imitare.
Un’ulteriore prova della fama goduta dal filosofo in età medioevale è nel gran numero dei codici, ma anche degli scritti apocrifi (i Monita Senecae, il Liber de moribus, ecc.). È soprattutto nei secoli XII e XIII che questo autore divenne popolare, e
a tale periodo risalgono le molte famiglie di manoscritti prodotti in vari conventi, come quello di Montecassino, alla cui attività assidua si deve in particolare la conservazione dei Dialogi, che in seguito ebbero grande diffusione nell’Europa settentrionale, nelle scuole universitarie di Parigi e di Oxford, in Germania. Grande interesse
per il teatro di Seneca fu espresso dalla corte papale trasferitasi ad Avignone.
Le Lettere a Lucilio e alcuni trattati furono letti da Petrarca e da Boccaccio, i quali però non pare ne avessero una conoscenza troppo approfondita. In Spagna Seneca fu
considerato autore nazionale e tradotto e commentato dal re Alfonso V in persona.
Alla fine del Quattrocento, nelle prime edizioni a stampa si distinse Seneca Philosophus e Seneca Tragicus. La prima edizione delle opere filosofiche è quella napoletana del 1475.
Nel Cinquecento Seneca fu maestro di saggistica in tutta Europa. Godette dell’ammirazione di Montaigne, i cui scritti sono densi di citazioni tratte dalle Lettere a Lucilio e dai Dialogi. Rilevante fu l’influsso di queste opere sulla cultura prima gesuitica, poi protestante.
Le tragedie dell’orrore di Seneca, con il loro barocco cupo e truculento, furono di
grande attualità sia in Italia, sia soprattutto nell’Inghilterra elisabettiana. Così il teatro di Seneca influenzò Shakespeare (in particolare nel Macbeth e nell’Amleto) e
tutto il teatro inglese.
Lessero Seneca Racine e Corneille, il quale nella Médée e nella Phèdre imitò le
tragedie omonime del filosofo latino.
Anche Voltaire conobbe le opere morali e il nostro Alfieri fu influenzato dalle vibranti e cupe scene del teatro senecano.
Nell’Ottocento Seneca continuò ad essere letto da scrittori e filosofi. Criticato da
Hegel che gli rimproverava il difetto di capacità speculativa, ammirato da Schopenhauer, Seneca prosatore ha goduto ininterrottamente del favore dei lettori e ancor
oggi continua a costituire uno dei capisaldi della paidèia umanistica. Non così per il
Seneca tragico, la cui fortuna, cresciuta senza interruzioni dal XIV al XVIII secolo,
sembra essersi definitivamente interrotta in Italia, dove alla disistima romantica si è
aggiunta poi nel Novecento la stroncatura crociana.
1. A meno che Dante non intendesse, con l’epiteto morale, distinguere il filosofo dal tragico ritenendoli due persone diverse. Pare che tale distinzione tra due Seneca non si facesse
all’età di Dante, ma sia stata introdotta in seguito, per un errore di interpretazione, dal Boccaccio, che ne persuase anche il Petrarca (cfr. Dante e Seneca filosofo, «Studi danteschi» VI
5-24).
Il Medioevo
Il Trecento e
il Quattrocento
Il Cinquecento e
il Seicento
L’epoca moderna
Ludmilla Mikaël nel ruolo di
Fedra, in una ripresa contemporanea del dramma di Racine da
parte della Comédie-Française.
465
466
Retorica, erudizione, filosofia
Lo stoicismo fino al II secolo d.C.
L. Anneo Cornuto
e Musonio Rufo
ALTO IMPERO
Epitteto
Marco Aurelio
Contemporanei di Seneca furono l’africano (di Leptis) L. Anneo Cornuto e Musonio
Rufo di Volsini (Bolsena). Il primo, forse un liberto di Seneca – alla famiglia degli
Annei appartenevano Seneca e Lucano – fu filosofo stoico e grammatico. La sua
scuola fu frequentata da Lucano e da Persio, del quale egli curò dopo la morte
l’edizione delle Satire. Per la sua libertà di pensiero fu esiliato da Nerone nel 65
d.C., l’anno della congiura dei Pisoni.
Negli stessi anni il filosofo e oratore Musonio Rufo teneva lezioni di etica stoica,
probabilmente in greco, ma non volle mai affidare il proprio pensiero alla scrittura.
Restano di lui citazioni trascritte dagli scolari, il più celebre dei quali è il filosofo
Epitteto. Fu grande ammiratore di Catone Uticense (il simbolo stoico dell’opposizione alla tirannia, celebrato da Lucano, protagonista di una biografia scritta dal martire per la libertà Tràsea Peto e del quale Seneca scriveva: «Catone non visse dopo
la libertà, né la libertà dopo Catone», De const. sap. II 3). Le sue idee politiche gli
procurarono due esili (nel 65 e nel 71). Si occupò anche di filosofia economica.
Dallo stoicismo furono influenzati anche, come vedremo, i poeti Lucano e Persio,
non a caso allievi di Cornuto.
Dopo Seneca, Cornuto e Rufo, furono interpreti di rilievo del pensiero stoico Epitteto e Marco Aurelio, esponenti della cosiddetta Stoà tarda.
Nato a Ierapoli in Frigia (50 ca. - 135 d.C.) e condotto a Roma come schiavo poi reso libero, fu coinvolto nell’espulsione dei filosofi decretata da Domiziano nell’88-89
d.C. Fondò una scuola a Nicopoli in Epiro e come Socrate non lasciò alcuno scritto.
Il proprio pensiero tuttavia fu raccolto fedelmente da un suo allievo, Arriano di Nicomedia, in due opere scritte in greco: le Dissertazioni o Diatribe e il celebre Manuale, tradotto da Leopardi. Epitteto intende recuperare lo stoicismo originario, privo di
concessioni e adattamenti, eliminando gli aspetti scettici introdotti nella Media
Stoà. Accorda la massima centralità all’etica identificando moralità e virtù. Questa
consiste nel desiderare solo ciò che è in nostro potere e nel disprezzare tutto il resto. La serenità va cercata nell’interiorità del proprio spirito e nella rinuncia a considerare come raggiungibili cose che non sono alla nostra portata. D’altronde il turbamento dell’animo è sempre soggettivo: «gli uomini non sono agitati e turbati dalle cose, quanto dalle opinioni che essi hanno delle cose». E poiché le opinioni dipendono da noi, la serenità è in nostro potere. L’antico motto stoico sustine et abstine («sopporta il dolore e astieniti dai beni apparenti»), che predica il distacco
dalle cose esterne e il pieno dominio dei nostri desideri, compendia
l’insegnamento morale di Epitteto.
L’ultima grande voce dello stoicismo è rappresentata dall’imperatore filosofo Marco
Aurelio Antonino (121-180 d.C.). Dedito agli studi di retorica sotto la guida di Frontone, appassionato di filosofia e lettore assiduo di Epitteto, scrisse un corpus di lettere in latino riportate nell’epistolario di Frontone e, in greco, l’opera in 12 libri intitolata A se stesso. Non si tratta dell’esposizione sistematica della dottrina stoica,
bensì di un diario spirituale che consiste in riflessioni sparse, espresse in forma di
aforisma, distillate nei momenti di tregua tra una campagna militare e l’altra. È una
rielaborazione personale e suggestiva di alcuni temi morali canonici, come quello
della serena accettazione del nostro destino, che ci impone d’essere soldati e imperatori, mentre avremmo preferito per intima inclinazione una vita dedita all’otium
filosofico. È un colloquio dell’autore con se stesso, che inaugura un genere lettera-
Lo stoicismo fino al II secolo d.C.
rio di grande fortuna, imitato da Agostino a Petrarca fino alle recenti Memorie di
Adriano della Yourcenar. Il tema è sempre quello della conquista dell’equilibrio interiore, della riflessione sulla morte, sul carattere effimero dell’esistenza sia individuale sia del grande impero, la cui sopravvivenza è minacciata da orde barbariche
che si affacciano sui vari confini.
La durata della vita umana è un istante, la materia fluisce, la sensazione è
subito cancellata, la compagine del corpo si sfascia, la forza vitale è un
vortice, la fortuna malcerta: insomma, tutte le cose del corpo sono un fiume, quelle dell’anima sono sogno e stupore, la vita è guerra e pellegrinaggio.
Di qui il senso di malinconia che pervade l’opera, nato anche dalla consapevolezza
che Marco Aurelio ha di essere l’ultimo grande imperatore, sulla cui tomba è già
stata incisa l’epigrafe: «Egli è l’ultimo della sua stirpe» (VIII 3, 1). Il fascino è, oltre
che nello stile scabro ed essenziale, nella disarmante sincerità che rende l’opera
non un compendio di astratta dottrina, ma l’espressione di una concreta e vissuta
ricerca della saggezza. Da questo punto di vista la figura di Marco Aurelio è davvero paradigmatica, in quanto ci si presenta come «la più concreta realizzazione
umana dello stoicismo romano, con il suo senso del dovere e del sacrificio pur nella assoluta libertà di giudizio interiore, con la sua superiore saggezza non priva di
malinconia e di pessimismo per la caducità della vita e della storia, donde un amaro desiderio di morte e di oblio» (Sini).
Con queste voci lo stoicismo come indirizzo filosofico autonomo conclude il proprio
ciclo. Echi stoici ritorneranno nel pensiero cristiano (in particolare si parlerà di «Seneca cristiano», vedi p. 464) e l’aggettivo stoico ancor oggi definisce la persona
saggia, capace di affrontare con fermezza e rassegnazione il dolore fisico e le
sventure.
Marco Aurelio, Pontefice Massimo,
compie un sacrificio (II sec. d.C.)
Roma, Palazzo dei Conservatori.
VII 5, 3
467
468
Retorica, erudizione, filosofia
La Institutio oratoria di Quintiliano
La «restaurazione»
dei Flavi
Al periodo turbolento della dominazione di Nerone (54-68 d.C.) seguì quello della
«restaurazione» di Vespasiano e dei suoi successori, i Flavi (69-96 d.C.): con un
parallelo stilistico potremmo fare corrispondere all’età neroniana le irregolarità dello stile asiano e alla successiva età flavia un’esigenza di ordine e organizzazione di
tipo piuttosto atticista. I Flavi sostituirono alla figura del filosofo e consigliere imperiale quella del retore e funzionario amministrativo, e di conseguenza attribuirono
grande importanza alla formazione retorica della nuova classe politica. È a questo
punto che entra in gioco la figura di Quintiliano, già insegnante di retorica nella nativa Spagna e primo professore a ricoprire la cattedra di eloquenza stipendiata dall’impero per volontà di Vespasiano nel 71 d.C. Il fatto che divenisse addirittura precettore dei figli di Domiziano potrebbe farlo apparire irrimediabilmente compromesso con la politica di regime, ma nonostante egli considerasse la realtà dell’impero
come necessaria – e quindi come imprescindibile posizione di partenza – tracciò
una figura nobile di oratore, con il cui contributo giovare certo più al bene della res
publica che del singolo principe.
ALTO IMPERO
La vita
Il clima politico e culturale
Ciò che sappiamo di Quintiliano ci è noto prevalentemente dalla sua opera e dalla
Cronaca di Girolamo, fonte preziosa peraltro di notizie riguardanti numerosi altri
scrittori latini.
Marco Fabio Quintiliano nacque fra il 35 e il 40 d.C. in Spagna, a Calagurris
(l’odierna Calahorra). Il padre, anch’egli maestro di retorica, lo condusse giovanissimo a Roma, dove seguì gli insegnamenti del grammatico Remmio Palemone e
dell’oratore Domizio Afro, personaggio da lui più volte ricordato con ammirazione.
Tornò in patria dove esercitò la professione di retore, raggiungendo successo e fama, fino a quando, nel 68 d.C., fu ricondotto a Roma da Galba, allora governatore
della provincia, acclamato dopo la morte di Nerone imperatore dalle legioni spagnole. Qui rimase anche dopo l’uccisione di Galba, avvenuta l’anno seguente e
l’elezione ad imperatore di Vespasiano (69 d.C.), dedicandosi all’avvocatura e all’insegnamento di retorica. Dagli imperatori che governarono durante la sua vita
ebbe grandi prove di stima: da Vespasiano gli fu attribuita una delle prime cattedre
di retorica (ebbe come allievi Plinio il Giovane e forse Tacito e Giovenale) con uno
stipendio annuo di 100 000 sesterzi; da Domiziano gli furono conferiti il consolato
e, dopo il suo ritiro dall’attività dell’insegnamento durata circa vent’anni, l’incarico di
istruire i suoi due pronipoti destinati, nella sua intenzione, al trono.
La data della morte va posta fra il 96 e il 100 d.C.
Quintiliano vide, durante la sua vita, il succedersi di numerosi imperatori in Roma.
Durante la sua gioventù, che egli trascorse prevalentemente in Spagna (tranne, come si è visto, il tempo in cui fu a Roma per gli studi di grammatica e retorica), governarono prima Claudio (41-54 d.C.) e poi Nerone (54-68 d.C.). In tale periodo il
potere si spostò sempre più dal senato all’imperatore, con conseguente perdita
della libertas, presupposto indispensabile per la lotta politica e linfa vitale per
l’oratoria che da essa aveva tratto vigore e passione.
Lo studio della retorica, che pur sempre a Roma aveva rivestito grande importanza
nell’iter formativo della classe dirigente, non fu più diretto prevalentemente alla formazione dell’oratore che avrebbe dato prova di sé nel foro e nella vita pubblica, ma
La Knstitutio oratoria di Quintiliano
divenne elemento base dell’istruzione superiore a cui si dedicavano intellettuali e alti
funzionari dello stato. Spia della mutata situazione è la pratica delle declamationes,
che, nate come esercitazioni da parte del maestro o degli allievi di una scuola di retorica, divennero discorsi fittizi che si tenevano in pubblico. Di conseguenza si affermò uno stile più ricercato, spesso artificioso, mirante a suscitare effetto sull’uditorio.
Tale ondata anticlassicistica si andò esaurendo con l’avvento degli imperatori della
dinastia Flavia. Tutto il loro programma, imperniato sulla ricerca di un nuovo equilibrio, rivela impostazione conservatrice: segni evidenti, sul piano della politica interna, il riavvicinamento al senato; sul piano sociale, il programma di ritorno agli antichi ideali e agli antichi costumi. In questo clima fu favorito, sul piano culturale, retorico e letterario, un ritorno al classicismo che trovò in Quintiliano uno dei suoi fautori. L’impegno da parte dei Flavi alla formazione della classe dirigente e la loro attenzione alla cultura che serviva all’insegnamento svilupparono gli studi di retorica;
questi furono tenuti in grande considerazione al punto che, per la prima volta, furono istituite cattedre di eloquenza latina e greca retribuite dallo stato.
L’opera
Gli interessi di Quintiliano, come rivelano le sue opere, furono incentrati esclusivamente sulla retorica ed i problemi ad essa connessi. La sua attività di scrittore si
svolse completamente dopo il ritiro dall’attività dell’insegnamento; tuttavia, come
egli stesso riferisce nella Institutio, già precedentemente era stata diffusa sotto il
suo nome un’opera, in due libri, di arte retorica, compilata da suoi allievi, che avevano raccolto il materiale stenografando una lunga conversazione e numerose sue
lezioni, senza alcuna revisione da parte del maestro.
Scrisse un De causis corruptae eloquentiae in cui esaminava le cause della decadenza dell’oratoria dei suoi tempi, opera per noi perduta, e la Institutio oratoria
(«La formazione dell’oratore»), la sua opera maggiore, scritta probabilmente fra il
93 e il 95 o 96. Inoltre sono state tramandate con il suo nome due raccolte di Declamationes (19 maiores, ampie e compiute, 145 minores in forma di schema o di
abbozzo di orazione), ma la loro paternità è, in parte o completamente, respinta da
molti studiosi.
Vivo fu nel I secolo d.C. il dibattito sull’oratoria. Oggetto del dibattito furono in particolare due questioni: quale fosse lo stile da perseguire nell’eloquenza (arcaizzante,
modernizzante, ciceroniano), e le cause della crisi dell’oratoria.
Sulla prima questione Quintiliano si pose fra i classicisti: il modello che egli addita
per il futuro oratore è Cicerone; dell’Arpinate ammira l’equilibrio stilistico, lontano
dalle eccessive ampollosità dell’asianesimo (di quest’ultimo, Seneca, contro il cui
stile si pronuncia più volte, era stato il maggior rappresentante) e dall’arida asciuttezza dell’atticismo.
Sulle cause che avevano provocato il declino dell’oratoria si pronunciarono parecchi scrittori del tempo e Quintiliano dedicò a questo problema un’intera opera (De
causis corruptae eloquentiae); nonostante la sua perdita possiamo individuare le
idee di Quintiliano in proposito da numerosi cenni presenti nell’Institutio. Egli dà al
problema una risposta di tipo morale in quanto intravvede nella decadenza dei costumi la causa principale del degenerare dell’eloquenza. Non manca di considerare anche la vacuità delle declamazioni (si ricordi che molti oratori nascevano come
delatori presso il principe), dovuta al venir meno di una complessiva formazione
culturale e morale, indispensabile per un buon oratore.
Quintiliano e il dibattito
sull’eloquenza:
la figura ideale dell’oratore
469
470
Retorica, erudizione, filosofia
Institutio oratoria
ALTO IMPERO
Proemio 4, 1 ss.;
trad. di R. Faranda
Questa formazione, che andava al di là del possesso di buone competenze tecniche, era stata proposta come ideale anche da Cicerone; tuttavia in essa, diversamente che per l’Arpinate, per Quintiliano non è più la filosofia che ricopre il ruolo
primario, ma la retorica, che in tal modo, nelle sue intenzioni, veniva a perdere una
connotazione puramente tecnica di strumento di persuasione, per avere invece
un’ampia valenza educativa.
Nel piano di educazione retorica del futuro oratore Quintiliano non manca di indicare quali letture ritenga più idonee; in questa prospettiva traccia nel X libro dell’Institutio un’ampia panoramica, considerata una breve storia letteraria, degli scrittori
greci e latini utili a formare lo stile migliore. Vengono espresse, in quest’ottica, valutazioni su diversi autori, a volte desunte da fonti, a volte personali, che ci testimoniano quali fossero «i canoni critici dell’antichità». Significativi delle sue scelte sono
in particolare i giudizi che esprime sullo stile di Cicerone e Seneca: decisamente
favorevole, frutto di un attento vaglio delle sue caratteristiche, quello sull’Arpinate;
negativo quello sul Cordovano, di cui afferma in X 1, 125: «di molti suoi brani è
consigliabile la lettura a scopo morale, ma per il riguardo stilistico sono generalmente corrotti e tanto più pericolosi, in quanto abbondano di allettanti vizi».
La formazione di questa figura ideale è tracciata nella Institutio oratoria, composta
in dodici libri dopo l’88, anno del suo ritiro a vita privata, in seguito a un’attività quasi ventennale di insegnamento. Indicativo è innanzitutto il fatto che si parli di Institutio, ossia di formazione, di istruzione, di educazione. Si tratta quindi di un manuale
di tecnica retorica accompagnato da un forte interesse didattico. Mentre le precedenti opere retoriche avevano sempre rivolto i loro precetti ad uomini già culturalmente formati, Quintiliano ritiene di dovere tracciare una metodologia di formazione dell’oratore che comprenda addirittura la fase dell’infanzia:
… generalmente gli autori di precettistica retorica iniziarono le loro opere
come rivolgendosi a persone già perfettamente versate in ogni ramo del sapere, per dar loro quindi l’ultima mano, consistente nei precetti dell’eloquenza; sia in dispregio dei primi studi, come fossero bagattelle, sia perché
credettero che non ad essi spettasse soffermarvisi, in quanto, a loro avviso,
esisteva la specializzazione professionale, sia forse – ed è questa l’ipotesi
più probabile – perché non speravano in alcun riconoscimento del loro ingegno, se si fossero attardati intorno a cose necessarie, sì, ma lontane dalla
possibilità di un certo esibizionismo: proprio come di un edificio si suole
osservare la parte alta, mentre le fondamenta restano nascoste. Personalmente, ritengo non esservi nozione alcuna, indispensabile alla formazione
di un oratore, che sia estranea all’arte oratoria, e che non si può giungere
alla formazione di qualche cosa, se non partendo dai suoi primi elementi;
ed è per questo che non mi rifiuterò di scendere fino ai semplici fondamenti della formazione retorica, i quali sono, tuttavia, premessa indispensabile
per le fasi più impegnative nel sèguito; e comincerò ad organizzare gli studi e le attività dell’oratore fin dalla sua infanzia, esattamente come se mi
venisse affidato perché lo allevassi.
È una impostazione che rivela l’atteggiamento ottimista di chi certo riconosce lo
stato decadente dell’oratoria contemporanea, ma al tempo stesso ritiene che possa esservi rimedio e che la soluzione consista in una riforma dell’educazione. Lo
storico Tacito, con maggiore penetrazione, individuerà le ragioni profonde della decadenza oratoria nella mancanza di libera espressione imposta dal regime imperiale: certo è che a Quintiliano interessa delineare maggiormente il ruolo culturale
dell’oratore piuttosto che la sua possibilità di affermazione sul campo politico.
La Knstitutio oratoria di Quintiliano
Dunque i primi tre libri sono dedicati alle definizioni generali di carattere retorico e
soprattutto alla prima formazione, grammaticale per il bambino e successivamente
retorica per il ragazzo di età maggiore. Sono pagine famose per l’acutezza dimostrata dall’autore in campo pedagogico, ad esempio quando raccomanda di prestare attenzione alle caratteristiche dell’indole di ogni fanciullo. Dal libro IV inizia la
trattazione tecnica delle parti tradizionali in cui si articola la retorica: fino al libro VI
si tratta dell’inventio, nel VII della dispositio, nell’VIII e nel IX dell’elocutio, e nell’XI
della memoria e dell’actio. Sono termini già presenti nella precedente trattatistica
retorica, dalla quale Quintiliano attinge aggiungendovi però una chiarezza didattica
di esposizione. Occorre subito sottolineare come l’auctor per eccellenza di Quintiliano sia Cicerone, per il quale tuttavia egli nutre un’ammirazione non passiva:
… spesso ho detto e dirò che Cicerone è oratore perfetto, così come chiamiamo generalmente gli amici e galantuomini e prudentissimi, mentre nessuna di queste qualità viene concessa, se non ai sapienti in assoluto. Ma,
quando bisognerà esprimersi con termini propri e secondo la legge stessa
della verità, cercherò quell’oratore che anche lui cercava. In sostanza, sebbene io confessi che egli è pervenuto al più alto fastigio dell’eloquenza e
non mi riesca quasi di trovare che cosa ancora gli si sarebbe potuto aggiungere, anche se potrei trovare, forse, che cosa a mio avviso gli si sarebbe ancora potuto togliere (effettivamente il giudizio degli studiosi, in generale, è
che siano in lui moltissime virtù e qualche difetto: del resto egli ammette
da sé di aver molto sfrondato dalla sua giovanile esuberanza): tuttavia, dal
momento che non si ascrisse il titolo di sapiente – ancorché fosse tutt’altro
che denigratore di se stesso – e che avrebbe potuto essere miglior oratore,
se almeno avesse avuto vita più lunga e maggiore tranquillità per comporre, potrei onestamente credere che gli sia mancata quella suprema perfezione, alla quale nessuno più di lui si avvicinò mai.
XII 1, 19, 3 ss.
La grande dote di Quintiliano appare proprio la moderazione, che gli consente di
evitare gli eccessi e di cogliere in ogni direzione le prospettive positive. Così egli si
distacca dalle esagerazioni sia dell’atticismo che dell’asianesimo, dalla moda dello
stile arcaico e dalla degenerazione delle declamazioni retoriche spettacolari. Non
gli piace nemmeno il filosofo Seneca (4 a.C. circa – 65 d.C.), con quel suo procedere a frasi spezzate e oscuri giochi di parole, ma ancora con equilibrio ne riconosce i pregi nel giudizio formulato nel libro X (p. 464).
Il libro X è noto per essere una sorta di «storia letteraria», composta allo scopo di
rendere visibile nei testi l’applicazione dei princìpi tecnici illustrati dai libri precedenti: si svolge la trattazione di autori greci e latini, poeti e oratori.
La prospettiva è diversa da quella ciceroniana che aveva affidato, nella cultura dell’oratore, una posizione preminente alla filosofia rispetto alla letteratura.
Il XII ed ultimo libro traccia un ritratto dell’oratore ideale, che trae dal modello ciceroniano la cultura enciclopedica e da quello catoniano la necessità di una solida
formazione morale:
Sia, dunque, l’oratore che andiamo formando e di cui dà la definizione Marco Catone, uomo onesto, esperto nell’eloquenza, ma soprattutto – come egli
pure ha posto in primo luogo ed è anche secondo la natura preferibile e più
importante – assolutamente onesto: e ciò non soltanto perché, se la capacità
nell’eloquenza fosse servita a dare armi alla malvagità, non ci sarebbe nulla
di più dannoso, per la vita pubblica e privata, dell’eloquenza, e noi stessi,
che abbiamo tentato di portare secondo le nostre possibilità personali un contributo allo sviluppo dell’eloquenza, avremmo fatto il peggiore servizio all’umanità, se forgiassimo queste armi per un predone e non per un soldato.
XII 1, 1 ss.
471
472
Retorica, erudizione, filosofia
I rapporti con il regime
La pedagogia
di Quintiliano
Il tentativo di riportare il modello ciceroniano nell’oratoria del I secolo d.C. rivela una
scarsa consapevolezza storica, in quanto Quintiliano non sembra rendersi conto che
l’eloquenza di Cicerone era frutto della passione politica dei suoi tempi e che, poiché
le condizioni politiche erano mutate, non era più proponibile, ma è allineato con il
programma culturale dei Flavi che perseguirono una politica di restaurazione morale
e politica. Quintiliano accettava il principato e per lui il sostegno al regime era fuori
discussione. «Comunque si giudichi il suo comportamento nei confronti di Domiziano, è certo che il compito da lui svolto e il compito da lui assegnato all’oratore, a proposito del quale insiste sulle doti morali, si pongono al servizio della res publica e
della società, non del principe in particolare. Pur segnando le debite differenze da
Tacito, va riconosciuto che anche lui cercava per l’intellettuale un grande compito
pubblico che non coincidesse né con la rivolta né con il servilismo» (A. La Penna).
Peculiarità dell’opera quintilianea è l’attenzione ai problemi didattici e pedagogici. Non
erano mancati spunti e riflessioni sporadiche che rivelavano sensibilità verso
l’insegnamento anche in opere di scrittori precedenti come Cicerone e Seneca (in hoc
aliquid gaudeo discere, ut doceam dice ad esempio il filosofo cordovano in Ep. 6, 4), ma
da parte di Quintiliano la preoccupazione di indicare a chi insegna comportamenti e suggerimenti tecnici è costante; egli traccia perciò l’intero percorso necessario alla formazione dell’oratore, accompagnato da una serie di indicazioni didattiche legate in modo organico e coerente. D’altronde egli crede fermamente alla determinante importanza dell’insegnamento nella formazione, tanto che ritiene che vi sia possibilità di miglioramento per
l’oratoria futura se vi sarà il contributo di docenti validi, moralmente ineccepibili.
Per Quintiliano, come si è ripetutamente detto, l’oratore deve raggiungere una formazione morale e culturale completa; per conseguire tale scopo è necessario che
il maestro lo segua fin dall’infanzia fornendogli non solo competenze tecniche, ma
anche un esempio morale che ne permetta un armonico sviluppo interiore.
In tal modo Quintiliano riporta nella sua opera la sua esperienza ventennale di docente attento e sensibile, dimostrando di conoscere le caratteristiche e le esigenze
dell’età infantile e di come i fanciulli vadano trattati per ottenere da loro i migliori risultati nell’apprendimento.
Alcune intuizioni pedagogiche sono ritenute ancora oggi valide, quali ad esempio
la necessità di alternare allo studio lo svago e la convinzione che non si debba ricorrere a punizioni fisiche, a quei tempi (ma anche fino all’età moderna) ricorrenti
nella scuola. Per questi aspetti la sua opera ha conosciuto una certa fortuna fin dal
Medioevo e Quintiliano è stato ritenuto un precursore della pedagogia moderna.
ALTO IMPERO
Lingua e stile
La lingua e lo stile di Quintiliano non possono non risentire della sua impostazione
teorica classicistica. Modello oratorio proclamato, come si è detto, è Cicerone, che
quindi è scelto anche come modello di scrittura per il suo stile armonioso e misurato, che evitava gli eccessi sia dell’atticismo sia dell’asianesimo.
Tuttavia la lingua, come la storia, conosce un’evoluzione a cui non ci si può sottrarre e fra i due scrittori non mancano le differenze.
Quintiliano presenta tratti caratteristici della sua età sia nelle scelte lessicali, sia
nella collocazione dei termini, sia nella sintassi (usa poco, ad esempio, il nesso relativo, di cui tanto spesso si era servito Cicerone), che nella sua opera ha una
struttura meno regolare e simmetrica di quella ciceroniana. Per conferire maggiore
piacevolezza e vivacità all’espressione del pensiero ricorre inoltre spesso a iperba-
La Knstitutio oratoria di Quintiliano
ti, a similitudini e metafore, peculiari della locuzione poetica (si ricordi che i tratti
della lingua della prosa e di quella della poesia in età postclassica si avvicinano);
non mancano inoltre quelle sententiae caratteristiche dello stile «moderno», il cui
uso eccessivo egli aveva condannato in Seneca e nei suoi imitatori, ma che evidentemente erano entrate nella prassi dello scrivere del tempo, al cui gusto rispondevano. Il suo modo di scrivere risulta dunque «ornato», anche se in misura equilibrata, e chiaro, come si addiceva ad un trattato di tipo didascalico.
La fortuna
Quintiliane, vagae moderator summe iuventae, / gloria Romana, Quintiliane, togae
(«Quintiliano, sommo maestro della volubile gioventù, gloria del foro di Roma»); così Marziale si rivolge idealmente a Quintiliano in un suo epigramma (II 90, 2), testimoniandone in tal modo la fama che aveva presso i suoi contemporanei come
maestro e come retore. Furono suoi allievi, oltre i nipoti di Domiziano, Plinio il Giovane che, in un’epistola in cui tratta del decadimento dell’eloquenza giudiziaria (II
14, 9), lo chiama praeceptor meus, e forse anche Tacito.
Anche se Quintiliano non raggiunse il suo obiettivo di imporre il modello stilistico ciceroniano in cui credeva, e la sua opera «legata com’era alle esigenze di una precisa contingenza storica, determinata dalla volontà restauratrice dei Flavi, non conobbe grande fortuna presso le età successive della letteratura latina» (Salemme),
tuttavia il suo magistero ebbe, nei secoli, grande autorità. A testimonianza di ciò, le
parole di grande considerazione di poeti e scrittori posteriori: ad esempio Ausonio,
autore del IV secolo, più volte nelle sue opere ne ricorda la indiscussa fama; Girolamo, in una lettera a Leta (Ep. 107) in una parte dedicata a consigli sull’educazione della figlioletta Paola, destinata alla vita monastica, ne accoglie i principi educativi, dimostrando in tal modo che l’opera quintilianea era divenuta punto di riferimento nel campo pedagogico e didattico.
Il gran numero di manoscritti medioevali delle Declamationes testimonia che la loro
fortuna, e quindi quella di Quintiliano che ne era ritenuto l’autore, continuava anche
in quel periodo.
Ma è soprattutto nel Rinascimento che l’Institutio oratoria, che autori medioevali
avevano già conosciuto (anche se non completamente) e utilizzato, venne apprezzata; e ciò in seguito alla scoperta da parte di Poggio Bracciolini di due codici che
riportavano il testo integrale dell’opera. L’interesse riscosso fra gli studiosi del tempo fu notevole e furono scritti studi e stilati commenti all’opera quintilianea da noti
umanisti quali ad esempio Lorenzo Valla e Angelo Poliziano.
Grande continuò ad essere la fortuna di Quintiliano nella cultura europea, che dalla sua opera trasse spunti di riflessione in ambito retorico-letterario e soprattutto in
quello educativo e didattico, venendogli riconosciuta una sorta di paternità della
pedagogia. Nell’Ottocento, che pure non ne accettò le regole stilistiche, ne espresse un giudizio altamente lusinghiero il Mommsen.
Dopo un’attenzione lungamente e prevalentemente volta agli aspetti pedagogici dell’opera quintilianea, negli studi contemporanei si torna a studiarne maggiormente
l’aspetto retorico. Ciò fors’anche per un recupero della retorica non più vista come «sinonimo d’artificio, d’insincerità, di decadenza», ma come «sistema di leggi convenzionali» a cui l’artista antico si atteneva nella creazione dell’opera letteraria «senza che
ne venisse a soffrire la sua sincerità» (Marrou); si ritiene inoltre che la sua conoscenza
possa rivestire anche oggi una notevole importanza come tecnica della persuasione.
Quintiliano
e i contemporanei
Gli scrittori tardo-antichi
Il Medioevo
e il Rinascimento
Dal Seicento
ai tempi nostri
473
474
Retorica, erudizione, filosofia
Il Dialogus de oratoribus
L’eloquenza nasce
dal disordine sociale
ALTO IMPERO
La tesi di Materno
Altre tesi
Un’analisi storicamente penetrante sulle cause politiche della decadenza oratoria
è presentata dal Dialogus de oratoribus («Dialogo sugli oratori»): opera controversa quanto ad attribuzione e datazione, è quasi concordemente assegnata a Tacito
(55/60-117 d.C. circa) e agli anni intorno al 100 d.C. Il dialogo è di stile ciceroniano e ricorda infatti l’impostazione del De oratore, salvo poi non concordare con Cicerone riguardo ad un punto fondamentale: mentre per l’oratore del I secolo a.C. il
dispiegarsi della grande eloquenza è legato ad una condizione di pace, per
l’autore del Dialogus l’oratoria repubblicana fu il frutto del turbolento clima delle
guerre civili e conseguentemente la pax imperiale comporta un affievolirsi della
stessa oratoria.
Se prima dell’avvento dell’impero i discorsi furono lo strumento dell’affermazione
politica, si legarono tuttavia alle ambizioni aristocratiche di potere, mentre la presenza attuale dell’imperatore, garante dell’assenza di conflitti, confina lo strumento oratorio ad un ruolo di secondo piano. «La scomparsa dei grandi processi
politici è anche segno della scomparsa dei mali da cui essi traevano origine. La
grande oratoria era radicata nel disordine sociale e istituzionale; la sua crisi è
sintomo di una ritrovata salute sociale, e del buon funzionamento delle istituzioni»1. Nell’oggettività delle considerazioni presentate dall’autore del Dialogus pare
tuttavia di scorgere il tono disilluso di chi in fondo comprende che la pace imperiale viene a corrispondere con l’assenza di dibattito, con l’impossibilità di esprimere la propria opinione e insomma con la mancanza di libertà. Tacito aveva abbandonato l’attività forense, deluso dal clima di violenza che nei tribunali si andava diffondendo soprattutto a causa dei delatori, e aveva scelto di dedicarsi alla
storiografia, alla redazione di opere di carattere storico. Del suo interesse e della
sua competenza retorica si ha prova attraverso i discorsi rappresentati nell’opera
storica intitolata Annales.
Non a caso il portavoce delle idee di Tacito nel Dialogus appare Curiazio Materno,
il personaggio che, davanti alla decadenza dell’oratoria contemporanea, sceglie
una strada alternativa: in questo caso non la storiografia ma la poesia, attraverso le
cui immagini esprimere liberamente il proprio pensiero nel clima sorvegliato della
corte imperiale. E la poesia preferisce un’ambientazione campestre, lontana dalla
confusione cittadina della corte e del foro. Emerge qui rinnovata la concezione del
sofista greco Gorgia, secondo la quale oratoria e poesia sarebbero di uguale natura e solo le differenzierebbe la presenza del metro, del ritmo. L’autore del Dialogus
specifica che oratoria e poesia hanno un diverso fine, poiché l’oratoria mira ad essere utile e la poesia a dilettare.
Oltre a Curiazio Materno vi sono nel Dialogus altri interlocutori, impegnati a
discutere sulla superiorità dell’oratoria antica o di quella moderna. Marco Apro
afferma che non si possa nemmeno parlare di decadenza dell’oratoria contemporanea, ma solo di un cambiamento di gusto: gli oratori della generazione precedente non sono più attuali, con le loro lungaggini, se confrontati con le moderne tendenze dello stile, che deve essere breve e incisivo. Vipstano Messalla al
contrario sostiene decisamente la preminenza antica e attribuisce la decadenza
contemporanea alla formazione scolastica, che non avviene più presso un orato1. E. Narducci, Oratoria e retorica, in «La prosa latina», Roma 1991, p. 98.
Il Dialogus de oratoribus
re affermato e nel mezzo della reale vita del tribunale ma attraverso le declamazioni fittizie. A questa considerazione bene si legano le conclusive e vivaci immagini del Dialogo:
Quanta forza non dobbiamo pensare che abbiano tolto ai discorsi questi
ambienti di scuola e d’archivio, in cui si trattano quasi tutte le cause? A
quel modo che le corse su spazi aperti fanno riconoscere i cavalli di razza, così è necessario agli oratori un campo tale, che il loro talento vi si
possa muovere libero e sciolto; altrimenti l’eloquenza si affloscia e svanisce. E l’esperienza ci insegna che riesce contraria all’effetto anche la
cura stessa e la meticolosità nel preparare il modo dell’espressione: perché spesso il giudice ti interroga nel momento in cui tu stai per abbordare la trattazione, e allora devi incominciare dalla sua interrogazione: non
di rado poi egli ti fa tacere per dar luogo ad argomenti di prova e a testimoni, e in questo frattempo uno o due stanno ad ascoltare, e la causa si
svolge, per così dire, nel deserto. Ora invece l’oratore ha bisogno di acclamazioni e di plauso e quasi di una specie di teatro; il che toccava ogni
giorno agli oratori antichi, quando un uditorio tanto numeroso quanto
scelto affollava il foro, quando stuoli di clienti e tribù e deputazioni di
municipi e una parte dell’Italia presenziavano ai giudizi; quando il popolo romano si riteneva direttamente interessato all’esito della maggior parte dei processi.
39, 1, 4 ss.;
trad. di A. Arici
Fanciullo che declama di fronte
al maestro.
475
476
Retorica, erudizione, filosofia
Il Panegyricus Traiano imperatori di Plinio il Giovane
Allievo di Quintiliano, nonché amico e ammiratore di Tacito, fu Plinio il Giovane (vedi p. 495) il quale esercitò l’oratoria forense sia in cause civili di ordinaria amministrazione (riguardanti per lo più testamenti ed eredità), sia più raramente in processi di carattere politico. Lo stile delle orazioni di Plinio è assai ridondante, lontano
dai modelli di Cicerone e Demostene raccomandati dal maestro Quintiliano. O meglio, egli riprende di Cicerone la copia, l’abbondanza di parole, ma cerca di adattarla al gusto contemporaneo con abbellimenti di stile. Così Plinio stesso in una lettera descrive vivacemente le condizioni di una propria performance oratoria:
Epistole IV 16, 1, 2 ss.;
trad. di F. Trisoglio
Ultimamente, dovendo pronunciare un’arringa davanti ai centumviri, non
ebbi modo di arrivare al mio posto se non passando dalla parte del palco,
addirittura attraverso al collegio dei giudici, tanto grande era la ressa che
ostruiva tutto lo spazio rimanente. Inoltre un giovane particolarmente ben
messo, dopo che ebbe gli abiti lacerati, come suole avvenire nella calca, rimase là, con soltanto la toga indosso, e per ben sette ore; infatti tale fu la
durata della mia orazione, che mi costò molta fatica ma che ottenne un risultato ancora superiore.
Durante il più famoso dei processi politici a cui partecipò, Plinio fu a fianco di Tacito
nell’accusare per abuso di potere Mario Prisco, che era stato governatore d’Africa.
Mentre Tacito si era poi allontanato dall’ambiente forense – per disgusto nei confronti
dei procedimenti ormai sanguinari, innescati per esempio dai delatori –, Plinio, da uomo di mondo qual era, dimostrò al proposito minori preoccupazioni. Arrivò a dichiarare
di preferire comunque, per il suo carattere politicamente incontaminato, l’oratoria di
scuola che si esprimeva nelle declamazioni: queste, come si è ricordato, erano state
condannate da Petronio e invece accettate da Quintiliano solo perché ormai divenute
d’uso comune. Plinio, dopo avere pronunciato effettivamente in tribunale le proprie orazioni, le rielaborò a tal punto da trasformare lo schema iniziale in un nuovo discorso da
declamare davanti a un pubblico di amici. L’orazione giudiziaria diviene quindi occasione di intrattenimento, prima di raggiungere l’ultima definitiva fase scritta, ulteriormente
modificata sulla base anche dei consigli e delle critiche ricevuti dall’uditorio. Nell’epistola VII 9 Plinio indirizza ad un amico, aspirante oratore, alcuni precetti formativi:
ALTO IMPERO
ibidem, VII 9, 2 ss.
Come prima cosa è utile seguire la norma su cui tanti insistono, di tradurre
dal greco in latino o dal latino in greco. Questo tipo di esercizi fornisce una
terminologia precisa e colorita, larga disponibilità di figure stilistiche, capacità di enunciare agevolmente i concetti e inoltre, con l’imitazione dei
classici migliori, una fertilità d’inventiva che raggiunga effetti analoghi ai
loro. Nello stesso tempo, quelle finezze che fossero sfuggite durante la lettura non potrebbero certo rimanere inavvertite durante la traduzione. In
questa maniera si acquista forza di penetrazione e sicurezza di valutazione.
Sarà tutt’altro che dannoso leggere un passo in modo da ricordarne solo
l’argomento e la trama e poi stenderlo in una specie di gara con l’originale;
quindi paragonare la propria redazione con quello che si è letto e valutare
con diligente impegno che cosa sia riuscito più felicemente a te e che cosa
invece a lui.
Il panegirico
Plinio, quando nel 100 d.C. fu nominato console, volle ringraziare Traiano, che
l’aveva raccomandato per quella carica, con un’orazione in seguito rielaborata per
la pubblicazione e giunta a noi col titolo di Panegyricus Traiano imperatori dictus.
Il Ranegyricus Traiano imperatori di Plinio il Giovane
Si tratta dell’entusiastica celebrazione delle eccelse virtù pubbliche e private dell’imperatore (liberalità, moderazione, modestia, affabilità, austerità, rispetto per il
Senato) contrapposte sistematicamente ai vizi del predecessore, il despota e pessimus princeps Domiziano: «Non occorre adularlo come un dio e come un nume.
Infatti non stiamo parlando di un tiranno ma di un cittadino, non di un padrone ma
di un padre» (2, 3). Il panegirico segna l’avvento della felicitas temporum, del ritorno alla pace sociale e alla concordia. È il manifesto dell’ideologia traianea, che recuperava accanto a motivi augustei alcuni temi della tradizione repubblicana cari
all’aristocrazia: l’austerità e la frugalità dei prisci Romani, l’invito alla concordia ordinum, il rifiuto a ricevere onori divini e la riluttanza a fregiarsi del titolo di pater patriae, il rispetto per il Senato. Traiano incarna il modello del perfetto regnante, il suo
comportamento indicherà ai futuri imperatori «la via più spedita per accedere alla
medesima gloria» (III 18, 2).
In realtà il Panegirico è l’elogio della monarchia assoluta, nella quale la libertà è
solo un dono paternalisticamente elargito dall’optimus princeps, anzi paradossalmente un ordine: «Senza paura e con passione ti seguiamo dove ci chiami. Ci comandi d’essere liberi: lo saremo. Ci comandi di esprimere pubblicamente il nostro
pensiero: lo esprimeremo» (66, 3). Di fatto, la politica filosenatoria di Traiano, che a
sentire Plinio avrebbe restituito ai senatori le dovute dignitas e securitas («Ora imperatore e Senato approvano e disapprovano gli stessi provvedimenti», 62, 5) consisteva solo in un ossequio formale, in una maggiore attenzione che l’imperatore riservava alle procedure tradizionali, all’etichetta, ai privilegi di casta di un’aristocrazia di cui egli stesso faceva parte. D’altronde lo stesso Plinio che, pur talora pare rivendichi ingenuamente una funzione pedagogica nei confronti di Traiano e che in
effetti era uomo vicino al cuore dell’imperatore, «non è ... un consigliere a pieno titolo del principe, ma ... un funzionario subalterno, un portavoce che possiede gli
strumenti tecnici per trasmettere (e imporre) all’uditorio tradizionale (ma soprattutto
al Senato) le decisioni e i mandata dell’imperatore» (G.F. Gianotti). E l’incipit della
lettera famosa, scritta all’imperatore per avere lumi su come districarsi nei processi
contro i Cristiani («È mia usanza, signore, rimettere a te tutte le questioni su cui ho
dei dubbi. Chi meglio infatti potrebbe guidare la mia esitazione o colmare la mia
ignoranza?», X 96) potrebbe davvero essere assunta «come didascalia generale
dell’atteggiamento dell’autore nei confronti del principe» (Gianotti).
Il clima di cortigianeria che s’accompagnava alla perdita di libertà favoriva la diffusione del panegirico come genere. Si trattava, nell’antica oratoria greca, di un
discorso ufficiale tenuto in occasione di una festa panellenica (panégyris, ad esempio i giochi olimpici), per lodare la festa stessa o la città in cui si svolgeva. A Roma
questa forma celebrativa si riallacciava da un lato alle parti elogiative dei carmina
triumphalia, dall’altro alla letteratura delle laudationes funebres e degli illustrium virorum exitus: un genere, quest’ultimo, reso attuale ai tempi di Plinio dai frequenti
elogi delle vittime della tirannide imperiale, da Nerone a Domiziano, e per nulla
ostacolato dalla monarchia illuminata di Traiano, durante la quale fu anzi pubblicato
quel monumento della cultura senatoria che sono le opere storiche di Tacito.
Del panegirico imperiale la laudatio pliniana costituì il modello nei tempi seguenti,
fissando i tratti distintivi del genere: ricorso obbligato all’amplificatio per enfatizzare
le virtù del celebrato, e alla comparatio per sottolinearne, mediante il confronto con
i predecessori, la superiorità; definizione dello schema retorico, che prevedeva prima l’elogio delle res externae (natali, formazione culturale, imprese) poi delle res
Un manifesto
dell’ideologia di Traiano
L’ossequio formale verso
il Senato
Un tipo di eloquenza
adatto ai tempi
477
478
Retorica, erudizione, filosofia
corporis (qualità fisiche) e infine delle virtutes obbligatorie del principe ideale (clementia, pietas, humanitas, fortitudo, ecc.). Lo stile dell’elogio pliniano è, naturalmente, formale e magniloquente, gonfio d’enfasi e soffocato nelle volute dell’amplificazione retorica, incline nonostante l’intenzione ciceroniana ai vizi dello stile «moderno» (concettosità, ricerca di sentenze pregnanti e inattese). L’opzione è, insomma, quella dell’oratio lata et magnifica dell’asianesimo baroccheggiante, densa di
artifizi, di figure, di topoi.
ALTO IMPERO
Colonna Traiana, Roma.
Traiano e l’amico Sura. Particolare della Colonna Traiana.
Arcaismo e Neosofistica in Frontone
Il tramonto dell’eloquenza latina
Sotto gli imperatori antonini continua il successo dei retori e delle declamazioni
spettacolari. Non a caso, dell’intera opera De viris illustribus di Svetonio dedicata ai
letterati (vedi p. 449) ci è pervenuta solo la sezione De grammaticis et rhetoribus.
Stilisticamente dilaga – in parallelo alla scuola dei poetae novelli in poesia (vedi p.
538) – la tendenza arcaista, con il recupero degli autori latini antichi come Catone,
Ennio, Plauto, dei quali si apprezza, più che la forza espressiva, la possibilità che
essi offrono allo scrittore e all’oratore di attingere vocaboli inusuali, da combinare
per effetti vistosi di stile. L’interesse per la latinità arcaica non è confinato alla sola
letteratura, ma riguarda ogni testimonianza, dalle iscrizioni alle leggi più antiche.
Tale orientamento del gusto non determinò un movimento originale (a parte Apuleio, da considerarsi come un caso a parte), ma si tradusse in sterile imitazione
erudita.
L’arcaismo latino corrisponde a un’analoga tendenza al purismo riscontrabile in
ambito greco, dove i retori neosofisti rifiutano l’evoluzione del greco ellenistico e
predicano il ritorno ai modelli della prosa attica, Senofonte e Lisia. Tuttavia il parallelismo tra Neosofistica e Neoatticismo da una parte e arcaismo latino dall’altra è
solo parziale: mentre i neosofisti greci sono interessati a dare una patina filosofica
e politica alla loro retorica, gli arcaisti latini riservano un’attenzione pressocché
esclusiva alla purezza della lingua. Il prestigio culturale di questi due orientamenti
del gusto sembra culminare, emblematicamente, nell’anno 143 d.C., che vede associati nel consolato Frontone ed Erode Attico, rispettivamente massimo esponente dell’arcaismo latino e insigne maestro della neosofistica, entrambi prescelti da
Antonino Pio come educatori dei principi Marco Aurelio e Lucio Vero.
Arcaismo e Neosofistica
Arcaismo e Neosofistica in Frontone
Principale esponente dell’arcaismo latino è Frontone (100 circa - 166 circa d.C.),
nativo di Cirta in Numidia, celebre oratore a Roma sotto Adriano, nominato consul
suffectus da Antonino Pio (143 d.C.) che gli affidò anche l’educazione dei figli adottivi Marco Annio Vero (il futuro Marco Aurelio) e Lucio Vero. Il suo grande prestigio
intellettuale è confermato da Gellio:
Da giovane, prima di passare ad Atene, stavo a Roma, e quando avevo il
tempo libero dalle lezioni dei miei maestri, mi recavo a far visita a Cornelio Frontone, godendo del suo conversare purissimo e pieno di sana erudizione. Non capitò mai una volta che andassimo a vederlo e ascoltarlo senza
tornarcene in qualche modo arricchiti di cultura e di sapere.
Noct. Att. XIX 8, 1
Morì probabilmente dopo il 170.
Le opere pervenuteci furono scoperte nel 1815 dal cardinale Angelo Mai in un palinsesto
(cioè riscritto) del monastero di Bobbio. Prima di quella data, Frontone era noto solo come
uno degli interlocutori delle Noctes Atticae di Gellio (vedi p. 483).
Il corpus frontoniano comprende lettere a Marco Aurelio, Lucio Vero e altri personaggi; gli
scherzi neosofistici Laus fumi et pulveris e Laus neglegentiae; il De bello Parthico sulla
campagna di Lucio Vero contro i Parti e i Principia historiae, esposizione dei criteri storiografici in base ai quali Lucio Vero avrebbe dovuto rielaborare i diari della spedizione; lo
scritto consolatorio De nepote amisso; il De feriis Alsiensibus, dove si consiglia a Marco
Aurelio di godersi una vacanza sulla spiaggia di Alsio (ora Ladispoli); l’Arion, sulla favola di
Le opere
479
480
Retorica, erudizione, filosofia
Arione salvato dal delfino. Ad eccezione dell’Arion, tutto è in forma di epistola. Qualche lettera è scritta in greco. Restano solo frammenti delle opere oratorie che resero celebre
Frontone, la più famosa delle quali, ricordata da Minucio Felice nell’Octavius, era contro i
cristiani.
La teoria retorica
L’elocutio principis
Il corpus di Frontone – che dal punto di vista del genere epistolare trattiamo a p.
501 – è di notevole interesse per delineare la sua teoria retorica, in base alla quale
l’eloquenza del principe, che al pari della tromba militare guida i sudditi, deve possedere i mezzi retorico-linguistici adeguati a persuadere:
Epistole III 1, 1 ss.;
trad. di F. Portalupi
… quando dovesti parlare in senato o nell’assemblea del popolo, non usasti nessun vocabolo un po’ insolito, nessuna figura astrusa o inconsueta,
poiché tu sai che l’eloquenza di un Cesare deve somigliare alla tromba,
non al flauto, che ha un suono minore e presenta maggiore difficoltà.
ALTO IMPERO
L’elocutio novella
La «questione
della lingua»
Frontone distingue un’elocutio principis da un’elocutio novella. La prima è
l’eloquenza dell’imperatore, che si può paragonare al segnale di battaglia della tromba, per la sua caratteristica di essere immediatamente riconoscibile e comprensibile,
automaticamente comunicativa. Essa deve risultare chiara e servirsi di parole comuni e di uno stile semplice, perché svolge un ruolo di esortazione o di ammonimento
nei confronti del senato e del popolo. «Vi è dunque uno stile d’eloquenza
(l’eloquenza dell’imperatore) che formalizza la comunicazione persuasiva, coercitiva,
direttiva del sommo potere con i sudditi; è noto che una monarchia assoluta (e tale
era nella sostanza anche l’impero dei cosiddetti optimi principes del II secolo d.C.)
tende a livellare tutti i sudditi: quindi l’eloquenza dell’imperatore si rivolge egualmente al senato come alle assemblee del popolo e dell’esercito» (A. Pennacini).
Al contrario, l’elocutio novella – che costituisce il vero centro del pensiero retorico
di Frontone – si rivolge a un circolo ristretto di dotti, incluso l’imperatore quando sia
libero da incombenze di governo e la sua oratoria non abbia finalità operative e politiche. Si caratterizza per una minore chiarezza e potenza, ma sa meglio esprimere sentimenti ed emozioni, è più simile al suono vellutato del flauto che a quello imperioso della tromba. Si tratta di una oratoria patetica, che mira a colmare lo iato
tra le esigenze espressive personali e le possibilità della lingua d’uso, insufficiente
a rendere certe sfumature del reale. Si tratta di una oratoria creativa, che tenta le
vie della sperimentazione poetica e dell’innovazione linguistica (fictio novorum verborum) attingendo lessico e modelli espressivi dagli autori arcaici come Catone,
Ennio, Nevio o dagli imitatori di questi, come Sallustio e Lucrezio. Da questi scrittori, piuttosto che dai classici ormai troppo noti, si devono cogliere gli inopinata atque
insperata verba, cioè le espressioni e parole che – in quanto giungono inattese e
sono dotate di una purezza originaria – sono in grado di rinnovare l’espressione e
corrispondere alle esigenze non soddisfatte dalla lingua d’uso (sermo volgatus).
Ciò implica, per il retore e lo scrittore moderni, un’estenuante ricerca che consiste
nella schedatura del lessico arcaico, naturalmente ricco di quei termini imprevisti e
curiosi «che si scoprono soltanto a prezzo di studio, cura, veglie e larga memoria
della poesia antica».
L’arcaismo frontoniano è una risposta alla «questione della lingua», quale si poneva nel momento in cui la «purezza originaria» era compromessa dal fatto che il latino era usato da popoli di lingua madre diversa. Il purismo di Frontone è, come
ogni forma di purismo, una risposta in termini di protezionismo linguistico. Il model-
Arcaismo e Neosofistica in Frontone
lo di Latinitas a cui attenersi è quello tradizionale, disponibile all’innovazione purché questa avvenga nel rispetto delle strutture linguistiche originarie. A queste condizioni è ammesso anche il neologismo, purché ottenuto ricalcando le regole di formazione della parola latina: solo così non sembrerà una moneta falsa (aes adulterinum). «È significativo che come punto di riferimento s’identifichi il periodo arcaico,
precedente al processo di integrazione politica degli Italici e alla fondazione dell’impero su scala extranazionale» (G. Giannotti).
Lo stile
Lo stile di Frontone si conforma ai principi, enunciati nella lettera Ad Marcum Caesarem, sui quali si fonda l’elocutio novella, che sono latinitas, elegantia, diligentia.
Della latinitas già s’è detto. L’eleganza dell’eloquio è ricercata attraverso il dispiego
di mezzi retorici: parallelismi, antitesi, metafore, similitudini, ricerca di effetti sonori,
giochi di suono e di senso. Il virtuosismo retorico, che tocca l’apice negli elogi paradossali del fumo e della negligenza, degenera in una leziosaggine che, quand’anche sia eccessivo considerare come specchio di una «società affetta da un forma
collettiva di rimbambimento» (Perelli), risulta disturbante. Al tono sdolcinato, cerimonioso, stucchevole concorrono i complimenti affettati, i diminutivi in funzione
vezzeggiativa come nella poesia «leggera» dei Novelli, le espressioni retoricamente sproporzionate come le attestazioni di grave sollecitudine per un raffreddore del
destinatario. C’è l’ostentazione di sentimenti delicati e teneri, c’è il bamboleggiare
in futili giochetti verbali, come fata-fari mentre si accenna alla morte dei figli: singolare disponibilità al divertissement linguistico in un padre di sei figlie, delle quali,
come apprendiamo dall’epistolario, cinque morte bambine.
Il culto della parola è assoluto in Frontone e rasenta il fanatismo, la retorica per lui
non è più funzionale, come era sempre stata nei poeti e prosatori, all’espressione
di concetti, opinioni, sentimenti, ma è fine a se stessa. Convinto com’è della superiorità dell’eloquenza su ogni altra attività, neppure ammette che si possa avere interesse per la filosofia, come scrive a Marco Aurelio:
Virtuosismo e leziosità
Mi sembra che tu, come fanno i giovani, stanco e annoiato per la fatica, abbia abbandonato lo studio dell’eloquenza e ti sia rivolto alla filosofia, un
campo in cui non ci sono proemi da rifinire con cura, né narrazioni da
svolgere concisamente e chiaramente e da collocare con accortezza, né temi generali da suddividere in parti, non ci sono prove da cercare, non vi è
nulla da amplificare.
Epistole, p. 148,
Van den Hout
In realtà l’imperiale discepolo non abbandonò mai la retorica, tuttavia scrisse in
greco i suoi Pensieri, forse per insofferenza verso una concezione così assillante
dello strumento linguistico, quale fin da ragazzo gli era stata instillata dal maestro.
Il terzo principio su cui si fonda l’elocutio novella è la diligentia, che concerne soprattutto la scelta dei vocaboli (dilectus verborum):
Soprattutto mi fa piacere che tu non afferri le parole che da sole ti si presentano, ma cerchi quelle migliori. Infatti in questo il sommo oratore si
differenzia da quelli mediocri, nel fatto che gli altri sono pronti ad accontentarsi delle parole che possono andar bene, mentre il sommo oratore non
si accontenta di quelle che vanno bene, se possono essercene di migliori.
Di ogni parola, è scritto nell’epistola de eloquentia (2, 1), vanno sempre valutati
questi aspetti: loca, gradus, pondera, aetates dignitatesque «posizione, ordine, peso, antichità e rango».
La retorica fine a se stessa
Scelta e collocazione
delle parole
Epistole, p. 92,
Van den Hout
481
482
Retorica, erudizione, filosofia
L’opportuna conlocatio verborum è esemplificata sul passo sallustiano in cui è detto di Catilina che «aveva dilapidato i beni paterni manu, ventre, pene», cioè nel gioco, nei banchetti, nei bordelli. Il terzo vocabolo disturberebbe se fosse posto in prima sede, mentre attenua la sua crudezza se è dislocato alla fine della serie omosillabica:
Epistole, p. 147,
Van den Hout
L’effetto ottenuto dalla somiglianza della forma delle parole fa sì che
l’ultima parola, per quanto sia oscena, non risulti sconveniente. Questo,
perché è preceduta da due parole simili. Ma se avesse scritto: pene bona
patria laceraverat sarebbe apparsa subito l’oscenità del vocabolo.
Né Cicerone, né Seneca
L’arcaismo frontoniano è equidistante dal ciceronianesimo di Quintiliano e dalla
teatralità dello stile «moderno» di Seneca. Il retore africano rimprovera a Cicerone
d’essersi tenuto «lontano dalla scelta minuziosa dei vocaboli». Di Seneca invece
critica l’eloquenza spettacolare e ne giudica lo stile, ricco di argute sententiae, ricorrendo a una similitudine. In un banchetto, uno si porta le olive alla bocca e le
mastica coi denti; un altro le getta per aria e le acchiappa in bocca al volo, come fa
il prestigiatore con le palline. Certo, i convitati si divertono di più a guardare il secondo, ma «mentre il primo avrà pranzato decentemente, il secondo avrà solo eseguito una pantomima con le labbra». Seneca, funambolo della parola e capace di
prodursi in virtuosismi che compromettono la limpidezza, è simile a quest’ultimo.
Il neologismo. Il breve passo chiarisce la ragion d’essere dell’elocutio novella, nata per soddisfare le esigenze espressive di chi vuole comunicare sentimenti intensi e complessi o descrivere certe sfumature del reale, ma non trova nella
lingua d’uso gli strumenti adeguati. Di qui la necessità di ricorrere all’innovazione linguistica (fictio novorum verborum).
Domino meo
[1] Quod poetis concessum est o¬nomatopoieîn,
verba nova fingere, quo facilius quod sentiunt
exprimant, id mihi necessarium est ad gaudium
meum expromendum, nam solitis et usitatis
verbis non sum contentus, sed laetius gaudeo
quam ut sermone volgato significare laetitiam
animi mei possim: tot mihi a te in tam paucis
diebus epistulas scriptas easque tam eleganter,
tam amice, tam blande, tam effuse, tam flagranter conpositas, cum iam tot negotiis quot
officiis, quot rescribendis per provincias litteris
distringere.
3, 14
Al mio signore
[1] Il neologismo concesso ai poeti, cioè il
creare parole nuove, per estrinsecare con più
facilità i propri sentimenti, è necessario a me
per esprimere la mia gioia. In effetti le parole
usate comunemente non mi appagano; ma la
mia esultanza è troppo viva perché io possa
manifestare col linguaggio comune la felicità
del mio amico: che tu mi abbia scritto in così
pochi giorni tante lettere composte con tale eleganza e affetto, con tale dolce e ardente trasporto, quando appunto sei occupato da tanti
affari, da tanti compiti, dal dovere di rispondere a tante lettere nelle varie province.
ALTO IMPERO
(trad. di F. Portalupi)
Le Noctes Atticae di Aulo Gellio
Le Noctes Atticae di Aulo Gellio
Di Aulo Gellio (130 ca. - 180 ca. d.C.), forse africano, sappiamo solo ciò che lui stesso racconta di sé. Erudito e soprattutto appassionato di cultura, studiò a Roma sotto
maestri famosi come il grammatico Sulpicio Apollinare e il retore Antonio Giuliano.
Frequentò le maggiori personalità intellettuali del tempo, il celebre retore neosofista
Favorino e soprattutto Frontone, col quale condivise l’indirizzo culturale arcaistico.
Compì il viaggio d’istruzione canonico in Grecia, dove completò gli studi di filosofia.
Qui conobbe Erode Attico, che lo ospitò nella sua villa. Visse in seguito a Roma,
nei luoghi citati nella sua opera, Ostia, Tivoli, Preneste.
È autore di una monumentale raccolta di citazioni (in venti libri quasi completamente conservati, manca l’ottavo) desunte dalla lettura diretta di testi, soprattutto d’età
repubblicana. L’opera si immagina iniziata nelle sere d’inverno in una villa dell’Attica, e perciò è intitolata Noctes Atticae:
Poiché abbiamo cominciato a redigere questi capitoli, quasi per divertimento, nelle lunghe notti invernali trascorse, come dicevo, nel territorio
della regione attica, così li abbiamo intitolati Notti attiche.
Praef. 4
Il modello è quello della «miscellanea» (un genere noto anche coi titoli silvae o pratum), cioè di una raccolta di materiali eterogenei, volutamente priva di sistematicità, come precisa l’autore: nos usi sumus ordine rerum fortuito, «nella disposizione
degli argomenti ho adottato il criterio della casualità» (Praef. 2). In effetti gli argomenti si susseguono senza un ordine logico, presentati mano a mano che venivano raccolti (indistincte atque promisce annotabam «prendevo nota così come veniva, alla rinfusa», ibid.). Si passa dai venti ai poeti comici, dal genitivo partitivo alla
storia del figlio muto di Creso. I soggetti trattati sono i più svariati: etimologicogrammaticali e di semantica (ad esempio, differenze espressive dei sinonimi), letterari, filosofici, storico-giuridici, religiosi, concernenti la scienza, l’astronomia e la
medicina, perfino gastronomici. Tuttavia, pur nella varietà caleidoscopica,
l’interesse prevalente è per le discipline linguistiche e grammaticali, per i problemi
di critica testuale, cronologia, attribuzione.
Le Noctes riflettono l’aspirazione enciclopedica ad abbracciare ogni branca del sapere. Forse una suggestione derivava dalla Pantodapé historia («Questioni di ogni
genere») di Favorino, che aveva l’identica presunzione di trattare tutti gli argomenti.
Il carattere enciclopedico è confermato dagli indici redatti dall’autore, per agevolare
la fruizione dell’opera, evidentemente destinata, più che alla lettura integrale, alla
consultazione in rapporto a specifici interessi del lettore.
L’intento, espresso nella prefazione, era di costruire quasi quoddam litterarum penus, «quasi una dispensa di cibi culturali» (Praef. 2), «in modo da condurre gli ingegni ben disposti e alacri, per un sentiero svelto e facile, al desiderio di una scienza onorevole e alla cognizione delle arti utili» (Praef. 12). Il genere era, insomma,
quello di un’opera di «alta divulgazione» (Pennacini) destinata a un pubblico medio-alto, desideroso di svagarsi istruendosi. Per la configurazione sociologica di
questo pubblico «borghese», si veda quanto abbiamo scritto a p. 514 a proposito
dei ceti emergenti in età flavia.
Alla frammentarietà si lega il gusto per il particolare, per l’aneddoto «sfizioso», per
la curiosità erudita, sottile, spesso oziosa. Ai maggiori intellettuali del tempo – Frontone, esponenti insigni della Nuova Sofistica, grammatici e giuristi famosi – riuniti
nelle cene dei Saturnali, nell’atmosfera rarefatta delle gelide notti ateniesi, il padro-
Asistematicità e varietà
Il carattere enciclopedico
L’erudizione
483
484
Retorica, erudizione, filosofia
Il conservatorismo
culturale
Il valore dell’opera
ne di casa poneva questioni – ma c’è chi ha parlato di quiz – come quella grammaticale esemplificata nel brano che riportiamo sotto: se harena potesse essere usata
anche al plurale e se quadrigae avesse un singolare. Altri quesiti potevano vertere
sul significato di una parola rara, sulla spiegazione o commento di un passo difficile
di un autore antico, sulla correttezza di un’argomentazione o l’errore di un sofisma.
Si tratta di sottigliezze, di questioni formali talora vacue e capziose, ma a Gellio così
non pare. Anzi, egli critica gli eccessi dell’arcaismo ed è convinto di avere colto dagli
autori antichi, depurato dalle quisquiglie, ciò che serve davvero per la formazione
dell’uomo. Certo il suo orizzonte è più ampio e meno dogmatico di quello di Frontone, il cui interesse era circoscritto alla sola retorica. Gellio è interessato anche agli
aspetti di carattere morale, filosofico, giuridico (preziose informazioni egli ci offre sul
diritto dell’antica Roma). Inoltre egli dà spazio anche a chi contesta il frontoniano
culto della parola, come il retore Domizio che accusa gli arcaisti di ridurre tutto a
verba: «raccogliete glossari e parolette (lexidia), cose risibili, vacue, frivole» (18, 7).
Nondimeno Gellio è solidale con gli arcaisti, con questi condivide la convinzione che la
lingua antica possa esprimere adeguatamente ogni realtà del presente ed è pronto a
censurare ogni aspetto di novità che non si conformi alle categorie linguistiche – e
quindi morali, cognitive, estetiche – del mondo arcaico. «Le Noctes Atticae prospettano
una visione dei fenomeni culturali sotto il segno della continuità con un passato ormai
remoto e cristallizzato, che pure, per l’autore, è in grado di fornire i moduli espressivi
per ogni esigenza» (A. Pennacini). Il patrimonio della tradizione è il fondamento di ogni
realtà, ha un valore assoluto e discriminante nei confronti degli aspetti del presente.
A prescindere dalla loro qualità intrinseca le Noctes Atticae sono una preziosa miniera d’informazioni, soprattutto per le diverse centinaia di citazioni letterarie latine
e greche (accompagnate da aneddoti, informazioni, giudizi letterari spesso denotanti capacità di penetrazione critica) che grazie a essa ci sono state conservate.
Lo stile, semplice e piacevole come si addice a un’opera di divulgazione, varia dalla forma scarna e concisa della trattazione tecnica a quella più vivace e briosa del
dialogo a più voci, che conserva il sapore delle conversazioni colte del tempo.
L’inserimento della materia in una cornice narrativa, con incontri, cene, passeggiate, aneddoti gustosi, vivacizza la materia farraginosa e pedante. L’opera rimase per
secoli il modello della letteratura compilativo-erudita e una delle fonti più importanti
per la conoscenza antiquaria del mondo latino.
ALTO IMPERO
Il classico come metafora patrimoniale. La parola arena si può usare al plurale? E quadrigae si può dire al singolare?
Per risolvere dubbi linguistici di questo genere, si deve consultare un autore che sia classicus e non proletarius: due termini, questi, di cui Gellio chiarisce il senso originario che avevano otto secoli prima, nella Roma di Servio Tullio.
Quand’ero un giovinetto a Roma, prima di recarmi ad Atene quando mi lasciavano del tempo libero
i maestri e le lezioni, facevo sovente visita a Cornelio Frontone e godevo della sua conversazione
raffinata e ricca di ogni eccellente dottrina. E non avvenne mai, ogni volta che lo vedevo e lo udivo
discorrere, di ritornarmene meno istruito e informato. Ad esempio, nel giorno in cui tenne una dissertazione su un argomento leggero, ma non di poco conto per la conoscenza della lingua latina. Infatti, avendo un amico suo, persona assai colta ed eminente poeta in quel tempo, detto che era guarito dall’idropisia avendo fatto uso di harenis calentibus (sabbie calde), Frontone ridendo disse: «Sei
guarito dal male, ma non dal difetto di linguaggio. Gaio Cesare infatti, quel famoso dittatore perpetuo, suocero di Pompeo, da cui poi discese la famiglia dei Cesari che da lui così si chiamò, uomo di
meraviglioso ingegno, superiore a ogni altro del tempo suo per la purezza del linguaggio, nel libro
De analogia che dedicò a Marco Cicerone ritiene parlare improprio il dire harenae giacché harena
(arena) non ha plurale, così come caelum (cielo) e triticum (frumento); invece ritiene che quadrigae
(quadrighe), anche se si tratta di un solo cocchio trascinato da quattro cavalli, debba essere usato al
Le Noctes Atticae di Aulo Gellio
plurale, come arma (armi), moenia (mura), comitia (elezioni), inimicitae (ostilità); a meno che contro tale affermazione, mio finissimo poeta, tu abbia qualcosa da obiettare, sì da dimostrare che il tuo
non è un errore» [...] Tali questioni, penso, non possono venir investigate, chiarite e risolte da uomini indaffarati in una città così occupata. Persino le stesse poche cose che vi ho detto vi hanno trattenuto, mi sembra, da qualche affare, al quale, penso, dovevate accudire. Andate pure, e quando per
caso avrete del tempo libero, cercate se quadriga e harenae sia stato per caso detto da qualcuno di
quella antica schiera o di oratori o di poeti, cioè da qualche scrittore classico e autorevole, non proletario» (quaerite an «quadrigam» et «harenas» dixerit e cohorte illa dumtaxat antiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, id est classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius).
(XIX 8, 1-4 e 14-15; trad. di L. Rusca)
Qual è il significato di proletarius?
Un giorno mi trovavo a Roma nel Foro: gli affari eran sospesi; si celebrava lietamente una festività e in un crocchio di molte persone si leggeva un libro sugli Annali di Ennio. In tal libro si presentarono i seguenti versi:
«A pubblica spesa è armato di scudo
il proletario, e di crudele ferro;
egli guarda le mura, la città, il Foro».
Allora si cominciò a chiedere che cosa significhi proletarius. Ed io, scorgendo in quel gruppo un
amico esperto di diritto civile, gli chiesi di spiegarci quel vocabolo; avendo egli risposto che era
esperto in diritto e non in grammatica, gli dissi: «Proprio perché sei, come dici, esperto in diritto
puoi spiegarci quel vocabolo. Giacché Quinto Ennio prese quel termine dalla vostra legge delle
Dodici Tavole, nella quale, se ben ricordo, sta scritto: “Il proprietario sia garante per il proprietario. Per il cittadino proletario lo sia chi vuole”. Perciò ti chiediamo di voler considerare che ti abbiamo letto non gli Annali di Ennio ma le Dodici Tavole, e di spiegarci che cosa si intenda in quella legge per cittadino proletario». Ed egli rispose: «È vero che io dovrei saper spiegare e interpretare quel termine, se avessi imparato la legge dei Fauni e degli Aborigeni. Ma poiché oggi i termini di proletarii, adsidui, sanates, vades e subvades, viginti quinque asses, taliones, i processi di
furto cum lance et licio, sono tutti scomparsi, e la vecchia legge delle Dodici Tavole, salvo che nei
processi davanti ai centumviri, è stata messa a riposo dalla legge Ebuzia, io debbo studiare e occuparmi del diritto e dei termini legali che vengono al giorno d'oggi impiegati».
Proprio in quel momento vidi passare di là Giulio Paolo, poeta fra i più colti di mia conoscenza.
Avendolo salutato, gli chiesi di erudirci intorno al significato e all'origine di quel vocabolo. Ed
egli: «Coloro che fra la plebe romana erano più umili e più poveri e non erano censiti per più di
millecinquecento assi; venivan chiamati proletarii, e coloro poi che non dichiaravano nulla o quasi
al censo erano chiamati capite censi e il limite massimo dei loro censi era di trecentosettantacinque
assi. Ma poiché solo le proprietà e il denaro di una famiglia venivano considerati una garanzia e un
pegno di lealtà verso lo Stato e costituivano una premessa e un'assicurazione di patriottismo, né i
proletari né i capite censi venivano arruolati nell'esercito, salvo che in periodi di straordinari disordini, dato che la loro proprietà e il loro avere erano o modesti o inesistenti.
(XVI 10, 1-11; trad. di L. Rusca)
Qual è il significato di classicus?
Classici venivan detti non tutti coloro che erano divisi nelle cinque classi,1 ma soltanto quelli della
prima classe, che cioè eran censiti per un possesso di centoventicinquemila assi o più. Eran detti infra
classem quelli che appartenevano alla seconda o alle altri classi, e che eran censiti per una somma inferiore a quella sopra detta. Ho ricordato brevemente questo, perché nell'orazione di Marco Catone In
favore della legge Voconia2 si vuole ricercare la differenza fra classicus e infra classem.
(VI 13, 1-3; trad. di L. Rusca)
1. La divisione del popolo di Roma in cinque classi di seniores e una di iuniores veniva fatta risalire a Servio Tullio ed
aveva scopi militari e fiscali per contributi diretti. Alla prima classe inizialmente appartenevano, secondo Laevadan
(Dect. des Antiquités), coloro che avevano 100 000 assi di reddito; alla seconda, 75 000; alla terza, 50 000; alla quarta,
25 000; alla quinta, 1000. Coloro che avevano un reddito inferiore eran considerati extra classem.
2. Quinto Voconio Saxa, tribuno della plebe, propose nel 169 a.C. una legge che negava alla donna il diritto di ereditare, concedendole solo di ricevere un legato.
485
486
Retorica, erudizione, filosofia
ALTO IMPERO
Dai tre passi risulta che per Gellio il classico è innanzi tutto antico (cohorte ... antiquiore), inoltre è assiduus, cioè «benestante». Anche il significato originario di classicus riguardava il censo. Classici erano gli appartenenti alla prima delle
cinque classi istituite da Servio Tullio, quelli censiti per oltre centoventicinquemila assi. Invece proletari erano i più poveri, coloro che non avendo patrimonio erano ricchi solo di prole. Che c’entrano queste definizioni con i classici della letteratura? «Nella metafora patrimoniale di Gellio gli scrittori classici si distinguono sulla base della loro “solvibilità”, se così
si può dire: uno scrittore può aspirare alla classicità quando risulta talmente affidabile che chiunque può rivolgersi a lui
per stabilire se harena si può usare anche al plurale [...] La categoria della classicità corrisponde alla capacità di garantire, al possesso dell'autorevolezza, della rispettabilità. Il classico è uno scrittore che non t'inganna. Il suo patrimonio è
ricco: fidati, lo troverai sempre solvibile [...] Non si può negare che lungo l’arco della nostra cultura i classici abbiano
svolto una funzione di tipo autoritativo. “L'ha detto Platone”, si dice comunemente, “l'ho letto in Omero”: dunque si tratta
di una testimonianza importante, viene da un uomo di primo rango» (M. Bettini, I classici nell’età dell’indiscrezione, Einaudi, Torino 1995, p. 147).
Il Tempio dei Castori (o di Castore e Polluce, o dei Dioscuri).
Roma, Foro.
Neosofistica e oratoria: Apuleio
Neosofistica e oratoria: Apuleio
Il clima culturale
Per comprendere la figura di Apuleio (vedi il profilo a p. 591) è necessario rifarsi al
complesso panorama culturale che caratterizza i suoi tempi. In seguito alla mutata
condizione storico-politica nascono nel mondo romano, segnato da mancanza di
tensione ideale, nuove esigenze spirituali a cui la cultura latina non è in grado di
offrire risposte; si lascia spazio quindi a un processo di orientalizzazione che porta con sé esperienze religiose lontane dal tradizionale sentire del popolo di Roma
e dell’Italia. Sono queste legate ai Misteri, che, con il loro fascino esotico, assecondano il bisogno di trascendenza e spiritualità ormai diffuso. D’altro canto, segno
della povertà culturale dei tempi è anche la risposta dei letterati che si rifugiano nella retorica e in un nuovo culto della parola. È il periodo della «Seconda» o «Nuova»
Sofistica, che continua quella tendenza al disimpegno caratterizzata da indifferenza
per i contenuti che abbiamo visto affermarsi nelle declamationes del I secolo d.C. Il
recupero lessicale delle forme arcaiche è solo ricerca di novità e il richiamarsi alla
letteratura latina delle origini «ha un significato, sia pure non preminente, di risveglio e orgoglio nazionale» di fronte al dilagare di culture diverse; non manca
l’interesse per la filosofia, soprattutto pratica, ma l’atteggiamento è per lo più superficiale: «molto più del bisogno di verità, molto più dell’esigenza di fissare dei valori
per la vita, conta il piacere della conversazione erudita e della disputa; la grande
varietà di argomenti, la mancanza di sistematicità sono in funzione di una curiosità
senza tormento» (La Penna). I letterati conoscono grande popolarità e successi
strepitosi grazie alla moda che si era diffusa di andare in giro a tenere conferenze.
Le opere
Numerose e di vario genere, le opere di Apuleio stanno a dimostrare i suoi interessi nei campi più svariati: dall’erudizione scientifica (aritmetica, medicina, astronomia, scienze naturali ecc.) alla storia, la musica, la poesia, la filosofia; di queste
gran parte non ci è giunta, mentre abbiamo l’Apologia, i Florida e le Metamorfosi
(vedi pp. 591 ss.). Ci sono pervenuti anche numerosi scritti filosofici a lui attribuiti,
ma gli studiosi propendono per l’autenticità soltanto di De Platone et eius dogmate,
De mundo, De deo Socratis.
Le opere filosofiche
Apuleio amava definirsi philosophus Platonicus e con questo epiteto fu conosciuto
ed onorato dai suoi contemporanei, che gli tributarono l’onore di una statua con la
scritta sul basamento «Al filosofo platonico, i cittadini di Madaura».
In realtà i suoi trattati filosofici rivestono una certa importanza non tanto per originalità di pensiero, quanto perché rivelano e gli interessi che egli coltivò in questo
ambito e le tendenze culturali del tempo; contribuirono inoltre alla conoscenza del
pensiero platonico, seppure «contaminato», durante il Medioevo, quando ancora
non erano conosciute direttamente le opere del filosofo greco.
Il De mundo è il rifacimento in latino di un breve trattato in lingua greca, il Perì kòsmu, falsamente attribuito ad Aristotele, opera forse di un anonimo del I secolo
d.C. Vi sono sviluppate le teorie fisiche di Aristotele, non prive tuttavia di influssi
platonici e neo-stoici.
De mundo
487
488
Retorica, erudizione, filosofia
De Platone et eius dogmate
De deo Socratis
Nel De Platone et eius dogmate sono esposte la vita e la dottrina platonica secondo l’interpretazione del platonismo medio, «caratterizzato dalla ripresa e dall’approfondimento degli aspetti esoterici della filosofia di Platone, cioè da quelle dottrine “non scritte” di taglio mistico ed escatologico che rappresentavano le radici profonde del pensiero filosofico» (Cipriani).
Il De deo Socratis è in realtà un’ampia conferenza, con lo stile proprio dell’oratoria
epidittica del tempo, in cui viene ampiamente trattata la dottrina dei dèmoni diffusa
fra alcuni famosi seguaci di Platone: secondo questa i dèmoni che popolano il
mondo sarebbero potenze divine intermedie con funzione di mediatori fra gli dèi e
gli uomini; così era anche il dèmone di Socrate, quella voce che egli affermava di
sentire, la quale non gli diceva cosa dovesse fare, ma lo distoglieva dal compiere
azioni sbagliate.
Le opere oratorie
ALTO IMPERO
Apologia
Apulei Platonici pro se de magia è l’indicazione riportata nei codici più antichi a indicare il discorso – unica orazione giudiziaria della letteratura latina, oltre quelle di
Cicerone, giuntaci per intero – che Apuleio pronunciò in propria difesa (per questo
probabilmente in epoca umanistica fu chiamata anche Apologia) verso la fine del
158 d.C. a Sàbrata, città della regione sirtica, nell’Africa settentrionale.
Era infatti stato accusato di aver sedotto, attraverso arti magiche, la ricca e matura
vedova Pudentilla inducendola al matrimonio per impossessarsi delle sue ricchezze. L’accusa era grave in quanto già dal I secolo a.C. in Roma era in vigore una
legge, la Lex Cornelia de sicariis et veneficiis, che puniva duramente, anche con la
morte, chi ricorreva a veleni ed era dedito a culti proibiti e riti notturni; questa, ripresa all’epoca di Tiberio, venne ampliata e perseguiva qualunque reato di magia.
Che si dicesse nella città che Apuleio era un mago doveva essere la verità; i suoi
accusatori approfittarono di ciò e cercarono di dimostrare che era vero e che, solo
grazie a questa sua attività, era riuscito a convincere Pudentilla, fino ad allora restia ad un nuovo matrimonio, a sposarlo; l’insinuazione era che l’avesse sposata
per interesse. Nella prima parte del discorso Apuleio affronta l’accusa riguardante
la magia ribattendo punto per punto quanto aveva affermato o insinuato l’avvocato
d’accusa Tannonio Pudente: con abilità mette in luce dinanzi al giudice, a cui si rivolge confidenzialmente come a chi è fra i pochi che possono comprenderlo, che
l’atteggiamento dei suoi accusatori è dovuto ad ignoranza e rozzezza; contro di loro usa l’arma dell’ironia, il che conferisce al discorso un andamento vivace e un tono brillante; nella seconda parte si difende dall’accusa di seduzione di Pudentilla ricordando le intricate vicende connesse con l’eredità. Ne risulta uno squallido quadro in cui i parenti di lei sono mossi unicamente da interesse per le grandi ricchezze della vedova; Apuleio invece non può che essere immune da questo sospetto,
dato che – e qui c’è il colpo di scena – il testamento che Pudentilla aveva scritto
era tutto a favore del figlio Pudente! Se nella prima parte prevale l’ironia sulle accuse di magia (tra cui: Apuleio è bello ed eloquente, si è servito per un dentifricio di
erbe e polverine che si usano anche per pratiche magiche, ha scritto versi d’amore
per due fanciulli con evidente funzione magica per sedurli, possiede uno specchio,
seziona pesci, fa sacrifici notturni), tutta l’orazione è giocata sulla dimostrazione
«culturale e sapienziale, che necessariamente diventa, sul piano di Apuleio, filosofica (amore), scientifica (specchi e pesci), medicale (epilessia-incanti)» (Mosca), e
sulla distinzione fra la magia dei grandi pensatori che persegue il bene e la salvez-
Neosofistica e oratoria: Apuleio
za dell’uomo, e la magia nera, che ha per scopo il male ed è quella di cui è accusato Apuleio: ma egli afferma di credere ed essere dedito solo alla prima, dimostrando che la ricerca delle sostanze e dei metodi per curare l’uomo è del mago
come del medico, come del filosofo.
L’altra opera di Apuleio di carattere oratorio sono i Flòrida, antologia di conferenze
(sono ventitré, di estensione varia) tenute in Africa, tratte forse, non sappiamo da
chi, da una raccolta più ampia curata da Apuleio stesso. Testimonianza delle sue
capacità oratorie, trattano argomenti di natura diversa, affrontati in tono brillante
ma in modo superficiale: caratteristica più evidente, il virtuosismo linguistico che si
esplica nella costruzione del discorso come nella scelta delle parole.
Retorica e stile
A giudizio unanime degli studiosi Apuleio è un artista della parola. Il suo stile, frutto
di sofisticata elaborazione artistica, appare originalissimo: l’abbondante ricorso a
mezzi retorici non è riservato alle orazioni, ma si riscontra in tutte le sue opere. Tuttavia sull’artificiosità, peraltro talora presente, prevale il senso della raffinatezza determinata da particolare abilità nel mescolare registri linguistici diversi: ne risulta
una varietà che si concretizza nella scelta di un lessico a volte specifico, a volte fatto di arcaismi e poetismi, volgarismi e neologismi. Non è disdegnata la lingua parlata quotidianamente, ma la fantasia e la capacità inventiva di Apuleio la arricchiscono di echi e citazioni letterarie che stanno a dimostrare la sua grande cultura filosofica e letteraria. Lontano dal senso classico della forma, il suo stile si può dire
perfettamente inserito nelle tendenze dell’epoca: ama particolarmente i diminutivi
propri sia del linguaggio familiare, sia dei poetae novi e di Catullo (modelli dei poetae novelli), e a questi sa attribuire sfumature diverse a seconda delle esigenze del
testo. Ma l’aspetto in cui Apuleio maggiormente si distingue è il senso musicale
della lingua a cui presta la sua formazione retorica ricorrendo a giochi di parole,
accostamenti di frasi parallele e ad ogni tipo di figura di suono.
Flòrida
489
GRAMMATICA,
ERUDIZIONE
Macrobio
Vittorino, Donato, Servio,
Marziano Capella
Francesco Piazzi, HORTUS APERTUS - Autori, testi e percorsi - Copyright © 2010 Cappelli Editore
674
Grammatica, erudizione
Macrobio
La vita
I Saturnali
BASSO IMPERO
I contenuti
V 1, 7
I personaggi
Della vita di Ambrogio Teodosio Macrobio non sappiamo quasi nulla, tranne che
dovette essere un personaggio di rango senatorio (lo prova la formula vir clarissimus et illustris assegnatagli nei codici) forse di origini africane, legato alla famiglia
dei Simmachi. È incerto se lo si debba identificare col Macrobio prefetto di Spagna
nel 399 o con quello che fu prefetto del pretorio nel 430. La questione non è irrilevante e ha conseguenze nell’interpretazione dei suoi scritti, che sono i Commentarii in Somnium Scipionis (commento in chiave neoplatonica del finale del libro VI
del De repubblica ciceroniano), i sette Saturnaliorum convivia («Conviti durante i
Saturnali»), il trattato grammaticale De differentiis et societatibus Graeci Latinique
verbi («Differenze e analogie fra il verbo greco e quello latino») di cui restano scarsi frammenti.
Queste opere assumono un significato diverso a seconda che siano state composte alla fine del IV secolo, quando la cultura pagana conservava una certa vitalità,
o verso la metà del V, quando ormai il cristianesimo aveva celebrato il suo trionfo.
I Saturnaliorum convivia sono un dialogo che si svolge per tre giorni (dal 17 al 19
dicembre), durante la festa dei Saturnali, tra personaggi di primo piano della cultura pagana riuniti a convivio: Aurelio Simmaco, Avieno (forse figlio del poeta omonimo), il grammatico Servio, l’oratore Eusebio, il filosofo Eustazio e altri esponenti
dell’intellettualità del tempo. L’anno dell’ambientazione è il 384. La serena cornice
letteraria del banchetto dei sapienti, un espediente narrativo non nuovo il cui archetipo è nel Simposio di Platone, movimenta l’esposizione e rende più gradevole la
lettura.
Gli argomenti dibattuti nella prima giornata sono di varia erudizione e spaziano dalla linguistica alla letteratura, dalla medicina alla filosofia, dall’astronomia ai motti di
spirito arguti degli antichi. Nei due giorni successivi l’oggetto della discussione è
soprattutto Virgilio, considerato fonte d’ogni sapere (anche in campo scientifico,
giuridico, filosofico) e modello di ogni stile:
Quattro sono, disse Eusebio gli stili del discorso: quello copioso (copiosum), in cui prevale Cicerone; quello conciso (breve), in cui domina Sallustio; quello sobrio (siccum) di cui è maestro Frontone; quello ampolloso e
fiorito (pingue et floridum), nel quale si distinse in passato Plinio il Giovane ed ora, non inferiore ad alcuno degli antichi, il nostro Simmaco. Ma nel
solo Virgilio troverai questi quattro generi di stile.
Il poeta dell’Eneide è oggetto di un culto, da parte dei convitati, che fa presagire la
fortuna che avrà nel Medioevo. La sua opera comincia già ad essere interpretata in
senso mistico-allegorico.
I personaggi, e in particolare i tre anfitrioni (Pretestato, Simmaco, Flaviano), sono
ben caratterizzati e i loro interventi riflettono le specifiche competenze di ciascuno: il
Vittorino, Donato, Servio, Marziano Cappella
gran sacerdote e seguace di culti orientali Pretestato disquisisce di questioni di carattere religioso, di Virgilio trattano Simmaco, Eustazio, e Servio: il primo ne discute
lo stile, il secondo la filosofia, il terzo commenta alcuni passi controversi. Un personaggio petulante e solo letterario, Evàngelo, svolge il ruolo di denigratore di Virgilio
(obtrectator Vergilii), innescando vivaci scambi polemici con gli altri convitati.
Nonostante il carattere compilatorio dell’opera – che assembla materiali di varia
provenienza, spesso trasferendoli di peso dall’originale, come avviene per alcuni
passi delle Notti Attiche di Gellio – l’autore mira a dare organicità e ordine all’insieme: «Non ho certo raccolto senz’ordine, come in un mucchio, le cose degne di ricordo … ma le disparità dei vari argomenti … ho disposte in un complesso organico, di modo che … risultassero ordinate e ben connesse come le membra di un
corpo» (Praef. 3). Oltre a Gellio, figurano tra le fonti Varrone, Svetonio, Plutarco.
L’interesse antiquariale non concerne aspetti futili o secondari, ma focalizza problemi nodali della cultura pagana, concernenti il significato attuale e la sopravvivenza
di questa nei tempi del cristianesimo trionfante, anche se di cristianesimo Macrobio, curiosamente, non parla mai. Pur nella serena finzione del dialogo conviviale
tra dotti, si ha l’impressione di un arroccamento come per un’estrema, vana difesa.
Questi rappresentanti prestigiosi dell’intellettualità pagana, simboli della grande tradizione classica, percepiscono la fine d’un mondo e s’affrettano a rievocarlo, ben
consapevoli che non potrà più tornare. Essi «sembrano intenti a redigere un inventario globale del loro sapere, prima che si disperda o taccia sopraffatto da altre culture, da altre concezioni del mondo» (G.F. Giannotti). Incrollabile è infatti la loro
certezza che quel patrimonio culturale meriti d’essere conservato:
Se siamo assennati dobbiamo avere una sconfinata ammirazione per i tempi antichi. Sono quelle le generazioni che crearono questo immenso impero
col sudore e col sangue. Certo non vi sarebbero riusciti, se non li avessero
sorretti grandi doti di virtù.
L’intento enciclopedico
L’arroccamento culturale
III 14, 2
Vittorino, Donato, Servio, Marziano Capella
Africano d’origine, Mario Vittorino fu maestro di retorica famoso sotto Costanzo II,
al punto da ricevere nel 353 l’onorificenza di una statua nel Foro di Traiano. La vicenda della sua conversione al cristianesimo – esemplare per la notorietà del personaggio, la cui scuola era frequentata da membri dell’aristocrazia pagana – è riferita da Agostino, che rievoca il momento in cui «tra lo stupore di Roma e la gioia
della Chiesa» Vittorino, ormai in extrema senectute, prese il battesimo. In seguito al
decreto di Giuliano che vietava ai cristiani d’insegnare nelle scuole, si ritirò a vita
privata e attese alla composizione di molti scritti.
Vittorino curò varie traduzioni dal greco (perdute) di opere filosofiche di Aristotele, Porfirio,
Plotino; scrisse il trattato di logica De definitionibus (sulla teoria della definizione), l’Ars
grammatica (conservataci solo nelle parti relative alla fonetica e all’ortografia); compose
commenti al De inventione di Cicerone e alle epistole di S. Paolo (agli Efesini, ai Gàlati, ai
Filippesi), scritti teologici contro l’arianesimo e il manicheismo: De homousio recipiendo
(«Sulla necessità di accogliere la dottrina della consustanzialità», cioè dell’uguaglianza nella sostanza tra Padre e Figlio), Adversus Arium, Ad Candidum Arianum, De generatione divini Verbi. Restano anche tre inni ritmici sul tema trinitario, privi della struttura metrica tradizionale e notevoli per il lirismo ispirato ai Salmi.
L’interesse per i filosofi neoplatonici, in particolare per Porfirio – nel cui pensiero,
ammette Agostino, «almeno si suggerisce l’idea di Dio e del suo Verbo» – dovette
Le opere
675
676
Grammatica, erudizione
Elio Donato
BASSO IMPERO
Servio
Marziano Capella
facilitare la conversione al cristianesimo, col quale il neoplatonismo condivideva la
trascendenza divina e il monoteismo. Le traduzioni di Plotino e Porfirio attestano
anche un fervore di studi filosofici neoplatonici a Roma verso la fine del IV secolo.
L’apprezzamento di Agostino, che lo elogia come «dottissimo maestro, grande conoscitore di ogni disciplina liberale» (Conf. VIII 2), non è condiviso da Girolamo,
che ne critica le oscurità e le sottigliezze.
Forse africano, nato intorno al 310, il grammatico Elio Donato fu protagonista, insieme con Vittorino, della rinascita di studi filologici e antiquariali del IV secolo.
Grande cultore di classici, dei quali sapeva trasmettere l’amore ai propri discepoli
(tra questi, Girolamo e Rufino), scrisse due manuali scolastici di grammatica,
un’Ars minor per i principianti e un’Ars maior per gli studi avanzati. Nel primo si
analizzano le otto parti del discorso (conservate nell’analisi grammaticale fino ai
nostri tempi), nel secondo sono trattati argomenti di stile e di metrica.
Di un commento a Virgilio restano un’introduzione alle Bucoliche e una biografia
del poeta dipendente da Svetonio. Un commento alle commedie di Terenzio, pervenuto quasi integro (manca solo la parte relativa all’Heautontimorùmenos), è di
grande interesse per gli interpreti del commediografo, in quanto ci informa sulle circostanze delle rappresentazioni e sui rapporti con gli originali greci, che Donato
leggeva ancora mentre per noi sono perduti.
In particolare le due Artes ebbero grande fortuna durante il Medioevo fino a tutto
l’Umanesimo, al punto che Donatus finì col designare, per antonomasia, la grammatica. Divenuti un classico della grammatica latina, i due manuali furono variamente rimaneggiati: fusi in uno solo, ampliati oppure ridotti, trasformati in commenti. Dante ricorda nel Paradiso «quel Donato/ ch’a la prim’arte degnò porre mano»
(XII 137-138), intendendo con prim’arte la grammatica che apriva gli studi del Trivio.
Probabilmente allievo di Donato di cui curò un commento delle Artes (Explanatio in
artem Donati), Servio è uno dei convitati dei Saturnales di Macrobio. Vissuto a Roma tra il IV e il V secolo, scrisse un celebre commento a Virgilio (all’Eneide, alle
Bucoliche, alle Georgiche), del quale sono rimaste due stesure: una scolastica breve e una più ampia consistente in una serie di annotazioni (scolia) di carattere
grammaticale, stilistico, antiquariale. La seconda redazione – denominata Servius
Danielinus da Pierre Daniel, che ne curò l’edizione parigina del 1600 – fu incrementata nel tempo con l’aggiunta di materiali eruditi di altri autori (in particolare di
Donato), pertanto si configura come la summa di una lunga tradizione scolastica di
esegesi dei testi di Virgilio: perciò è denominata anche Servius auctus, cioè accresciuto da materiali medioevali. Le note «danieline» sono di grande interesse, oltre
che per lo studio di Virgilio, perché riportano citazioni di testi perduti che altrimenti
non potremmo leggere. Inoltre ci fanno conoscere i metodi della critica letteraria
nell’antichità. Virgilio nel commentario serviano comincia ad assumere i tratti del
maestro di sapienza, quale sarà nel Medioevo. Iniziano qui le interpretazioni allegoriche dei testi virgiliani (ad esempio dell’egloga IV, del VI libro dell’Eneide), nate
anche per favorire il sincretismo tra mondo classico e cristiano.
Sempre, nel corso della storia, la tradizione sopravvive se è in grado di accogliere
le istanze dei nuovi tempi. Così la cultura pagana, per non morire, doveva integrarsi nella visione cristiana del mondo. Alla sintesi tra cultura classica e cristianesimo,
tra vecchio e nuovo, preludono i nove libri del De nuptiis Mercurii et Philològiae dell’avvocato cartaginese Marziano Capella, vissuto nella prima metà del V secolo.
L’opera, mista di versi e prosa (prosimetro) sul modello delle sature Menippeae, è
l’enciclopedia delle arti liberali: grammatica, dialettica, retorica, geometria, aritmeti-
Vittorino, Donato, Servio, Marziano Cappella
ca, astronomia, musica. Queste, ridotte a sette rispetto alla suddivisione tradizionale che includeva anche l’architettura e la medicina, costituiranno il Trivio e il Quadrivio del Medioevo. Nell’allegoria del De nuptiis, Mercurio sposa la Filologia, doctissima virgo cui gli dei concedono l’immortalità. Le sette arti, ciascuna delle quali si
presenta a partire dal terzo libro (i primi due narrano le mistiche nozze), saranno le
sue ancelle. Le parti poetiche riecheggiano versi di Lucrezio, Catullo e dei poeti augustei. Il modello dell’allegoria è la favola di Amore e Psiche di Apuleio, da cui le
nozze di Filologia derivano molte immagini e situazioni narrative, il gusto per
l’allegoria, lo stile turgido e ricercato. Soprattutto apuleiano è l’elemento iniziatico e
misterico di ascendenza neoplatonica, che agevola il sincretismo religioso e culturale ricercato da questi autori della tarda latinità.
677
Oratoria, retorica,
epistolografia
I Panegyrici Latini
Simmaco e la reazione pagana
Retorica e Cristianesimo:
Tertulliano, Minucio Felice,
Cipriano, Ambrogio, Girolamo,
Lattanzio
La nuova eloquenza cristiana
di Agostino
Epistolografia cristiana:
Ambrogio, Girolamo, Agostino
680
Retorica e tarda latinità
Retorica e tarda latinità
I Panegyrici Latini
BASSO IMPERO
Gli stereotipi
del genere encomiastico
Lo stile
Il corpus dei cosiddetti Panegyrici Latini comprende 12 composizioni encomiastiche in
onore di imperatori pronunciate in un arco di tempo che va dal 289 al 389. La raccolta,
che probabilmente fu approntata in Gallia e aveva una destinazione scolastica, si apre
col Panegirico di Plinio il Giovane, che di questo genere oratorio è il modello indiscusso.
Dei 12 componimenti (includendo anche quello pliniano), cinque sono anonimi. Gli
autori dei rimanenti sono uno sconosciuto Memertino, i due retori gallici Eumenio e
Nazario, Flavio Claudio Mamertino, Latinio Pacato Drepanio. Gli imperatori dedicatari
sono Massimiano, Costanzo, Costantino, Giuliano, Teodosio. Le circostanze sono il
compleanno dell’imperatore, un matrimonio o una vittoria, l’assunzione di una carica
pubblica da parte dell’autore.
Il carattere ufficiale e propagandistico, l’aderenza a schemi retorici assai vincolanti,
la selezione dei soli contenuti positivi e la rimozione di quelli più imbarazzanti per il
celebrato rendono tutti simili tra loro i panegirici e comportano che il loro interesse
storico-documentario sia limitato. Il fatto stesso che nella raccolta sia incluso il panegirico di Plinio a Traiano, scritto quasi tre secoli prima, dimostra la fissità nel tempo delle forme dell’oratoria elogiativa.
Certo, la veste retorica e la visione obbligatoriamente ottimistica non sempre riescono
ad occultare le difficoltà dell’impero (i barbari ai confini, le condizioni dell’economia,
ecc.), ma il celebrato quasi sempre è presentato come colui che a questi problemi
cruciali ha saputo dare una soluzione. Ad esempio, nel panegirico di Massimiano, si
ammette che ad ogni secca del Reno sorge il timore che i Germani lo attraversino, ma
ciò riguarda il passato precedente alle vittoriose campagne militari di quell’imperatore:
«Ma tu, invitto signore, hai sottomesso quelle genti fiere e indomite … Da allora noi
siamo finalmente liberi da ogni preoccupazione» (2, 7, 6-7). Non si deve sottovalutare
la funzione «mediatica» di pubblicizzazione della politica dell’imperatore, svolta da
queste composizioni. Ma al di là dell’enfasi propria del genere encomiastico, questi
scritti attestano la sincera convinzione dell’importanza della cultura tradizionale e la
certezza di una sua rivincita sul trionfante cristianesimo, che nei panegirici viene semplicemente ignorato. Inoltre costituiscono un prezioso documento sull’insegnamento
della retorica e quindi sul tipo di istruzione impartita ai ceti dirigenti del tempo.
Queste composizioni d’apparato risultano fastidiose e stucchevoli per il gusto del lettore moderno a causa della magniloquenza, delle iperboli inverosimili, delle espressioni fatte per compiacere al celebrato, cui l’elogio era stato preventivamente sottoposto per l’approvazione. Disturbano la ricorsività monotona dei motivi, la fissità dello
schema espositivo simile a quello degli antichi elogia: si inizia con la descrizione della patria e della formazione del celebrato, poi si passa alle sue imprese e virtutes rafforzando le lodi con exempla tratti dal mito e dalla storia, infine si formulano gli auguri di fortuna e prosperità. Naturalmente abbondano poetismi e forme ricercate,
espressioni di sentenziosità astratta e solenne, dotte allusioni ai classici.
Simmaco e la reazione pagana
Simmaco e la reazione pagana
Il più audace tentativo di restaurazione pagana è rappresentato dalla politica di
Giuliano, detto l’Apostata per avere abiurato il cristianesimo, ormai divenuto religione di stato. Attorno a questo imperatore filosofo, imitatore di Marco Aurelio, si strinsero i massimi esponenti dell’intellettualità pagana. L’azione di Giuliano concerneva
il rilancio della religione tradizionale rivisitata in chiave neoplatonica, il restauro dei
templi, l’abolizione dei privilegi della Chiesa, il divieto ai cristiani di insegnare nelle
scuole pubbliche. La morte dell’imperatore nella campagna contro i Parti del 363
troncò il progetto, tuttavia non pochi esponenti dell’aristocrazia romana continuarono ad impegnarsi nella difesa della cultura tradizionale. In particolare due famiglie
della nobiltà senatoria, i Simmachi e i Nicomachi, furono il punto di riferimento della ripresa pagana, che in un primo tempo non fu ostacolata dalla politica tollerante
di Gioviano e Valentiniano, i successori di Giuliano. Ma con Teodosio i culti antichi
furono vietati e non ci fu più lo spazio politico per una restaurazione classicistica.
In tale contesto si svolge l’attività di Quinto Aurelio Simmaco, esponente dell’aristocrazia senatoria romana nato verso il 340, oratore famoso, prefetto di Roma nel
384-385 e console nel 391. Alla corte di Valentiniano I (364-375) conobbe il poeta
Ausonio. È il paladino della cultura negli anni cruciali in cui il cristianesimo diviene
religione di stato e il paganesimo è posto al bando.
La parentesi anticristiana
di Giuliano
Di lui ci restano otto orazioni incomplete, tre panegirici (dedicati a Valentiniano e Graziano,
pronunciati alla corte di Treviri) e un copioso epistolario di circa 900 lettere indirizzate a
personaggi pubblici tra i quali lo stesso Stilicone, il potente generale vandalo di Teodosio.
49 lettere sono Relationes, cioè rapporti ufficiali inviati all’imperatore da un magistrato, altre
hanno carattere privato (epistulae salutatoriae cioè di saluti e convenevoli, commendaticiae
cioè di raccomandazione, consolatorie, di ringraziamento, ecc.). L’epistolario è ordinato secondo il modello pliniano: dei nove libri in cui è diviso, i primi otto contengono lettere private, il decimo quelle di carattere pubblico.
Opere
In particolare nella Relatio III Simmaco chiede che venga ricollocata nella Curia
l’ara della Vittoria, rimossa da Graziano. Il monumento, voluto da Augusto dopo la
battaglia di Azio nel 31 a.C., era un simbolo della paganità e il segno visibile della
protezione accordata dagli dei pagani all’impero romano: sull’ara i senatori gettavano granelli d’incenso entrando nella Curia. Simmaco presenta la petizione alla corte di Milano nel 384, nella sua veste di praefectus urbi. La restituzione dell’insigne
monumento s’impone, secondo Simmaco, per motivi di tolleranza religiosa e per
garantire la sicurezza dell’impero:
La questione dell’altare
della Vittoria
Restauriamo, quindi, i riti e i culti, che così lungamente protessero il nostro
stato. Possiamo certo noverare prìncipi seguaci dell’una o dell’altra fede:
d’essi i primi hanno professato la religione dei padri; altri, più vicini a noi,
pur non professandola, non l’hanno soppressa. Ora, se non serve a voi
d’esempio la religione dei primi, vogliate almeno ispirarvi alla tolleranza
di quegli altri. Chi è così amico dei barbari da non rimpiangere l’altare della Vittoria? Noi siamo pensosi delle future sorti dell’impero e temiamo che
l’avvenuta rimozione di quell’ara possa essere per l’impero presagio di
sventure.
III 3; trad. di L. Canfora
Un parere contrario alla ricollocazione fu espresso in due discorsi da Ambrogio, il
cui punto di vista intransigente finì col prevalere presso l’imperatore Valentiniano II.
L’ara della Vittoria non ritornò più nella Curia.
Al nobile pagano che affermava un principio di relativismo culturale e di rispetto
La battaglia di Simmaco
681
682
Retorica e tarda latinità
delle diversità («Che importa se ognuno cerca la verità a modo suo? Non si può
conoscere un così grande mistero per un solo cammino», 3, 10) il vescovo cristiano rispondeva così: «La salvezza non potrà essere ottenuta se non si adora il vero
Dio, cioè quello dei cristiani … gli dèi pagani sono demòni» (par. 1).
La durezza della contrapposizione tra pagani e cristiani in questi anni cruciali per il
rapporto tra le due culture non impediva tuttavia al cristiano Prudenzio di esprimere stima e ammirazione per Simmaco, auspicando che egli ponesse la propria eloquenza al servizio della vera fede:
O lingua che spande una fonte mirabile di parole, gloria dell’eloquenza romana, di fronte alla quale s’inchinerebbe perfino Cicerone, tanto è il fulgore della sua mirabile facondia! Bocca degna di risplendere eternamente
d’oro, se mai volesse un giorno lodare Dio, al quale ha preferito orridi mostri, profanando con un delitto la sua voce armoniosa.
BASSO IMPERO
Contra Symm. I 632-637
Dittico dei Nicomachi e dei Simmachi (400 circa). Parigi, Museo di Cluny; Londra, Victoria and Albert Museum.
Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio
Retorica e Cristianesimo
Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio
Il rapporto degli scrittori cristiani con il patrimonio retorico classico – nei secoli che
conducono dalla tarda antichità al Medioevo – si articola lungo due direttive principali: da un lato essi conoscono gli strumenti della persuasione retorica e se ne valgono, soprattutto nella predicazione o negli scritti a difesa del pensiero cristiano;
dall’altro ne rifiutano il carattere di artificio contrapposto alla semplicità anche stilistica del messaggio evangelico.
Tra i tipi canonici di orazioni, quella di genere giudiziario è ben conosciuta dagli autori che, all’epoca delle persecuzioni, si propongono di difendere i cristiani come
davanti a un tribunale.
È il caso evidente dell’Apologeticum (scritto apologetico, ossia di difesa) del cartaginese Tertulliano, composto verso la fine del II secolo d.C. da uno scrittore che ben conosceva i procedimenti della giurisprudenza e della retorica. Indirizzando la propria difesa ai governatori romani, egli da un lato respinge le accuse infamanti rivolte alle prime
comunità cristiane, dall’altro, in perfetto stile processuale, controbatte passando all’attacco. La terminologia oratoria giudiziaria appare evidente all’inizio del capitolo II:
I padri della Chiesa
Se dopo tutto è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dai nostri simili, cioè dagli altri
delinquenti, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento
uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono
imputate, essi possono, con la propria voce o per mezzo di una voce pagata, provare la propria innocenza; essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio, perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani non è invece permesso di dire ciò che li
discolperebbe dall’accusa, farebbe rifulgere la verità dei fatti, impedirebbe
al giudice di commettere un’ingiustizia …
Apologeticum II 1 ss.;
trad. di L. Rusca
Probabilmente conobbe l’Apologeticum tertullianeo Minucio Felice, che ne riecheggia
alcuni passaggi nel dialogo Octavius. Nato nell’africana Numidia, Minucio Felice visse a cavallo dei secoli II e III e fu avvocato: conobbe quindi anch’egli le procedure
dell’oratoria giudiziaria e le leggi della retorica classica. Il dialogo si svolge tra l’autore
stesso, il cristiano Ottavio ed il pagano Cecilio, che, scettico all’inizio, si convertirà infine al cristianesimo. Si tratta quindi sempre di un’opera apologetica, ma condotta nei
toni più temperati e moderati del dialogo e con notevoli aperture nei confronti della
cultura classica, di cui traspare nel testo la conoscenza da parte dell’autore.
Echi dell’Octavius si ritrovano a loro volta nell’Ad Donatum di Cipriano (III secolo).
Anch’egli africano e famoso professore di retorica prima della conversione, così
esprime nell’Ad Donatum la differenza tra la forma esteriore dell’oratoria giudiziaria
e l’importanza del contenuto della Parola divina:
Nei tribunali e nei discorsi che si tengono al foro, facciano pure sfoggio di
ricca facondia messa al servizio della volubile ambizione. Quando si parla
Minucio Felice
Tertulliano
Cipriano
Ad Donatum;
trad. di G. Toso
683
684
Retorica e Cristianesimo
del Signore e di Dio la nostra parola dev’essere chiara e sincera; per documentare la fede dobbiamo far uso dei fatti, non della forza che deriva dall’eloquenza. Ascolta quindi gli argomenti che hanno della sostanza e non si
curano della forma. Accetta le parole che non sono artificiosamente costruite ed esposte in modo elegante per adescare le orecchie della gente,
ma sono semplici parole dette sulla falsariga di una disadorna verità, però
adatte a divulgare la bontà di Dio.
De habitu virginum XXI
1 ss.;
trad. di G. Toso
Ambrogio
BASSO IMPERO
Girolamo
Epistola 22;
trad. di S. Cola
Lattanzio
Dal trattato De habitu virginum («La condotta delle vergini»), nato da una raccolta
di omelie (i discorsi di insegnamento ed esortazione tenuti dal predicatore durante
il rito religioso), si legga inoltre l’inizio del paragrafo XXI come esempio della facoltà oratoria di Cipriano predicatore:
Ascoltatemi dunque, o vergini, come un padre: vi prego di ascoltarmi,
mentre mi preoccupo di voi e vi ammonisco. Date ascolto a uno che con
sincerità si preoccupa del vostro bene e del vostro vantaggio. Siate come vi
ha fatto Dio Creatore. Siate come le mani del Padre vi ha fatte. Conservate
il volto senza trucco, il collo libero da collane, l’aspetto naturale.
La maggior parte degli scritti esegetici del grande vescovo di Milano (vedi il profilo,
p. 644) rappresentano la rielaborazione di precedenti omelie. La destinazione originaria traspare dall’intento pratico e didattico dei testi. Di qui anche la frequenza dei
modi del parlato. Della suggestione esercitata sui fedeli dall’oratoria di Ambrogio fu
testimone anche il giovane Agostino, giunto a Milano dall’Africa.
Parte dei discorsi di Ambrogio hanno una valenza politica e si legano all’alto magistero ricoperto e agli obblighi conseguenti. È il caso delle orazioni funebri Sulla
morte di Valentiniano II e Sulla morte di Teodosio (pronunciato nel 395 davanti al figlio ed erede Onorio). Originarie omelie sono anche gli scritti dei trattati De sacramentis e De mysteriis. L’oratoria cristiana di Ambrogio testimonia l’impegno di adeguare al messaggio cristiano le forme dell’oratoria epidittica insegnate nelle scuole,
fondendo motivi retorici tradizionali con i temi della liturgia ecclesiastica. Di qui
l’impiego degli strumenti retorici tradizionali, usati a fini parenetici e persuasivi.
Nel IV secolo si collocano Elio Donato e Girolamo. Elio Donato è autore di quella
famosa Ars grammatica che avrebbe costituito durante il Medioevo il manuale di riferimento per l’educazione elementare (vedi p. 676). Allievo di Elio Donato a Roma
fu Girolamo, che dal maestro apprese i fondamenti della cultura classica, la cui approfondita conoscenza avrebbe contrassegnato, come una trama sotterranea, la
sua successiva produzione letteraria. Egli avverte con intensità il contrasto del pensiero cristiano con i testi pagani. Nei confronti di questi prova sia attrazione che repulsione, ritenendo infine possibile una loro convergenza secondo una prospettiva
cristiana. Famosa è al proposito l’epistola 22:
… me ne ero andato a Gerusalemme a militare per Cristo. Ma dalla mia biblioteca, messa assieme a Roma con tanto amore e tanta fatica, proprio non
avevo saputo staccarmi.
Povero me! Digiunavo, e poi andavo a leggere Cicerone. Dopo molte notti
trascorse vegliando, dopo aver magari versato fiumi di lacrime che sgorgavano dal profondo del cuore al ricordo dei peccati d’un tempo, prendevo in
mano Plauto. Se talvolta, rientrando in me stesso, aprivo i libri dei Profeti,
il loro stile disadorno mi dava la nausea.
Insegnanti di retorica furono Arnobio – vissuto sotto l’imperatore Diocleziano e nel territorio dell’Africa proconsolare, autore anch’egli di un’opera di stampo apologetico, dal
titolo di Adversus gentes – ma soprattutto Lattanzio (IV secolo). Questi fu definito da
Girolamo nel De viris illustribus «una sorta di fiume di eloquenza ciceroniana», per il
Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio
suo bagaglio di conoscenze classiche, che egli mira a conciliare con quelle cristiane.
Dalla retorica classica vorrebbe trarre gli ornamenti stilistici per avvicinare al messaggio evangelico anche i pagani, sospettosi nei confronti dello stile troppo spoglio delle
Sacre Scritture. La sua opera maggiore, le Divinae Institutiones, modella, per ammissione dello stesso autore, il titolo sulla denominazione di Institutiones civilis iuris («Istituzioni di diritto civile») e l’impostazione apologetica – come di un avvocato che conduca la difesa in tribunale – emerge subito dalla Prefazione:
Il parlar bene può riguardare pochi, ma il ben vivere è cosa che tocca tutti.
Tuttavia quel nostro esercizio di trattare cause, questioni immaginate, ci ha
giovato molto, così che ora possiamo difendere la causa della verità con
più numerosi e più gravi argomenti: essa, per altro, potrebbe essere sostenuta anche senza l’aiuto dell’arte oratoria, come fu appunto per parte di
molti; tuttavia ci pare di doverla illustrare con chiarezza e splendore di
espressione, perché essa si fissi più stabilmente negli spiriti, forte della sua
stessa forza, illuminata dalla luce della parola.
L’inizio del libro III bene esprime l’utilità per la fede cristiana di un’eloquenza di
scuola classica:
… io vorrei mi fosse concessa – sia pure non come quella che rifulse in M.
Tullio Cicerone, veramente grande e magnifica – una certa facoltà oratoria,
da poter far sì che la verità – per quanto essa valga prima e soprattutto per
la sua intima forza – risplendesse in tutto il suo splendore, e, confutati tanto gli errori del volgo, quanto di coloro che sono reputati saggi, potesse apportare agli uomini luce magnifica e fulgidissima. Ed io desidererei di poter fare ciò per due cause: prima, perché gli uomini potrebbero, certamente
con maggior ragione, prestar fede alla verità luminosa, essi che credono
anche alla menzogna, se attratti da quello che sia lenocinio di forma e magnificenza di espressione; seconda, perché certamente gli stessi filosofi sarebbero confutati e confusi da noi con quei mezzi, e con quelle stesse armi
delle quali sono soliti compiacersi e in cui fermamente confidano.
Lattanzio introduce anche il tema della diffidenza degli intellettuali pagani verso lo
stile dimesso delle Sacre Scritture:
… presso i sapienti, i dotti, e i luminari di questa età, la Sacra Scrittura non
riscuote autorità e fede; perché i Profeti parlarono con parola semplice e
piana, qual si conviene a chi deve parlare al popolo. Sono tenuti in poca
considerazione da coloro che non intendono di ascoltare o di leggere, se
non quello che sia elegante, forbito e presentato in una forma veramente
squisita, e nell’animo loro non può restare se non ciò che molce l’orecchio
con soavità di suono. Tutto quello, invece, che riveste un carattere di pura
semplicità e schiettezza, è considerato inutile ciarla, cosa volgare e non degna di considerazione alcuna. È così che essi non stimano vero, se non
quello che a loro fa piacere ad ascoltare; non v’è niente a cui si debba prestar fede, se non ciò che possa svegliare una certa soddisfazione e lusingare; è per questo che nessuno giudica una data cosa nel suo giusto valore,
ma dall’apparenza. Non credono quindi questi pretesi saggi a quanto vi è
di divino, perché ogni orpello è lontano dalle cose di Dio, e non prestano
fede neppure a coloro che delle cose divine sono gli interpreti e i banditori,
perché anche essi vivono in tutta semplicità, e sono addirittura rozzi, o, almeno, hanno un limitato grado di cultura. È rarissimo il caso che essi abbiano il dono di un’eloquenza fluente e magnifica, e la ragione di ciò, del
resto, è chiara: la parola è in servigio delle cose del mondo; desidera di farsi valere fra le genti e rifulgere in quanto possa magari non esser buono; se
pure, come avviene assai spesso, non arriva a voler abbattere la verità, per
dimostrare così la sua potenza; aspira ad aprire la strada alle ricchezze, ha
brama di onori, rivendica a sé il più alto grado di dignità e di onore.
Divinae Institutiones,
Prefazione;
trad. di G. Mazzoni
ibidem, III 1 ss.
ibidem, V 1 ss.
685
686
Retorica e Cristianesimo
La nuova eloquenza cristiana di Agostino
Sarà Agostino (354-430, vedi il profilo a p. 664) a porre le fondamenta di una nuova eloquenza cristiana, la quale non prende a modello gli artifici retorici dei Greci,
ma ha il fondamento nello stile stesso delle Sacre Scritture. Queste sono criticate
dai sapienti pagani a causa del loro aspetto apparentemente poco curato, che invece esprime per ciò stesso lo «scandalo della Croce». Come infatti il Dio cristiano
si rivela agli uomini non nella figura vittoriosa di un regnante ma nelle semplici spoglie di un bambino e nella sconfitta umana della morte sulla croce, allo stesso modo la Bibbia sceglie parole umili per esprimere un contenuto sublime. Come la linearità del linguaggio biblico rende il messaggio comprensibile anche ai semplici,
allo stesso modo la profondità del suo significato costituisce degno alimento per
l’intelletto dei dotti.
Nelle Confessiones Agostino descrive la propria iniziale incomprensione per lo stile
delle Sacre Scritture:
Confessiones III 9;
trad. di C. Carena
… mi proposi di rivolgere la mia attenzione alle Sacre Scritture per vedere
come fossero. Ed ecco cosa vedo: un oggetto oscuro ai superbi e non meno
velato ai fanciulli, un ingresso basso, poi un andito sublime e avvolto di
misteri. Io non ero capace di superare l’ingresso o piegare il collo ai suoi
passi. Infatti i miei sentimenti, allorché le affrontai, non furono quali ora
che parlo. Ebbi piuttosto l’impressione di un’opera indegna del paragone
con la maestà tulliana. Il mio gonfio orgoglio aborriva la sua modestia, la
mia vista non penetrava i suoi recessi. Quell’opera invece è fatta per crescere con i piccoli; ma io disdegnavo di farmi piccolo e per essere gonfio
di boria mi credevo grande.
Certo, anche l’oratore cristiano dovrà munirsi di armi retoriche, per non presentarsi
sprovveduto nel suo ufficio di persuadere il prossimo al bene e alla verità:
BASSO IMPERO
De Doctrina Christiana
IV 2, 3 ss.;
trad. di M.Simonetti
Dato che con la retorica si sostengono argomenti sia veri sia falsi, chi oserà dire che contro la menzogna i difensori della verità debbono essere del
tutto disarmati? Perché mai quanti cercano di accreditare il falso sanno accattivarsi coi loro esordi l’ascoltatore rendendolo attento e arrendevole,
mentre invece costoro non lo sanno fare? Perché quelli sanno esporre il
falso con brevità chiarezza verisimiglianza, mentre questi espongono il vero in modo che l’ascoltatore s’annoi, non riesca a capire e non resti convinto? Perché quelli riescono con argomenti ingannevoli a impugnare la verità
e affermare la falsità, mentre questi non sono capaci né di difendere il vero
né di confutare il falso? Perché quelli con le loro parole sanno smuovere e
spingere all’errore gli animi degli ascoltatori atterrendoli rattristandoli rallegrandoli esortandoli col massimo impegno, mentre questi in difesa della
verità sonnecchiano pigri e fiacchi? Chi può essere tanto sciocco da pensarla così? Dato perciò che la capacità di parlare è moralmente neutra ed è
molto efficace per sostenere argomenti sia cattivi che buoni, perché mai la
persona dabbene non si dovrebbe mettere in condizione, grazie a questo
studio, di battersi per la verità, dal momento che i malvagi se ne servono
per far prevalere cause disoneste e prive di fondamento a beneficio dell’iniquità e dell’errore?
L’oratore cristiano si potrà valere dunque dei tre stili ciceroniani (umile, medio e alto) mescolandoli all’interno della stessa omelia. Dovrà di preferenza docere, «insegnare» con stile umile, nella spiegazione del testo sacro; saprà vituperare o laudare, «rimproverare» ed «elogiare» in stile medio, ornato da figure retoriche; potrà
movere, «convincere» con stile alto:
La nuova eloquenza cristiana di Agostino
Se si devono istruire gli ascoltatori, bisogna esporre in modo da far conoscere l’argomento di cui si tratta, purché ce ne sia necessità. Se poi si vuol
rendere certo ciò che è dubbio, bisogna far uso del ragionamento, confortandolo con elementi di prova. Se invece chi ascolta, più che apprendere,
deve essere stimolato perché non si impigrisca nel fare ciò che già sa e dia
il proprio assenso a ciò che riconosce essere vero, in questi casi c’è bisogno di maggiore capacità di eloquio, perché qui è necessario far uso di preghiere e rimproveri, di esortazioni e divieti, e di tutto ciò che è capace di
muovere gli animi.
ibidem, IV 4, 6
Si preferiranno le figure retoriche che permettono un più stretto collegamento con
la sostanza del messaggio (ad esempio le parabole) o che conferiscono al discorso un ritmo incalzante (come le ripetizioni di parole o la loro collocazione parallela).
Per apprendere gli strumenti oratori non tanto servirà studiarne accuratamente le
regole, quanto seguire l’esempio di valenti predicatori:
Chi poi ha intenzione di apprendere a parlare non solo con sapienza ma anche con eloquenza, perché certo riuscirà di maggiore utilità se sarà capace
di fare l’una cosa e l’altra, lo invito a leggere ascoltare e imitare con
l’esercizio chi è abile nel parlare, piuttosto che consigliargli di andare a
scuola dai maestri di retorica.
Pagina miniata del XV sec. raffigurante i grandi difensori della
dottrina cristiana. Milano, Collezione Mario Crespi Morbio.
Gregorio di Nazianzo, Padre della Chiesa di lingua greca, Ambrogio, l’imperatore Graziano, Girolamo, Giovanni Crisostomo, Padre della Chiesa di lingua greca, Agostino, Giovanni
Damasceno, Padre della Chiesa di lingua greca, Paolo Orosio,
storico latino cristiano e il Papa Leone Magno.
ibidem, V 5, 8
687
688
Retorica e Cristianesimo
Epistolografia cristiana: Ambrogio, Girolamo, Agostino
Le epistole di S. Paolo
L’epistola consolatoria
BASSO IMPERO
Epistolografia
di lingua greca
Ambrogio
Il primo esempio di epistolografia cristiana è rappresentato da quattordici lettere di
S. Paolo, scritte tra il 50 e il 66 d.C. Nella struttura e nei contenuti si ritrovano le caratteristiche dell’epistolografia tradizionale pagana, ma in ogni epistola è presente il
messaggio cristiano che influenza i contenuti e finanche le formule di saluto e di
congedo. Le tipologie sono varie: lettere di viaggio, dottrinali, pastorali, polemiche,
«aperte». Egli sfrutta le potenzialità comunicative della lettera e la sua forma polivalente per fare circolare il messaggio cristiano, sostenuto dalle continue citazioni
dei passi biblici. Dopo S. Paolo la lettera diverrà lo strumento comunicativo più usato dalle comunità cristiane, in quanto risulterà un utile mezzo per organizzarle ed
anche una valida forma di propaganda religiosa. Le lettere, redatte con cura e con
arte, sono «aperte», cioè rivolte ad un pubblico e destinate ad essere diffuse, per
questo spesso il destinatario assume il volto anonimo di un’intera comunità, senza
un’apparente precisa individualità storica.
Tra le tipologie epistolari dell’antichità i Padri della Chiesa svilupparono e trasformarono soprattutto l’epistola consolatoria, la più adatta a mostrare la misericordia
di Dio nel momento del dolore. Le consolationes della tradizione pagana erano costituite generalmente da due parti, una personale che si adattava alle circostanze
del destinatario ed una generale rappresentata da massime, esempi, luoghi comuni sulla morte e sul dolore. Seguendo questo schema topico, ereditato da scrittori
come Cicerone e Seneca, i Padri della Chiesa trasformarono in particolar modo la
parte generale, dedicata alla glorificazione di Dio, all’elogio delle virtù evangeliche,
all’insegnamento della dottrina e delle verità bibliche: «la consolatio diventa esortazione, esegesi, insegnamento teologico, guadagnando in varietà ciò che perde in
unità» (Ciccarese).
In lingua greca, oltre alle lettere di San Paolo, ci sono stati tramandati numerosi
epistolari, soprattutto di vescovi. Alcuni sono giunti in forma completa, altri in
frammenti, altri, pur essendo perduti, ci sono noti da altri epistolari coevi. Al III
secolo risale l’epistolario di Cipriano, vescovo di Cartagine, che si rivela un’ottima fonte documentaria per testimoniare un momento di crisi della Chiesa, vessata all’esterno dalle persecuzioni di Decio e spaccata, all’interno, su questioni
dogmatiche.
Nel IV secolo si assiste ad una fioritura di epistolari cristiani, che, sulla scorta della
teorizzazione retorica sia latina (Giulio Vittore) che greca (Pseudo Libanio), tendono ad assorbire i canoni tradizionali del genere. In particolar modo i proemi delle
lettere tendono a retoricizzarsi e a divenire modelli per i secoli a venire. Tra gli scrittori del IV secolo è importante ricordare Gregorio di Nazianzo, che fu il primo autore greco a divulgare in modo sistematico le proprie lettere; egli inoltre, nell’epistola
51, ha delineato i tratti peculiari dell’epistolografia, contribuendo alla codificazione
del genere epistolare.
Anche in ambito latino il IV secolo mostra una fioritura di epistolari cristiani. Il primo
importante è quello di Ambrogio (vedi p. 644), costituito da 92 lettere, distribuite in
10 libri e scritte tra il 379 e il 396 d.C. La maggior parte di esse sono legate alla
sua attività di vescovo, indirizzate agli uomini che ricoprivano le più alte cariche
dell’amministrazione imperiale e ai confratelli. I temi trattati sono prevalentemente
dogmatici o morali. Anche le lettere di Ambrogio risentono dei canoni retorici formulati in quegli anni e si mostrano attente a tutte le regole del genere e alle norme
relative all’elaborazione stilistica.
Epistolografia cristiana: Ambrogio, Girolamo, Agostino
A cavallo tra il IV e il V secolo vive ed opera Girolamo (vedi p. 707), il cui epistolario è costituito da 154 lettere, in parte scritte da lui, in parte risposte dei corrispondenti. Furono redatte tra il 374 e il 410 e fu lui stesso a curarne l’edizione. Dall’epistolario emerge la figura di Girolamo non solo come uomo di Chiesa, ma anche come erudito. Possediamo lettere di vario genere: occasionali, consolatorie, polemico-apologetiche, didattiche ed altre che affrontano temi letterari. Interessanti quelle
che testimoniano il suo lavoro di esegesi biblica che lo condusse a pubblicare il primo testo della Bibbia tradotto in latino, a tutti noto con il nome di Vulgata. La corrispondenza epistolare fu per Girolamo il modo più naturale per esprimere i suoi
pensieri. Per la sua capacità di modularli variamente e di piegare lo stile epistolare
a rendere i più svariati contenuti e a servire a scopi molteplici, «ci ha dato il vero
modello del genere epistolare moderno» (Moricca).
Tra le più note sono le epistole che affrontano il problema del rapporto tra cristianesimo e cultura pagana. Girolamo, lettore e conoscitore dei classici, visse sempre
in modo lacerante il dissidio tra cultura classica pagana e cultura cristiana, come è
dimostrato da questo sogno raccontato in un’epistola inviata ad una sua discepola:
[…] D’un tratto ho come un rapimento spirituale. Mi sento trascinato davanti al tribunale del Giudice, e mi vengo a trovare tra un tale sfolgorio di
luce che irradia da ogni parte, che io, sbattuto a terra, non oso levare in alto lo sguardo. Mi chiede chi sono. «Un cristiano!» rispondo. Ma il giudice
dal suo trono esclama: «Bugiardo! Sei ciceroniano, tu, non cristiano! Dove
è il tuo tesoro, là è il tuo cuore!». Resto di colpo senza parola. […] comincio a giurare, a dare la mia parola, invocando Lui stesso a testimone: «Signore se d’ora innanzi avrò ancora fra le mani un’opera profana, o la leggerò, vorrà dire che t’ho rinnegato!». […] Da quel giorno mi sono messo a
leggere la Scrittura con un ardore che mai ne avevo messo l’eguale nelle
letture pagane.
Girolamo
Di Agostino (354-430, vedi il profilo a p. 664) restano 267 lettere indirizzate, tra il
386 ed il 429-30, a diversi destinatari, tra cui spicca Girolamo. Fu lo stesso autore
a curarne la pubblicazione, dopo aver apportato alcune correzioni. Le tipologie epistolari sono le più varie: lettere consolatorie, dottrinali ed esegetiche, ufficiali, pastorali-organizzative, alcune di carattere intimo. I modelli latini erano ben presenti
ad Agostino, il quale però mostra in molte occasioni di staccarsi dalla tradizione
pagana, per segnare anche a livello stilistico e formale la sua conversione al cristianesimo. Questo atteggiamento si nota in particolar modo nelle lettere consolatorie. Rispetto alla tradizione pagana, in Agostino si riscontra l’assenza delle laudes del defunto, che invece erano sempre presenti negli autori classici, anche in
Ambrogio e Girolamo. Inoltre gli exempla storici vengono sostituiti con esempi tratti
dalle Sacre Scritture.
Ampio spazio viene dedicato al tema della sofferenza. Agostino comprende il dolore dei fedeli e ritiene che non debba essere soffocato dalla ragione, ma debba trovare conforto nella fede, nelle promesse evangeliche e nella speranza della resurrezione dei corpi:
Tuo fratello, cara figliuola, dorme nel corpo ma vive nello spirito; forse
che uno che dorme non si ridesterà mai più? Dio, che ha accolto il suo spirito, gli restituirà il corpo che gli ha tolto, non già perché andasse perduto
ma perché è rinviato il tempo in cui gli sarà restituito […] Questa speranza
non l’hanno i pagani che ignorano la S. Scrittura e la potenza di Dio, il
quale può rinnovare le cose andate in rovina e far tornare in vita quelle
morte, restituire nella loro integrità quelle corrotte, riunire di nuovo quelle
Agostino
trad. di S. Cola
Epist. 263, 4;
trad. di L. Carrozzi
689
690
Retorica e Cristianesimo
disgiunte e conservare senza fine quelle prima corrotte e arrivate alla fine.
Questo ha promesso di fare colui il quale ce ne dà la certezza in virtù delle
promesse che ha già mantenute.
Anche le epistulae exhortatoriae della tradizione pagana sono modificate e adattate alla nuova cultura cristiana. L’esortazione alla sapientia non è più identificabile
con la filosofia dei pagani, bensì con la dottrina cristiana. La finalità delle lettere è
conquistare nuovi proseliti, diffondere il messaggio cristiano, invitando tutti a leggere le Sacre Scritture:
BASSO IMPERO
155, 2, 6;
trad. di L. Carrozzi
Vetro dorato con l’apostolo
Paolo (IV secolo). Città del Vaticano, Museo Sacro.
[…] se vogliamo essere veramente felici – né possiamo non volerlo – teniamo bene a mente la massima imparata dalle stesse Sacre Scritture: Beato chi ripone la propria speranza nel Signore e non segue la falsità né le
pazzie menzognere. […] Riflettiamo quindi, te ne prego, le stolte e pazze
menzogne dei falsi filosofi […].
794
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta
della pubblicità
La dimensione letteraria della retorica:
il passaggio all’Età di Mezzo
De nuptiis Philologiae
et Mercurii
di Marziano Capella
Boezio e Cassiodoro
Con l’Alto Medioevo appare compiuto il distacco della retorica dalla vita politica e giudiziaria, perciò la continuità con la tradizione classica si realizza prevalentemente riguardo al
genere dimostrativo e celebrativo. Indicazioni in tale senso erano state anticipate in epoca
romana. Come si ricorderà, Tacito aveva amaramente riflettuto sul tramonto della libertà
politica e con essa del dibattito oratorio. D’altro canto Quintiliano aveva concesso largo
spazio, nella sua trattazione retorica, allo studio della letteratura, preannunciando
l’assunzione da parte della retorica di una veste letteraria. Non a caso, dal V secolo in
avanti, viene dedicata grande attenzione alla sezione retorica dell’elocutio, che del discorso
cura l’espressione stilistica e che viene sviluppata secondo una suddivisione approfondita
delle figure retoriche. Muta significativamente anche la scelta dei testi retorici della classicità presi a riferimento: si preferiscono i trattati di carattere tecnico e precettistico, come i Topica aristotelici e ciceroniani, la Rhetorica ad Herennium o il De inventione di Cicerone,
piuttosto che le opere di respiro più filosofico, come la Rhetorica di Aristotele o il De oratore ciceroniano.
Al V secolo risale l’opera dal titolo De nuptiis Philologiae et Mercurii («Le nozze della Filologia con Mercurio») di Marziano Capella: è un testo che avrà larga diffusione nel Medioevo e che rivela già dal titolo una struttura allegorica. Allegoria è parola greca che significa
«dire altro, parlare diversamente» e indica una figura retorica la quale, attraverso il riferimento a una cosa, intende significarne un’altra. Dunque poiché l’allegoria allude attraverso
un termine a un significato più profondo, avrà grande fortuna nel Medioevo cristiano, perché tra i luoghi retorici si rivela assai adatta a sottolineare il legame tra le vicende terrene
dell’uomo e la sua prospettiva ultraterrena. Nel De nuptiis le ancelle della Filologia sono le
sette arti medioevali del Trivio e del Quadrivio, che costituivano il fondamento dell’educazione scolastica. Mentre le arti del Quadrivio sono di carattere scientifico (matematica, geometria, astronomia e musica), le arti del Trivio riguardano le discipline del discorso: grammatica, dialettica e appunto retorica, allegorizzata da Marziano Capella con i caratteri regali di una donna maestosa.
Il successo della rappresentazione allegorica è consacrato dalla raffigurazione della Filosofia personificata quale donna consolatrice nella Consolatio Philosophiae di Severino Boezio
(480-524). La figura di quest’ultimo acquista rilevanza per la storia della retorica non solo
perché egli fu traduttore dei Topica ciceroniani, ma soprattutto perché conobbe profondamente gli scritti aristotelici: da Aristotele deriva la considerazione della retorica come subordinata alla dimensione filosofica della dialettica, una costante che accompagnerà tutto il
Medioevo.
Sempre a cavallo dei secoli V e VI si collocano le Institutiones divinarum et saecularium
litterarum – destinate all’educazione dei monaci – di Cassiodoro (490-575); il secondo libro è dedicato alle arti del Trivio e del Quadrivio e quindi anche ad una sezione retorica,
che con lui acquista piena dignità anche in ambiente cristiano, come strumento del quale
la Parola divina possa giovarsi utilmente. Allo stesso periodo risale l’Institutio de arte
grammatica di Prisciano, significativa per la dimensione grammaticale in cui la retorica
viene inserita.
Le artes
Tra il VI e il VII secolo le Etymologiae di Isidoro di Siviglia (570-636) costituiscono la tipica
«enciclopedia» medioevale con la trattazione delle sette arti ed ancora una sintesi retorica
realizzata sulla base dei trattati più tecnici della latinità. Un secolo dopo il Venerabile Beda
(672-735) riprende la ricerca agostiniana delle figure retoriche nel testo delle Scritture. Si
potrebbe accelerare il corso della trattazione affermando che «il tramando attraverso i secoli bui (X e XI secolo) non porta insomma a uno scardinamento del reticolo istituzionale su
cui si regge la retorica, ma tutt’al più a un suo prosciugamento, a una nozionistica sempre
più ridotta e povera» (R. Barilli).
Etymologiae di Isidoro di
Siviglia
Le artes
Allievo del Venerabile Beda fu Rabano Mauro, il quale selezionò dal patrimonio retorico
classico quanto poteva servire all’arte dei predicatori cristiani. Anticipò così le linee che
avrebbero condotto alla compilazione nel XIII secolo dei primi manuali per la predicazione,
i quali assumono il nome tecnico di artes praedicandi e hanno lo scopo di fornire agli oratori cristiani le strutture argomentative atte a difendere la fede dall’attacco delle eresie. Ancora la teoria retorica si intreccia con l’oralità della predicazione. Un caso isolato resta al proposito quello di S. Francesco d’Assisi (1181-1226) il cui carisma fu tale da non necessitare
di strutture retoriche, appoggiandosi quindi sulla sola actio, termine tecnico che designa la
sezione orale dell’esercizio oratorio. Infatti di solito un predicatore aveva bisogno di supportare la sostanza del messaggio con strumenti tecnici retorici, che si andavano differenziando non a seconda del tipo di situazione (come previsto dallo schema classico il quale divide l’oratoria politica da quella giudiziaria e da quella celebrativa) bensì in relazione al tipo
di pubblico: l’oratore utilizzerà toni drammatici con un interlocutore pericolosamente esposto alla minaccia dell’eresia, oppure toni distesi rivolgendosi alla benestante borghesia
mercantile della città. Il mutamento dell’interlocutore è davvero fondamentale: se il predicatore si rivolge ad una platea di studiosi o di ecclesiastici, tenterà di convincerli servendosi
delle più raffinate armi della discussione filosofica; se invece parla al popolo incolto dei
contadini e degli artigiani, utilizzerà massime di comune saggezza, come i proverbi, e strutture di carattere più narrativo che logico, ma soprattutto si esprimerà non in latino bensì in
volgare. Delle parti canoniche dell’orazione viene ad essere valorizzata la dispositio, che
nella retorica si propone di ordinare le parti dell’orazione, come in teologia (cioè nello studio
della scienza divina) vuole dare ordinamento all’universo e al sapere medioevale. Acquista
importanza anche la memoria, che permette di esprimere in maniera semplice alcuni concetti teologici, associandoli ad immagini più concrete ed immediate.
Alle artes praedicandi si associano le artes dictandi, manuali che insegnano ad applicare le
regole retoriche non a una predicazione orale ma a documenti scritti e precisamente a epistole, cioè a lettere. Queste possono avere carattere ufficiale ed essere redatte presso le
corti, la sede papale o le cancellerie (ossia gli «uffici» amministrativi degli stati), oppure essere scritture private dei mercanti e dei notai nelle città. Sono caratterizzate dalla mancanza di un interlocutore fisicamente presente, dal che deriva la svalutazione di due requisiti
canonici del discorso classico: dell’actio, cioè della normativa riguardante la prestazione
oratoria «dal vivo», e della memoria, che non è necessario esercitare trattandosi di documenti scritti. Sono invece importanti la parte iniziale della presentazione (exordium) e quella finale del saluto (salutatio). La struttura feudale delle classi sociali si riflette nella scelta
del lessico e nell’ordine delle parole, da variare a seconda del destinatario più o meno illustre. Le epistole ufficiali, di carattere amministrativo, nascono dalla necessità dei grandi regni di comunicare con tutte le regioni, anche le più lontane. Le lettere di contenuto privato
riflettono invece la vita movimentata delle città, ove hanno la funzione di dare scrittura a un
contratto o a un ordine commerciale: attraverso il loro ruolo pratico, la retorica acquista rilevanza cittadina. Essa diviene l’arte dei governanti e dei legislatori, che hanno necessità di
persuadere della validità delle proposte avanzate.
Rabano Mauro
e le artes praedicandi
Le artes dictandi
795
796
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Boncompagno da Signa
Rettorica di Brunetto Latini
Il principale rappresentante in Italia dell’ars dictandi fu il toscano Boncompagno da Signa
(1170-1240 circa), insegnante di retorica a Bologna e in altre città e autore di una Rhetorica antiqua (meglio nota come Boncompagnus) e una novissima. Il primo ad applicare i canoni dell’ars dictandi al volgare italiano fu Guido Faba, notaio bolognese e anch’egli maestro di retorica, vissuto nella prima metà del XIII secolo. Scrisse manuali tra cui i Parlamenta et epistolae, ove esempi di lettere latine sono tradotti in volgare e presentati in redazioni
di diversa lunghezza.
Ma la figura più di rilievo è quella del maestro fiorentino Brunetto Latini, vissuto nel corso
del XIII secolo, al tempo delle lotte politiche tra ghibellini e guelfi. Lo storico trecentesco
Giovanni Villani lo definisce «sommo maestro in rettorica, tanto in bene saper dire come in
bene dittare», dunque valente nell’oratoria («bene saper dire») e nell’epistolografia («bene
dittare»). Tradusse e commentò i primi capitoli del De inventione ciceroniano, nel testo intitolato Rettorica. Ecco come, in italiano antico, Brunetto si presenta nel Prologo:
L’autore di questa opera è doppio: uno, che di tutti i detti de’ filosofi che fuoro davanti lui e dalla viva fonte del suo ingegno fece suo libro di rettorica, ciò fue Marco Tullio Cicero, il più sapientissimo de’ Romani; il secondo è Brunetto Latino,
cittadino di Firenze, il quale mise tutto suo studio e suo intendimento ad isponere
e chiarire ciò che Tullio aveva detto.
Dante
Il maestro impartisce la lezione
ex cathedra (dalla cattedra).
Per concludere la trattazione della retorica nel Medioevo non è possibile non citare Dante
Alighieri (1265-1321) per la mescolanza degli stili retorici da lui mirabilmente operata nella
Divina Commedia. L’utilizzo dello stile era spesso determinato da motivi di ordine «sociale»:
l’autore sceglieva il registro alto, medio o umile a seconda del grado sociale del destinatario.
Ma il lettore della Commedia è l’umanità intera, cui si propone un cammino di redenzione
cristiana: la divisione degli stili perde di significato e tutti i registri si susseguono nel poema a
seconda delle diverse situazioni. Vi è anche un’opera dantesca, il Convivio, ove la retorica è
paragonata al pianeta Venere e quindi considerata una sorta di persuasione piacevole. Tuttavia per Dante la parte della retorica più rilevante non fu l’elocutio, l’ornamento delle figure
(in consonanza con l’immagine di Venere), bensì la dispositio, l’ordinata disposizione delle
parti del discorso che ancora vuole riflettere l’ordine teologico dell’universo medioevale.
Umanesimo e Rinascimento
Petrarca
Nel XV secolo, attraverso il movimento umanistico, la cultura europea rientra in possesso
di opere letterarie e filosofiche dell’antichità greca e latina, che durante il Medioevo erano
rimaste custodite soprattutto nelle biblioteche dei conventi, senza nutrire di nuovi fermenti il
panorama intellettuale. Anche la retorica vuole riconquistare un legame più schietto con la
sapienza delle fonti classiche.
Il padre della «riscoperta» dei classici è Francesco Petrarca (1304-1374), autore di molte
opere latine e della raccolta di liriche volgari dal titolo di Canzoniere. Egli è tra l’altro lo scopritore del manoscritto contenente le Lettere di Cicerone, attraverso le quali rinnova il genere letterario dell’epistolografia: nei propri Epistolari Petrarca preferisce il modello ciceroniano e si distacca dalle rigide norme delle artes dictandi medioevali. Nella sua produzione
letteraria è possibile individuare «una retorica doppia, quella esterna, dell’uomo pubblico,
del cittadino, dell’oratore che vuole imporre le proprie ragioni, e quella interna, dell’Io dialogante con Dio senza potergli nascondere il proprio cuore»1. L’ideale concreto di oratore è
per Petrarca Cola di Rienzo (1313-1354), il quale, eletto «tribuno» del popolo, si proponeva
di rifondare Roma sul modello dell’antica repubblica (nel periodo in cui la sede del papato
si trovava ad Avignone in Francia e Roma era in preda al disordine politico). La contemporanea Cronica di Anonimo Romano parla infatti di Cola come «nutricato de latte de eloquenzia, bono gramatico, megliore retorico».
1. E. Battistini e E. Raimondi, Retoriche e poetiche dominanti, in Letteratura italiana, Torino 1984, III 1, p. 48.
Umanesimo e Rinascimento
Amico di Petrarca fu il fiorentino Giovanni Boccaccio (1313-1375), autore della raccolta delle cento novelle dal titolo di Decamerone. L’opera denuncia chiaramente la conoscenza da
parte dell’autore dell’Institutio di Quintiliano, il cui testo in forma integrale sarebbe stato ritrovato dall’umanista Poggio Bracciolini in un convento della Svizzera oltre cinquant’anni
dopo. Nel Decamerone si ritrovano inoltre esempi di oratoria, quando i diversi personaggi
pronunciano discorsi e difendono la loro causa in toni appassionati. Dalla lettura delle novelle risulta infine evidente la conoscenza della teoria retorica classica del «riso». Riportiamo la divertente descrizione di frate Cipolla:
Decamerone di Boccaccio
Era questo frate Cipolla di persona piccolo, di pelo rosso e lieto nel viso, e il miglior brigante del mondo: e oltre a questo, niuna scienzia avendo, sì ottimo parlatore e pronto era, che chi conosciuto non l’avesse, non solamente un gran retorico
l’avrebbe stimato, ma avrebbe detto esser Tullio medesimo o forse Quintiliano.
Decamerone VI 10
In un’opera dello stesso Boccaccio dedicata ai miti classici (Genealogia deorum gentilium,
«Genealogia degli dèi pagani») alcune funzioni oratorie (quella della persuasione emotiva
o quella celebrativa o di incitamento alla battaglia) sono considerate prerogative dell’unica
figura del poeta.
Si accennava alla riscoperta dell’Institutio oratoria di Quintiliano, avvenuta nel 1416. Nel
1421 è riportato alla luce anche il De oratore di Cicerone. Questi due fondamentali testi – di
cui già si è rilevato, a proposito della storia retorica latina, il respiro «filosofico» – si affiancano, a partire da quest’epoca, ai manuali tecnici su cui si era esercitata la retorica medioevale, ossia la Rhetorica ad Herennium e il De inventione ciceroniano. L’Umanesimo rilegge i classici non solo latini ma anche greci: questi ultimi erano stati spesso studiati durante il Medioevo non nel testo originale bensì in traduzioni. Gli umanisti si riappropriano
del testo greco della Retorica aristotelica, leggendola non con prevalente interesse filosofico, come in epoca medioevale, ma con angolatura propriamente «retorica». Nessun testo
retorico classico assume comunque la valenza rigida di «manuale di regole», perché gli
umanisti amano esercitare la propria facoltà di giudizio e di libera scelta, e traggono dalla
lettura diretta degli autori greci e latini una sorta di retorica personalizzata.
Tale disciplina, nell’ambito dell’Umanesimo, non è un esercizio fine a se stesso ma si lega
strettamente alla vita politica e sociale delle città. L’umanista Lorenzo Valla (1405-1457)
considera l’oratoria come la più importante delle scienze, proprio per il suo collegamento
con la realtà e con tutte le discipline, dalla letteratura alla storiografia alla filosofia. I protagonisti del primo Umanesimo fiorentino (e, in misura minore, delle altre città) sono maestri, ma
anche funzionari e uomini politici: valga per tutti ricordare la figura del cancelliere di Firenze
Leonardo Bruni (1370 circa - 1444), autore di una Laudatio florentinae urbis, ossia di un encomio di Firenze, che appartiene al genere oratorio celebrativo. Bruni compose anche, non
a caso sul modello del De oratore ciceroniano, i Dialogi ad Petrum Histrum: la persuasione
retorica dell’Umanesimo troverà spesso espressione nella forma del dialogo, che dà voce ad
una pluralità di opinioni diverse, le quali rispecchiano la complessità della vita reale.
È un atteggiamento di apertura che si riflette anche nell’oratoria umanistica, la quale si
esplica soprattutto in occasione delle cosiddette prolusioni, cioè i discorsi di presentazione
delle lezioni all’inizio dell’anno universitario. Gli oratori umanisti non procedono con rigida
organizzazione logica dei passaggi del discorso, ma lo improntano ad una retorica più mobile e meno severa.
Cola di Rienzo (1313-1354), il
notaio romano, amico e ammiratore del Petrarca, tribuno del
popolo.
Valla, Bruni e Poliziano
Prolusioni
Oratio super Fabio Quintiliano
Tra queste prolusioni è da ricordare quella tenuta nel 1480 dal grande poeta e umanista fiorentino Angelo Poliziano (1454-1494), nella quale dialogano due voci non canoniche della letteratura latina: il retore Quintiliano e il poeta Stazio. Il confine tra retorica e poesia
si fa sottile, come testimoniato dal titolo di un’altra opera dello stesso Poliziano, l’Orfeo, personaggio mitologico la cui lira simboleggia
certo la poesia, ma anche la forza psicagogica della retorica. Poliziano non può che rivolgere all’eloquenza parole di lode, nell’Oratio
super Fabio Quintiliano:
Riunì in una sola città gli uomini dapprima dispersi, mise pace tra i contendenti, e avvinse tutti quanti con le leggi, la
morale, con ogni forma, insomma, di educazione umana e civile.
797
798
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Machiavelli
La retorica civile dell’Umanesimo, legata a un’attiva partecipazione politica, trova ancora
voce attraverso Niccolò Machiavelli (1469-1527), che nelle Istorie fiorentine rappresenta le
ultime battute di un’oratoria deliberativa, legata alle urgenze della lotta, nel periodo drammatico che a Firenze conduce dalla caduta del regime repubblicano alla restaurazione del
potere signorile dei Medici. A proposito del tumulto dei Ciompi, cioè dei lavoratori della lana, avvenuto nel 1378, uno dei rivoltosi «de’ più arditi e di maggiore esperienza, per inanimire gli altri parlò», e alla fine dell’orazione «queste persuasioni accesero forte i già per loro medesimi riscaldati animi al male» (III 13).
Arte della guerra
Nell’Arte della guerra, opera in forma di dialogo dello stesso Machiavelli, è rievocata l’eloquenza trascinatrice del capitano militare:
… gli eccellenti capitani conveniva che fussono oratori, perché, sanza sapere parlare a tutto l’esercito, con difficultà si
può operare cosa buona; il che al tutto in questi nostri tempi è dismesso. Leggete la vita d’Alessandro Magno, e vedete
quante volte gli fu necessario concionare e parlare pubblicamente all’esercito; altrimenti non l’arebbe mai condotto, sendo diventato ricco e pieno di preda, per i deserti d’Arabia e nell’India con tanto suo disagio e noia; perché infinite volte
nascono cose mediante le quali uno esercito rovina, quando il capitano o non sappia o non usi di parlare a quello; perché
questo parlare lieva il timore, accende gli animi, cresce l’ostinazione, scuopre gl’inganni, promette premii, mostra i pericoli e la via di fuggirli, riprende, priega, minaccia, riempie di speranza, loda, vitupera, e fa tutte quelle cose per le quali
le umane passioni si spengono o si accendono.
La retorica dei predicatori
Quando tuttavia Machiavelli parla dell’oratoria militare come ormai «dismessa», cioè abbandonata, svela una visione scettica sulla possibilità della retorica di agire concretamente
nella vita politica e anzi nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio ne critica la qualità
negativa di mistificazione, di nascondimento della realtà: ingannevoli sono le interpretazioni
di una retorica al servizio del potere. Nostalgicamente ricorderà l’oratoria delle lotte fiorentine, raccontata soprattutto da Machiavelli, la Rhetorica di Bartolomeo Cavalcanti (15021562), ispirata a quella aristotelica e non a caso costruita in modo da concedere più spazio
a riflessioni etiche che a discussioni tecniche sull’ornamentazione retorica.
Al genere dell’oratoria civile si possono collegare le prediche fiorentine del frate domenicano Girolamo Savonarola (1452-1498), il quale dal pulpito tuonava contro la corruzione, proponendo una restaurazione morale della Chiesa e dell’Italia intera. Nonostante egli ritenga
che la verità dei fatti non abbia bisogno dell’ornamento della retorica, tuttavia si serve nelle
sue omelie di artifici retorici.
Girolamo Savonarola
Si noti per esempio l’inizio incalzante dell’omelia in cui Savonarola propone il «rogo delle vanità», ossia dei libri di argomento pericoloso:
O Italia, o Firenze, fa penitenzia; quia propter peccata tua venient tibi adversa; per li tuoi peccati si apparecchiano grandi tribulazioni. Fa penitenzia, dico, acciò che Dio abbia misericordia di te; voi tenete molti libri in casa che non li doverresti tenere, perché v’è scritto di molte cose inoneste.
S. Bernardino da Siena
L’oratoria omiletica, cioè costituita dalle omelie dei predicatori al popolo cristiano, aveva già trovato nel Quattrocento rinomanza grazie alle prediche volgari di San Bernardino da Siena (1380-1444), dal ritmo vivace, incalzante, dalla forma ben comprensibile all’uditorio dei semplici ma al contempo dotata di accorgimenti retorici:
Dico che la donna è più pulita e preziosa nella carne sua, che non è l’uomo; e dico, che se egli tiene il contrario, egli
mente per la gola: e tolgolo a provare. Vuolo vedere? Ma dimmi, l’uomo non fu egli criato da Dio di fango? – Sì – O
donne, la ragione in mezzo. E la donna fu fatta di carne e d’ossa, si ch’ella fu fatta di più preziosa cosa che tu.
Il Predicatore del Panigarola
La consacrazione teorica della prosa omiletica a genere letterario si avrà un secolo dopo con il manuale dedicato a Il Predicatore di
Francesco Panigarola (1548-1594), egli stesso accreditato oratore, dallo stile impetuoso e mirato ad impressionare gli ascoltatori:
Il Seicento
Cruda, aspra, terribile et horrenda materia da ragionare insieme ci propone oggi la conditione di questi tempi, o Bologna
mia cara; poiché né questa così folta frequenza, né questa inaspettata mia salita al pergamo, né questo mio inusitato modo di ragionare, né questa nuova gratia venuta da Roma, né questo o tremore o pallore o dentro alla mia voce o nel mio
volto altro però ci accennano, altro ci additano, altro ci mostrano, altro ci significano, altro ci figurano, altro c’insinuano
che punitioni, che vendette, che flagelli, che ire, che furori, che pene, che morbi, che morti.
Alla retorica persuasiva e finalizzata a un intervento attivo, civile o religioso, si accompagna
nello stesso periodo una retorica più distesa e colloquiale, sorta di intrattenimento cortese
e cittadino, bene rappresentata dal trattato De sermone dell’umanista Giovanni Pontano
(1429-1503), il quale dalla teoria classica retorica riprende soprattutto le riflessioni aristoteliche e ciceroniane sul riso.
Né è da dimenticare l’esistenza di una retorica «di corte», che si esprime nelle regole che
scandiscono il rapporto tra il cortigiano ed il Signore. Una sezione del De cardinalatu di
Paolo Cortese (1465-1510) descrive le tecniche retoriche, necessarie anch’esse, al pari di
altre discipline, a formare il Cardinale, l’alto prelato ecclesiastico.
Retorica teorica
e «cortese»
Il Cortegiano del Castiglione
Di carattere formale e stilisticamente ornato sarà poi la conversazione con il Principe condotta dal Cortegiano di Baldesar Castiglione
(1478-1529):
Io estimo che la conversazione, alla quale dee principalmente attendere il cortegiano con ogni suo studio per farla grata,
sia quella che averà col suo principe.
(Cortegiano II 18)
All’ambiente della corte si collega anche il genere dell’oratoria diplomatica, che gli ambasciatori dei regnanti dovevano esercitare quando venivano inviati in rappresentanza.
L’oratoria diplomatica presenta le tradizionali caratteristiche sia del genere deliberativo
(perché deve sapere persuadere riguardo a decisioni politiche), sia del genere celebrativo
(quando le viene richiesto di rivolgere complimenti formali ad un illustre interlocutore). Vi
sono scritti che teorizzano le caratteristiche di questa oratoria diplomatica, come il De officio legati («Sui doveri dell’ambasciatore») di Ermolao Barbaro (1453-1493) e Il messaggiero di Torquato Tasso (1544- 1595).
In alternativa alla corte – luogo in cui l’intellettuale si rivolge al Principe con controllato rispetto – si afferma l’Accademia come spazio apparentemente più libero di conversazione
fra letterati. Essa diviene l’unica sede in cui sia possibile apprendere la retorica, che tuttavia vi assume l’aspetto sterile dell’esercitazione scolastica, come appare dall’Orazione in
lode delle Accademie di Scipione Bargagli (1540-1612). Le linee esteriori e celebrative della retorica cinquecentesca sono tracciate dal Dialogo della retorica di Sperone Speroni
(1500-1588). Il nuovo retore è un tecnico che a pagamento si presta a comporre orazioni
celebrative: modello di questo «avventuriero della penna» fu Pietro Aretino (1492-1556).
Un’altra tappa significativa della storia di questa disciplina nel Cinquecento è rappresentata
dall’opera in cui per la prima volta pienamente vengono applicate alla lingua volgare italiana le regole della retorica classica. Si tratta delle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo
(1470-1547) che propongono – come modello assoluto di lingua volgare – la perfezione di
Petrarca per la poesia e di Boccaccio per la prosa, in modo da dotare anche l’italiano di
una «grammatica retorica» che gli consenta di raggiungere l’esemplarità del latino.
Il Seicento
Durante il XVII secolo (l’età barocca) i trattati di retorica diventano espressione delle norme
che regolano la vita della società aristocratica cittadina: essa è scandita dal susseguirsi degli intrattenimenti mondani, in cui acquista un ruolo importante la conversazione cortese. «Il
Le Accademie
Bembo
799
800
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Il secolo della metafora
primato della socialità ripristina la supremazia della retorica in quanto codice eletto che va
posseduto da chi, ammesso in uno spazio privilegiato, voglia partecipare ai riti e alle feste
che vi si celebrano» (Battistini e Raimondi). Poiché la conversazione mondana è volta a
delectare piuttosto che a docere, quindi a divertire invece che ad ammaestrare, la parte
della retorica che acquista maggiore rilevanza è quella dell’elocutio, dell’ornamentazione
stilistica e delle figure retoriche.
Tra queste ultime spicca la metafora, la quale diviene quasi una chiave interpretativa della
realtà. La metafora, come è noto, si ottiene sostituendo a una parola un’altra il cui significato presenti qualche tratto comune con la prima (ad esempio quando per indicare il concetto
di «origine», si utilizza l’immagine della «radice», che però propriamente sarebbe quella di
un albero). Se tuttavia Aristotele raccomandava di costruire questa figura tra termini con significato affine, in modo che il meccanismo retorico fosse facilmente ricostruibile, l’età barocca collega nella metafora vocaboli appartenenti ad aree lontane e non associabili intuitivamente, se non facendo ricorso alla dote dell’ingegno, dell’acutezza intellettuale. La metafora nasconde dunque un significato oscuro: il letterato «vela» il significato ultimo della metafora che il lettore deve «disvelare». Il procedimento comporta da un lato un gioco delle
parti tra letterato e lettore, dall’altro è un modo prudente per non esprimere a chiare lettere
il proprio pensiero nell’età della censura politica e della Controriforma cattolica.
Cannocchiale aristotelico del Tesauro
La teoria della metafora barocca è compiutamente esposta nel Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro (1592-1672) al capitolo VII intitolato Trattato della metafora. Del meccanismo metaforico si dice tra l’altro:
Ingegnosissimo veramente, però che se l’ingegno consiste (come dicemmo) nel ligare insieme le remote e separate nozioni degli propositi obietti, questo apunto è l’officio della metafora, e non di alcun’altra figura: perciò che, traendo la
mente, non men che la parola, da un genere all’altro, esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, trovando
in cose dissimiglianti la simiglianza. Onde conchiude il nostro autore che il fabricar metafore sia fatica di un perspicace
e agilissimo ingegno.
(Cannocchiale aristotelico VII 7 ss.)
Alcuni celebri trattati
I Gesuiti
Il trattato più completo sull’argomento è Agudeza y arte de ingenio («Acutezza e arte dell’ingegno») dello spagnolo Baltasar Gracián (1601-1658). Affine è anche l’opera di Matteo
Peregrini (1595 circa -1652) dal titolo Fonti dell’ingegno ridotti ad arte, ove si approfondisce
la parte tecnica dell’inventio, ossia del reperimento delle fonti, dei luoghi attraverso i quali
costruire metafore argute, nonostante l’autore metta poi in guardia dagli eccessi di acutezza delle figure retoriche.
D’altro canto nel Trattato dello stile e del dialogo del gesuita Pietro Sforza Pallavicino
(1607-1667) la retorica si lega non alla dimensione ingegnosa bensì patetica, drammatica,
perché il fine della predicazione cristiana è piuttosto movere che delectare, cioè commuovere gli animi invece che divertirli. Il concetto del patetico si lega a quello di sublime, cioè
del grado più alto dello stile, che era stato oggetto del trattato greco omonimo, il quale non
a caso in questo periodo conosce rinnovata fortuna. Al terreno dell’oratoria omiletica riporta
anche l’Uomo di lettere di Daniello Bartoli (1608-1685), sempre gesuita, il quale raccomanda al predicatore cristiano non tanto le arguzie dell’ingegno, che servono solo a compiacere chi le inventa e non a colpire l’animo dell’ascoltatore, ma una veemenza solenne, i cui
dettami retorici sono illustrati dall’Eloquentia sacra et humana del gesuita francese Nicolas
Caussin (1583-1651).
Grande importanza fu attribuita alla retorica dai Gesuiti, un ordine religioso caratterizzato
da una vocazione non contemplativa ma attiva, e pronto a lottare contro l’eresia protestante nel clima difficile della Controriforma. I Gesuiti organizzano un raffinato sistema educativo, efficace per rafforzare i propri novizi nell’arte della persuasione. Gli esercizi comprendono sia la parola scritta (nella forma dell’epistolografia, che riguarda la stesura delle lettere),
sia la parola orale (nella forma delle omelie). Lo stile della scrittura è modellato su quello
degli autori latini e greci, la cui lettura viene proposta nella scuola perché l’allievo possa
Il Settecento
esercitare l’occhio a riconoscere in essi le figure retoriche. Sulla falsariga del famoso libro
X dell’Institutio oratoria di Quintiliano (che si svolgeva come una sorta di storia letteraria), la
Bibliotheca selecta del gesuita Antonio Possevino (1533 ca-1611) elenca gli autori classici
la cui lettura viene consigliata ai cattolici. Mentre in un primo tempo la retorica è appresa
per lettura diretta dei testi di Aristotele, Cicerone e Quintiliano, successivamente nascono
manuali e compendi, tra cui il più famoso è il Candidatus rhetoricae di Pomey, edito nel
1659. I Gesuiti sono particolarmente attenti alle indicazioni classiche sull’importanza di variare lo stile in conformità al tipo di destinatario ed infatti adottano diversi registri stilistici a
seconda dei popoli presso cui si trovano in missione o delle classi sociali davanti alle quali
conducono la predicazione. È importante infine sottolineare il legame dell’oratoria gesuitica
con il teatro: il novizio gesuita alla fine del corso di studi dà dimostrazione della perizia retorica raggiunta, attraverso l’esercizio di una rappresentazione teatrale che gli permette di
affinare actio e pronuntiatio, cioè tono della voce, pronuncia, gestualità, in vista della futura
predicazione. Naturalmente il soggetto dello spettacolo è di carattere edificante e ha come
scopo la persuasione retorica: vuole infatti indirizzare lo spettatore verso una determinata
ideologia sia religiosa che politica e conservatrice.
Nel XVII secolo nasce anche la prosa scientifica e con essa un nuovo tipo di retorica, i cui
strumenti sono volti non a persuadere sulla base di argomenti «probabili» bensì a descrivere oggettivamente realtà la cui evidenza è dimostrata dalla ragione. Il filosofo francese Cartesio (1596-1650) fonda il movimento filosofico del razionalismo, che appunto alla ragione
assegna il ruolo primario nel processo di conoscenza del mondo. Ne consegue una svalutazione delle funzioni irrazionali della retorica, come la sua capacità di delectare e movere,
di suscitare emozioni. La sfera emotiva è certo rivalutata da altri filosofi come il francese
Blaise Pascal (1623-1662) il quale contrappone all’esprit de géométrie (lo «spirito di geometria», cioè la ragione della scienza) l’esprit de finesse (lo «spirito di finezza», la ragione
del cuore). Ma a proposito della retorica Pascal afferma: «la vera eloquenza si beffa dell’eloquenza», perché la «ragione del cuore» non può essere espressa a parole.
Dunque la nuova prosa scientifica ha carattere denotativo e referenziale, cioè serve a «denotare», a indicare l’oggetto di cui si occupa, «riferendo» ad esso la parola. L’esempio più
famoso di questa prosa scientifica è certo quello di Galileo Galilei (1564-1642), il fondatore
della «nuova scienza».
Ignazio di Loyola presenta, nel
1540, a papa Paolo III la richiesta per fondare la Compagnia di
Gesù (Roma, Chiesa del Gesù).
La prosa scientifica
Il Settecento
Il Settecento è per eccellenza il secolo della ragione e vede svilupparsi il movimento filosofico dell’Illuminismo, che si propone di analizzare ogni campo dell’esperienza umana attraverso i «lumi», le luci della razionalità. Sulla scia di Cartesio la retorica classica è svalutata
perché persuade e offusca la ragione, la capacità di formulare sulle cose dei giudizi autonomi. In altre parole, la verità non ha bisogno di imporsi attraverso gli ornamenti dello stile
ma si afferma con la sua nuda evidenza. Di fronte all’attacco della nuova scienza le divisioni tradizionali della retorica resistono ma si indeboliscono soprattutto nelle sezioni dell’elocutio (le figure retoriche propriamente dette), dell’inventio (il reperimento delle tematiche
che vengono proposte dalla nuova ricerca scientifica e che quindi non è più compito della
retorica procurare), della dispositio (la disposizione delle diverse sezioni del discorso, anch’essa razionalizzata e semplificata). Si inaugura la fase della cosiddetta retorica ristretta,
limitata ormai ad un esiguo numero di figure.
Alla critica nei confronti di quella classica subentra tuttavia una fase costruttiva, che vede la
fondazione di una retorica nuova, la quale prosegue la linea aperta nel secolo precedente
dalla prosa scientifica, con le sue esigenze di ordine e chiarezza e nello stesso tempo con
l’aspirazione a uno stile che non sia aridamente tecnico. Nasce il genere letterario dell’articolo di giornale e con esso una retorica adeguata: il giornalista adotta un linguaggio e una
disposizione della materia che siano comprensibili al lettore e svolge un ruolo di mediazio-
La retorica ristretta
Il conte Paul Barras, nel suo
abito ufficiale di membro del Direttorio; acquaforte colorata
(Parigi, Bibliothèque Nationale).
801
802
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Giambattista Vico
«Le tribun du peuple» dell’8 ottobre 1794, il giornale di Gracco Babeuf, esempio di stampa
politica rivoluzionaria (Parigi,
Bibliothèque Nationale).
Il sensismo
Un caffè inglese del XVIII secolo. Questi locali divennero la sede dei club politici che animarono la circolazione delle idee a
partire dal Settecento.
ne tra il sapere tradizionale, racchiuso in libri di difficile lettura, e il pubblico dei destinatari
che assimilano e rielaborano le informazioni ricevute nella forma più accessibile dell’articolo. Tra i fini classici della retorica prevale in questo caso la funzione informativa del docere,
che tuttavia diviene un insegnare di tipo non più morale ma strettamente collegato al movimento della vita intellettuale e politica.
Un’originale difesa della retorica è condotta da Giambattista Vico (1668-1744), non a caso
autore di un’opera dal titolo Scienza nuova e filosoficamente avverso al razionalismo di
Cartesio. Professore di eloquenza all’Università di Napoli, nelle prolusioni, ossia nei discorsi di presentazione dei corsi universitari, difende la retorica classica con argomentazioni già
avanzate da Cicerone: come nel grande oratore romano essa si lega a competenze non
solo tecniche ma anche filosofiche e letterarie, così per Vico l’eloquenza non si può
disgiungere dalla sapienza. Egli ritiene che la parola abbia origine divina e che il suo valore
psicagogico, persuasivo, non sia negativo, perché la persuasione può condurre al bene ed
al vero. Alla retorica illuministica e francese della ragione egli ne affianca una italiana del
cuore: mentre la prima si fonda sull’analisi geometrica, la seconda sfrutta tutte le facoltà
umane, come la fantasia, l’ingegno, il senso comune e la memoria. La retorica di Vico non
si occupa solo di ciò che è scientificamente vero ma anche di quanto si presenta solo verosimile o probabile. Non rifiuta la razionalità ma si allea con essa affiancandole la sfera dei
sentimenti. La teoria retorica di Vico diventa anche parte del programma pedagogico da lui
esposto nel De nostri temporis studiorum ratione («Sulla struttura degli studi della nostra
epoca») del 1708: all’educazione degli adolescenti si addice la topica, ossia quella parte
della retorica che insegna a cercare i topoi, i luoghi, i temi da trattare. Come la retorica è
adatta alla formazione dell’età giovanile, così fu conosciuta, sia pure in maniera inconsapevole, dalla «giovinezza» del mondo, dalle epoche primitive. «Nel sistema di Vico la retorica
diventa lo strumento provvidenziale attraverso cui Dio insegna all’umanità, nelle sue fasi
primordiali (primordi sia dell’individuo sia del gruppo), certe verità che questa non sarebbe
in grado di comprendere in versione nuda. Bisogna quindi presentargliele avvolte nella fabula e nell’esempio, condite con linguaggio immaginoso. Ma successivamente, avvenuta
l’evoluzione psicologica, subentrata l’età adulta, sarà possibile accogliere il linguaggio diretto della logica: dalla filologia alla filosofia» (R. Barilli).
Un’altra tendenza retorica del Settecento consiste nell’apprezzamento dello stile alto o sublime, con conseguente rilettura del trattato dell’anonimo greco Sul Sublime. Viene rivalutata
la sfera della percezione dei sensi, per l’influsso del movimento filosofico francese cosiddetto del sensismo. Su questa linea di pensiero, alla retorica interessa più il modo in cui
viene percepito l’oggetto che l’oggetto in sé. L’attenzione si sposta dal messaggio all’effetto
patetico che esso produce sul destinatario, quindi la funzione più importante tra quelle attribuite classicamente alla retorica diviene il movere, il provocare moti dell’animo. Le figure
retoriche non sono più svalutate come ornamento ma diventano importanti per la loro capacità di suscitare emozioni.
Quanto all’oratoria, essa rimane nel XVIII secolo ancora prevalentemente di carattere sacro: nella prima parte del Settecento risente dell’influenza barocca e quindi ha stile ricercato e altisonante, mentre nella seconda metà riflette lo sviluppo della filosofia razionalistica e
procede con rigorosi schemi logici (che tuttavia non la aiutano a creare un clima di comunicazione cordiale con gli ascoltatori). Esiste anche un’oratoria politica, soprattutto legata alla
Rivoluzione francese: anche in essa è possibile individuare due tendenze, una enfatica e
appesantita dalle figure retoriche, l’altra più attenta all’interlocutore, rappresentato dall’assemblea del popolo, tanto da utilizzare anche il dialetto. In Italia il poeta Giuseppe Parini
(1729-1799) si pronunciò in favore di un’eloquenza civile, legata alla vita politica e giudiziaria, lontana dai precetti della retorica classica. Il tragediografo Vittorio Alfieri (1749-1803)
desiderò che l’eloquenza spronasse a reagire contro il potere tirannico, con toni energici da
rafforzare attraverso accorgimenti retorici e un accorto studio della pronuntiatio. Avversò
quindi l’oratoria epidittica e celebrativa, come il genere classico del panegirico rivolto all’imperatore.
L’Ottocento
L’Ottocento
Durante il XIX secolo si approfondisce nella cultura, nella filosofia e nella letteratura il senso
del distacco nei confronti della tradizione classica e di ogni principio di autorità assoluta. Ne
deriva una crescente diffidenza anche verso il tradizionale sistema retorico, inteso come insieme di regole da applicare ad un testo. Addirittura vengono soppresse alcune cattedre universitarie di retorica, come accade in Italia, nello stato Lombardo-Veneto, per opera degli Austriaci. Nel movimento del Romanticismo la retorica perde considerazione, ma tra le arti del
discorso acquista un ruolo importante la poesia: anch’essa vuole persuadere e ha quindi una
connotazione retorica, ma non deve essere condizionata dall’applicazione di schemi rigidi
che anzi ostacolerebbero l’espressione spontanea del sentimento. Il poeta segue la propria
ispirazione e dall’ispirazione è generata naturalmente la struttura retorica. Il testo poetico è
concepito come unione di diverse componenti non separabili tra loro: non è possibile applicare alla poesia una struttura retorica esterna, come se poesia e retorica fossero due momenti
separati. Dell’opera letteraria, sia poetica che prosastica, importa non l’applicazione astratta
delle regole che strutturano il discorso, ma la sua capacità di movere, di spingere all’azione
civile e politica. I retori che hanno bisogno degli artifici dello stile per nascondere la loro mancanza di slancio sentimentale sono i sofisti. È una posizione chiara tra gli intellettuali del Romanticismo lombardo riuniti attorno alla rivista. «Il Conciliatore», i quali ritengono che la letteratura italiana debba porsi il fine di ammaestrare e non di persuadere, perché ancora associano al concetto di persuasione retorica una connotazione negativa di inganno.
Nonostante le opposizioni, la retorica non scompare ma certo si indebolisce soprattutto nella sezione dell’elocutio, che tratta degli strumenti più tecnici delle figure retoriche. Tra queste ultime acquista tuttavia rilievo il simbolo, che allude a un significato nascosto dietro
l’oggetto: il procedimento mentale di associazione dell’oggetto al significato è sintetico e
globale, quindi consono alla concezione romantica che considera il processo creativo come
unitario e non divisibile in operazioni distinte. Permangono manuali tradizionali e un insegnamento scolastico di retorica improntati ad uno schema classico, apprezzato soprattutto
dalla borghesia conservatrice. Ma la continuità retorica acquista una dimensione più vitale
lontano dalle formulazioni precettistiche, incarnandosi in maniera libera all’interno dei testi.
Vi sono scrittori che si servono degli strumenti retorici nel vivo dell’opera letteraria anche se
in teoria li rifiutano, come il romanziere francese Victor Hugo (1802-1885) di cui è rimasto
famoso il motto «Guerra alla retorica e pace alla sintassi!». Vi sono autori che ad esempio
utilizzano il tradizionale criterio dell’ordo, dell’ordine delle parole, ma nel contempo lo stravolgono, perché le parole non si dispongono più secondo l’ordine razionale della logica
bensì seguendo quello imprevedibile che i sentimenti dettano. O ancora prestano attenzione al destinatario del loro testo, in tal modo richiamando l’importanza tradizionalmente attribuita dalla retorica al particolare tipo di pubblico.
Alessandro Manzoni (1785-1873) propone quindi un utilizzo moderato e sapiente della retorica, che sia «discreta, fine, di buon gusto». Nell’Introduzione alla sua opera più famosa,
il romanzo I Promessi sposi, così parla a proposito del manoscritto seicentesco da cui
avrebbe avuto origine il racconto:
L’antica retorica
del Romanticismo
Il recupero del «simbolo»
Alessandro Manzoni
Il buon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virtù; ma poi,
nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, lo stile cammina ben più naturale e più piano. Sì; ma com’è dozzinale! com’è sguaiato! com’è scorretto! Idiotismi lombardi a iosa, frasi della lingua adoperate a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati. E poi, qualche eleganza spagnola seminata qua e là; e
poi, ch’è peggio, ne’ luoghi più terribili o più pietosi della storia, a ogni occasione
di eccitar maraviglia, o di far pensare, a tutti que’ passi insomma che richiedono
bensì un po’ di rettorica, ma rettorica discreta, fine, di buon gusto, costui non manca mai di metterci di quella sua così fatta del proemio.
Il poeta Giosuè Carducci (1835-1907) ritiene la retorica strumento indispensabile per chi Carducci e Pascoli
come lui scriva in versi, perché, essendo il poeta una sorta di «operaio» della letteratura,
803
804
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
L’oratoria pubblica
Foscolo
Monti
D’Annunzio
La retorica nella modernità
L’iperbole
La persuasione occulta
necessita di adeguate tecniche. Né del resto sarebbe possibile neppure al lettore di poesia,
al critico letterario, intendere correttamente il testo senza conoscerne l’intelaiatura retorica.
Mentre Carducci rinsalda l’unione della retorica con la poetica, un altro poeta famoso, Giovanni Pascoli (1855-1912), ritiene che chi compone versi debba occuparsi solo di poesia e
non assumere le funzioni dell’oratore: certo le figure retoriche sono utilizzate dalla poesia,
ma non con fini persuasivi, bensì per riuscire a vedere, attraverso il simbolo, l’essenza vera
delle cose, al di là delle apparenze.
Quanto all’oratoria di carattere pubblico, cessa di dare voce al potere politico dominante,
per divenire strumento di protesta e di opposizione. È quindi coltivata in Italia dagli scrittori
democratici, dai patrioti del Risorgimento.
Anche il poeta Ugo Foscolo (1778-1827) aveva creduto a un’eloquenza non alleata del potere ma capace di denunciarne gli abusi. Se l’eloquenza è l’arte del persuadere, essa avrà
maggiore efficacia sui sentimenti che sulla ragione: si riaffaccia la retorica del trattato greco
Sul Sublime, che tuttavia – in linea con il rifiuto ottocentesco per ogni principio di autorità –
non è accettato dal Foscolo come fonte indiscutibile di ispirazione. Egli afferma infatti che
del trattato si potrebbero salvare solo poche pagine ma facendone quasi dei «manifesti»
per le scuole di eloquenza. In altre parole, della teoria greca sul sublime è mantenuta
l’esortazione al movere, l’invito a suscitare sentimenti, ma se ne perde l’illusione che lo stile alto nasca solo da una tecnica linguistica, ad esempio dall’uso di figure retoriche o dalla
scelta di vocaboli solenni, invece che da uno slancio politico e civile.
Anche il poeta Vincenzo Monti (1754-1828) nelle Lezioni di eloquenza esorta a fidarsi più
degli slanci del cuore che dei precetti della retorica per divenire eloquenti. Tuttavia non
ama il modello di oratoria rappresentato nell’antichità da Demostene e ora incarnato nella
figura di poeta e soldato del Foscolo. Ritiene infatti che questa eloquenza trascinante possa avere fini sanguinosi, come nel caso della Rivoluzione francese, e ne preferisce una forma più distesa.
Esempio emblematico di oratoria pubblica è rappresentato dai discorsi pronunciati e riflessi
nelle opere del letterato Gabriele D’Annunzio (1863-1938). Si tratta di un’eloquenza tanto
impetuosa da sembrare teatrale per l’importanza accordata alla presenza fisica dell’oratore
quasi più che alla sua parola. Questi non si rivolge a una folla impersonale e lontana ma instaura con essa un rapporto diretto, basato su un coinvolgimento intenso e non su un accordo solo intellettuale. L’oratore risulta una sorta di «capo carismatico» della folla, per
l’influenza che esercita su di essa, in un vincolo così stretto da creare quasi un rito collettivo.
La rivoluzione industriale e il delinearsi della società di massa mutano anche la funzione
della letteratura, soprattutto nella dinamica della comunicazione con un nuovo pubblico e
nel rapporto con l’industria dell’editoria. Anche la retorica si adegua al mutamento, reinterpretando i generi tradizionali in forme consone ai tempi. Il genere deliberativo si trasforma
nell’oratoria delle aule parlamentari, mentre il genere giudiziario riscuote un grande interesse popolare, presentando nei tribunali processi in cui gli avvocati sfoggiano doti oratorie
quasi teatrali. La retorica si specializza per accontentare un pubblico che si va sempre più
differenziando: tra i vari manuali di retoriche settoriali sono da ricordare quelli che insegnano le tecniche di recitazione per il teatro, perché l’importanza data alle specialità classiche
dell’actio e della pronuntiatio, delle doti vocali e gestuali indispensabili per recitare, si riflette in tutte le manifestazioni oratorie, al di là di quelle specificamente teatrali.
Anche il genere celebrativo trova un nuovo linguaggio nell’espressione della pubblicità, improntata ad una retorica dell’iperbole, dell’esagerazione, necessaria per catturare
l’attenzione di un lettore distratto, da stupire con l’incisività del messaggio commerciale. È
possibile parlare anche di una retorica della persuasione occulta, soprattutto a proposito di
giornali e riviste, che spesso nascondono dietro un’apparenza descrittiva un intento politico. I meccanismi della retorica incarnati nella nuova dimensione industriale della cultura sono ben compresi da Renato Serra (1884-1915), intellettuale romagnolo dalle aperture europee, che non a caso nelle sue Lettere dedica una sezione a «Il mercato e gli aspetti della
produzione libraria».
Il Novecento
Il Novecento
Il Novecento si apre in Italia nel segno della negazione della retorica avanzata dal filosofo
Benedetto Croce (1866-1952). Nell’opera giovanile dal titolo di Estetica (1902) Croce ritiene infatti che l’arte nasca dall’intuizione e dalla fantasia, doti «spontanee» che non necessitano dell’apparato tecnico delle figure retoriche. Il rifiuto della retorica pare mitigato nell’opera più tarda intitolata Poesia (1936), ove si riconosce proprio alla poesia una funzione
persuasiva e quindi una connotazione retorica, per quanto quest’ultima appaia comunque
svalutata come insieme di espedienti pratici di cui purtroppo non è possibile fare a meno.
L’arte come strumento di persuasione retorica è guardata con interesse dagli intellettuali
che si propongono di influenzare la massa popolare nell’intento di rinnovare positivamente
la vita culturale e politica della nazione. Ciò appare soprattutto nella rivista «La Voce», fondata nel 1908 con il fine appunto di dare voce ad un nuovo partito degli intellettuali ed al loro proposito di rinnovamento. Il primo direttore fu Giuseppe Prezzolini (1882-1982), autore
non a caso di un’Arte di persuadere, che descrive cinicamente l’aspetto carismatico del retore, capace di convincere e anche ingannare la massa utilizzando il registro emotivo invece di quello logico delle argomentazioni. A questa visione spietata della retorica risponde
amaramente la teoria esposta nella tesi di laurea La persuasione e la rettorica del giovane
intellettuale Carlo Michelstaedter (1887-1910). Michelstaedter parla della retorica in termini
non tecnici bensì filosofici, distinguendo una persuasione illusoria e una persuasione autentica. La persuasione di cui l’uomo si può valere è illusoria quando vuole rimuovere il problema di fondo costituito dalla realtà della morte e del dolore e si fonda su valori non reali
ma apparenti, organizzati dalla retorica. La persuasione è invece autentica quando nasce
dalla consapevolezza della natura mortale dell’uomo, accettando la quale sarà possibile vivere almeno in maniera cosciente e responsabile.
Sono gli anni pieni di tensione ed incertezza che precedono l’entrata dell’Italia nella prima
guerra mondiale e anche all’interno della rivista «La Voce» si crea una spaccatura tra coloro
che vorrebbero partecipare attivamente alla lotta politica e coloro che, delusi, vorrebbero rifugiarsi nella letteratura. Non a caso muta la direzione della rivista, che nel 1914 passa sotto la
guida di Giuseppe De Robertis (1888-1963), accusato di essere un retore di vecchio stampo
per la sua convinzione dell’utilità degli strumenti retorici soprattutto per chi eserciti la professione di critico letterario: è una posizione che si avvicina a quella già esaminata del Carducci.
Il clima concitato che precede la guerra influisce anche sull’oratoria, la quale prende la forma
dei discorsi tenuti nelle piazze dai rappresentanti delle diverse posizioni: gli interventisti, che
sostenevano il coinvolgimento dell’Italia nel conflitto, ed i neutralisti, che invece volevano conservare al Paese una posizione neutrale. Questa oratoria potrebbe essere compresa nell’antico genere deliberativo o politico, ma il tono è più che semplicemente persuasivo, è violento: il
retore si configura come un agitatore delle masse. Lo svolgersi degli eventi conduce al primo
dopoguerra, quando alle folle deluse parlano retori demagoghi, che mirano ad una persuasione politica del popolo fondata su argomenti emotivi. Nel successivo periodo fascista la retorica
è utilizzata per produrre nelle masse un clima di consenso nei confronti del regime politico.
Un aspetto sempre importante da considerare è anche quello della retorica incarnata nei
testi, ossia non discussa teoricamente ma sperimentata nella pratica della letteratura. Valgano al proposito due esempi antitetici e significativi, rappresentati dalle figure di due narratori: Carlo Emilio Gadda (1893-1973) e Italo Calvino (1923-1985). Gadda utilizza le figure
retoriche con un’abbondanza che può parere eccessiva e difficile, come se volesse attraverso di esse rappresentare la vita reale con tutta la sua complessità. Le figure non devono
denotare la realtà rispecchiandola in maniera cruda, ma connotarla nella sua polisemia,
cioè nella contemporanea presenza di tanti significati diversi e non di uno solo. Non a caso
egli, nella Meditazione milanese, si dichiara ammiratore di Cicerone. È inoltre sensibile all’antica caratteristica retorica del linguaggio chiamata pronuntiatio («pronuncia», «dizione»), perché scrive alcune Norme per la redazione di un testo radiofonico.
A Calvino interessa invece non tanto la complessità retorica dello stile, quanto la linearità
del racconto, che si dipana chiaro e rispettoso dell’antico ordo retorico, cioè dell’ordine del-
Croce
Il gruppo de «La Voce»
Cerignola (Bari): il giovane
Giuseppe Di Vittorio, ex bracciante, deputato socialista dal
1921, esponente della CGIL di
cui sarà il leader indiscusso nel
secondo dopoguerra, arringa i
lavoratori.
Gadda e Calvino
805
806
Dalla retorica pubblica alla persuasione occulta della pubblicità
Perelman
Curtius e la storia
dei topoi
Linguistica, strutturalismo,
formalismo
La psicoanalisi
La semiologia
le parti e della loro combinazione. Interessante risulta il romanzo intitolato Se una notte
d’inverno un viaggiatore, perché svela al lettore il meccanismo della narrazione e spiega il
funzionamento degli artifici letterari e retorici, che sono i ferri del mestiere dello scrittore.
Per intendere tuttavia le nuove prospettive offerte alla retorica dal Novecento occorre uscire d’Italia e ricordare innanzitutto il Trattato dell’argomentazione del logico belga Chaïm Perelman (1912-1984). Perelman vuole dimostrare la validità della persuasione retorica, affinché non venga svalutata nei confronti della dimostrazione scientifica. La scienza logica e
matematica si occupa infatti solo di ciò che si presenta vero e razionalmente dimostrabile,
ma trascura il verosimile, il probabile, l’indefinito, ossia quelle aree dell’esperienza umana a
cui si rivolge la persuasione retorica. Perelman ripropone il pensiero retorico di Aristotele,
sottolineando l’importanza di inventio e dispositio, ossia delle tecniche che permettono di
trovare gli argomenti e disporli, e rivalutando l’elocutio, per il suo valore inerente non solo
alla forma esteriore delle figure retoriche, ma anche al contenuto del discorso.
Molte altre sono le direzioni della ricerca novecentesca sulla retorica, a cui è possibile solo
accennare. Fondamentale è ad esempio Letteratura europea e medioevo latino del critico e
storico della letteratura tedesco Ernst Robert Curtius (1886-1956), che analizza diacronicamente, cioè attraverso le epoche, dall’antichità ai giorni nostri, il succedersi dei topoi, i «luoghi» retorici. Di Curtius è allievo lo studioso Heinrich Lausberg, autore di una sorta di enciclopedia delle figure retoriche. Non a caso il contesto è quello tedesco, ove sembra necessario approfondire lo studio retorico, dato che «l’ignoranza dei trucchi retorici ha permesso
a Hitler di ammaliare con una psicagogia di massa senza precedenti un popolo retoricamente indifeso perché senza maestri d’oratoria» (Battistini e Raimondi).
E ancora nel corso del Novecento lo studio della retorica si intreccia con quello di nuove discipline come la linguistica (è il caso di un allievo di Lausberg, il linguista e critico letterario
Harald Weinrich) e la «sociologia della letteratura» (nella scuola strutturalista di Praga). La
retorica si identifica con l’analisi linguistica del testo (nel movimento russo del formalismo)
o coincide con la poetica, nel senso che l’opera poetica è considerata inscindibile dalla
struttura retorica (come sostenuto dai new critics statunitensi).
Grande è stata l’influenza della psicoanalisi fondata dal dottor Sigmund Freud (1856-1939),
perché permette di intendere le figure retoriche anche come espressione del profondo inconscio, della componente irrazionale dell’uomo. Un cenno va infine al teorico e critico della letteratura Gérard Genette (n. 1930) con la sua teoria della retorica ristretta (cioè ridotta
progressivamente nei secoli a studiare solo l’elocutio, le figure, e tra esse soprattutto la metafora) e al cosiddetto «gruppo m di Liegi», che ha classificato minuziosamente le figure,
però confermando di interessarsi alla sola sezione retorica dell’elocutio.
Interessante infine la collaborazione della retorica con la semiologia, cioè con la nuova scienza che studia i «segni» (non solo linguistici, ma anche visivi, gestuali e così via) che è possibile interpretare sulla base di un codice conosciuto e accettato dalla società: anche la retorica
può quindi offrire gli strumenti per interpretare i fenomeni culturali. Ciò accade a maggior ragione nella nostra era elettronica, che – attraverso la comunicazione permessa da telefono,
radio, televisione e computer – ha rivalutato le doti retoriche della actio (la gestualità di un
personaggio televisivo), della pronuntiatio (la dizione, importante per rendere incisiva la voce
radiofonica) e della memoria (di cui necessita l’improvvisazione del cronista). Queste qualità
non erano indispensabili quando la trasmissione della cultura e delle informazioni avveniva
solo attraverso il libro, la pagina scritta, la quale impegnava il lettore in una comprensione solitaria e solo visiva. La dimensione collettiva e acustica era propria dell’oratoria antica, greca e
romana, e lo è di nuovo della retorica moderna, attraverso i mezzi di comunicazione planetaria. L’antico genere oratorio deliberativo o politico è rinnovato continuamente nelle discussioni
delle assemblee di ogni tipo; il genere giudiziario è presente ben al di fuori delle aule di tribunale: in quanto discorso con cui si esprime un giudizio, esso si realizza tutte le volte in cui
l’opinione pubblica, sollecitata dai mass media, risponde attraverso la propria opinione che
giudica. Infine il genere epidittico o celebrativo è quanto mai vivo attraverso la pubblicità. Il
destino della retorica pare quindi indirizzato all’applicazione in campi ben più vasti di quello
letterario, come ipotesi interpretativa della cultura e della società.