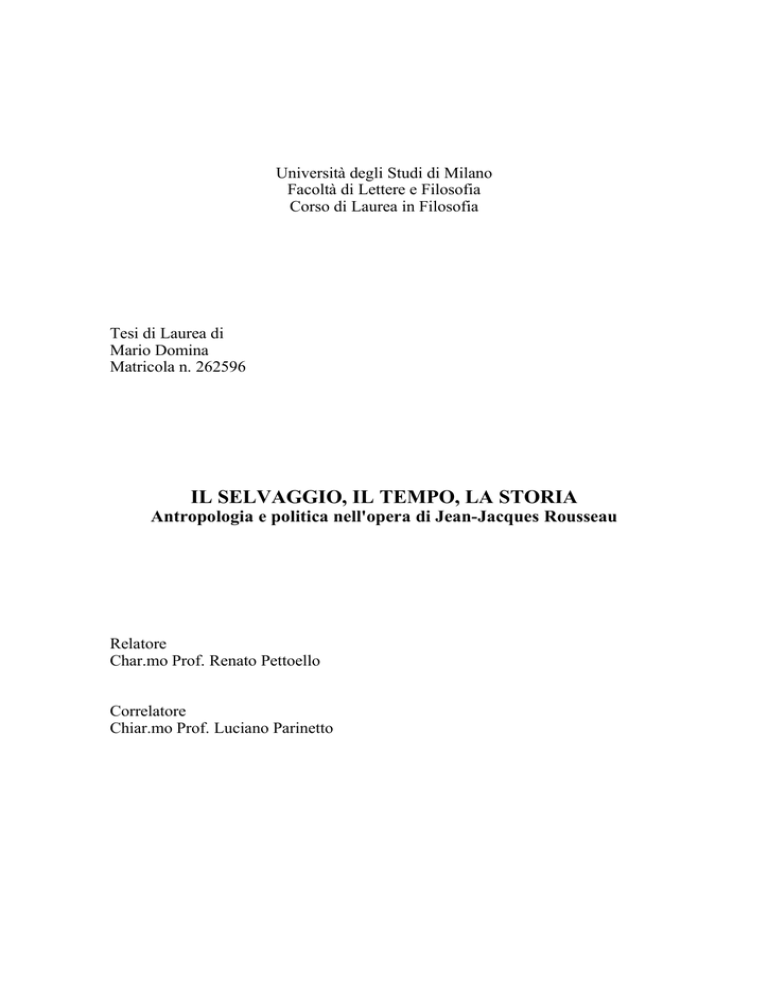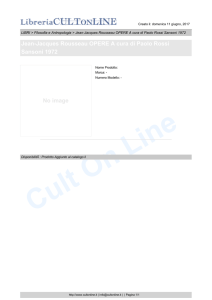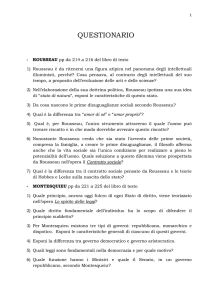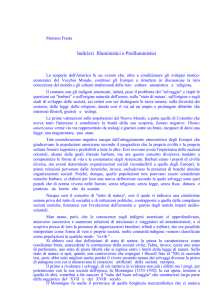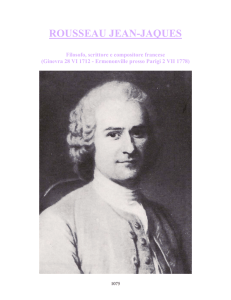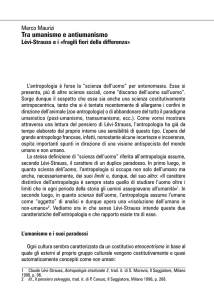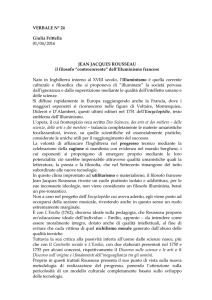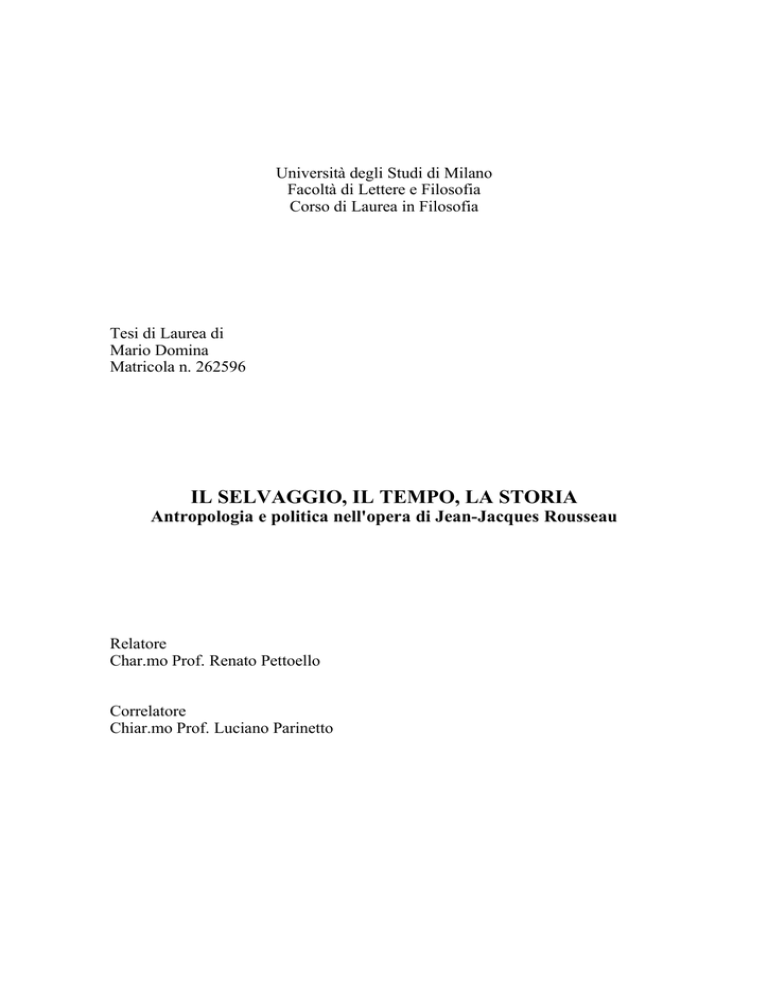
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Filosofia
Tesi di Laurea di
Mario Domina
Matricola n. 262596
IL SELVAGGIO, IL TEMPO, LA STORIA
Antropologia e politica nell'opera di Jean-Jacques Rousseau
Relatore
Char.mo Prof. Renato Pettoello
Correlatore
Chiar.mo Prof. Luciano Parinetto
Anno Accademico 1996/97
Indice
p. III
Premessa
I. Il “selvaggio” tra mito e scienza (da Montaigne a Montesquieu)
2
5
11
22
1. Il dibattito sulle origini del Nuovo Mondo
2. La critica dell'etnocentrismo in Montaigne
3. L'immagine del selvaggio e lo stato di natura
4. Teoria dei climi e sauvagerie in Montesquieu
II. L'uomo naturale e il selvaggio nei Discorsi di Rousseau
39
45
49
55
70
73
79
88
90
1. Età dell'oro e degenerazione
2. Le basi dell'antropologia roussoiana
Metodo ed esperienze
Il selvaggio, i selvaggi: prototipo ed exempla
3. L'uscita dallo stato di natura
Il ruolo dell'hazard nella storia congetturale
Popoli selvaggi e barbarie: il livello intermedio delle “società nascenti”
Al di là del Discours sur l'inégalité:
percorsi per una “resurrezione” possibile dell'uomo naturale
4. La Tahiti mitica di Diderot
III. La sintesi di “natura” e “cultura”
99
108
111
125
129
132
142
1. L'isola di Clarens
2. La formazione dell'uomo naturale
Necessità e sensibilità
L'ordine morale
«Riunire i vantaggi dello stato naturale con quelli dello stato civile»
3. Natura e convenzione:
dall'antropologia del sauvage alla politica del citoyen
4. Rousseau scisso, Jean-Jacques sauvage
IV. Antropologia e storia
156
160
163
172
184
194
1. Un breve riepilogo ed un chiarimento dovuto
2. Il selvaggio, il tempo, la storia
Excursus. Alcune note sull'“idéologie rousseauiste” di Lévi-Strauss
3. La nozione di progresso: Voltaire contra Rousseau
4. Rousseau e la “società immaginaria”
Bibliografia
II
Premessa
Sono ormai trascorsi cinquecento anni da quando gli Europei hanno scoperto, o
hanno creduto di scoprire, i “selvaggi” del Nuovo Mondo. Oggi, che di quell'umanità
più espropriata che esplorata rimangono poche vestigia e molte macerie, e dopo che
l'etnologia e l'etnografia ce lo hanno ampiamente documentato, sappiamo essersi trattato
di un complesso straordinariamente variegato di culture, di organizzazioni sociali, di
costumi e di modi di vita.
È vero però che i selvaggi, come ha osservato Cocchiara, sono stati più
un'invenzione che una scoperta, e proprio per questo un denso ricettacolo di simboli, di
paradigmi, di metafore – in ogni caso «uno dei maggiori protagonisti della nostra storia»
dal ‘500 ad oggi . Un'invenzione cui, a parere di Gliozzi, se ne sarebbe sovrapposta
1
un'altra di carattere storiografico: quel mito del buon selvaggio desumibile dalla
letteratura francese dei secoli XVI e XVII e concernente i viaggi, le esplorazioni, gli
stanziamenti coloniali degli Europei nel Nuovo Mondo, mito che avrebbe poi celebrato i
suoi fasti nell'epoca dei lumi, a voler ben guardare è più una costruzione ideologica
della storiografia tra ‘800 e ‘900, di quanto in realtà non sia direttamente reperibile nei
récits e nelle opere che ad essi si ispiravano .
2
Diventa così difficile penetrare la spessa cortina del tempo e della storia, che su
quella figura – che pure doveva essere l'immagine della purezza e della semplicità delle
1
Cfr. G. COCCHIARA, L'eterno selvaggio. Presenza e influsso del mondo
primitivo nella cultura moderna, Il Saggiatore, Milano 1961, pp. 15-16.
2
Cfr. G. GLIOZZI, Il mito del “buon selvaggio” nella storiografia tra Ottocento
e Novecento, saggio apparso nel 1967 nella “Rivista di filosofia”, LVIII, ora in
Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti 1966-1991, a cura di
A. Strumia, Vivarium, Napoli 1993, pp. 25-81.
III
origini – hanno finito per depositare la molteplicità di simboli rilevata da Cocchiara,
proiezioni tutte generate da problemi interni alla civiltà europea e che poco spazio
hanno lasciato all'osservazione oggettiva, non eurocentricamente orientata, dell'alterità
che nel Nuovo Mondo si era nel frattempo venuta profilando. Le estese ricerche di
Sergio Landucci e di Giuliano Gliozzi, pur nella diversità dell'approccio, oltre che dei
limiti temporali, hanno senz'altro chiarito che la figura del selvaggio appare quanto mai
poliedrica e complessa, proprio perché inestricabilmente connessa alle diverse posizioni
ideologiche, culturali o “nazionali” dei vari autori che vi si riferiscono.
Quella poliedricità, manifestatasi in un arco temporale che va all'incirca da
Montaigne a Montesquieu, troverà infine una sua poderosa sintesi, così da costituirne
per certi versi la pietra angolare, nel pensiero antropologico di Jean-Jacques Rousseau.
Il presente studio, che ha come proprio oggetto specifico il significato che la figura del
selvaggio viene via via assumendo entro lo sviluppo del “sistema” roussoiano, muove
però dalla critica netta del tradizionale assunto secondo cui egli sarebbe il maggior
rinnovatore settecentesco del mito (mito che, peraltro, è dubbio sia mai esistito, se non
in una parte minoritaria della letteratura).
Certo, per quanto concerne Rousseau si deve tener conto anche di talune
connotazioni rievocative dell'età dell'oro, della mistica della natura o della nostalgia
della semplicità delle origini, tutte cose legate forse all'«interpretazione del primitivo
che è in noi» di cui ha parlato Mircea Eliade; ma l'interesse precipuo per i selvaggi
finisce per operare in ambiti che con il mito non hanno più a che fare: proprio perché le
società selvagge si sono arrestate ad un certo punto dello sviluppo storicoantropologico, rendono con ciò più agevole la ricostruzione dell'ipotetico uomo
primitivo del puro stato di natura, e del delicato passaggio natura-cultura, fornendo ad
un tempo un modello antropologico ed un tipo di società utili (forse) a suggerire
IV
percorsi alternativi al processo di snaturamento e alla dialettica storica delle
diseguaglianze socio-economiche che quel processo comporta. La figura del selvaggio si
collocherebbe in tal modo al centro della storia della specie (che non è la storia
dell'Antico Mondo): in primo luogo evocandone il passato e contribuendo
metodologicamente all'ascesa vertiginosa alle origini, visto che nel caso di alcune
culture primitive non vi sarebbe stato un allontanamento radicale dal puro stato di natura
(fatto ad esempio constatabile presso i Caraibi o gli Esquimesi); in secondo luogo i
popoli selvaggi sono nondimeno collocabili entro un segmento temporale – uno stadio –
ben determinato; infine il selvaggio rinvia, pur non identificandosi con esso, all'uomo
naturale e ad un tipo ideale di società che non si pongono affatto fuori della storia, ma
che sono attingibili in un futuro utopico da prefigurare ed insieme ricostruire.
Quest'ultimo aspetto denota a nostro parere una concezione della politica – del
contratto sociale e della sua futura istituzione storica – che non può non tener conto di
un modello antropologico alternativo (ideale ed utopico, appunto) a quello storicamente
realizzatosi, respinto da Rousseau in maniera inequivocabile. D'altro canto, ci pare di
dover simmetricamente criticare una lettura che, privilegiando il lato antropologico,
finisce per relegare ai margini il discorso più propriamente politico (ed eventualmente
rivoluzionario). A tal proposito, nel dichiararci grati debitori dell'entusiastica lezione
che Lévi-Strauss ha saputo impartire attraverso la sua nota ed originale rilettura dei testi
roussoiani, dobbiamo tuttavia denunciare con Michèle Duchet il pericolo grave di
separazione ideologica che dall'aver eletto Rousseau a primo etnologo e fondatore delle
scienze umane potrebbe derivare: la frattura tra antropologia e politica sembra recare
con sé il rifiuto dell'agire politico ed in ultima analisi la rinuncia alla dimensione storica
propria della specie – luogo per eccellenza della libertà e della perfettibilità, dunque
della trasformabilità dell'esistente .
1
1
Si veda in proposito il capitolo “Le rousseauisme de Claude Lévi-Strauss ou le
V
Nessun ritorno nostalgico alla natura appare pertanto desiderabile, e neppure la
fuga verso lontane sponde esotiche: Rousseau è un osservatore serio ed attento del
mondo selvaggio (auspica anzi che la filosofia cominci finalmente a viaggiare, e non
solo in compagnia di mercanti e di cannoni), e tramite esso – il più lontano e diverso –
ha modo di studiare integralmente l'uomo, conoscenza che si ottiene, come avverte nel
Saggio sull'origine delle lingue, coll'«imparare a spingere lo sguardo lontano», proprio
perché «occorre prima osservare le differenze per scoprire le proprietà». Riflessione
eminente, dunque, intorno a identità e diversità: contro quel che pensa uno dei suoi
maggiori studiosi americani, Rousseau è coerentemente antietnocentrico (pur esaltando
le patrie) e, insieme, radicalmente anticolonialista. Il programma di superamento
dell'uomo etnocentrico delineato di recente da Remo Cantoni, trova anzi in lui, dopo
Montaigne, un ineguagliabile sostenitore, se è vero che l'interesse per le scienze umane
(ambito della conoscenza fino ai suoi tempi trascurato, come è detto nel Discours sur
l'inégalité), e l'impulso dato al loro sviluppo, in particolare all'antropologia,
contribuiscono in misura notevole, e potremmo dire in via preliminare, alla critica del
pregiudizio etnocentrico.
Ed è proprio da qui che partiremo. Dal contraccolpo che la novità e radicale
diversità del Nuovo Mondo provoca negli uomini di cultura e nei filosofi dell'epoca
moderna. Ciò ci consentirà inoltre di raccogliere i lati sparsi della poliedrica figura del
selvaggio e di vederne il riproporsi complessivo ed emblematico nella filosofia di
Rousseau. Seguiremo il dispiegarsi della sua eco non solo nei Discorsi e nell'Emilio,
dove i riferimenti alla sauvagerie sono più cospicui e frequenti, ma anche nell'opera più
tarda e, se così possiamo dire, fin dentro l'esistenza tormentata di un Jean-Jacques scisso
territoire de l'ethnologue” in M. DUCHET, Le partage des savoirs. Discours
historique, discours ethnologique, La Découverte, Paris 1984, pp. 192-218.
VI
ed in fuga dal mondo.
Vedremo così emergere, se la nostra lettura è corretta, un paradigma che allude
insieme all'uomo naturale (cifra e summa di tutto il pensiero roussoiano) e ad alcuni
suoi tratti esistenziali, oltre che ad un modello di società nascente che non
necessariamente sia da confinare nei tempi mitici dell'età dell'oro: alla definitiva
interdizione del ritorno alle origini non corrisponde infatti l'inesorabilità del corso
storico, entro cui è anzi prospettabile un'eventuale mutazione antropologica.
Se da tutto ciò dovesse poi nascere l'impressione di un qualche cedimento alle
illusioni primitivistiche derivanti dalla nebulosa dell'idéologie rousseauiste, sì
aspramente combattuta dalla Duchet, si tratterebbe probabilmente di un moto inconscio,
un esito non voluto e non perseguito razionalmente – generato forse da quell'universale
disagio della civiltà indagato da Freud, e che è del resto trasversale alle culture (oltre
che comune agli individui). Ma crediamo che proprio uno studio sistematico
dell'antropologia roussoiana, del posto che la figura del selvaggio non miticamente
intesa vi occupa, possa svolgere un'importante funzione chiarificatrice circa la radicalità
di un pensiero che ben poco si nutre o si illude di impossibili ritorni ad edenici mondi
perduti.
VII
VIII