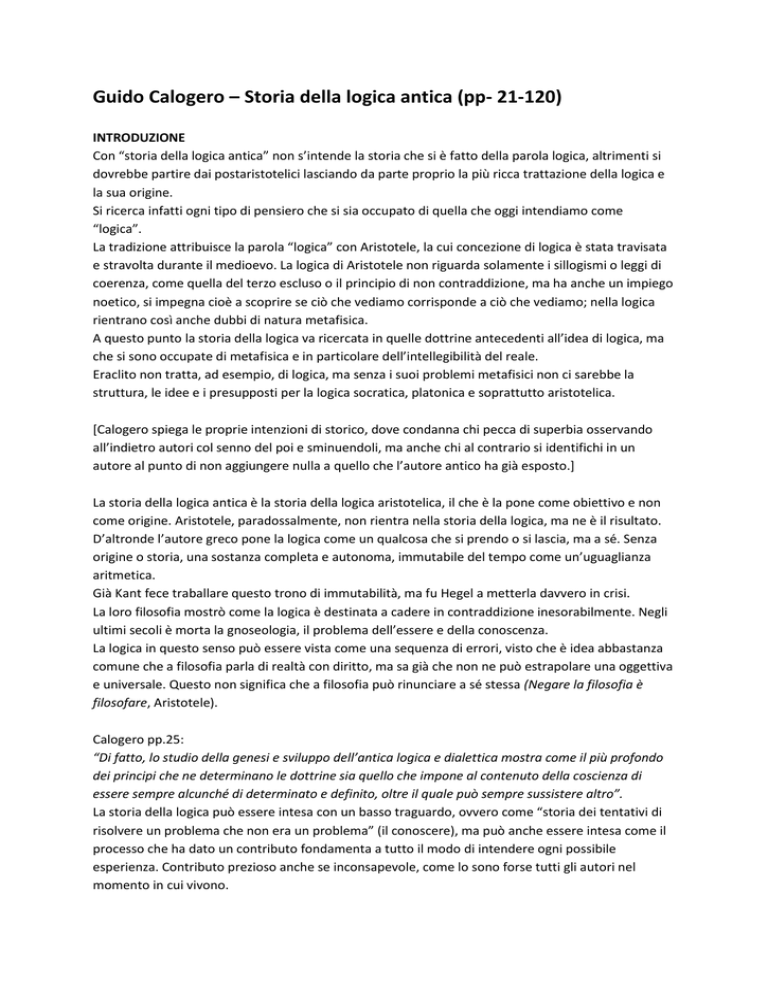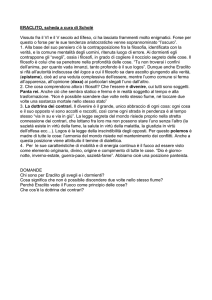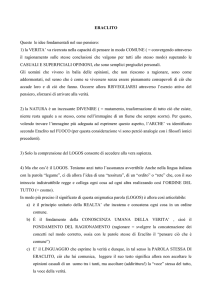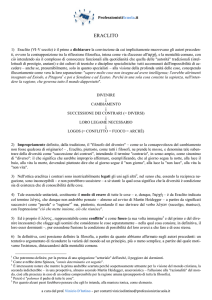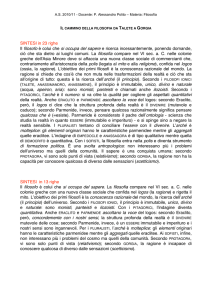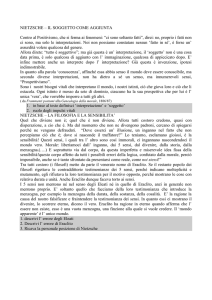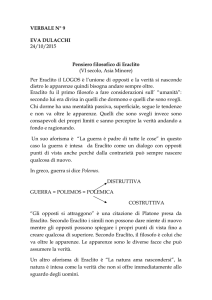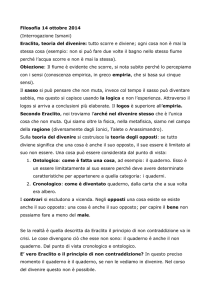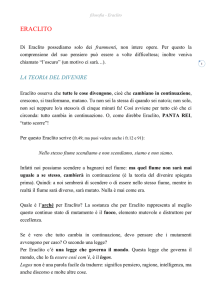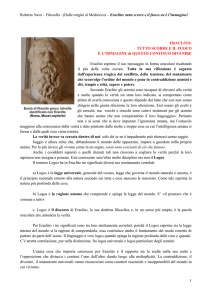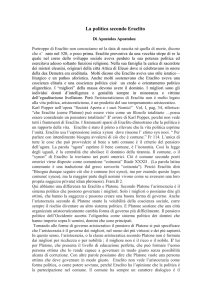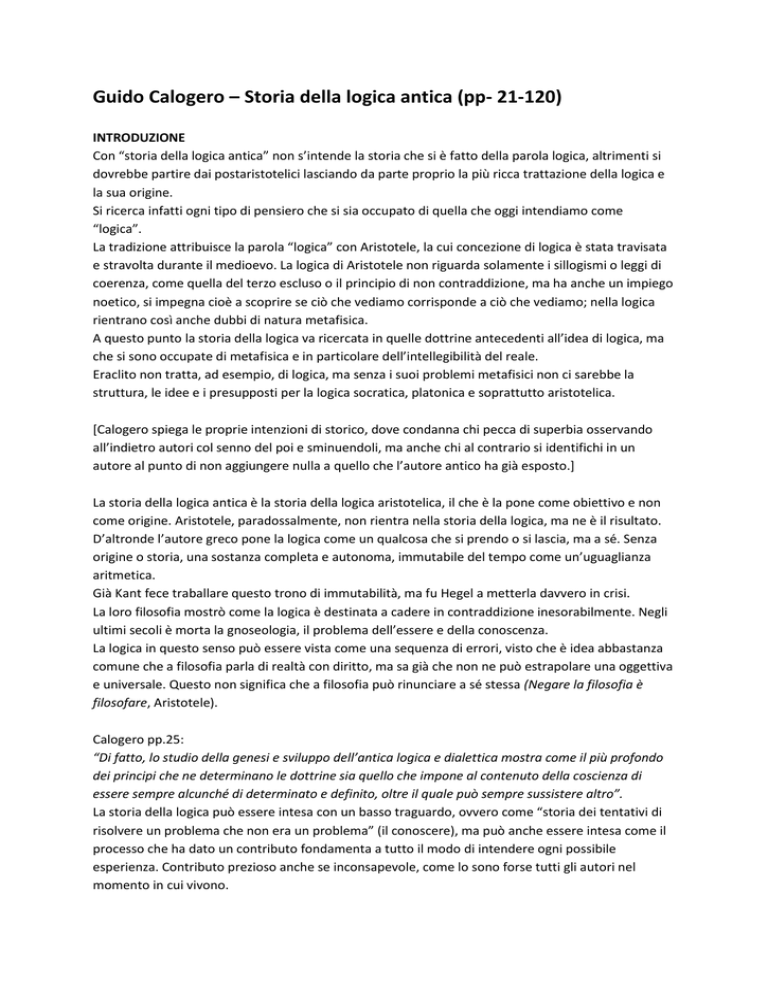
Guido Calogero – Storia della logica antica (pp- 21-120)
INTRODUZIONE
Con “storia della logica antica” non s’intende la storia che si è fatto della parola logica, altrimenti si
dovrebbe partire dai postaristotelici lasciando da parte proprio la più ricca trattazione della logica e
la sua origine.
Si ricerca infatti ogni tipo di pensiero che si sia occupato di quella che oggi intendiamo come
“logica”.
La tradizione attribuisce la parola “logica” con Aristotele, la cui concezione di logica è stata travisata
e stravolta durante il medioevo. La logica di Aristotele non riguarda solamente i sillogismi o leggi di
coerenza, come quella del terzo escluso o il principio di non contraddizione, ma ha anche un impiego
noetico, si impegna cioè a scoprire se ciò che vediamo corrisponde a ciò che vediamo; nella logica
rientrano così anche dubbi di natura metafisica.
A questo punto la storia della logica va ricercata in quelle dottrine antecedenti all’idea di logica, ma
che si sono occupate di metafisica e in particolare dell’intellegibilità del reale.
Eraclito non tratta, ad esempio, di logica, ma senza i suoi problemi metafisici non ci sarebbe la
struttura, le idee e i presupposti per la logica socratica, platonica e soprattutto aristotelica.
[Calogero spiega le proprie intenzioni di storico, dove condanna chi pecca di superbia osservando
all’indietro autori col senno del poi e sminuendoli, ma anche chi al contrario si identifichi in un
autore al punto di non aggiungere nulla a quello che l’autore antico ha già esposto.]
La storia della logica antica è la storia della logica aristotelica, il che è la pone come obiettivo e non
come origine. Aristotele, paradossalmente, non rientra nella storia della logica, ma ne è il risultato.
D’altronde l’autore greco pone la logica come un qualcosa che si prendo o si lascia, ma a sé. Senza
origine o storia, una sostanza completa e autonoma, immutabile del tempo come un’uguaglianza
aritmetica.
Già Kant fece traballare questo trono di immutabilità, ma fu Hegel a metterla davvero in crisi.
La loro filosofia mostrò come la logica è destinata a cadere in contraddizione inesorabilmente. Negli
ultimi secoli è morta la gnoseologia, il problema dell’essere e della conoscenza.
La logica in questo senso può essere vista come una sequenza di errori, visto che è idea abbastanza
comune che a filosofia parla di realtà con diritto, ma sa già che non ne può estrapolare una oggettiva
e universale. Questo non significa che a filosofia può rinunciare a sé stessa (Negare la filosofia è
filosofare, Aristotele).
Calogero pp.25:
“Di fatto, lo studio della genesi e sviluppo dell’antica logica e dialettica mostra come il più profondo
dei principi che ne determinano le dottrine sia quello che impone al contenuto della coscienza di
essere sempre alcunché di determinato e definito, oltre il quale può sempre sussistere altro”.
La storia della logica può essere intesa con un basso traguardo, ovvero come “storia dei tentativi di
risolvere un problema che non era un problema” (il conoscere), ma può anche essere intesa come il
processo che ha dato un contributo fondamenta a tutto il modo di intendere ogni possibile
esperienza. Contributo prezioso anche se inconsapevole, come lo sono forse tutti gli autori nel
momento in cui vivono.
La storia della logica antica è la storia di un popolo dedito alla perfezione logica del vissuto, è la
storia del loro modo di pensare e del loro linguaggio che spesso hanno adattato al loro modo di
pensare.
Se il non aver scisso il “parlare” dal “pensare” si vuole condannare come errore degli antichi logici,
allora ecco una spiegazione del perché della storia dei loro errori che mostrandone le conseguenze li
fa comprendere ed evitare.
1: La struttura del pensiero arcaico
La nascita della logica non si può ricercare nell’origine della parola “logica”. Essa infatti prese forma
con Aristotele, ma con un significato diverso, quasi quello di “dialettica”. Aristotele indicava con
“analitica” ciò che noi oggi siamo inclini e definire logica.
Se si restassi ancorati alla parola, si perderebbe così la più viva nascita del concetto di logica. Dunque
storia della logica comprende in vero tutti i problemi che si sono occupati del realtà in rapporto al
pensiero e quindi storia della fisica, metafisica, dialettica.
Calogero spiega che non si può intendere come “realtà storica” un documento antico; bensì si può
considerare il documento come “il più” antico, ma non necessariamente il primo. Così Talete si
suppone sia il primo a porsi determinati problemi, finché una nuova scoperta non potrà smentire
quella che oggi è una realtà.
Il porsi problemi è proprio il principio della ricerca della nascita delle logica; essa infatti va ricercata
molto prima che la logica esista. La sua nascita infatti non è da ricercare nella prima soluzione, ma ai
suoi albori, nel primo problema posto al quale lentamente si andrà formando quella struttura che
porterà a una consapevolezza logica.
Questa indagine è contestualizzata da Calogero, infatti egli intende la storia non in un senso
hegeliano, ovvero una linearità totale fatta di causa-effetto, dove ogni cosa ha un principio e genera
una conseguenza; così andrà necessariamente ricercato IL principio, e quasi sempre questo è
impossibile. Difatti è più corretto intendere la storia e in particolare la storia ella filosofia come una
dimostrazione per esempi, dove gli esempi sono gli autori del passato e le loro esperienze che si
possono commentare, tradurre, analizzare. Ognuna di queste realtà è quindi una realtà
indipendente, che seppur ha una origine e un fine essa è legittima. La storia è sempre incompleta,
l’importante è lasciar spazio alla scoperta di nuove esperienze che arricchiscano i quadro. Allo
storico d’altronde interessa il dipinto, non la cornice.
Per capire la nascita della logica è necessario capire la struttura mentale di un uomo arcaico e come
si rapporta al reale. Il greco arcaico non distingue il concetto di reale da quello di vero, infatti le due
parole sono usate indistintamente. Questo perché l’oggetto che si manifesta ed è contemplabile è
vero e reale, non vi è una distinzione tra il mondo oggettivo e quello soggettivo.
Questa sovrapposizione del conosciuto e del reale rende impossibile l’esistenza della gnoseologia,
ovvero l’indagine di come il pensiero possa appropriarsi del reale. Soltanto i postaristotelici
perderanno la fiducia del conoscibile.
Il pensiero arcaico (e classico) non distingue anche un terzo elemento: la parola. Significato e
significante sono la stessa cosa e la parola corrisponde assolutamente all’oggetto.
Esempio di questa unità è il termine logos, che ha molteplici significati, tutti indicanti di fondo una
parola che fa da veicolo a un immutabile significato, essa è esistenza, verità, parola.
Dialettica e logica sono fortemente unite e lo sono anche l’oggetto e la parola, il significato e il
significante, il simbolo e il concetto.
Oggi intendiamo tutto ciò come separato e chiaramente distinto, ma non era così per l’uomo greco.
Il tutto era sullo stesso livello, dunque l’errore era solamente dato da un errare espositivo. Come il
motto empiristico afferma che l’unica scienza esatta è un lingua ben fatta, possiamo affermare che
per i greci la lingua era sinonimo di realtà e l’oggetto era esattamente il simbolo.
La conoscibilità era diretta, difatti come scrive Aristotele “l’uomo tende al sapere, e per farlo si affida
naturalmente ai sensi, in particolare agli occhi”.
Perfino “l’idea” rientra in questo schema. Ella è infatti invisibile all’occhio umano, ma lo è per quello
spirituale. Nella concezione ideale infatti l’idea è stabilita dalla sua immobile essenza, con la propria
forma e confine.
Il concetto di finito è dominante in tutta la struttura del pensiero greco.
Nonostante possedessero il concetto di infinito e lo prendessero in esame, fu sempre considerato
irrazionale e falso. I pitagorici si posero il problema data la natura del numero, ma appunto il
numero era sinonimo di simbolo del reale, quindi un concetto a-numerico come l’infinito, senza
confini, limiti e immediatezza sensoriale era considerato assolutamente falso in quanto avrebbe
messo in discussione tutta la realtà empirica, mai messa in discussione.
2: Eraclito (P.59)
Molti frammenti suggeriscono che Eraclito e Parmenide fossero coetanei, e seppur non lo furono è
lecito considerarli contemporanei.
Per comprendere il loro pensiero è necessario capire chi sia il primo a produrre una certa filosofia
così innovativa. Con tutta probabilità questi fu Eraclito. Difatti diversi studi affermano che
Comprendere Eraclito supponendo che conoscesse la filosofia di Parmenide ostacola la sua
limpidezza e lo stesso vale per i principi di Parmenide senza la dottrine di Eraclito.
Al contrario invece tutto sembra molto più lineare.
Eraclito conferma l’unitarietà delle tre sfere: verbo-verità-realtà e lo fa tramite l’uso della parola
“logos”. Per Eraclito il logos è IL discorso, che può essere udito propriamente ma ha un che di
fondante e universalmente valido; logos è anche l’essenza di un determinato oggetto e l’uso che ne
fa il filosofo Ionico mostra come il termine non sia equivocabile, non può esserci errore. Difatti
distingue il logos dall’epos, ovvero il discorso “comune” del parlato che può essere erroneo.
Logos è anche fama e riconoscimento nel parlare, il valore.
Logos è portatore di verità ed essenza, che appunto sono uniti in un'unica direzione.
Spesso si afferma che Eraclito è oscuro e intraducibile. Effettivamente ciò che rende Eraclito difficile
da comprendere è la traduzione nella lingua moderna che presuppone la scissione di concetti che nel
mondo arcaico erano fusi.
Calogero insiste nel dire che per comprendere la filosofia e la logica arcaica non si può dimenticare
quale contesto mentale c’era presso i greci. La diversità nelle tre sfere non era contemplabile.
Ulteriore conferma della parola che è veicolo di verità-realtà è l’uso che Eraclito fa della parola
“arco”, ovvero “bios”. Bios significa infatti sia vita, che appunto arco cioè oggetto che semina
morte.
L’assonanza non è una coincidenza, ma è una realtà. Questo è lo stimolo al pensiero di Eraclito che
vita e morte sono correlate e l’arco ne è l’esempio e simbolo. “Vita nel nome, morte nell’atto.”
Eschilo vede nei nomi di persona un’essenza primordiale, difatti nell’Agamennone definisce il nome
il Elena come veritiero, in quanto “Elenaus” significa “distruttrice di navi”.
L’unità è un concetto chiave per Eraclito.
Non solo relativo alle tre sfere, ma anche nei concetti universali del reale. Infatti per Eraclito chi ha
compreso il logos sa che “la saggezza è convenire che tutto è uno”.
Come dice degli dei, essi sono fame e sazietà, giorno e notte. Sono la sintesi del binomio, sono una
cosa e il suo contrario.
Difatti per Eraclito non c’è differenza tra il desto e il dormiente, tra l’umido e l’arido o tra il freddo e
il caldo: l’uno è la conseguenza dell’altro e diverrà nuovamente ciò che era. Nel fiume, Eraclito non
segue il Panta Rein, non è lo scorrere dell’acqua che gli interessa, ma gli scogli sulla quale si schianta.
L’esistenza è continuo divenire, fatto di scontri tra oggetti e dei loro binomi, che sono però la stessa
cosa, proprio come l’arco, una cosa da vita ed è genesi dell’altra che ne implica la morte e così via.
Nonostante tutto nel mondo di Eraclito è antitesi e guerra e la morte di una cosa è la vita di un’altra,
lascia spazio a un primo moto di relativismo.
Prende in esame la differenza del giudizio sul gusto del cibo, il non scansare il letame nei maiali, il
rotolarsi nella polvere dei polli, la differenza del cibo preferito da buoi o asini; ma anche la vitalità
dell’acqua per i pesci e la sua mortalità per gli uomini.
Questi opposti sono riconosciuti da Eraclito come relativi: la più bella della scimmie è brutta se
paragonata a un uomo, un bambino è un bambino rispetto a un uomo e l’uomo è un bambino
rispetto al dio.
C’è quindi una gerarchia, difatti gli dei non vedono nelle cose il buono o il cattivo, ma per loro tutto è
bene. Difatti si torna all’importanza dell’unità anche nel relativismo: la malattia rende gradevole la
salute e il buio permette la luce. Senza il proprio opposto il mondo non potrebbe affatto intendersi.
Esempio emblematico è quello della “discesa” e della “salita”. Vedendo una strada in pendenza
infatti Eraclito ammette che quella stessa strada è allo stesso tempo sia una discesa che una salita.
Oggi questo non desterebbe nessuna meraviglia, ma se Eraclito ha potuto costatare una
incongruenza è proprio per il principio secondo cui la parola è identica alla realtà, dunque la discesa
è una identità autonoma, ma per Eraclito essa contiene anche il suo contrario, la sua antitesi.
Da vari documenti posteriori a Eraclito, sembrerebbe che il filosofo abbia assimilato ed estremizzato
la sua teoria dell’unione di tutte le cose, della loro intrinseca essenza comune fino alla forma parlata
“comune”. Egli infatti affermava e negava qualsiasi cosa. Il sì e il no per Eraclito erano anch’essi la
stessa cosa. Criticava l’uomo greco che si illudeva che le cose fossero giudicabili con un sì o con un
no, senza rendersi conto che erano entrambe le cose in un solo tempo.
Da qui la sua assoluta oscurità e il suo difficilissimo essere compreso.
Da questo uso del linguaggio nasce la Parola-verità-realtà di Parmenide, che contrasta l’einai
eracliteo.
3: Parmenide (P. 85)
Per comprendere il pensiero di Parmenide è necessario inserirlo nel giusto contesto mentale, senza
giudicarlo o tentare di capirlo con la consapevolezza di ventiquattro secoli di evoluzione del
problema da lui stesso creato.
Centrale è l’essere, ma per Parmenide l’essere non è altro che un verbo utile a dimostrare e dire
determinate cose in casi specifici; non ha coscienza del problema dell’essere inteso come dubbio
di esistenza e proprietà, fenomeno o noumeno.
La sua è una ingenuità immediata, un oggetto è una cosa e non è una tale altra cosa, al pari del
verbo “avere”. Ente o entità può essere un oggetto più o meno oscuro o una legge giuridica, senza
metafisica, ma con appunto una ingenuità del parlato diretto e spontaneo.
Interessante vedere come termini che venivano usati in età arcaica spontaneamente, divenne
problematico e oggetto di indagine nei secoli successivi, ad esempio Omero parla di Ettore come
“non essere”, cioè non numerabile tra i guerrieri, non presente, morto. La sua non-essenza è un dato
percettivo, immediato, sensibile ma dopo l’essenza diverrà metafisica, prescinderà il tempo e quindi
costituirà un problema. Il verbo essere è usato spontaneamente in tutte le sue declinazioni molto
diverse, tra persona verbale ma anche presente o futuro; ma non essendo la grammatica ancora
anta, il greco non aveva la percezione che tutto faceva capo al concetto di einain , di essere
come esistenza ed essenza.
Altra dato rilevante è l’uso di “tà onta”, ovvero “le cose”. Anche questo termine è
immediato e ingenuo, usato per casi particolari delucidando questo o quello, ma non ha niente a che
fare con la “cosalità” dell’oggetto.
L’uso empirico e spontaneo dell’einain era dovuto al sovrapporre il verbo essere con la realtà-verità.
Se un arcaico avesse dovuto approvare una affermazione, avrebbe potuto dire “èstin
ùtos” cioè “è così” (trad. La cosa è). Al contrario, per dirla falsa e irreale “uk èstin ùtos” (Uk = non).
Così l’irrealtà e la falsità erano semplicemente date da un oggettivo dato empirico. Il problema che
poi esplode in Eraclito è quello di non distinguere il “no” dell’errore dal “no” della negazione (intesa
come irrealtà). Questa non divisione portò a crollare su sé stessa. Un oggetto era un qualcosa e non
era qualcos’altro, ma nel parlato e nel pensato queste due realtà andavano a interferire, poiché il
“sì” di una cosa-nome-realtà, andava a negare un’altra cosa-nome-realtà.
Fu questo il crollo che portò Eraclito ad accogliere tutte le cose in una unità, e fu così impossibile
capirlo per i suoi contemporanei, poiché era aberrante e assurdo, dissennato, che una cosa potesse
essere insieme estìn e uk estin.
È proprio da questo crollo di Eraclito che Parmenide, riconoscendolo legittimo, si manifestò. Egli capì
il controsenso, scorse l’irrealtà e la relatività delle cose, ma il suo cuore ellenico non poteva
rassegnarsi all’irrealtà e così abbandonò l’einain come sinonimo di realtà, creando il ““, Tò
eòn, “l’ente”. La creazione dell’ente influenzò per sempre tutta la filosofia occidentale e sacrificò a
questo nuovo concetto tutta la realtà. Il tò eòn non era infatti una realtà visibile, ma una realtàparola, un concetto mentale che non passava per il mondo sensoriale. Non solo, era anche la
negazione di ogni visibile.
Ma la realtà non poteva comunque essere deducibile dall’eòn (participio di einain), disfatti l’eòn era
legittimato solamente nella forma linguistica e pensata. Era una realtà sostitutiva ed essenziale, ma
non autonoma. L’ente si racchiude con “ciò che è è, e ciò che non è non è”, che un greco avrebbe
inteso come “il bianco è bianco o il cielo è cielo”, ovvero il semplice ribadire un dato empirico. In
verità la giusta interpretazione sarebbe “una cosa detta è quella cosa detta e non è tutte le cose
che sarebbero potute esser dette”. L’eon è quindi strettamente connesso con illogòs, e la
sua origine infatti non può che essere dedotta dalla crisi data dall’essere, dalla antitesi della realtà
del “sì” con l’irrealtà del “no”.
La lingua greca, che era anche la struttura del pensiero greco, non aveva di fondo un’idea negativa
della realtà, proprio per questo principio di parola-verità-realtà. La luce è, così come l’ombra. Il bene
è, così come il male e il bianco, il grigio, il nero sono. Tutta l’accezione è positiva, ogni cosa è
esistente pur riconoscendo lo scontro gerarchico della realtà e la lotta tra oggetti che comportano
l’uno la morte dell’altro, ma in ogni caso essi sono.
Non vi è il concetto di negazione della realtà, non esiste un non-essere puro. Einain può avere un
valore solamente positivo, così come l’eon.
Asserire il nulla era nulla asserire.
(PP.93-112)
Calogero esegue un’analisi dei testi di Parmenide dove esamina il suo procedere logico-mentale e
come struttura l’esposizione del proprio pensiero, traducendolo e commentandolo.
Ciò che emerge è l’assoluta volontà di Parmenide di affermare che la via della conoscenza e della
verità è quella dell’essere e non quella del non-essere. In questo appare evidente l’aspra critica ad
Eraclito che sembra aver abbracciato la via dell’errore (quella del non-è) affermando che gli oggetti
sono e non-sono allo stesso momento.
Eraclito è stato però il motore che ha generato l’ente. L’ente è quell’essenza che è in tutte le cose. Il
termine di paragone logico di Parmenide è ancora primitivo, infatti “ciò che è” è “ciò che è”, significa
avere un oggetto esteso mentalmente in due momenti, il prima e l’adesso (e come aspettativa
dell’adesso col dopo) e un rudimentale principio di identità impone che esso sia ciò che è stato.
Parmenide insiste dicendo che “l’è” si può conoscere e attribuire alle cose, mentre la via del non-è
non può essere conoscibile e non si può affermare che una cosa non-è, poiché essa la esperisco e
quindi esiste.
La verità (l’ente) è rappresentata da Parmenide come una sfera.
Perfettamente lineare e uguale a sé stessa. Perché essa non può essere diversa da un lato, non può
essere influenzata da “essere più” o “essere meno”. La verità è l’essenza universale.
Conoscere una cosa equivale a dire che essa è, ed è nella sua forma.
Il pensiero di Parmenide si esaurisce attorno alla parola e alla volontà di non rassegnarsi al nonessere delle cose. La parola è il simbolo della verità, che è addirittura subordinata ad essa.