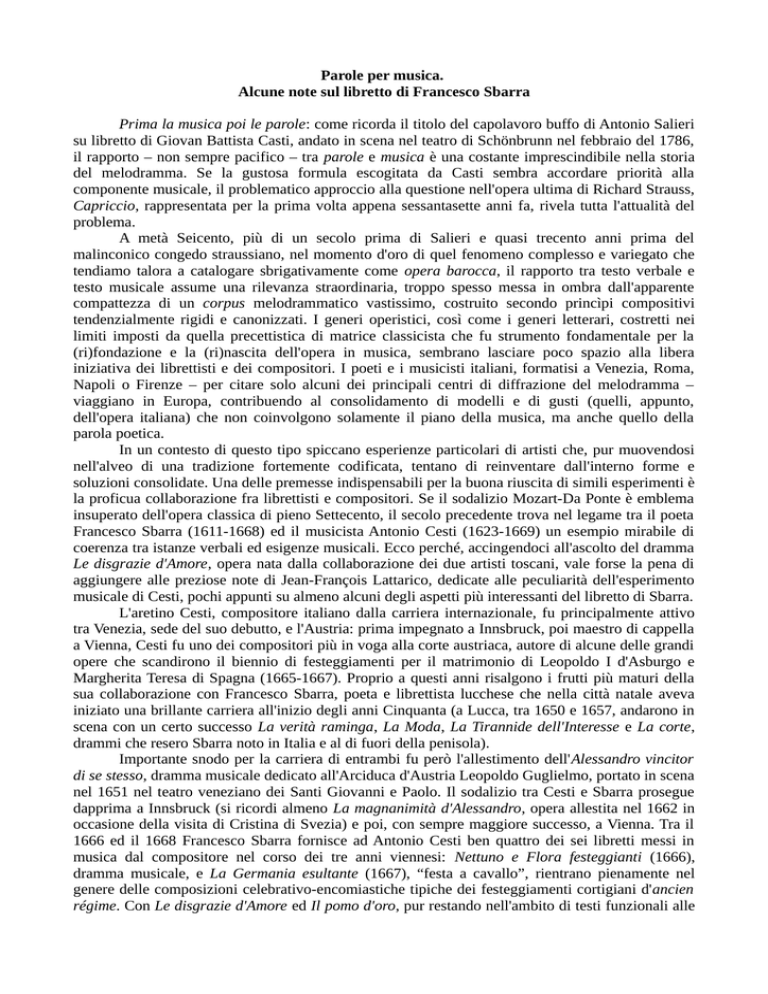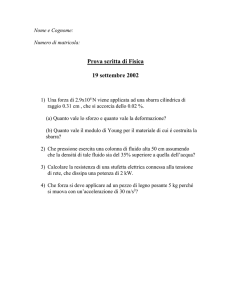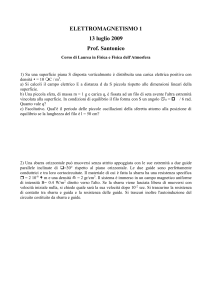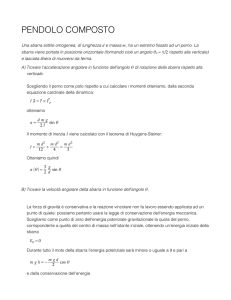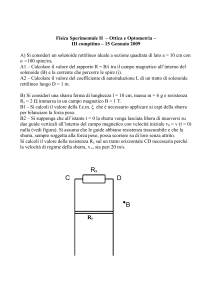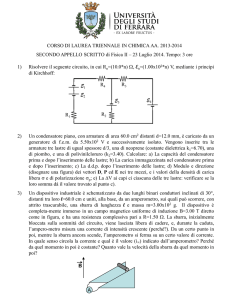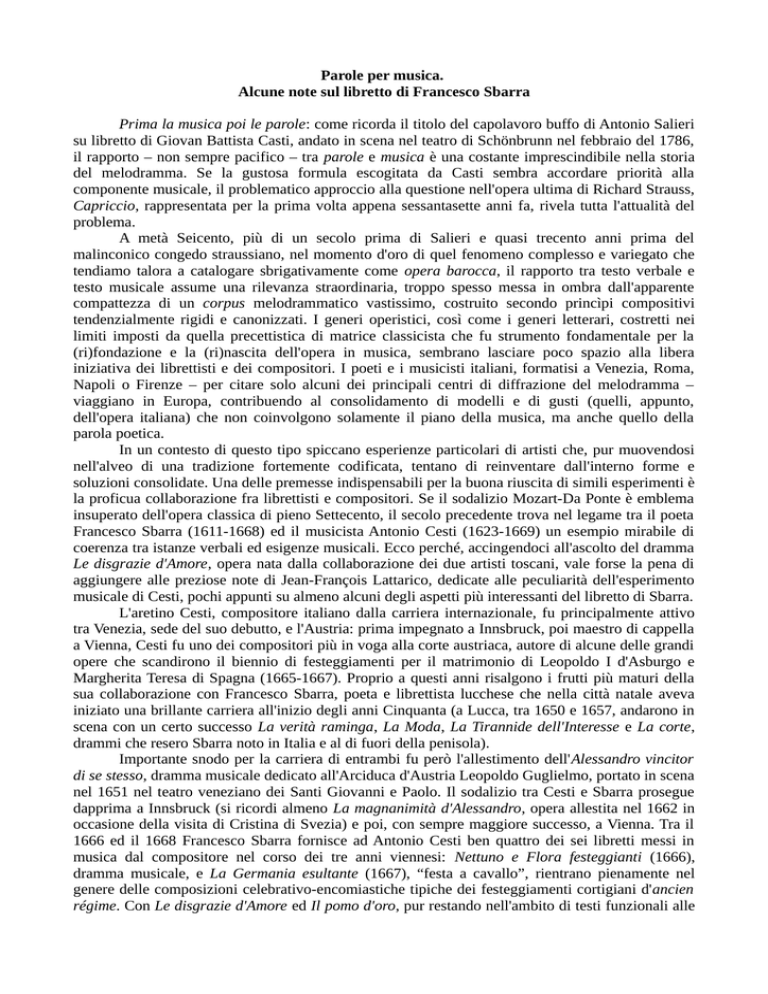
Parole per musica.
Alcune note sul libretto di Francesco Sbarra
Prima la musica poi le parole: come ricorda il titolo del capolavoro buffo di Antonio Salieri
su libretto di Giovan Battista Casti, andato in scena nel teatro di Schönbrunn nel febbraio del 1786,
il rapporto – non sempre pacifico – tra parole e musica è una costante imprescindibile nella storia
del melodramma. Se la gustosa formula escogitata da Casti sembra accordare priorità alla
componente musicale, il problematico approccio alla questione nell'opera ultima di Richard Strauss,
Capriccio, rappresentata per la prima volta appena sessantasette anni fa, rivela tutta l'attualità del
problema.
A metà Seicento, più di un secolo prima di Salieri e quasi trecento anni prima del
malinconico congedo straussiano, nel momento d'oro di quel fenomeno complesso e variegato che
tendiamo talora a catalogare sbrigativamente come opera barocca, il rapporto tra testo verbale e
testo musicale assume una rilevanza straordinaria, troppo spesso messa in ombra dall'apparente
compattezza di un corpus melodrammatico vastissimo, costruito secondo princìpi compositivi
tendenzialmente rigidi e canonizzati. I generi operistici, così come i generi letterari, costretti nei
limiti imposti da quella precettistica di matrice classicista che fu strumento fondamentale per la
(ri)fondazione e la (ri)nascita dell'opera in musica, sembrano lasciare poco spazio alla libera
iniziativa dei librettisti e dei compositori. I poeti e i musicisti italiani, formatisi a Venezia, Roma,
Napoli o Firenze – per citare solo alcuni dei principali centri di diffrazione del melodramma –
viaggiano in Europa, contribuendo al consolidamento di modelli e di gusti (quelli, appunto,
dell'opera italiana) che non coinvolgono solamente il piano della musica, ma anche quello della
parola poetica.
In un contesto di questo tipo spiccano esperienze particolari di artisti che, pur muovendosi
nell'alveo di una tradizione fortemente codificata, tentano di reinventare dall'interno forme e
soluzioni consolidate. Una delle premesse indispensabili per la buona riuscita di simili esperimenti è
la proficua collaborazione fra librettisti e compositori. Se il sodalizio Mozart-Da Ponte è emblema
insuperato dell'opera classica di pieno Settecento, il secolo precedente trova nel legame tra il poeta
Francesco Sbarra (1611-1668) ed il musicista Antonio Cesti (1623-1669) un esempio mirabile di
coerenza tra istanze verbali ed esigenze musicali. Ecco perché, accingendoci all'ascolto del dramma
Le disgrazie d'Amore, opera nata dalla collaborazione dei due artisti toscani, vale forse la pena di
aggiungere alle preziose note di Jean-François Lattarico, dedicate alle peculiarità dell'esperimento
musicale di Cesti, pochi appunti su almeno alcuni degli aspetti più interessanti del libretto di Sbarra.
L'aretino Cesti, compositore italiano dalla carriera internazionale, fu principalmente attivo
tra Venezia, sede del suo debutto, e l'Austria: prima impegnato a Innsbruck, poi maestro di cappella
a Vienna, Cesti fu uno dei compositori più in voga alla corte austriaca, autore di alcune delle grandi
opere che scandirono il biennio di festeggiamenti per il matrimonio di Leopoldo I d'Asburgo e
Margherita Teresa di Spagna (1665-1667). Proprio a questi anni risalgono i frutti più maturi della
sua collaborazione con Francesco Sbarra, poeta e librettista lucchese che nella città natale aveva
iniziato una brillante carriera all'inizio degli anni Cinquanta (a Lucca, tra 1650 e 1657, andarono in
scena con un certo successo La verità raminga, La Moda, La Tirannide dell'Interesse e La corte,
drammi che resero Sbarra noto in Italia e al di fuori della penisola).
Importante snodo per la carriera di entrambi fu però l'allestimento dell'Alessandro vincitor
di se stesso, dramma musicale dedicato all'Arciduca d'Austria Leopoldo Guglielmo, portato in scena
nel 1651 nel teatro veneziano dei Santi Giovanni e Paolo. Il sodalizio tra Cesti e Sbarra prosegue
dapprima a Innsbruck (si ricordi almeno La magnanimità d'Alessandro, opera allestita nel 1662 in
occasione della visita di Cristina di Svezia) e poi, con sempre maggiore successo, a Vienna. Tra il
1666 ed il 1668 Francesco Sbarra fornisce ad Antonio Cesti ben quattro dei sei libretti messi in
musica dal compositore nel corso dei tre anni viennesi: Nettuno e Flora festeggianti (1666),
dramma musicale, e La Germania esultante (1667), “festa a cavallo”, rientrano pienamente nel
genere delle composizioni celebrativo-encomiastiche tipiche dei festeggiamenti cortigiani d'ancien
régime. Con Le disgrazie d'Amore ed Il pomo d'oro, pur restando nell'ambito di testi funzionali alle
celebrazioni festive, ci troviamo di fronte ad opere di maggiore complessità, tanto sul piano
dell'ambizione e dell'originalità letterarie, quanto su quello del progetto drammaturgico.
La complessità del Pomo d'oro, unica opera di Sbarra e Cesti ad aver goduto di una qualche
attenzione da parte della critica in tempi non troppo lontani, è insita nel genere cui il testo
appartiene: la nozione di “festa teatrale” – è questo il termine utilizzato per definire l'opera nelle
prime edizioni a stampa – suggerisce un componimento ambizioso che non si risolve nella semplice
alternanza di atti ed intermezzi. Il pomo d'oro, allestito in due giornate nel luglio 1668, poco dopo la
morte del librettista, si distingue infatti dalle più tradizionali forme del melodramma d'origine
veneziana per l'eccezionalità dei mezzi richiesti dalla messa in scena. Il ricorso ad un organico
orchestrale insolitamente ampio, affiancato da numerosi cori, va di pari passo con l'utilizzo di
sofisticati congegni scenotecnici che portano in scena tempeste, battaglie navali e suggestive
apparizioni sovrannaturali.
Di tutt'altro genere il dramma «giocosomorale» Le disgrazie d'Amore che, rappresentato nel
1667, costituisce la penultima collaborazione di un sodalizio tra librettista e compositore che solo la
morte del primo poté interrompere (Cesti sarebbe mancato l'anno successivo). Il titolo del dramma
evoca al tempo stesso l'intreccio dell'opera ed il suo significato allegorico. La vicenda di Amore
che, dopo aver abbandonato la madre Venere ed il patrigno Vulcano, è vittima delle astuzie di
Inganno e Adulazione, suggerisce infatti una morale che mette in guardia da passioni amorose che
non siano nobili e spiritualmente elevate. D'altro canto, la gustosa trama del libretto di Sbarra, per
quanto vincolata dalle regole del genere del dramma morale, tende senz'altro a privilegiare la
componente giocosa.
Tale impostazione emerge chiaramente nella caratterizzazione di Venere, Vulcano e Amore,
presentati secondo i luoghi comuni della commedia di costume. Venere è la dea della bellezza,
giovane consorte di un vecchio zoppo, e la dissonante unione tra le due divinità si offre ad una
facile rivisitazione comica . Vulcano diventa così il vecchio marito geloso e possessivo che, alle
prese con una moglie ben più giovane di lui, è costretto a pagare sulla propria pelle l'avventatezza di
una scelta matrimoniale innaturale e discutibile. La dea, dal canto suo, offre al librettista il destro
per riprendere e sviluppare uno dei topoi più duraturi della tradizione comica rinascimentale: la
polemica contro la cosmesi femminile. L'impertinente Amore sottrae lo «stipo prezioso» di Venere e
può finalmente rivelare a tutti cosa si nasconda dietro la «falsa beltà» femminile: novello vaso di
Pandora, lo stipo della dea cela tutti gli artifici cui le donne ricorrono per sembrare belle. Il gusto
iperbolico per il catalogo inesauribile permette a Sbarra – per bocca di Amore – di snocciolare un
impressionante elenco di belletti e prodotti cosmetici che vira progressivamente verso il grottesco.
Anche la fucina di Vulcano, luogo celebrato dalla tradizione poetica classicista, diventa nelle
Disgrazie d'Amore una bottega artigiana sottomessa a dinamiche tutte umane e ben poco edificanti:
non appena Vulcano parte per accompagnare Venere nella ricerca di Amore fuggitivo, i tre giganti,
ben lungi dal rispettare le raccomandazioni e le consegne del padrone, si mettono a giocare a carte
finendo per darsele di santa ragione.
Alle divinità, umanizzate in chiave comica, si affiancano alcune personificazioni
allegoriche: Inganno, Adulazione, Avarizia, Amicizia. Pur agendo nel pieno rispetto dei valori che
sono chiamate ad incarnare, anch'esse passano attraverso il filtro della scrittura giocosa. Le tre
incarnazioni viziose – Inganno, Adulazione ed Avarizia – offrono in tal senso al librettista materia
ben più ricca di quanto non possa fare la virtuosa Amicizia. La presentazione dei personaggi sfrutta
in modo emblematico la materializzazione di metafore topiche: Inganno ed Adulazione compaiono
«con una rete da tendere», attributo che diventa strumento effettivo dell'azione. Nella rete – non
solo metaforica – dell'Inganno cadrà ovviamente Amore che, bendato come lo vuole la tradizione
iconografica, non vede dove mette i piedi. Così come la benda, attributo tradizionale del cieco
Amore, torna ad essere un semplice oggetto che impedisce la vista, anche le armi dorate del dio
sono destinate ad una sorte affine: valutate per quello che sono – frecce e faretra d'oro – esse si
riducono a pura merce di scambio (e come tali saranno contese dai protagonisti).
I vari personaggi torneranno a incontrarsi all'osteria di Avarizia, vero fulcro dell'azione, non
casualmente situata, come spiega puntualmente una didascalia, su una «piazza di città». La piazza,
scena a cielo aperto, è assunta come immagine del mondo, ridotta in scala e riprodotta a significare
il mondo stesso nello spazio limitato della scena teatrale: il dramma giocosomorale di Sbarra si
appropria di tutti gli elementi più caratteristici dell'immaginario teatrale barocco piegandoli
all'intento del docere delectando. Le divinità scendono dal piedistallo per comportarsi come uomini,
e degli uomini acquisiscono tutti i difetti. Le dinamiche più tipiche del comportamento umano
vengono sintetizzate efficacemente attraverso la personificazione dei molti vizi e delle poche virtù.
Il tutto condito – come avremo modo di vedere tra breve – da un sapido gioco di travestimenti e
smascheramenti che, coinvolgendo direttamente i personaggi allegorici, ne potenziano l'efficacia e
lo spessore drammatici. Travestendosi rispettivamente da ciarlatano e zingara, Inganno e
Adulazione celano la propria identità: d'altro canto, il travestimento permette loro di dare corpo ad
esempi viventi dei vizi che, in quanto allegorie, sono chiamati a rappresentare. Paradossalmente le
personificazioni, celando se stesse, si rivelano personaggi pronti a calcare la scena nel pieno rispetto
delle convenzioni teatrali. L'impianto tradizionale del dramma allegorico, chiamato nel libretto di
Sbarra ad ospitare una vicenda che vuole essere comico-giocosa, se non propriamente burlesca, è
rivitalizzato dall'interno: con grande sensibilità per la resa scenica dell'intreccio, Sbarra alterna
monologhi più distesi a dialoghi serrati che sfociano spesso nel battibecco, privilegiando in ogni
caso le potenzialità offerte dal contrasto tra i personaggi.
Se al pubblico è costantemente richiesto di cogliere con prontezza doppi sensi e allusioni,
l'ammiccante componente burlesca raggiunge il culmine proprio nella scena dell'osteria
dell'Avarizia. Come precisato dalla didascalia cui si è già fatto riferimento, sulla porta della locanda
è affissa un'insegna che rappresenta una lesina accompagnata dal motto «quanto più s'assottiglia
ancora è meglio». L'impresa non è invenzione del librettista, ma riprende quasi alla lettera quella
della Compagnia della Lesina («L'assottigliarla più meglio anche fora»), celebre nella tradizione
burlesca fiorentina per i suoi Capitoli e ragionamenti, stampati molte volte tra Cinque e Seicento.
La lesina, utensile da calzolaio composto da un uncino ricurvo applicato ad un manico in legno, è
simbolo dell'avarizia: come tale, associato al motto citato da Sbarra, campeggia sui frontespizi delle
numerose edizioni che raccolgono i testi burleschi dei “lesinanti”. Riconoscendo l'impresa, lo
spettatore può giocare d'anticipo sull'agnizione della locandiera, giustappunto l'Avarizia, e
prevedere i moventi che la spingeranno a farsi coinvolgere nell'intreccio.
Il libretto di Sbarra, ricco di raffinate e colte allusioni, mira al coinvolgimento totale di un
pubblico che sia in grado di coglierle. I luoghi comuni della tradizione amorosa e morale, declinati
in chiave comico-burlesca, giocano un ruolo determinante nell'elaborazione di un testo che,
destinato alla corte, della corte sfrutta i codici e le esigenze di intrattenimento (in tale contesto
rientrano gli spunti di polemica cortigiana che, topici essi stessi e sostanzialmente innocui, affiorano
nel terzo atto).
Mutatis mutandis, se oggi ha senso riscoprire un'opera come Le disgrazie d'Amore, il merito
non è solo delle innovative soluzioni musicali di Antonio Cesti. Esse trovano infatti un
complemento imprescindibile nel libretto di Sbarra. Prima la musica, quindi, o le parole? Come
l'ascoltatore potrà sperimentare assistendo alla rappresentazione, il dramma giocosomorale di Cesti
e Sbarra è l'esempio lampante di un universo teatrale in cui il rapporto tra parole e musica non è di
mera sovrapposizione, ma di vera e propria consustanzialità.
Eugenio Refini