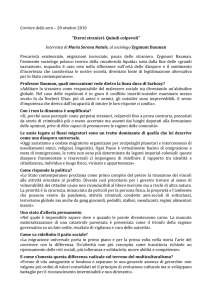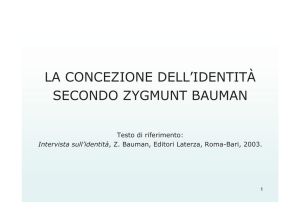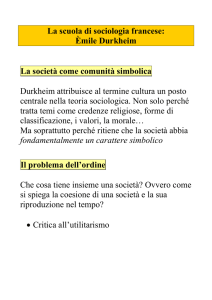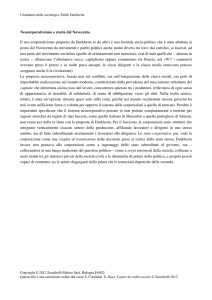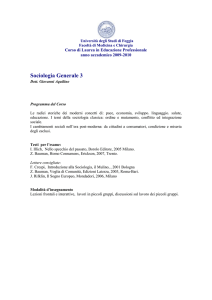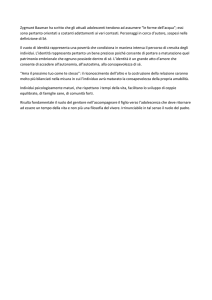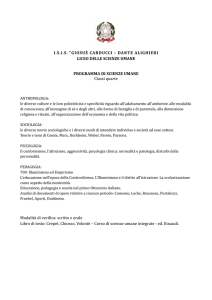UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
DOTTORATO in SOCIOLOGIA APPLICATA E METODOLOGIA
DELLA RICERCA SOCIALE - XXIV° ciclo
a.a. 2008/2009
“DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA”:
L’IMPATTO DELLA DIVISIONE DEL LAVORO SULLA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Bauman vs Durkheim
Paper Teorico
Elena Giudice
Matricola 070420
Febbraio 2009
1ndice
Introduzione__________________________________________________________________ 3
1. Tra modernità e postmodernità: gli autori in contesto _________________________ 5
2. Lo specialista solidale vs il giardiniere_______________________________________ 7
2.1 La solidarietà organica e l’avvento della società civilizzata: la divisione del
lavoro come ordine morale _________________________________________________ 7
2.2. Anomia e vocazione: la divisione del lavoro industriale ___________________ 9
2.3 La società dei giardinieri: il volto deresponsabilizzante e disumano della
divisione del lavoro.________________________________________________________ 12
3. Il soggetto, il professionista e la morale: due prosepttive contrastanti_________ 15
4. Responsabilità professionale nel servizio sociale ____________________________ 18
Conclusioni: verso una critica e riflessiva responsabilità professionale __________ 23
Bibliografia __________________________________________________________________ 24
22
Introduzione
Uno dei temi più trattati in sociologia, sia dai classici sia dai contemporanei,
riguarda le implicazioni della divisione del lavoro nella società moderna ed in
quella contemporeanea, postmoderna o di modernità liquida1 come la definisce
Bauman. In questa sede l’analisi si focalizzerà sulle sue implicazioni rispetto alla
responsabilità professionale2.
In accordo con Mordeglia (2008) ritengo che nel lavoro si condensino le molteplici
stratificazioni dei rapporti sociali attraverso i quali si costruisce non solo il mondo
degli oggetti materiali, ma anche e soprattutto il mondo degli oggetti simbolici in
cui si trovano iscritti tanto i valori della società nel suo complesso quanto quelli
dell’individuo che ne fa parte. Il lavoro diventa, sempre più, un luogo per il
riconoscimento di un lato della multipla identità di appartenenza e allo stesso
tempo base dell’incertezza esistenziale: essere attivi o inattivi nell’organizzazione
societaria modifica la percezione del Sé e la percezione che gli altri hanno di noi.
“Di cosa ti occupi?” è una delle prime domande che ci sentiamo chiedere
quando conosciamo un’altra persona: da questa banale constatazione si evince
l’importanza che il ruolo lavorativo e professionale riveste nella struttura della
società. E’ indiscusso inoltre che la società contemporanea sia fortemente basata
sulla divisione del lavoro3, ed un esempio specifico ci viene dalla scienza: “non
soltanto lo scienziato non coltiva più contemporaneamente delle scienze
differenti, ma neppure abbraccia una sola scienza nella sua totalità. L’ordine delle
sue ricerche si restringe ad un ordine determinato di problemi o perfino ad un
unico problema. Nello stesso tempo la funzione scientifica, […], diventa sempre
più autosufficiente”.
1
Bauman Z., Modernità liquida, Ed. La terza, Roma, 2002
In questa sede con il termine “professionale” si intende qualunque attività lavorativa, così come
utilizzato nel linguaggio italiano corrente. Come evidenzia bene Mordeglia (2008) alcuni derivati di
questo termine (professionista, professionale) vengono invece caricati di valenze esclusive allo
scopo di differenziare una professione da altre generiche occupazioni. La scelta di attenersi ad un
significato ampio del termine appare congruente con l’idea di occuparmi della responsbailità
lavorativo-professionale in senso esteso: tutti gli individui hanno possibilità di scelta e sono
responsabili per sè e per gli altri.
2
Volutamente introduco il termine “divisione del lavoro” piuttosto che “divisione del lavoro sociale”
per evidenziare la possibilità di differenti declinazioni di questa dimensione, come ad esempio la
divisione del lavoro tecnico, burocratico o industriale sulla scrota di autori come Marx e Durkheim..
3
33
Dal titolo dell’elaborato si comprende che analizzerò opportunità e limiti
dell’iperspecializzazione e della separazione professionale e scientifica partendo
dalle analisi di due appassionanti sociologici: Durkheim e Bauman.
Metterò inizialmente in luce come l’analisi di Durkheim ne La divisione del lavoro
sociale possa apparire internamente contradditoria nell’elaborazione di una terza
parte che sembra porre in evidenza tutte le ambiguità del modello di divisione del
lavoro proposto dall’autore. D’altra parte si potrebbe invece rilevare una
continuità tra le tre parti dell’opera: le prime due potrebbero essere intese come
la declinazione di un postulato teorico desiderabile, un tipo ideale di divisione del
lavoro, mentre la terza parte, contestualizzata in una dimensione pragmatica,
permette l’emersione delle criticità e delle insanabili ambiguità dell’impatto della
divisione del lavoro nella realtà sociale. La divisione del lavoro industriale diventa
allora una distorsione del tipo ideale postulato dal sociologo francese.
Effettuando un’analisi comparata tra i due autori, le riflessioni di Bauman
sembrano trovare una connesione con l’opera del sociologo francese proprio
attraverso la declinazione della divisione del lavoro industrializzato, anche se
Bauman non la limita ad esso. L’autore polacco infatti fa emergere la dimensione
della manipolabilità della società e degli strumenti utili a raggiungere quella
società ordinata che Durkheim tanto auspicava.
Il collegamento tra le analisi sviluppate dai due autori è oggettivo relativamente
alla tematica affrontata e non certo di debito da parte di Bauman nei confronti di
Durkheim. L’uno vede la divisione del lavoro come ordine morale e solidale tra gli
individui che caratterizzerebbe la modernità in senso positivo e prende in
considerazione, criticandola, le “faccia negativa” della modernità solo come
forma patologica della prima. Il secondo parte invece dal presupposto opposto,
ovvero che la modernità porti in sè il seme sia di opportunità sia di aberrazione: è il
prodotto stesso della processo di “civilizzazione” e di divisione del lavoro industriale
che porta ad un decremento della densità morale piuttosto che ad un suo
aumento come ipotizzato da Durkheim.
Attraverso una breve analisi della responsabilità professionale nell’ambito
specifico del servizio sociale, metterò a tema la dimensione specifica della scelta
44
come opportunità di spinta propositiva e creativa, come potenzialità per porre
basi di una responsabilità riflessiva e critica.
1. Tra modernità e postmodernità: gli autori in contesto
Durkheim, a differenza di Bauman, non ha assistito ad alcuni eccezionali4 eventi
storico-politici che hanno caratterizzato l’epoca moderna. Inoltre i due autori presi
in considerazione partono da approcci epistemologici differenti, dai quali
derivano concettualizzazioni diametralmente opposte.
Durkheim intende la ricerca sociale in senso naturalistico, ossia vede la collettività
come un organismo biologico, con gli stessi funzionamenti, mentre Bauman è un
sociologo della condizione umana. Il sociologo per Bauman deve interpretare il
suo tempo, mentre per Durkheim deve analizzare i fatti sociali, il che vuol dire
fatalmente interpretarli.
Nel far emergere le ambiguità tra il tipo ideale e le derive anomiche della
divisione del lavoro sociale, l’opera di Durkheim rappresenta vividamente la
scenografia di ciò che Bauman identifica con il termine modernità nella sua
duplice accezione di opportunità e manipolazione, ovvero un’epoca basata
sull’illusione della pianificazione, della scienza e della competenza. Per il sociologo
francese le componenti della modernità dovrebbero fungere come forze
equilibratrici che permettono ai singoli di sentirsi parte di un tutto coeso e
finalizzato che valorizzi l’essere umano senza ridurlo ad un ingranaggio
intercambiabile, mentre Bauman ne mette in luce il versante delle “ombre” che
esse portano con sè. L’accento di Bauman sull’illusione della modernità è un
punto fondamentale del suo pensiero che si riconnette con la rilfessione di
Durkheim rispetto al fatto che l’anomia sia più una malattia che un’imperfezione
di possibile risoluzione: il tipo ideale di divisione del lavoro non può trovare spazio
di sviluppo positivo, laddove il piano della modernità porta in sè il germe della
perfezione funzionale, della sistematizzazione della complessità che non può
accogliere ciò che non si conforma, che tende a finalità e obiettivi diversi.
Per esempio l’Olocausto e la fine del socialismo reale, anche se con il termine eccezionali, come
si vedrà in seguito, si intende imprevisti piuttosto che impossibili, ovvero l’altra faccia della
modernità in contrapposizione alla visione di Durkheim.
4
55
Per comprendere la visione della modernità di Bauman come ordine e progetto
sociale, è utile far ricorso alla metafora della società dei giardinieri:
5
i giardinieri
rispondono solo a quel committente esigente che è la società, che ricerca
l’”Ordine”. Un tentativo affannoso, perché gli imprevisti, le deviazioni dalla media
– concetto tanto caro ad un positivista critico come Durkheim - sono state delle
costanti piuttosto che sporadiche. Bauman ha infatti messo in rilievo come
l’Olocausto abbia dimostrato in tutta la sua chiarezza la possibile manifestazione
crudele e disumana degli stessi mezzi che avrebbero dovuto, nelle speranze dei
moderni, portare alla società perfetta. La modernità è quindi per lo studioso
polacco l'era delle utopie, talvolta confliggenti tra loro, ma accomunate dalla
volontà di plasmare la vita di una società in base a una visione accuratamente
elaborata, accompagnata da razionalità, pianificazione, efficienza, competenza
e coordinamento (Bauman, 1992): la moderntà solida.
Tester (2005) evidenzia che, durante gli anni Ottanta, Bauman riteneva fosse in
atto un deliberato abbandono del progetto della modernità. Affermava infatti
che l’esperimento dello Stato Sovietico e di quello Nazista esprimesse i contorni
essenziali del progetto moderno, in grado di produrre religioni secolari con sue
ideologie che ponevano come punto cardine la dipendenza dal ruolo forte ad
autorevole dello Stato giardiniere (ibidem). La postmodernità diventa quindi
espressione di una modernità priva di illusioni, consapevole dei propri limiti e
disposta ad abitare con ambivalenza ed incertezza (Leccardi in Bauman, 2008, p.
12). La sua analisi della modernità e della divisione del lavoro è quindi
strettamente legata al concetto di ambivalenza, secondo cui qualunque forma
della vita sociale è segnata da una profonda ed insanabile contraddizione che si
riscontra anche nella dimensione etica, ovvero “ciò che resta una volta liberato il
soggetto dai doveri e dagli obbilghi stabiliti: i sentimenti e le emozioni morali, le
incertezze, la spontaneità, l’inderminatezza e l’ambivalenza delle sue scelte”
(Leccardi in Bauman, 2008, p. 14).
Metafora utilizzata per la prima volta in La decadenza degli intellettuali, Universale Bollati
Boringhieri, Torino,1992: “il potere che presiede alla modernità […] è modellato sul ruolo del
giardiniere” p.66
5
66
2. Lo specialista solidale vs il giardiniere
2.1 La solidarietà organica e l’avvento della società civilizzata6: la divisione
del lavoro come ordine morale
L’interesse principale di Durkheim si fonda sulla presenza dell’ordine morale, e
proprio partendo da questa base egli arriva a definire la divisione del lavoro come
un fatto morale prendendo in considerazione due fattori. Innanzitutto la realtà lo
porta a constatare che la divisione del lavoro è inevitabile in quanto costante
storica; in secondo luogo ritiene che per dichiararla immorale sarebbe necessaria
una netta separazione tra morale e realtà, ma questo non è ovviamente possibile
perchè la morale vive nella vita del mondo (Durkheim, 1996). La divisione del
lavoro acquista nella concezione del sociologo francese la funzione di creare
legami di solidarietà, densità morale, ovvero diventa la base della solidarietà
organica. Durkheim crede quindi che il bisogno al quale la divisione del lavoro
sociale risponde oltrepassi il campo degli interessi puramente economici, ma
incarni in sè un bisogno morale, a differenza dell’attività industriale. L’autore infatti
ritiene che, tra lo sviluppo della solidarietà e la specializzazione professionale della
società
non
vi
accrescerebbe
sia
contraddizione.
contemporaneamente
Con
l’individualizzazione
quella
delle
parti
e
del
la
tutto
si
società
imparerebbe ad agire sempre più in perfetto accordo, nello stesso tempo in cui
ognuno dei suoi elementi acquista una maggior autonomia. La solidarietà
organica trova pertanto la propria forza nella differenziazione che porta i membri
di una società a completarsi l’un l’altro, in un sistema di compiti divisi e
complementari. Se da una parte le società basate sulla divisione del lavoro
enfatizzano le singole individualità perchè portatrici di ruoli specifici, non più
confuse in un gruppo sociale; dall’altra vi è il riconoscimento della finalità
collettiva intrinseca alla realizzazione della personalità e dei fini individuali nelle
attività specializzate. Il simbolo visibile del nuovo tipo di solidarietà diventa sempre
più il diritto ed in special modo quello cooperativo che determina le conseguenze
giuridiche degli atti e che esprime le condizioni normali dell’equilibrio: definisce ciò
Si utilizza il termine “società civilizzata” come nell’uso che ne fa Durkheim, ovvero per intendere le
società moderne in contrapposizione alle società primitive.
6
77
che dobbiamo fare e ciò che possiamo esigere. Al di fuori della sfera contrattuale,
ovvero della pressione organizzata che il diritto esercita, subentra la pressione dei
costumi e dell’opinine pubblica. Gli individui non sono più assorbiti dal gruppo,
come avveniva nelle società tradizionali, ma sono legati ad esso da un sistema di
regole nuovo, e la cui inosservanza fa incorrere in sanzioni di tipo restitutivo.
Con l’avvento
della
modernità,
o
della
civilizzazione Durkheim
teorizza,
condividendo in parte la teoria di Spencer7, la progressiva prevalenza delle
società organiche su quelle tradizionali, nelle quali la solidarietà si basa sempre più
sulla divisione del lavoro. La differenziazione cresce quindi con il complessificarsi
dei rapporti sociali tra gli individui – densità dinamica – perchè aumenta la
competizione tra questi ultimi. Per sfuggire agli effetti dannosi della competizione
le persone cercano però di specializzarsi “creando delle piccole aree riservate in
cui esercitare un tendenziale monopolio delle prestazioni” (Ibidem): diminuisce
quindi la densità morale in intensità, ma aumenta la complessità delle relazione
nella quale essa si colloca. Durkheim sostiene quindi che la divisione del lavoro
non è un fenomeno naturale, moralmente neutro, ma piuttosto il fondamento
della solidarietà, e quindi un fenomeno moralmente normativo.
Il dovere dell’individuo è quello di aderire a tale struttura normativa sforzandosi di
realizzare se stesso nel suo compito specializzato anche se limitato, accettando di
essere parte di un tutto, sacrificando parte delle sue capacità a favore della
specializzazione di competenze particolari che lo porteranno a svolgere la
funzione prevista, ad offrire un servizio preciso. In questa visione, lo spazio per le
dissidenze individuali si troverebbe nella maggior generalità e inderminatezza
della coscienza collettiva, anche se egli la intende come possibilità di avere una
forza creativa all’interno della propria funzione, che adempie ai principi della
solidarietà organica .
Spencer postulava che la solidarietà sarebbe fondata sull’accordo spontaneo degli interessi
individuali espressi nel sistema dei singoli contratti particolari. Tutto è quindi regolato per accordo
delle parti, e la società ha sempre meno ragione di intervenire. L’azione sociale organizzata tende
quindi a sparire e così anche lo Stato che ne è l’organo. Secodno Durkheim, nel contratto non
tutto è contrattuale e si riferisce all’elemento istituzionale, che inserisce il contratto in un corpo di
norme, e gli dà sicurezza, durata, prevedibilità di conseguenze. Atrimenti le relazioni contrattuali
sarebbero eccessivamente instabili, tanto da rendere impossibile qualisiasi forma di ordine sociale,
perchè I conflitti latenti dominerebbero sulla pretesa armonia degli interessi. (Introduzione a “La
divisione del lavoro sociale”)
7
88
Cambiando la forma di solidarietà deve quindi cambiare anche la forma della
società e in quest ultima l’organo centrale, ovvero lo Stato, che esercita nei
confronti del resto della società un’azione moderatrice, dipende dagli altri tanto
quanto essi dipendono da lui. Lo Stato stabilisce le regole entro cui le funzioni
specifiche devono cooperare; l’ambiente naturale diventa quello professionale
ed è allora la funzione che assolve a contraddistinguere il posto che ognuno
occupa, piuttosto che la consanguineità come nelle società primitive.
Poichè ragiona in termini di modelli, Durkheim ritiene che pur in una società
organica sia possibile trovare forme di solidarietà meccanica, anche se auspica “il
giorno in cui la nostra organizzazione sociale e politica avrà una base
esclusivamente professionale” (ibidem, pag.199) quando saranno eliminate le
cause anormali che ne limitano lo sviluppo. Le forme anomiche sono per il
sociologo francesce il punto di rottura oltre il quale la specializzazione non risulta
più una forza equilibratrice.
2.2. Anomia e vocazione: la divisione del lavoro industriale
Durkheim guarda a tutto ciò che differisce dalla media, dal comportamento
convenzionale, come deviante, nell’accezione di patologico. Nonostante ciò,
l’autore sostiene anche che solo da condizioni di disordine possa nascere il
cambiamento, altrimenti impensabile. Se allora le deviazioni dalla media sono
condizioni anomiche, che minano l’ordine sociale e vanno riportate nella media,
corrette, o isolate, si deve rilevare che la modernità - e nessun cambiamento
anche positivo - avrebbe potuto instaurarsi se non grazie a forme patologiche. Si
può allora desumere che una condizione patologica sia anche l’unica fonte di
liberazione da un’ordine prestabilito e la garante della possibilità di innovazione.
Mi sembra quindi che si possa riscontrare una contraddizione di fondo nel
“disegno”
dell’autore
che
postula
un
ideale
di
organizzazione
sociale
irraggiungibile, seppur desiderabile, e l’anomia come una malattia, e non solo
come un’imperfezione del sistema, senza prendere in considerazione, posizione
assunta invece da Bauman, le patologie del sistema come possibilità generate da
esso. Se infatti consideriamo, come fa Durkheim, la diseguaglianza di partenza
come
una
fonte
di
anomia,
sia
la
società
ottocentesca
sia
quella
contemporanea, si troverebbe in una situazione di costante mancanza di regole,
99
oppure potremmo pensare che la stessa organizzazione della società genera tale
diseguaglianza.
Per Durkheim è fondamentale che le persone abbiamo la possibilità di sviluppare
le capacità e le competenze di cui sono portatori e che li porterà a raggiungere il
loro posto all’interno della società solidale. L’anomia si manifesterebbe in primis a
causa della mancata realizzazione di una rigorasa uguaglianza delle possibilità di
partenza, “fino al momento in cui iniziano a manifestarsi in rispettivi meriti”
(Pizzorno in Durkheim, 1996): ognuno dovrebbe essere messo nella condizione di
seguire la propria vocazione, ovvero l’espressione individuale dei fini collettivi che
caratterizzano la società fondata sulla divisione del lavoro sociale, e di realizzare
l’integrazione dell’individuo nel sistema dei valori collettivi.
Il concetto di vocazione appare vago ed eccessivamente evocativo di una
“predestinazione”, seppur non geneticamente determinata, come se la persona
dovesse solo disvelare ciò che è il suo dovere all’interno della collettività; in altri
passaggi però sembra che la vocazione coincida con l’attitudine, ovvero la
comprensione delle potenzialità individuali. E’ lo stesso Durkheim a rilevare che la
vocazione alla quale l’individuo si sacrifica volontariamente diventa a poco a
poco una prigione, ma ipotizza che l’individuo stesso, che si è impegnato in essa,
possa anche liberarsene e riscattarsi per contrarne8 altre (Durkheim, 1996, pag.
327). Anche l’impossibilità di conquistare altre posizioni e funzioni è, nell’analisi
durkeheimiana, una forma di anomia della società. Ciò appare però poco
realistico rispetto a ciò che accadeva nella sua stessa epoca nella quale le
diseguaglianze di partenza erano, come lo sono oggigiorno, parte integrante
della struttura sociale, pur esistendo la possibilità di mutarle. Nel lavoro industriale,
per esempio, i compiti vengono assegnati piuttosto che scelti: questo aspetto
comporta, secondo l’autore, l’estraneità al sistema di valori. La situazione
anomica appare dunque costitutiva di un certo tipo di divisione del lavoro e non
un’anomalia cancellabile con uno svolgimento normale che in questo caso risulta
già di per sè anomico.
Ho volutamente mantenuto il termine “contrarre” in quanto mi sembra esplicativo della
dimensione del dovere della quale è intrisa l’opera del sociologo francese.
8
1100
Durkheim non mette in luce come l’uguaglianza di partenza si possa realizzare nel
passaggio da una società all’altra, come si possa mantenerla e sulla base di quali
criteri sono definiti i meriti. Il diritto non può essere l’unica risposta a questi quesiti in
quanto “più moltiplichiamo le regole e più la condizione dell’operaio presenta
appunto i caratteri dell’anomia” (Pizzorno in Durkheim, 1996). Da queste parole,
dal concetto di vocazione e da ciò che accade nella società industriale emerge
immediata un’assonanza con il lavoro estraniato di Marx che, ne “I Manoscritti del
‘44”, lo definisce come la disumanizzazione, la mercificazione dell’operaio ed al
contempo l’attività di produzione è vista come alienante, non volontaria, nella
quale la persona sfinisce il suo corpo e sviluppa la sua infelicità. Secondo Marx il
lavoro estraniante porta l’uomo in quanto essere cosciente a fare dell’essenza
soltanto un mezzo per la sua esistenza, in questo modo l’uomo non è più libero e il
suo lavoro è al servizio della retribuzione, non della soddisfazione. Durkheim ritiene
che l’individuo, per ovviare a ciò che avviene nel lavoro industriale, ovvero
diventare una macchina, deve tenersi strettamente in contatto con le funzioni
vicine e non chiudersi nella propria, in modo che diventi cosciente dei loro bisogni
e dei mutamenti alle quali sono soggette. Nonostante ciò l’autore evidenzia un
tipo di solidarietà, per esclusione, che nasce dalla divisione del lavoro tecnica o
industriale: una solidarietà che non presuppone nessuno scambio di prestazioni,
nè necessariamente una conoscenza o l’accettazione della complementarietà
dei compiti, piuttosto una comunanza di condizione, il lavorare a stretto contatto
che non crea le premesse per lo sviluppo della solidarietà organica.
Durkheim ipotizza che la situazione di anomia possa essere risolta attraverso la
formazione di gruppi professionali in stile corporativo e con statuto di istituzione
pubblica che emanino una regolamentazione giusta: emerge l’ideale societario
dell’autore, ovvero basato sull’uguaglianza delle opportunità di partenza: “ finchè
vi saranno dei ricchi e dei poveri di nascita non potranno esservi contratti giusti, nè
una giusta ripartizione delle condizioni sociali” (Durkheim, 1996, p. 34).
Le professioni e le corporazioni rivestono quindi molta importanza nella trattazione
del sociologo francese, e sono intese non solo come la messa in comune di
interessi economici da far valere, ma piuttosto come la volontà di associarsi per
comunicare, condurre insieme una medesima vita morale. Anche in questo caso
1111
emerge però la stessa ambiguità ed idealizzazione che si evidenzia nella
trattazione de La divisone del lavoro sociale: Durkheim auspica che le
coorporazioni incarnino le finalità sia dei singoli che del gruppo, ma non prende
sufficientemente in considerazione le dinamiche che si attuano a seguito
dell’istituzionalizzazione dei gruppi professionali. I gruppi corporative, secondo il
sociologo francese, avrebbero favorito la costituzione di una morale e di un diritto
professionale, e pur prendendo in considerazione le possibili distorsioni che le
istituzioni portano in sè oltre alla loro scarsa propensione al cambiamento e
all’autoreferenzialità, ritiene che non vi sia ragione per distruggerle perchè
possono essere l’unica base di costituzione della morale di un gruppo
professionale (ibidem, p. 20) in rapporto di complementarietà funzionale con
l’organo centrale: quest ultimo fissa i principi generali della funzione industriale,
mentre le declinazioni specifiche dovrebbero essere lasciate alle corporazioni. Un
aspetto invece che Durkheim non sembra prendere sufficientemente in
considerazione è la forza dei gruppi intermedi, ad esempio la famiglia e gli amici,
che esercitano pressioni più o meno evidenti, e a volte maggiori delle norme del
diritto.
2.3 La società dei giardinieri: il volto deresponsabilizzante e disumano della
divisione del lavoro.
La modernità per Bauman non è tanto l’esito, quanto il processo, il continuo
cambiamento che scaturisce nella ricerca costante della “modernizzazione”: “se
ci si ferma si smette di essere moderni” (Bauman, 2006).
Abbiamo già visto che la prima fase della modernità - “solida” - è ben descritta
dalla metafora del giardiniere che parte da un progetto di giardino, in cui ogni
pianta è classificata in termini di funzionalità e compatibilità con il progetto stesso.
Tutto ciò che non entra nell’ordine pensato è erbaccia da strappare ed
eventualmente sterminare: la modernità è dunque la costruzione di ordine a
partire dal caos. In Bauman la sostanza della modernità è la stessa della
managerialità ed era innanzitutto il capitale ad essere solido: non solo le fabbriche
non potevano essere trasportate ma gli stessi capitalisti dipendevano per la loro
fortuna dai lavoratori. Lavoratori e capitalisti erano legati indissolubilmente fra loro
e al territorio: era come nella formula matrimoniale “finché morte non ci separi”
1122
(Bauman, 2006). Perché la vita fosse sopportabile, bisognava trovare un modus
vivendi valido per ogni componente dell’unione.
I manager moderni, come nel Panopticon9, potevano osservare i dipendenti in
ogni momento e questi non sapevano mai se e quando erano osservati, quindi
erano spinti a comportarsi in ogni momento secondo il disegno dei manager.
L’orologio e la catena di montaggio, nella loro idea di routine, rappresentano
altre due metafore che ben spiegano quel periodo. L’essenza della managerialità
era dunque usare la libertà d’azione al fine di tagliare le possibilità di libertà
d’azione agli altri. È un paradosso solo apparente: il potere dei manager stava
proprio nel sovradeterminare le azioni dei dipendenti e ridurre la possibilità di
imprevisti, contando sull’immobilità e l’immutabilità dello spazio d’azione. Il sistema
sovietico, ad esempio, rappresentava la modernità solida all’ennesima potenza:
tutto era pianificato, nella sua essenza rappresentava il sogno manageriale dove
tutto era stabilito e soggetto a regolamentazione. Tutto ciò che non era permesso
era proibito e tutto quello che non era obbligatorio era parimenti proibito. Il
sistema rettificava la logica manageriale portata al suo eccesso. Con ciò stesso,
rivelava l’implicita insanità dell’ideale manageriale di plasmare il mondo secondo
un progetto che ha avuto conseguenze macroscopiche sia nel periodo di Stalin
sia con il Nazismo.
In Modernità e Olocausto infatti Bauman smaschera la faccia della modernità che
nella sua dimensione di progetto assume forme tutt’altro che astratte, nelle quali il
professionista giardiniere gestisce strumentalmente delle classificazioni –distinzione
e segregazione - nel giardino di sua competenza (Tester, 2005). Bauman identifica
gli avvenimenti tragici del ‘900 come possibilità insite nella modernità, nella sua
capacità di slegare l’essere umano dalla sua umanità (ibidem, pag.156). Anche in
questo concetto rieccheggia l’alienazione di Marx, seppur Bauman non la
intenda come un prodotto esterno a sè, ma piuttosto come condizione
caratteristica della condizione umana dalla quale però esiste la speranza di
affrancarsi. Nello stato eteronomico però questa possibilità diventa molto
complicata perchè non ha alcuna importanza che gli attori siano d’accordo con
Bauman si rifà alla metafora utlizzata da Focault in Sorvegliare e punire, Einaudi, 1976, per
caratterizzare la modalità della divisione del lavoro tecnica.
9
1133
gli ordini impartiti, importa solo che li eseguano. E’ la società stessa a diventare
disumanizzante, a far coincidere la responsabilità con il ruolo e a rendere anche i
comportamenti più aberranti possibili. E’ in questa chiave che si inscrive la visione
critica della Shoah da parte di Bauman: la società moderna ha creato la
possibilità perchè esso avvenisse attraverso la tacitazione della responsabilità,
l’adiaforizzazione dell’azione. Il sociologo polacco evidenzia con forza due
elementi alla base della perdità della dimensione morale dell’azione: in prima
istanza
la
delega
alle
organizzazioni
di
questa
dimensione,
ovvero
è
l’organizzazione che decide; di conseguenza il significato morale è espulso
dall’azione soggettiva, che a presecindere dalla sua valutazione morale è
legittima – è morale tutto ciò che è giustificato dal ruolo e dall’organizzazione.
Non si può quindi più rinchiudersi nella comoda spiegazione che solo persone
crudeli e patologiche abbiano commesso atti così raccapriccianti, ma piuttosto
bisogna fare i conti con il fatto che il progetto della modernità, e nella sua
accezione pegggiore quello nazista, poteva realizzarsi solo attraverso persone
obbedienti, dedite al loro compito, rispettose delle regole (Modernità e
Olocausto, 1992). E’ proprio nel pieno sviluppo della divisione del lavoro, con la
costante cura nella trasmissione degli ordini, la sincronizzata coordinazione delle
azioni autonome e tuttavia complementari, che si innesca la possibilità di vedere
l’aspetto aberrante della modernità.
Un ulteriore aspetto emergente nella trattazione di Bauman ed inestricabilmente
legato al precedente, riguarda la sempre maggior mediazione dell’azione che
porta ad una lontananza del soggetto dalle conseguenze delle sue azioni e alla
cecità morale10 (ibidem, p.45): “la maggior parte dei partecipanti al genocidio
non arrivò mai a sparare su bambini nè ad introdurre gas nelle apposite camere.
La maggior parte dei burocrati coinvolti stilava promemoria, preparava progetti,
parlava al telefono, e partecipava a conferenze. Essi erano in grado di
distruggere un intero popolo stando seduti alla propria scrivania” (Hilberg in
Bauman, 1992) Bauman sottolinea però che la civiltà moderna non è stata la
Si vedano su questo tema le ricerche di Milgram che evidenziano come persone non ritenute
patologiche dalla società siano in grado di commettere azioni ritenute generalmente crudeli
anche da loro stessi.
10
1144
condizione sufficiente dell’Olocausto, ma ne ha rappresentato la sua condizione
necessaria (ibidem, p.32).
Lo stesso autore, che vive nella società contemporanea ed ha assistito a quasi un
secolo di storia, ritiene che sia finita l’era della modernità solida, quella
caratterizzata dalle istituzioni, dalla solidità del capitale; oggi, di fronte a lavoratori
indisciplinati i padroni possono muovere la produzione in un’area più disponibile, è
il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive combinata con la fine
della necessità di trasferimento fisico dei centri di controllo. Viviamo in un’epoca
di progetti a termine, senza sapere chi ci impiegherà l’anno successivo. Tutto si sta
sciogliendo, ma non più al fine di creare un’altra solidità, perché nulla ha il tempo
per solidificarsi. La modernità odierna, come i liquidi, non può assumere una forma
per lungo tempo, ma è in continua evoluzione e produce costante incertezza ed
instabilità (Bauman, 2006). Ogni impegno è ora valido “fino a un nuovo ordine”
(ibidem) e deve poter essere rimpiazzato qualora si presentino migliori opportunità.
3. Il soggetto, il professionista e la morale: due prosepttive contrastanti
Come si può intuire dalle pagine precedenti, entrambi gli autori prendono in
grande considerazione la dimensione morale seppur con presupposti ed esiti
differenti: da dove nasce allora la morale?
Per Durkheim la morale11 ha fondamento collettivo, ovvero nasce dalla società, e
si esplicita principlamente in un insieme di regole. La morale è quindi composta da
precetti particolari, socialmente riconosciuti che precedono l’azione, piuttosto
che da principi posti a priori. I fatti morali12 incarnano in sè la legge generale della
morale che non è però visibile, e quindi non studiabile se non attraverso i fatti
morali. Sono proprio i precetti specifici, che hanno dignità propria, che obbligano
E’ da sottolineare che Durkheim differenzia tra morale, che è colletiva, ed etica, che è invece la
sua declinazione individuale, ma che è comunque individuale solo in apparenza perchè dipende
da condizioni sociali; mentre Bauman utilizza un termine per l’altro.
11
“Si dice fatto morale normale per una specie sociale data, considerate in una fase determinate
del suo sviluppo, ogni regola di condotta alla quale è collegata – nella media delle società di tale
specie, considerate nello stesso periodo della loro evoluzione – una sanzione repressive diffusa; in
secondo luogo la setssa qaulificazione conviene ad ogni regola che, senza presentare nettamente
questo criterio, è tuttavia analoga ad alcune delle regole precedenti, e cioè serve agli stessi scopi
e dipende dalle medesime cause.” (Durkheim, La diviosne del lavoro sociale, 1996, p.65).
12
1155
in ogni istante la volontà, che tracciano la condotta per le circostanze ordinarie
della vita. Queste pratiche sono “riflessi incisi, non all’interno dell’organismo, ma
nel diritto e nei costumi; si tratta di fenomeni sociali e non già biologici” (Durkheim,
1996, p. 54).
Potremmo già trovare in queste parole parte della differente visione da parte dei
due autori: la sociologia di Durkheim infatti finisce per elaborare un paradigma
secondo cui la morale, per usare le parole di Bauman, è “prodotto della società e
risultato del controllo sociale assistito da sanzioni”. L’autore polacco ritiene infatti
che, alla luce degli avvenimenti del ‘900, sia più realistico sostenere che le società
manipolano la moralità piuttosto che produrla. Il paradigma etico sociologico di
Durkheim rischia quindi, alla luce dell’analisi baumaniana, e delle stesse
contraddizioni interne all’opera del sociologo francese, di essere accusato di
indifferentismo (Morri, 2004) proprio perchè identificando la morale con il sistema
delle regole condivise, sembra essere destinato a giustificare come morale
qualunque sistema sociale, per quanto ingiusto o crudele possa rivelarsi. D’altra
parte Durkheim cerca di supportare l’idea che le regole non hanno una forza
costrittiva tale da soffocare il libero esame, ma nella sua tesi, come si è visto,
l’aspetto della libertà critica sembra fortemente vincolato dall’organizzazione.
Bauman
postula
burocratizzazione
una
e
tesi
la
opposta
a
razionalizzazione
quella
dell’autore
possano
francese:
portare
ad
la
una
deresponsabilizzazione morale spinta fino alle più infauste conseguenze, seppur si
abbia sempre la possibilità di scegliere.
La visione morale di Durkheim appartiene quindi alla cornice paradigmatica che
intende la morale come socialmente prodotta – “[…] la storia ha dimostrato che
ciò che era morale per un popolo poteva essere immorale per un altro, e non
soltanto di fatto, ma anche di diritto” (Durkheim, 1996, p.56) – mentre Bauman la
intende come presociale, avvicinandosi accidentalmente alle nuove scoperte
neuroscientifiche su un possibile sesto senso morale (Pinker, 2008; Rozin, 1993;
Wilson, 1993).
Nella modernità invece, secondo il sociologo polacco, la morale è la regolazione
coercitiva dell’agire sociale attraverso la proposta di valori o leggi universali a cui
1166
nessun uomo ragionevole può sottrarsi, mentre nella postmodernità, con la fine
delle ideologie, si rendono possibili tante morali.
Bauman propone un tipo di morale13 basato sull’impulso, non razionale, ad essere
per l’altro, a donarsi all’altro, indipendentemente da come l’altro si atteggia nei
nostri confronti: la morale è quindi del tutto irrazionale. L’origine della morale è
sempre un atto individuale, che implica necessariamente un io - è la mia
decisione, mai un noi in quanto non è un atto collettivo, né l’esito di un accordo.
La morale quindi è un atto del tutto individuale, ma crea la società (Bauman,
2006). La società nasce da una scelta etica individuale, e però crea un vincolo:
viviamo in società, siamo in società, solo in virtù del nostro essere morali. L’atto
morale ci permette di incontrare l’altro non come persona/maschera14, ma come
volto, cioè nella sua vera identità e non nel ruolo. Il paradosso della morale per
Bauman è che da un lato crea disordine; dall'altro è necessario come atto
fondante della società in quanto senza l'impulso di aprirsi all'altro non ci sarebbero
le relazioni sociali. Tuttavia, essendo l'impulso della morale irrazionale e libero, è in
antitesi all'ordine sociale, e pertanto la morale rischia di non avere molto spazio in
una società sempre più complessa che ha bisogno di regole sempre più
sofisticate. Bauman non risolve questo paradosso del ruolo della morale, pur
essendo cruciale nella sua visione.
Come può allora crescere l’etica che ha bisogno del sentimento di appartenenza
comune, del “siamo tutti nella stessa barca”, di solidarietà, di una responsabilità
mutua che ci faccia prendere consapevolezza di questa responsabilità?
Dipendiamo l’uno dall’altro e se non cooperiamo siamo condannati: è questo lo
sfondo nel quale porre diritti, doveri, responsabilità, che sono i fili che intessono
l’etica (ibidem). La morale dominante di una fuga dalle responsabilità e dagli
impegni assunti, porta a guardare all’etica come ad un costo non necessario,
dunque da evitare. L’uomo quindi nasce responsabile prima ancora di essere
la concezione morale di Buamna prende spunto dalle teorizzazioni sulla dimensione morale di
Levinas, filosofo francese.
13
Bauman usa il termine “persona” nel senso in cui viene usato dall’interazionismo simbolico, per
cui il concetto di persona è inteso nel senso di una maschera che ricopre un ruolo. L’identità di
ogni individuo è la somma di tutti i ruoli che copre, per questo si parla solo di persone, cioè di attori
che ricoprono ruoli.
14
1177
libero: egli si trova originariamente assegnato all'alterità e alla responsabilità,
prima di ogni eventuale accettazione o rifiuto. La soggettività non è un per sé ma
un per l’altro. Questo peso della responsabilità è anche la sua suprema dignità
(Mordeglia, 2008).
Vi è pertanto concatenazione tra responsabilità, decisione e conseguenze di tale
decisione; ciò implica la convinzione che l'uomo abbia il potere di conoscere o
quantomeno di prevedere gli effetti di una decisione. L'imperativo dell'etica della
responsabilità è quindi così formulato: “agisci in modo tale che gli effetti della tua
azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente
umana” (Mordeglia, 2008). L’aspetto estremamente interessante di questa visione
della morale è il focus posto sulla scelta: la responsabilità esiste in collegamento al
prendere una decisione; una persona decide di fare una cosa invece di un’altra
compiendo in questo modo una scelta e facendosi carico dei suoi effetti. La
scelta è una dimensione costante del vivere sociale, dalla quale non ci si può
sottrarre pena atteggiamenti vittimistici15: in Modernità e Olocausto Bauman
esprime bene questo bivio morale mostrando che non tutti i tedeschi hanno scelto
una posizione passiva di fronte alle aberrazioni del progetto nazista.
4. Responsabilità professionale nel servizio sociale
Il servizio sociale si è confrontato negli anni con diversi cambiamenti16, più o meno
lenti, sia organizzativi sia relativi al ruolo dei professionisti e tuttora vive di molte
contraddizioni: si oscilla tra l’impegno civile e politico con un focus sulla comunità,
a puntare invece sul soggetto singolo; da promotori di cambiamento ad esperti di
problem
solving;
dall’assistenzialismo
all’empowerment;
da
organizzazioni
verticistiche autoritarie ad aziende gestite con logiche manageriali.
La divisione tecnica del lavoro appare a tutt’oggi l’impianto sul quale si basano i
servizi sociali, connotati da specializzazione passiva e frammentazione degli
interventi, che pur si sta tentando di superare, ma che tiene in scarsa
considerazione i soggetti e la loro attiva partecipazione come attori competenti.
Nelle pagine di Modernità e Olocausto è ben esplicitato il ruolo delle vittime nella possibilità del
carnefici di perpetrare i propri orrori.
15
Per un’analisi delll’evoluzione della professione dalla sua nascita ad oggi, si rimanda alla tesi di
dottorato di Silvana Mordeglia.
16
1188
In questo scenario organizzativo è allora il professionista a dover giocare la propria
umanità professionale, a dover diventare agente di cambiamento all’interno del
sistema nel quale lavora, ad uscire dal ruolo specifico diventando una “sinapsi”
che mette in comunicazione e non che si sostituisce alle persone. E’ necessario
che gli ssistenti sociali escano da un attaggiamento vittimistico rispetto alle
“professioni forti” e difensivo nei confronti dell’altro, per proporsi come soggetto
che agevoli l’attuazione dei diritti di cittadinanza ed umani tanto sbandierati dai
partiti politici ed operatori, ma che spesso non trovano riscontro nella quotidianità.
“Non posso fare nulla, non sono io che faccio le Leggi”: una frase che spesso
rieccheggia negli uffici degli operatori sociali.
Possiamo evidenziare due livelli di responsabilità nel lavoro sociale, quello del
professionista nei confronti della comunità e delle persone con le quali si trova ad
interagire, e quello nei confronti di sè stesso e della professione. Solo
apparentemente le due dimensioni della responsabilità potrebbero contraddirsi
l’un l’altra, ma piuttosto la seconda rafforza la prima.
Credo infatti, concordando con le parole di John McKnight17, che le persone,
utenti o clienti dei servizi sociali18, non siano soggetti in uno stato di bisogno, ma
piuttosto persone di cui abbiamo bisogno. Riflettiamo su un parallelismo
provocatorio: se la solidarietà ideale di Durkheim funzionasse perfettamente non
ci sarebbero più evoluzioni; altrettando se gli obiettivi dei servizi sociali e di quelli
preventivi ottenessero effetti duraturi e stabili, non ci sarebbe più lavoro per gli
assistenti sociali. Forse si tratta di una posizione un pò scomoda, ma credo che
uscire dalla dinamica della persona bisognosa aiuti non solo a vederla come
risorsa, e non come problema o portatore di carenze, ma anche come funzione
essenziale di “soddisfare il bisogno dei servizi” (McKnight in Illich, 2008, p.77). I servizi
sociali dispongono di un pericoloso potere a doppio taglio, perchè il loro aiuto
può accompagnarsi ad una sistematica disabilitazione dei cittadini rispetto al
controllo della propria vita. Nell’ambito del lavoro sociale si parla molto di
17
McKnight J., assistenti sociali disabilitanti, in Ivan Illich et al., Esperti di troppo, Erickson, Trento, 2008
Vi è un dibattito aperto tra posizioni che ritengono opportuno chiamare le persone che
accedono ai servizi sociali clienti, ed in quanto tali assimilabili ai consumatori che hanno la
possibilità di scegliere, e utenti.
18
1199
partecipazione attiva dei cittadini e di valutazione dei servizi sociali da parte degli
utenti,
ma
sembrano
più
principi
formali
dichiarati
che
non
pratiche
effettivamente implementate.
La creazione dei bisogni è un tema molto aperto e si dibatte se siano le istituzioni,
con la loro nascita, a crearli ed alimentarli, oppure se esse li riconoscano e
vadano a fornire una risposta: ad esempio, se la pratica di attivazione delle reti di
vicinato per il supporto alle situazioni di difficoltà famigliare fosse maggiormente
utilizzata, potremmo pensare che diminuirebbe il numero di educatori professionali
impiegati; invece l’assistenza domiciliare per i minorenni è fortemente utilizzata
anche se il suo impatto positivo non è stato mai seriamente studiato.
E’ possibile allora che, “a forza di immettere risorse, che appaiono comunque
sempre poche a chi lavora nei servizi, non stiamo ottenendo l’esatto contrario di
ciò che quel sistema dovrebbe produrre”? (ibidem, p.78): credo sia un quesito
che valga la pena di porsi. Dovrebbe essere responsabilità degli assistenti sociali
conoscere i costi delle risorse utilizzate, mentre la budget accountability è quasi
inesistente nei servizi sociali: la responsabilità del budget dovrebbe costituire una
pretesa fortemente ricercata dagli operatori nelle organizzazioni perchè avvicina
gli operatori ai centri di controllo con uno scambio attivo e critico.
Come specifica McKnight la maschera dei servizi, quella della care, non è
necessariamente falsa, “chi si impegna nei servizi è convinto di trasmettere
davvero cura e amore” (p. 76), in questo aspetto troviamo un collegamento con
la visione morale di Bauman: la maschera fa un tutt’uno con il volto, dove il volto è
l’autenticità che però è nascosta. Se invece togliamo la coperta mistificatoria del
care, possiamo vedere altro, così come in qualunque ambito lavorativo: la
necessità di avere un lavoro e di guadagnare; il desiderio di affermazione e di
prestigio nella cerchia dei professionisti o dell’ambito scientifico; la concorrenza.
Questo disvelamento non toglie alla pratica sociale la sua profonda e radicata
sensibilità nei confronti dell’altro, ma rende quest’ultima molto più autentica.
La responsabilità professionale nel servizio sociale si declina quindi, in prima
istanza, nella consapevolezza di sè, dei bisogni che si portano nella scelta
lavorativa: una docente illuminata molti anni fa mi aiutò a capire che spesso chi
approccia il lavoro sociale lo fa per sè prima che per gli altri; prima si entra in
2200
contatto con questo fondamentale aspetto, più si è in grado di essere
consapevoli della maschera, e di conseguenza del volto. Solo questa pratica
costante di scandaglio nel Sè apre la strada per un approccio autentico e
professionale all’altro nella sua completezza di uomo e non di caso sociale. La
consapevolezza di sè, dei propri limiti e delle proprie risorse, è quindi la prima
responsabilità del professionista sociale. Rientra in questo livello di responsabilità la
sperimentazione del professionista sul campo: “sporcarsi le mani” provando gli
effetti disabilitanti (Illich, 2008) e positivi che la propria professione, e la struttura
nella quale opera, ha sulla comunità e sulle persone, è un fattore imprescindibile
per essere professionisti responsabili.
In seguito all’accesso alla consapevolezza di sè, subentra allora la responsabilità
di confrontarsi; di approcciare l’altro con umiltà e rispettosamente curiosi; di
mettersi continuamente in discussione e avere l’abilità di mostrare il volto; di
riconoscere i propri pregiudizi ed utilizzarli come strumenti positivi di lavoro. Solo da
ciò può nascere la possibilità di scegliere di essere disobbedienti, nell’accezione
baumaniana, o di mantenere consapevolmente la stabilità del sistema; “di fare
pressione nei confronti dello Stato e degli Enti affinchè si orientino verso un
cambiamento politico che renda i servizi più adeguati a cittadini visti come
competenti e non carenti” (Mordeglia, 2008, p. 100) oppure di aderire
all’organizzazione nella maniera solidale pensata da Durkeheim.
Gli assistenti sociali hanno molto più potere di quanto se ne riconoscono sia nei
confronti delle Autorità Giudiziare sia degli Enti nei quali lavorano: opporsi a scelte
politiche mistificatorie o ad una burocrazia tuttora presente e a imposizioni dei
Tribunali ritenute contrarie agli interessi delle persone è possibile. E’ sicuramente
difficile, ma sempre possibile, ed in questo emerge la lungimirante visione di Illich:
se chi lavora nel sociale lo facesse per prendersi cura degli altri, non si porrebbe
certo il problema del mantenimento del proprio posto di lavoro di fronte a ciò che
ritiene ingiusto, perchè l’unico principio sarebbe la care.
Possiamo pensare che attraverso un processo di triangolazione tra teoria, pratica
e teoria sia possibile vedere al di là della celebrazione del prendersi cura, è
possibile ripensarsi e ripensare la professione in maniera effettivamente critica e
riflessiva, senza “utilizzare continuamente l’identità professionale come difesa”.
2211
Il continuo scambio tra teoria e pratica implica attenzione nei confronti della
comunità, ma anche dei professionisti che si stanno formando: la triangolazione
del sapere porta a una ricchezza di contenuti e di dibattito che altrimenti si
scontrerebbe
con
un’astrazione
eccessivamente
elevata;
si
evita
inoltre
l’autoreferenzialità del formatore. Il professionista responsabile è allora colui che
attraverso la circolarità del sapere teorico e pratico, ma anche organizzativo,
riesce a pensare alla propria professione come ad una dimensione creativa e
generatrice di giustizia basata su un pensiero critico nel quale l’altro è soggetto da
cui imparare, e non al quale impartire prescrizioni: gli utenti sono La risorsa dei
servizi, senza di loro essi non esisterebbero.
2222
Conclusioni: verso una critica e riflessiva responsabilità professionale
Dall’analisi emerge la realistica visione della modernità come composta da due
facce “che aderiscono in perfetta armonia allo stesso corpo” (Bauman, 1992) e
diventa chiara la persistenza dell’ambivalenza, che si nota con particolare
efficacia nell’opera di Durkheim.
La divisione del lavoro sociale come declinata nella prima parte dell’opera del
sociologo francese può essere intesa come un tentativo di esplicitare e
sistematizzare ciò che “dovrebbe essere”, ossia il desiderabile; mentre l’analisi
delle forme anomiche può apparire un tentativo di analizzare ciò che stava
avvenendo sotto i suoi occhi e porre una forte critica a quella deriva negativa
della modernità. In sintesi, il sociologo francese poteva intendere la divisione del
lavoro industriale solo come patologica a seguito delle premesse di partenza del
suo approccio epistemologico.
Partendo dalle contraddizioni presenti nella trattazione del sociologo francese e
nelle riflessioni di Bauman possiamo dedurre che le ambivalenze sono ineliminabili
nella società e che l’ordine perfetto di una società completamente integrata sia
possibile solo ad un elevato livello di astrazione, ma mai nella vita reale.
Impariamo però da Bauman che si dovrebbe essere responsabili e cercare di
tendere alla creazione di un mondo nel quale ognuno sia responsabile per sè, ma
soprattutto per l’altro. E’ venuto il tempo di accettare l’altro nella sua diversità, per
diventare uno di noi, ma non necessariamente uno uguale a noi. È solo lasciando
che l’altro resti ciò che è, o meglio sia se stesso, che possiamo scoprire e
valorizzare la differenza creativa invece di continuare a ritirarci in noi stessi, nei ruoli
che ricopriamo, e quindi a separarci dall’altro, esasperando la competizione;
possiamo allora scegliere una seconda opzione, quella di una ambizione globale,
la global responsibility (Bauman, 2006).
2233
Bibliografia
Bauman Z., Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna, 1992
Bauman Z., Universal Sun and Domestic Lamp, Corso di Alta Formazione in Business
Ethics Management, Assoetica, Docenza di sabato 27 marzo 2006
Durkheim E., La divisione del lavoro sociale, Ed. Di Comunità, 1996
Harendt A., la banalità del male. Eichman a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 2001
Illich I. et al., Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Ed.
Erickson, Trento, 2008
Leccardi C., Dentro l’individualizzazione. Etica della responsabilità e politica, in
Bauman Z., Individualmente insieme, Ed. Diabasis, Reggio Emilia, 2008
Marx K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1968
Mordeglia S., Il profilo della responsabilità profesionale nel servizio sociale, Tesi di
Dottorato di Ricerca in Servizio Sociale XX° ciclo, università degli Studi di Roma Tre,
2008
Morri L., Etica e società nel mondo contemporaneo, Franco Angeli, Milano, 2004
Steven Pinker, “The moral instinct”, The New York Times Magazine del 13 gennaio
2008
Rozin P., Markwith M, & Stoess C. (1997). Moralization and becoming vegetarian:
the transformation of preference into values and the recruitment of disgust.
Psychological Science, 8 (2), 67-73
Salamone N., Postmodernità, Carocci, Milano, 1999
Tester k., Il pensiero di Zygmunt bauman, Ed. Erickson, Trento, 2005
Wilson James, The moral sense, Free Press Paperback, New York, USA, 1993
2244