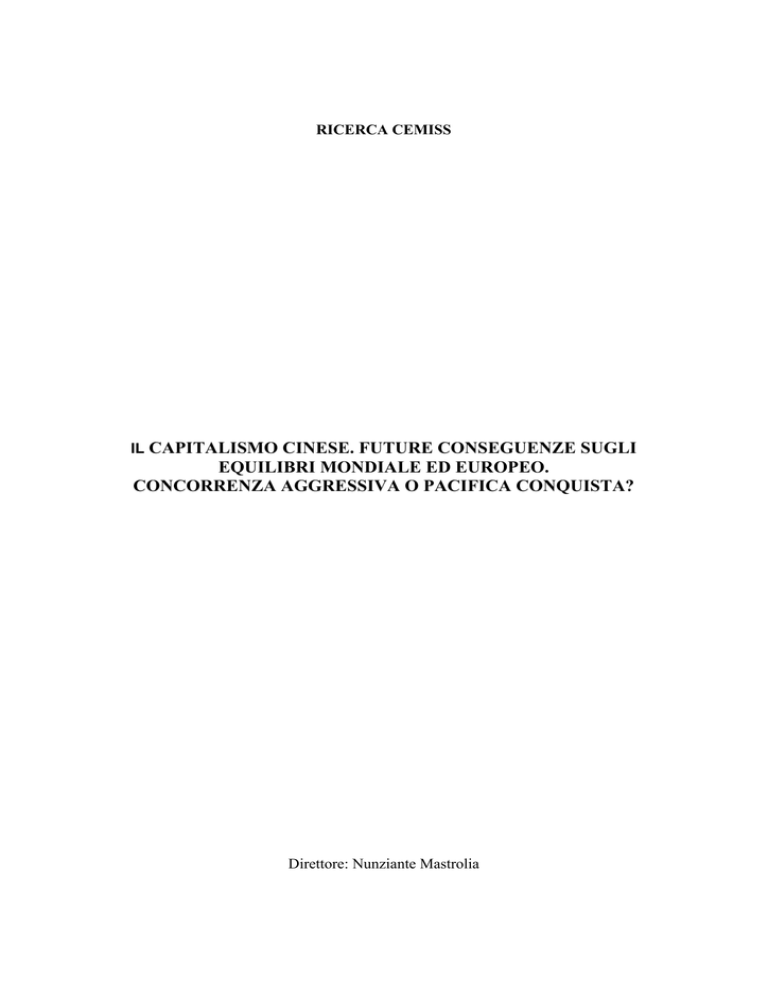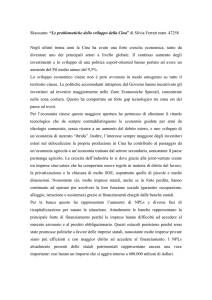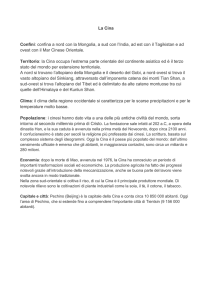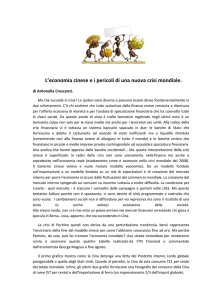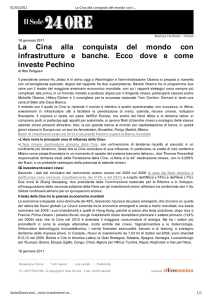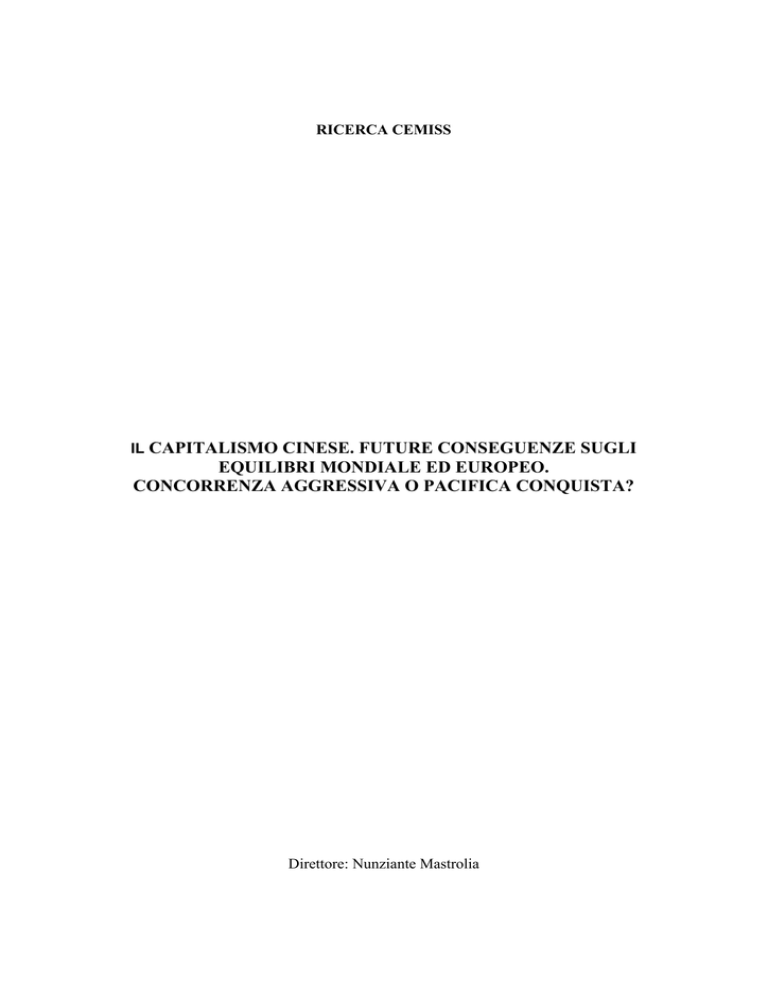
RICERCA CEMISS
IL CAPITALISMO CINESE. FUTURE CONSEGUENZE SUGLI
EQUILIBRI MONDIALE ED EUROPEO.
CONCORRENZA AGGRESSIVA O PACIFICA CONQUISTA?
Direttore: Nunziante Mastrolia
INDICE
EXECUTIVE SUMMARY
4
LA GLOBALIZZAZIONE DI RITORNO
7
UNA NECESSARIA PREMESSE STORICA
16
Lo splendore del celeste Impero
18
La lettera di Giorgio III
20
La lettera dell’Imperatore, come ad uno Stato Vassallo
22
Le conseguenze della sufficienza cinese
24
Alla ricerca delle fonti della potenza europea
29
La fine dell’Impero
34
LA CINA DIVENTA GLOBALE
36
Non solo miniere
39
Dall’Open door al Go Global
43
L’evoluzione del quadro regolamentare
45
La distribuzione geografica e settoriale degli IDE cinesi
50
I campioni nazionali cinesi
52
FUSIONI ED ACQUISIZIONI
65
GLI INVESTIMENTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
75
Petrolio e non solo
76
Cina-Africa
Quali conseguenze politiche?
81
88
Cina-America Latina
92
Cina e Medio Oriente.
100
ITALIA E GO GLOBAL
111
2
Le società costituite o acquisite in Italia
118
La questione dei porti
125
CONCLUSIONI
133
ALLEGATI
136
BIBLIOGRAFIA
151
3
EXECUTIVE SUMMARY
The emergence of China as a global economic powerhouse is now widely recognized
among business and policy circles around the world. It has become conventional
wisdom, for example, to speak of the imperative for all businesses, indeed all
government departments even, to develop a “China Strategy”, whether or not these
entities do any direct business with China.
Most of the attention on China’s economic prowess has been directed at its sustained
high economic growth of the last two decades, driven in part by massive inflows of
foreign direct investment (FDI) and by the rapid expansion of exports. China’s openness
to foreign investment, chiefly in the manufacturing sector, has reshaped global supply
chains, and affected production, sourcing, and investment decisions .
In contrast, much less attention has been given to China’s role as a source of outward
direct investment (ODI). While Chinese ODI is still very small relative to global flows,
the rate of growth is among the fastest compared to other source countries.
By the end of 2006, more than 5,000 domestic Chinese investment entities had
established nearly 10,000 overseas direct invested enterprises in 172 countries around
the world. The accumulated outward FDI stock volume stood at US$ 90. 63 billion,
among which non-finance FDI reached US$ 75.02 billion, accounting for 82.8%. The
outflows of finance outward FDI reached US$ 3.53 billion in 2006, among which the
banking industry invested US$ 2.508 billion, accounting for 71%. By the end of 2006,
the accumulated stock of finance outward FDI stood at US$ 15.61 billion, among which
US$ 12.336 billion was of banking industry and US$ 776 million was of insurance
industry, accounting for 79% and 5% respectively. By the end of 2006, the Chinese
state owned commercial banks had established 47 branch offices, 31 affiliated
institutions and 12 representative offices in 19 countries including the United States,
Japan and Britain, etc, hiring more than 20,000 local staff. By the end of 2006, China
had established 12 financial institutions in insurance industry abroad. The non-finance
outward FDI reached US$ 17.63 billion in 2006, marking an increase of 43.8% year-onyear.
4
According to the UNCTAD World Investment Report 2006, the world’s FDI outflows
reached US$ 778.7 billion and the stock volume of FDI amounted to US$ 10671.9
billion in 2005. Calculated with this as the base period, China’s FDI outflow and stock
constituted 2.72% and 0.85% of the world’s total respectively in 2006, ranking China
13th in the world’s total FDI outflow among all countries.
The prospect of China becoming a major source of FDI is received with a mixture of
enthusiasm and apprehension by many recipient countries. While most economies
would welcome the inflow of long-term equity investment, there are concerns -especially in industrialized countries -- about the motivations and quality of Chinese
capital. These concerns include the fear of ceding sensitive technologies to a potential
military competitor; loss of control over natural resources in the event of global
scarcity; poor management and governance practices; and the unsavoury human rights
reputation of the Chinese government and, by extension, of its stable of state-owned
companies. While some of the concerns around Chinese ODI are not without merit, it
would be foolhardy for recipient countries, including Italy, to ignore the phenomenon of
China as a capital exporter or, worse, to reject Chinese investment on the basis of gross
generalizations about the motivations and practices of the Chinese government and of
Chinese industrial concerns.
At the same time, few issues have generated as much heat in recent Africa and Latin
American affairs as China’s engagement in the two continents. China has been pushing
increased investment and cheap credit into Africa and Latin America for at least five
years. But the astonishing levels of expenditure and the breadth of Chinese involvement
reached levels in 2006 that focused minds in the West and provoked much media
hyperbole.
China, meanwhile, has been growing at just short of 10% a year for the past four years
and reached 10.7% in 2006. Such growth, in a country and an economy that size,
generates a huge appetite for inputs. Electricity demand is so high that last year China
added new power capacity “equal to the entire capacity of the UK and Thailand
combined, or about twice the generating assets of California.” China overtook Japan to
become the world’s second largest oil consumer in 2003 and now trails only the United
States.
5
In its engagement with Africa and Latin America, China certainly aims to build a
political constituency for its much-touted “peaceful development.” But its primary
interest is petroleum and raw materials. If Beijing’s goal of quadrupling the size of the
economy by 2020 is to be met, energy consumption, and therefore demand, will climb
even higher. Africa and Latin America have resources in abundance but almost low
capacity to process those resources: a perfect opportunity for a rising economy like
China. Africa and Latin America can supply its raw inputs and also provide a market for
China’s manufactured products.
The developed world fears that the inflow of investment from China is a concrete
demonstration that the Western model of development has failed. The implication is that
Africa and Latin American leaders should worry less about meeting demands for
transparency, accountability, rule of law, and other such “neo-liberal” objectives and
focus instead on economic growth. With China in the picture, they will find the
resources they need.
6
La globalizzazione di ritorno
Pechino una potenza benevola. Potrebbe sembrare una affermazione azzardata ed in
controtendenza, ma una serie di elementi lasciano supporre questo. L’economia cinese è
trainata dagli investimenti internazionali e dalle esportazioni, dipende quindi
completamente dai mercati esteri e dalla stabilità e tranquillità dell’ambiente
internazionale. Se Pechino nutrisse delle aspirazioni anti sistema e covasse delle velleità
per la costruzione di un ordine cinese a livello regionale dovrebbe in primo luogo
cercare di diminuire la propria stretta connessione con i mercati internazionali, un
fattore che in caso di crisi, rappresenterebbe il suo primo tallone di achille. In altre
parole se Pechino avesse delle aspirazioni “rivoluzionarie” sarebbe in primo luogo
indotta a dare il via ad una politica di import-substitution e in secondo luogo dovrebbe
legare la propria crescita più sui consumi interni che sulle esportazioni. Ma tutto ciò non
si sta verificando, nonostante le dichiarazioni delle autorità cinesi di fare crescere la
quota dei consumi interni.
In secondo luogo, se Pechino avesse delle aspirazioni anti sistema, dovrebbe impiegare
le ricchezze accumulate in trent’anni di crescita economica per finanziare i propri sogni
di potenza globale, dovrebbe quindi impiegare politicamente quelle risorse economiche.
Ma ciò non si sta verificando. La maggior parte delle preoccupazioni derivano dal fatto
che Pechino segue, nel settore della sicurezza energetica e dei rifornimenti di materie
prime, un “approccio strategico”, non uno “di mercato”1. Vi sono però segni che la Cina
stia modificando la sua politica del settore, e che, seppur progressivamente, abbandoni
l’approccio strategico, per orientarsi più verso il mercato. I fatti del 2007 sembrano
indicare che Pechino stia impiegando le proprie riserve secondo logiche esclusivamente
economiche e non politiche.
Tali riserve, in un fenomeno di globalizzazione di ritorno, vengono investite sui mercati
internazionali, nelle più classiche operazioni di mergers & acquisition o in investimenti
greenfield, e nei fondi sovrani, e non restano in patria.
1
Philip Andrews-Sped, Xuanli Liao and Roland Daunreuthe, The Strategic Implications of China
Energy’s Needs, International Institute for Strategic Studies, Adelphi Papers n. 346, London 2002; vds.
anche Steven Lewis, Beijing Oil Diplomacy, Survival, Spring 2002, pp. 15-34.
7
In altre parole i timori da molti espressi negli anni passati che Pechino potesse utilizzare
le ricchezze accumulate per finanziare i propri sogni di potenza, vanno scemando.
Non solo, ma anche l’attenzione che i massimi vertici politici, in un appuntamento
fondamentale, come quello del XVII Congresso del partito, hanno riservato alla politica
industriale e, nello specifico, alla creazione di imprese a caratura globale e
all’acquisizione di marchi che potenzino le capacità di penetrazione economica sui
mercati internazionali, indicano che la Cina vuole competere sui mercati internazionali
esclusivamente secondo le logiche economiche.
Pechino quindi, anche con la creazione della la China Investment Corporation (Cic)
lanciata ufficialmente il 29 settembre del 2007, la grande holding di Stato che avrà in
compito di investire il tesoro di 1400 miliardi di dollari, è impegnata ancora seriamente
nella più ampia strategia di “uscita”, ovvero investire oltre le frontiere per avere gli
strumenti più idonei per competere economicamente sui mercati internazionali.
Questa strategia era stata inizialmente enunciata nel decimo piano quinquennale del
2001 come uno dei quattro pilastri che avrebbero permesso alla Cina di adeguarsi in
maniera efficace al fenomeno della globalizzazione economica. Con la creazione del
fondo sovrano (la CIC appunto), il governo cinese accentrerà in un unico organo
funzioni che erano assolte in precedenza da altre branche dell’amministrazione in
maniera da rendere più efficace ed incisiva la conquista di mercati ed aziende estere.
Guidato da Lou Jiwei, uno dei vice segretari generali del Consiglio di Stato (l’organo di
governo cinese) ed ex ministro delle finanze, la neonata agenzia avrà il compito di
investire all’estero le ingenti riserve internazionali accumulate dalla Repubblica
Popolare negli ultimi anni. A fine settembre 2007, tali riserve avevano toccato la cifra di
1,4 trilioni di dollari (le più alte del mondo). Gli analisti si aspettano che entro la fine
dell’anno si arrivi a 1,5 trilioni. Inizialmente la Cic è stata dotata di 200 milioni di
dollari che secondo fonti ufficiali saranno via via aumentati in base agli investimenti
che la nuova agenzia governativa effettuerà. Secondo uno studio di Chatham House
pubblicato a settembre 2007, la nuova compagnia di investimenti cinese sarà presto il
numero due del mondo, dietro solo all’Adia, il fondo degli Emirati Arabi. La questione
centrale è pertanto dove e verso quali settori e industrie si indirizzeranno le ingenti
riserve valutarie cinesi. È opinione degli addetti ai lavori che la Cic procederà lungo un
8
doppio binario: da una parte accompagnerà il governo e le grandi imprese statali nel
loro shopping mondiale di materie prime, soprattutto energetiche, nei paesi in via di
sviluppo e nelle economie emergenti del Sud-Est asiatico, America latina ed Africa.
Allo stesso tempo, investirà in tecnologie avanzate, know-how, stabilimenti di ricerca e
sviluppo e marchi internazionali nelle economie avanzate dell’occidente, Giappone ed
Australia. In particolare, l’Europa è vista dalla dirigenza cinese come fonte di grandi
opportunità.
Se negli Stati Uniti le tendenze protezionistiche che stanno accompagnando la
campagna per le elezioni presidenziali potrebbero, infatti, creare qualche difficoltà alla
Cic, l’Europa sta lentamente emergendo come il luogo più favorevole per investire i
capitali cinesi, in particolare nell’Ict, energia, aerospaziale e bio/nano tecnologie. Tali
settori sono interessanti sia per i possibili ritorni sull’investimento che per
l’acquisizione di conoscenze e tecnologie di grande valore strategico e con possibili
ricadute sul settore della difesa. Alcuni policy makers europei si sono già espressi a
favore dei capitali cinesi. Il ministro dell’economia italiano, Tommaso Padoa-Schioppa,
ha giustamente invitato le autorità di Pechino a venire ad investire in Italia. Similmente
hanno fatto altri ministri europei. Allo stesso tempo, il presidente francese, Nicolas
Sarkozy, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, si sono espressi a favore di una sorta
di golden share europea esprimendo preoccupazione che i fondi statali come quello
cinese possano acquisire partecipazioni e financo quote di controllo in settori industriali
europei ritenuti di interesse strategico.
Molte di queste remore e paure appaiono, però, alquanto eccessive se si considera, come
si diceva poc’anzi, che Pechino non sta impiegando le proprie riserve per finanziare i
suoi sogni di potenza politica, ma sta continuando a perseguire i suoi sogni di
arricchimento secondo le logiche del sistema economico internazionale, “restituendo” a
questo i capitali incamerati.
Dal punto di vista economico, sappiamo bene che il sistema paese Italia è arrivato buon
ultimo tra i grandi paesi europei ad investire sul mercato cinese. Le aziende italiane,
spesso lasciate a sé stesse, scontano ancora mille difficoltà nell’immenso mercato
cinese. La creazione della Cic e l’interesse ad investire in Europa offrono pertanto
all’Italia l’opportunità di guadagnare in casa quel terreno che si è perso per vari motivi
9
in Cina. E’ richiesto, dunque, uno scatto in avanti per cogliere al meglio i flussi
finanziari provenienti dal gigante asiatico. Dagli investimenti delle sue riserve valutarie,
le più cospicue al mondo, possono infatti derivare grandi opportunità per le imprese e
l’intero sistema paese italiani.
Stiamo infatti assistendo ad una nuova fase della globalizzazione economica, che
potremmo definire di ritorno. Se la prima fase infatti, ha comportato una migrazione dei
capitali in massima parte nei paesi in via di sviluppo, comportando una parcellizzazione
del processo produttivo, attraverso la delocalizzazione delle fasi labour intensive nei
mercati più basso costo della manodopera, la nuova fase comporta il ritorno di quei
capitali sia nei paesi in via di sviluppo alla ricerca di materie prime, sia, e in maniera
sempre più crescente nei paesi sviluppati acquistando aziende spesso in crisi ma che
continuano a detenere importanti marchi, assets e tecnologie e know how.
Questa globalizzazione di ritorno ha anche altre importanti implicazioni. Non solo
Pechino si lega sempre più ai mercati internazionali e a quel sistema liberal-democratico
che ne è la matrice, ma immette le imprese cinesi, soprattutto quelle di Stato, in quello
stesso percorso di occidentalizzazione delle proprie prassi sui cui la Cina si è dovuta
incamminare per poter crescere economicamente.
L’apertura economica della Cina ha reso, infatti, il paese la piattaforma industriale del
mondo, legando così la propria crescita economica e la propria prosperità alla necessità
di un ambiente internazionale stabile e pacifico. A partire dalla riforme lanciante da
Deng Xiaoping la goccia dell’economia è riuscita, dunque, a spegnere le velleità
rivoluzionarie globali di Pechino e trasformare il paese nel motore della globalizzazione
economica e liberale occidentale. Un risultato non casuale, ma anzi il frutto diretto di
una lungimirante visione.
“A lunga scadenza, è del tutto impossibile credere di poter lasciare per sempre la Cina
fuori della comunità delle nazioni, a rimuginare sulle sue fantasie, coltivare i suoi odi e
minacciare i suoi vicini. Sul nostro piccolo pianeta non ha senso che un miliardo dei
suoi abitanti, potenzialmente più solerti, sia lasciato in irato silenzio. A breve scadenza
ciò suggerisce una politica di fermo riserbo, di rifiuto di concessioni e di
contropressione costruttiva intesa a persuadere Pechino che i suoi interessi fondamentali
possono essere soddisfatti solo con l’accettazione delle regole fondamentali della civiltà
internazionale. A lunga scadenza ciò significava recuperare la Cina alla comunità
10
mondiale, ma come nazione grande e progressista, non come epicentro della
rivoluzione”.2
Questo scriveva Nixon su Foreign Affairs nell’ottobre del 1967. In altre parole
containment nel breve periodo, enlargment nel lungo periodo e, nel contempo,
incamminare Pechino su un percorso obbligato per condurla lentamente all’interno delle
regole del mondo liberal democratico, fino a trasformarla in un attore, non solo,
funzionale al rafforzamento dell’ordine liberal-democratico, ma anche in grado di agire
da co-tutore di quest’ordine in Asia.
Ora, se nell’approccio alle questioni internazionali gli anni novanta hanno fatto segnare
uno sbilanciamento verso l’uso del condizionamento economico e, negli anni successivi
all’11 settembre, è stata data una maggiore propensione all’uso della coercizione
militare, là dove gli strumenti della strategia americana non hanno mai subito pesanti
oscillazioni, al di là delle increspature di superficie, è proprio nei rapporti con la Cina.
A partire dal viaggio segreto di Kissinger a Pechino, gli Stati Uniti, al di là delle battute
d’arresto, degli attriti più o meno frequenti, hanno adottato nei confronti della Cina una
strategia coerente: containment delle velleità espansionistiche e delle aspirazioni di
potenza antisistema, e, nel contempo, hanno cercato di portare la Cina al banchetto
dell’ordine liberal democratico attraverso l’engagment economico.
Gli Stati Uniti, dunque, hanno costruito per la Cina un percorso forzoso: lo spettacolare
sviluppo economico di Pechino è stato possibile grazie all’apertura agli investimenti
internazionali, che rappresentano il vero motore del progresso cinese. Tali investimenti
sono confluiti in Cina sia per la legge dei vantaggi comparati, sia perché tutelati ed
incentivati nelle zone economiche speciali, sia perché Pechino era in grado di garantire
una stabilità politica e comportamenti prevedibili sulla scena internazionale.
Ora, se la Cina vuole che il motore del proprio sviluppo continui a funzionare a pieno
regime non può fare altro che comportarsi in maniera responsabile sulla scena
internazionale, così come durante la crisi finanziaria del 1997 e così come ha fatto
appoggiando la guerra dell’amministrazione Bush al terrorismo e la politica americana
per la denuclearizzazione della penisola coreana. Deve, insomma, comportarsi in
maniera responsabile e matura all’interno di quell’ordine liberal-democratico che le
2
Richard Nixon “Asia after Vietnam”, Foreign Affairs, ottobre 1967.
11
garantisce prosperità e sviluppo e, almeno per il momento, la base per la legittimazione
della leadership politica.
Non solo. Ma per potersi svincolare dalla dipendenza dagli investimenti esteri e scalare
livelli a sempre maggiore valore aggiunto e a maggiore contenuto tecnologico, ha
bisogno di richiamare dall’estero quell’esercito di studenti formatisi nei tempi del
sapere dell’occidente; ha bisogno di un libero sistema universitario, di un una comunità
scientifica ed accademica libera e in costante contatto con il mondo, ha bisogno di dare
maggiore trasparenza al proprio sistema finanziario e industriale, per poter attrarre
maggiori investimenti ed, allo stesso tempo, è chiamata a dare trasparenza agli
investimenti internazionali che compie sia tramite le proprie aziende di Stato che
attraverso gli hedge funds, per evitare che il timore ed il sospetto delle opinioni
pubbliche, chiudano ai capitali cinesi i mercati sviluppati.
E ancora. Le autorità di Pechino per poter continuare a crescere sono costrette ad
imparare in fretta la lingua franca su cui si basa il commercio internazionale: il diritto.
E’ per questo che l’entrata della Cina nel WTO ha delle conseguenze enormi sul futuro
del paese. Certamente questa aumenta la potenza di impatto sulle economie occidentali
e certamente ciò aumenta i problemi per le aree arretrate della Cina e per alcuni settori
della sua economica, ma il dato fondamentale è che Pechino, d’ora in poi, dovrà
declinare il proprio comportamento secondo le logiche, astratte e generali, del diritto
che sono l’infrastruttura su cui si è arrampicata la crescita dell’Occidente.
E’ un percorso forzoso che può essere paragonato ad un sistema di chiuse. Per poter
continuare a rimanere al potere la leadership comunista di Pechino ha basato la propria
legittimazione politica sulla crescita economica. Ora, proprio come in sistema di chiuse,
per non ristagnare sempre sullo stesso livello, la Cina deve accettare continuamente
nuove inondazioni di pezzi di quel sistema liberal-democratico che regola l’economia
internazionale.
La maggiore, e per quasi quindici anni desiderata, inondazione della Cina si è avuta con
l’apertura delle chiusa, che ha immesso Pechino, come si diceva, nell’Organizzazione
Mondiale del Commercio. Al di là di tutte le considerazioni che questo evento porta a
fare, una in particolare merita attenzione: Pechino si è, non solo sottomessa al giudizio
della comunità internazionale, che ne verificherà i passi nell’adempimento degli
impegni sottoscritti, ma soprattutto ha accettato di gestire il proprio potere nelle sfere
12
economiche e commerciali secondo i dettami del diritto commerciale internazionale,
secondo i principi di astrattezza e generalità, che sono le caratteristiche della legge e i
limiti della discrezionalità del potere e dell’autoritarismo.
Nei confronti di Pechino gli Stati Uniti, dunque, da trent’anni applicano, in maniera
equilibrata e stabile la propria Grand Strategy: contenimento delle minacce,
condivisione dei benefici dell’ordine liberal-democratico e accettazione della
concorrenza economica dei paesi emergenti. Controllano i mari e i cieli intorno alla
Cina, attraverso le basi di Guam, Manila, Okinawa, Yokosuka e con le basi in Corea del
Sud, Malesia, Singapore e Giappone, si sono infiltrati in Asia Centrale, sino ai confini
cinesi, ne controllano le esportazioni di materiali sensibili e ne sorvolano i cieli, con
aerei spia, come l’EP-3. A cui va aggiunto il lento formarsi di un sistema di
cooperazioni rafforzate tra India, Giappone, Australia e Stati Uniti incentrato su una
ancora vaga funzione di containment cinese.
Ma nel contempo hanno fatto sedere i leader comunisti al Consiglio di Sicurezza della
Nazioni Unite; hanno aperto il proprio mercato alle merci cinesi fino a mettere in crisi
interi settori della propria economia, favorito gli investimenti nel territorio della
Repubblica Popolare cinese e, con essi, trasferimento tecnologico. Hanno accettato che
Pechino finanziasse il proprio debito e consentito che acquistasse forti partecipazioni in
strutture vitali dell’economia americana, basti considerare l’acquisizione del 10% cinese
di Blackstone, trasformando così la Cina in uno dei maggiori stakeholder della stabilità
e crescita economica americana.
In più di trent’anni gli Stati Uniti sono riusciti, dunque, a legare la Cina all’ordine
liberal democratico e a inserire Pechino nel mondo dell’economia di mercato, su basi
mutuamente vantaggiosi. Ma non sono pochi gli elementi che potrebbero, a dispetto
della comune volontà cinese e americana di peaceful development, far deragliare questo
processo.
Un irrigidimento delle posizioni sulle due sponde dello stretto di Taiwan, sarebbe
foriero dei più foschi scenari, così come il mancato raggiungimento dei quelle riforme
per armonizzare la crescita interna che la leadership della quarta generazione si è posta.
Così potrebbe essere gravido di conseguenze negative un cambio del “clima economico
internazionale” con un aumento delle tensioni protezionistiche. Allo stesso modo il
13
prevalere di un sentimento anti-cinese negli Stati Uniti potrebbe alterare la percezione
della propria sicurezza a Pechino, soprattutto legata alla maggiore vulnerabilità cinese:
le linee di comunicazione marittima che garantiscono la vita economica del paese.
In tale scenario, Pechino potrebbe essere tentata di garantire direttamente e militarmente
il flusso di approvvigionamento energetico che arriva in Cina via Oceano Indiano,
attraverso lo stretto di Malacca, dal Nord Africa, dall’Asia Occidentale, dal Sudan, dal
Mare Arabico e soprattutto dal Golfo Persico. Attraverso lo stretto di Malacca passa
oltre l’80% delle importazioni cinesi di energia: un corridoio sotto sorveglianza della
Marina Militare degli Stati Uniti d’America, che controlla l’intera regione. Se la Cina
dovesse
convincersi
che
gli
Stati
Uniti
sono
una
minaccia
al
proprio
approvvigionamento energetico, le rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese meridionali
- funzionali al controllo dello stesso da parte cinese - potrebbero esacerbarsi e Pechino
potrebbe essere tentata di sfidare il predominio navale americano della regione per
assicurarsi l’energia che tiene in vita il regime.
Per sessant’anni gli Stati Uniti hanno prevenuto le guerre tra le maggiori potenze,
assumendosi l’onere di fornire loro, in cambio dell’accettazione della leadership di
Washington, quei beni di pubblica utilità internazionale funzionali alla crescita
economica interna: sicurezza, controllo e liberà delle rotte, accesso alle materie prime e
alle risorse energetiche su base non discriminatoria. Agendo così, le grandi potenze
hanno, da una parte, tratto vantaggio dalla guida americana, potendo dedicarsi alla loro
crescita economica, senza gli oneri della difesa, dall’altra si sono trasformate in cotutori a livello regionale dell’ordine americano. In tal modo, ordine globale ed ordine
regionale non si oppongono necessariamente gli uni agli altri, anzi sono tenuti insieme
da un complesso gioco di interessi e valori, di alleanze, divisioni di competenze e
pacificazioni delegate: il primo dipende dai secondi e i secondi dal primo. Tale
lungimiranza americana ha risolto la piaga delle guerre europee e inglobato il Giappone
e la Germania.
Allo stesso modo la lungimiranza e la sagacia delle amministrazioni che si sono
susseguite alla Casa Bianca (basti considerare l’esempio dell’intervento in extremis
dell’amministrazione Bush che è riuscita a bloccare il voto al Congresso su una legge
che avrebbe imposto un dazio del 27,5% sulle importazioni dalla Cina se lo yuan non
fosse stato rivalutato secondo le aspettative americane.) stanno garantendo lo sviluppo
14
cinese all’interno del sistema evitando che Pechino ritorni a chiudersi su se stessa e che
inizi a covare e a rimuginare, vedendosi frustrata nelle sue aspirazioni di crescita e di
prestigio, un ordine completamente altro rispetto a quello americano
15
Una necessaria premesse storica
IL 26 settembre del 1972 il Lion, l’Indostan e il Jackal salparono all’alba, con la prima
marea, allontanansi velocemente dal porto di Portsmouth e sospinti da venti favorevoli
presero a veleggiare verso le coste del Celeste Impero.
Lord Macartney, già ambasciatore di sua Maestà Giorgio III d’Inghilterra in Russia,
nei Caraibi e a Madras, era a capo dell’ambasciata. Era la più imponente missione
diplomatica mai organizzata da un re d’Inghilterra. A bordo insieme ai più moderni
ritrovati della scienza e della tecnica, simboli della grandezza dell’inventiva britannica,
oltre settecento uomini tra cui diplomatici, musicisti, scienziati, saggi e filosofi che
avrebbero dovuto aprire le porte della Cina ai commerci con la Gran Bretagna,
propiziando l’incontro tra la più potente nazione del mondo, che sui mari stava
fondando la propria potenza e la più grande e antica civiltà del mondo che volgendo le
spalle al mare si chiudeva da secoli in uno splendido isolamento.
La missione nasceva sotto la pressione degli uomini della Compagnia delle Indie
Orientali, stanchi delle continue vessazioni cui erano sottoposti e delle limitazioni
asfissianti ad essi imposte nel commercio3 con la Cina dalla Corte imperiale, che
teneva in sommo spregio le attività commerciali e che vegliava perché la purezza della
civiltà cinese non venisse inquinata dai troppo frequenti contatti con i barbari degli
oceani.4
3
La missione nasceva anche per tentare di equilibrare la bilancia commerciale degli scambi tra i due
paesi, in pratica le importazioni inglesi di prodotti cinesi (pagati esclusivamente in argento) come
tessuti, sete lavorate e grezze, porcellana, lacca, te’ e generi di lusso quali ventagli, paraventi, smalti
ed argenti lavorati, erano di gran lunga superiori alle misere esportazioni inglesi.
4
Un editto imperiale del 1760 regolava le condizione del commercio della Cina con i Barbari:
all’inizio di ogni nuovo anno cinese gli stranieri erano obbligati a lasciare Canton per ritirarsi a
Macao fino all’inizio dell’autunno; ai cinesi non era consentito intrattenere rapporti commerciali con
gli stranieri né porsi al loro servizio pena la deportazione; agli stranieri non era consentito apprendere
il cinese né avere contatti con i cinesi stessi se non attraverso interpreti accreditati; funzionari cinesi
dovevano essere istallati a bordo di tutte le navi alla rada in acque cinesi; agli stranieri era fatto
divieto di portare armi così come di intrattenere rapporti con i propri stati di provenienza se non sotto
precisa autorizzazione delle autorità cinesi; gli stranieri implicati in incidenti con i cinesi erano
sopporti alla giurisdizione dell’Imperatore.
16
L’eco della partenza della missione era stata amplificata da tutti i legati e gli
ambasciatori inglesi in Asia. Tutto il mondo era a conoscenza della missione, e a Lord
Macartney erano stati conferiti pieni poteri per portare a termine la sua missione5
Mentre, dunque, in Europa infuriavano le lotte della Francia rivoluzionaria, un pezzo
di Occidente, intriso di una visione lineare e progressiva, che sul movimento e sui
mari, sullo scambio e sulle conquiste, stava basando la propria crescita, si staccava
dalle coste inglesi per scontrarsi con l’immobilismo della Cina, chiusa da trecento anni
al mondo, che proprio sul rifiuto del mondo, sulla contemplazione del proprio
splendore, della perfezione del sistema e dei propri antenati basava la sua essenza.
Da quell’incontro - scontro la Cina, che per secoli si era compiaciuta della propria
limpida superiorità, inizia un lungo, lento e drammatico viaggio verso la modernità,
fatto di aperture entusiastiche e forzose, di repentine e sanguinose nuove chiusure, di
esperimenti fantasiosi e pragmatici avvicinamenti all’Occidente.
5 In dettaglio gli obiettivi che da Giorgio III erano: aprire nuovi porti al commercio con la Cina,
ottenere la cessione di una porzione di territorio o di un’isola, abbastanza vicina alle zone di
produzione del tè e della seta, dove i mercanti britannici potessero risiedere per tutto l’anno sotto la
giurisdizione inglese; abolire gli abusi esistenti nel sistema in vigore a Canton; aprire nuovi mercati
in tutta la Cina e specialmente a Pechino; ottenere l’apertura di una rappresentanza permanente a
Pechino.
17
Lo splendore del celeste Impero
Quando Lord Macartney prese il largo dalle coste inglesi, regnava sulla Cina “dove
l’agricoltura abbonda e l’umanità pullula”, il terzo Imperatore della dinastia mancese,
Qianlong, l’ultimo grande Imperatore.
Con il regno di Qianlong (1736-1796), l’imperò mancese, e con esso la Cina,
raggiunse la massima estensione territoriale e l’apogeo della sua potenza. Al momento
della sua assunzione al trono Qianlong trovò l’Impero in una situazione assai fiorente,
specie dal punto di vista finanziario. Il riassetto operato dalle continue cure del padre
Yongzheng aveva dato, e avrebbe continuato a dare, ancora per qualche decennio i
suoi frutti. Portò la pace all’interno della corte facendo accettare definitivamente agli
intellettuali cinesi il dominio mancesi e all’estero con i paesi confinanti.
Qianlong regnava, oltre alle diciotto province tradizionali, abitate in prevalenza da
popolazioni di stirpe e lingua han, anche sulla Manciuria fin oltre l’Amur, sulla
Mongolia interna ed esterna, sul Turchestan, la Zungaria fino alla valle dell’Ili, il
Tibet.
La Corea, il Laos, la Cambogia, il Bhutan, il Nepal, le isole Ryukyu, il Vietnam erano
stati che recavano periodicamente tributi all’Imperatore. I sovrani di questi regni al
momento dell’accessione al trono ricevevano il riconoscimento ufficiale di Pechino,
quelli di civiltà sinica (Corea, Ryukyu, Vietnam) adottavano il calendario cinese, tutti
senza eccezioni, inviavano periodicamente ambascerie tributarie a Pechino, con doni
reciproci e la possibilità di intrattenere temporanei commerci, era il sistema
sinocentrico di tributi. Quasi tutta l’Asia ruotava intorno alla Cina e al suo Imperatore.
Questo immenso Impero era retto da una amministrazione burocratica centralizzata,
formatasi nel volgere dei secoli e che ricalcava, nelle sue linee essenziali i modelli
formatisi fin dal tempo delle dinastie Sui e Tang. Era un’amministrazione che,
nonostante gli sfaldamenti, i casi sempre più frequenti di corruzione, lo strapotere degli
eunuchi, pure continuava a funzionare, dimostrando, a ogni crisi, di possedere
un’inaspettata vitalità, derivante dalle solide basi culturali e dalla perfezione, nel suo
genere, dei meccanismi.
Capo supremo di questa amministrazione l’Imperatore, il Figlio del Cielo, vertice
burocratico e politico, era il “propiziatore del Cielo e della Terra”, il suo compito era
18
quello di garantire l’ ordine entro la società umana; fungendo da garante presso i suoi
sudditi della regolarità della natura, dei “favori del Cielo”, vale a dire delle condizioni
generali ed obiettive che rendessero possibile e redditizia l’attività agricola. Il suo
potere non era, però, un potere divino, eterno, indipendente dalle circostanze. Esso
dipendeva dai risultati effettivi della sua azione nel “propiziare il Cielo e la Terra”: se
la natura rompeva l’ordine costituito che consentiva il regolare lavoro agricolo, se il
sovrano non era capace, di garantire il necessario coordinamento tra le forze della
natura e le esigenze della collettività umana, diveniva legittima la sua sostituzione: il
trasferimento del mandato, la rivolta, fatta per mantenere l’ordine, anzi per ristabilire le
condizioni dell’ordine. La rivolta fatta ad opera di altri, più del precedente, capaci di
adempiere i suoi compiti.
E questi erano i terrestri, minuti, prosaici compiti del capo di una società agricola:
curare il controllo dei fiumi, il mantenimento delle difese, la riscossione dei tributi
necessari per queste opere, la continua e totale applicazione di tutte le energie umane al
lavoro agricolo.
Né la lirica visionaria della vita di Alessandro Magno, né le gesta di Cesare e neppure
il pragmatismo di Filippo II avrebbero suscitato l’ammirazione dei cinesi. Il modello di
sovrano ideale fu sempre impersonato nelle figure mitiche di Yao, Shun e Yu, gli
imperatori leggendari che avevo arginato i fiumi, messo a cultura le foreste, permesso
che l’agricoltura potesse prosperare e l’umanità crescere.
19
La lettera di Giorgio III
Lord Marcartney, giunse il Cina nell’agosto del 1793. L’Imperatore era in quel
periodo, per sfuggire alla calura di Pechino, nella residenza estiva di Jehol, in
Manciuria. I planetari, le macchine a vapore, tutte le meraviglie dell’Occidente che
Macartney confidava avrebbero suscitato l’ammirazione presso i cinesi, delle capacità
inglesi, per le difficoltà del viaggio vennero lasciate a Pechino.
Lord Macarteny recava con sé una missiva del re d’Inghilterra
“Sua Maestà Giorgio III, per grazia di Dio, Re di Gran Bretagna, di Francia e
d’Irlanda, Sovrano dei mari, difensore della fede, saluta il supremo Imperatore della
Cina Qianlong.
Abbiamo allestito una imponente flotta e vi abbiamo imbarcato i più eruditi dei nostri
sudditi, affinché scoprano i regni lontani e sconosciuti. Non per allargare i nostri
possedimenti, che bastano a soddisfare tutte le nostre necessità, ma per tentare di
aumentare la nostra conoscenza del globo terrestre, e fare approfittare delle nostre
arti e del nostro benessere i paesi dove questi sono ancora poco conosciuti.
Siamo ancora più desiderosi di informarci delle arti dei paesi dove la civilizzazione è
stata portata alla perfezione. Il nostro desiderio più ardente è sempre stato di stabilire
legami con queste istituzioni famose che disciplinano l'Impero così vasto e così
popolato della vostra maestà e che destano l'ammirazione nelle nazioni intorno (...)
Abbiamo la felicità di essere in pace con il mondo intero (...) Già da molto tempo un
certo numero dei nostri sudditi abborda alle rive della vostra maestà per fare
commercio.
Lo scambio di beni tra nazioni situate lontano una dell'altro contribuisce al loro
benessere reciproco, alla loro industria, alla loro ricchezza. Abbiamo un uguale
interesse a che i nostri sudditi non commettano nessun male nel paese che li accoglie,
e di sapere che essi stessi non vi soffriranno nessuna ingiustizia. Non c’è modo
migliore a questo scopo, che la residenza nel paese ospite di una persona autorizzata
da noi a regolare la condotta dei nostri sudditi.
Con questo mezzo, si preverrebbe ogni malinteso, ogni forma di disaccordo tra i nostri
rispettivo imperi. Tutte queste considerazioni ci hanno condotto ad inviare alla vostra
20
Corte un ambasciatore straordinario, il nostro gradito cugino Lord Macartney.
Contiamo sulla benevolenza della vostra maestà perché il nostro ambasciatore e
rappresentante presso la vostra Corte abbia la possibilità di ottenere tali informazioni
sulle vostre istituzioni sublimi, tanto da poterci illuminare sulla vostra grandezza al
suo ritorno. Egli stesso è incaricato di fare conoscere interamente e liberamente alla
vostra maestà le arti, le scienze e le osservazioni che, con la pratica o la curiosità,
l'ingegnosità particolare degli europei e le loro esperienze hanno permesso loro di
sviluppare.
Contiamo che Voi accorderete a ciascuno dei nostri Sudditi che toccano le vostre rive
e che si comportano adeguatamente, una residenza sicura ed un libero accesso ai
vostri mercati (...)
Saremmo estremamente lieti di apprendere che, così come il nostro ruolo di sovrani ci
rende naturalmente e rispettivamente fratelli, così possa stabilirsi una rapporto di
particolare fratellanza tra le nostre nazioni.”
Augustissimo Imperatore, Vostro Fratello e Amico
Giorgio III, Re.
La lettera di Giorgio III fu giudicata una carte di ignoranti e secondo la mentalità
cinese ve ne erano ben le ragioni. Fare approfittare la Cina dei progressi degli inglesi,
come se il Celeste Impero non bastasse a sé stesso e avesse da apprendere dai barbari.
Chiedere che cessassero le ingiustizie nei confronti dei sudditi britannici a Canton,
come se l’Imperatore e la sua Corte potessero commettere delle ingiustizie. Pretendere
che una rappresentanza permanente venisse installata a Pechino, non tenendo in
nessuna considerazione i riti che impongono ai barbari di lasciare il paese dopo aver
offerto il loro tributo di fedeltà. Pretendere di essere il fratello e l’amico di Qianlong,
come se l’unico figlio del Cielo potesse avere dei fratelli e degli amici.
21
La lettera dell’Imperatore, come ad uno Stato Vassallo
“Noi, Imperatore, per grazia del cielo, ordiniamo al re d’Inghilterra di prendere nota
delle nostre volontà. Nonostante che il tuo paese si situi negli oceani lontani tu hai
disposto il tuo cuore ad ammirare la nostra Civiltà. Ci hai inviato un messaggero per
presentarci rispettosamente un messaggio ufficiale. Attraversando i mari si è recato
alla nostra corte per compiere le nove prostrazioni del kotow e per presentarci le sue
felicitazioni in occasione del nostro anniversario imperiale, così come per offrirci
alcuni vostri prodotti. Egli ha, pertanto, testimoniato la tua lealtà. (…) Riguardo al
tuo Primo Inviato e al suo assistente, che ci hanno portato il tuo messaggio ufficiale e
gli oggetti che costituiscono il tuo tributo, noi abbiamo tenuto conto del fatto che loro
sono venuti da molto lontano e hanno attraversato i mari e noi abbiano steso su di
loro il nostro favore. Abbiamo dato ordine ai nostri ministri di presentarli ad una
udienza imperiale. Abbiamo offerto loro un banchetto ed abbiamo offerto loro svariati
doni per dimostrare la nostra bontà (…)
Riguardo alla richiesta formulata nel tuo messaggio di essere autorizzato ad inviare
un tuo suddito a risiedere nel Celeste Impero per attendere ai traffici commerciali con
il tuo paese, essa non è conforme ai riti del Celeste Impero e non può pertanto essere
accolta. Sino ad oggi, ogni volta che degli uomini provenienti da diversi paesi
dell’oceano occidentale hanno desiderato di venire nel Celeste Impero per entrare nel
nostro servizio imperiale, abbiamo concesso loro di poter risiedere nella nostra
capitale. Ma una volta che sono venuti, sono stati obbligati ad adottare i costumi, le
abitudini e la lingua del Celeste Impero; sono stati confinati nelle residenze loro
assegnate e non sono mai stati autorizzati a ritornare nel loro paese.
Queste sono le regole inflessibili del Celeste Impero. Pertanto tu vuoi inviare un tuo
suddito nella capitale. Ma non potrà comportarsi come un uomo dell’oceano
occidentale che viene nella nostra capitale per entrare nel nostro servizio imperiale e
poter ritornare nel suo paese natale; né potrà ricevere il permesso di andare e venire
e di poter tenere una corrispondenza. Per tale motivo non sarebbe di nessuna utilità
(…) Inoltre numerosi sono i paesi dell’oceano occidentale; il tuo non è affatto il solo.
Se, seguendo il tuo esempio, questi paesi faranno tutti richiesta di inviarci qualche
inviato permanente nella nostra capitale, come potremmo noi consentire a ciascuna di
22
queste richieste? Questo per noi sarebbe assolutamente impossibile. Come potremmo
arrivare fino al punto di cambiare le regole che reggono l’Impero Celeste, e che sono
più che secolari, sulla richiesta di uno solo – sulla tua richiesta, o Re?
Noi che siamo maestri del mondo e regniamo tra i quattro mari, noi ci dedichiamo
solamente a condurre bene l’arte del governo. Oggetti strani e costosi non ci
interessano. Se abbiamo dato ordine che i doni da voi offerti in segno di omaggio
fossero accettati, questo è soltanto per un riguardo allo spirito con il quale li avete
inviati da così lontano. Come il vostro ambasciatore può constatare di persona, noi
qui abbiamo ogni sorta di prodotti. Non riconosciamo valore ad oggetti strani e
ingegnosi e non vediamo ragione d’impiego per i prodotti della vostra industria. (…)
Per tale motivo abbiamo ordinato che i tuoi inviati tributari ritorni nel loro paese in
sicurezza. Tu, o Re, non devi fare altre che agire secondo i nostri voleri, riaffermando
la tua fedeltà e giurandoci una obbedienza perpetua, in modo che il tuo paese
partecipi ai benefici della pace.”
A re Giorgio III dunque tutto è negato in ragione degli usi secolari.
Nelle parole di uno dei membri della missione, con crudezza è racchiuso tutto il senso
del viaggio: “in tre parole ecco tutta la nostra storia: siamo entrati a Pechino come dei
mendicanti, vi abbiamo soggiornato come dei prigionieri, partiamo come dei ladri.”
La causa dei fallimenti di questi primi tentativi diplomatici occidentali va ricercata in
quello spirito immobilistico che caratterizzava la Cina premoderna. Per essa, in
definitiva, sulla base del pensiero confuciano dominante, il bene si identificava con la
tradizione del passato e il male con quanto minacciasse di modificarla. Conservare
quello spirito e quella tradizione immuni da contatti era pertanto l’unico mezzo per
assicurare la conservazione morale, politica e sociale.
Così mentre sulla spinta del nascente capitalismo industriale gli Europei bussavano
alla porta del grande Impero, intesi a guadagnarne il mercato, l’Imperatore cinese,
interprete di quello spirito e di quelle esigenze di conservazione, non poteva che
disattendere le loro richieste.
Tale scelta, sebbene inevitabile secondo la logica cinese, fu così gravida di
conseguenza da innescare una serie di azioni e reazioni che condizioneranno la storia
della Cina e, più in generale, della Asia fino al 1978.
23
Le conseguenze della sufficienza cinese
Se il Celeste Impero non dava nessun valore alle merci che la missione diplomatica
aveva recato con sé, tanto da definire i planetari, le macchine a vapore, degli strumenti
buoni per far divertire i bambini, v’era qualcosa che gli inglesi avevano notato essere
molto gradita ai sudditi cinesi: l’oppio.
Fu per questo che i barbari occidentali, per incrementare le loro vendite ricorsero allo
smercio dell’oppio, che veniva prodotto nel Bengala dalla Compagnia delle Indie
Orientali. La richiesta della droga crebbe velocemente, determinando una serie di
danni economici, morali, fisici e sociali, che provocarono la reazione delle autorità
cinesi.
L’incremento delle vendite dell’oppio, inoltre, aveva portato ad un crescente drenaggio
di argento dalle casse dello Stato6. Non mancarono editti e sanzioni contro il
commercio dell’oppio, ma i grossi interessi coinvolti nel contrabbando li resero lettera
morta. Di fatto i reiterati divieti non fecero che accrescere il contrabbando:
l’importazione di oppio salì da 120 tonnellate del 1800 a 2400 nel 1838. Tra le autorità
imperiali emerse allora forte la tendenza ad un rigoroso intervento per eliminare
totalmente tale traffico, attraverso l’arresto degli spacciatori cinesi e soprattutto il
taglio netto dei rifornimenti dall’estero.
La Cina tentava nuovamente in estremis una chiusura all’oppio che si era
subdolamente infiltrato tra le crepe della muraglia che garantiva l’isolamenti cinese.
Fu a questo punto che la Gran Bretagna si decise. Per due volte, gli inglesi avevano
bussato alle porte del Celeste Impero: a Lord Macartney tutto venne rifiutato, Lord
Amherst, non fu neanche ricevuto dall’Imperatore. La terza volta le porte che
chiudevano il Celeste Impero furono aperte con le cannonate.
Le truppe inglesi sbarcarono in varie località della costa cinese, occupando Canton,
Shanghai, Ningbo (1839-42). Il trattato di Nanchino del 1842, che pose fine alla prima
guerra dell’Oppio costituì il primo dei cosiddetti trattati ineguali imposti alla Cina
6
Ciò determinava uno squilibrio nel sistema monetario cinese che si fondava sul rapporto fra il rame,
che veniva usato per la coniazione delle monete correnti, e l’argento. La svalutazione del rame
rispetto all’argento significò soprattutto un aggravio delle condizioni di vita dei contadini piccoli e
medi, che pagavano le tasse sulla base di una valuta di argento e ricevevano monete in rame dalla
vendita dei loro prodotti.
24
dalle potenze Occidentali, integrato con i regolamenti generali e il trattato di Humen
del 1843, stabiliva la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna, l’apertura dei porti di
Canton, Shanghai, Ningbo, Xiamen e Fuzhou e il pagamento di una forte indennità a
carico dell’erario imperiale. Veniva inoltre consentito ai mercanti inglesi di risiedere
nelle aree dei porti aperti, dove erano autorizzati a prendere in affitto terre e costruirvi
abitazioni. Da queste ultime clausole si sarebbero poi sviluppate le cosiddette
Concessioni7, con la costituzione di vere e proprio encalaves con amministrazione
straniera. In ogni porto aperto, quindi, i cittadini britannici godevano del diritto di
extraterritorialità, erano cioè sottoposti alla giustizia del proprio paese e non a quella
cinese, con la clausola, significativa, che tale doppia giurisdizione sarebbe cessata
quando la Cina avrebbe adottato un sistema legale moderno.
Dopo meno di cinquant’anni le richieste di Macartney erano state strappate
all’Imperatore. Le richieste delle altre nazioni della terra, così come previsto dalla
Corte Celeste, non si fecero attendere. Gli Stati Uniti e la Francia riuscirono ad
ottenere un analogo trattamento nel 1844. Gli effetti economici del trattato di
Nanchino, uniti alle conseguenze valutarie dovute allo squilibrio della bilancia
commerciale, contribuirono ad aggravare la situazione della campagne cinese e al
sorgere di rivolte contadine.
Altre sconfitte attendevano il Celeste Impero. Gran Bretagna e Francia, non soddisfatte
dei risultati ottenuti dai trattati della prima guerra dell’oppio e desiderose di aprire il
mercato cinese ai propri prodotti, approfittarono della situazione di debolezza in cui si
trovava la dinastia per sferrare un nuovo attacco.
Il conflitto, passato alla storia come la seconda guerra dell’oppio, scoppiò nel 1856. Il
governo imperiale paralizzato dai contrasti fra le diverse tendenze, si mostrò incapace
di reagire in modo adeguato. Dopo una serie di sconfitte e il saccheggio di Pechino,
durante il quale furono ritrovati, inutilizzati, i cannoni che lord Macartney aveva
portato in dono a Qianlong, l’Impero cinese fu costretto a sottoscrivere il trattato di
Tianjin e quello di Pechino.
In base al primo trattato, la Cina oltre a dover pagare una indennità ancora più pesante
di quella versata dopo la prima guerra dell’oppio, dovette aprire altri porti e concedere
7
Fra il 1854 e il 1864 sorsero le Concessioni, aree urbane con una propria amministrazione
finanziaria, fiscale, giudiziaria e di polizia, sotto il controllo delle legazioni straniere e sottratte
all’autorità cinese.
25
la libera circolazione ai mercanti e missionari stranieri sul proprio territorio, che
ottennero tutta una serie di privilegi che accrebbero i sentimenti xenofobi della
popolazione cinese. Il base al trattato di Pechino poi, le condizioni di pace furono
ulteriormente aggravate e le potenze occidentali ottennero fra l’altro esenzioni
doganali e il libero accesso per le loro flotte alla rete fluviale cinese. Ebbero inoltre il
diritto di stabilire delle legazioni diplomatiche all’interno della capitale.
Le pressioni commerciali continuarono anche negli anni Settanta, e i porti aperti
salirono a venti. La Gran Bretagna dopo aver occupato la Birmania, premeva sulla
Cina per ottenere facilitazioni commerciali e logistiche sulle province confinanti con
l’Impero. Facilitazioni che ottenne con la convenzione di Yantai (1876). La Francia dal
canto suo, attaccò direttamente le coste cinesi dopo che Pechino era intervenuta
militarmente a fianco del Vietnam, costringendo la Cina a un nuovo umiliante trattato
nel 1885 (Tianjin): la dinastia Qing doveva rinunciare alle tradizionali relazioni che la
legavano al Vietnam, e aprire la Cina sudorientale al commercio francese.
Ben più grave fu comunque il colpo che alla Cina inferse il Giappone, gradualmente
affermatosi come potenza espansionistica, sulla base di una società che aveva acquisito
un potenziale tecnologico, industriale e militare moderno, senza tuttavia eliminare le
forti ipoteche di carattere feudale gravanti sui contadini e sugli operai, oltre che, in
generale, sulle istituzioni. Lo scontro tra i due paesi avvenne quando la penetrazione
giapponese in Corea (protettorato cinese) assunse carattere così clamoroso da non
poter essere nascosto. Quando la guerra scoppio, il 1 agosto del 1894, essa volse
rovinosamente ai danni della Cina, ed il successo giapponese fu così travolgente da
lasciare allibite e preoccupate le stesse grandi potenze, che soltanto da pochi anni
avevano dovuto rinunciare al regime dei trattati ineguali imposti anche al Giappone. Il
trattato di Shimonoseki che il Giappone impose alla Cina era di gran lunga il più
gravoso tra tutti quelli firmati sino ad allora: non soltanto la Cina doveva rinunciare al
proprio protettorato e riconoscere il protettorato giapponese sulla Corea, non soltanto
doveva aprire una nuova serie di porti, e pagare un’indennità che cominciava a
costituire un gravoso drenaggio di denaro liquido dal tesoro imperiale, ma doveva
anche cedere al Giappone l’isola di Formosa e l’arcipelago delle Pescadores8
8
Nel trattato si prevedeva anche la cessione della penisola di Liaotung nella Manciuria Meridionale
con la base di Port Arthur, ma questa clausola scatenò le obiezioni della Russia che aveva considerato
la Manciuria come la propria area di espansione: intervenne un complesso gioco di mediazione
26
Fra il 1895 e il 1902, oltre al Giappone, la Germania, la Gran Bretagna, la Russia e la
Francia, il Belgio, l’Italia e l’Impero Austriaco ottennero concessioni ed aree
privilegiate. All’inizio del XX secolo, tutta la zona costiera e periferica era
monopolizzata dalle grandi potenze, e così suddivisa: la Manciuria alla Russia, lo
Shadong alla Germania, il bacino dello Yangzijiang alla Gran Bretagna, il Fujian al
Giappone, il Guangdong, il Guangxi e lo Yunnan alla Francia e alla Gran Bretagna.
In un confuso tentativo di rivincita, i circoli più conservatori della corte finirono per
incoraggiare allora la ribellione dei Boxers , che fra il 1897 e il 1900, condusse ad una
serie di gravi incidenti a sfondo xenofobo, culminati nel celebre “assedio delle
legazioni”, che finì per accompagnarsi ad una dichiarazione di guerra da parte della
corte Qing all’Inghilterra e alla Francia, cui fece seguito una spedizione internazionale,
che, dopo aver conquistato Pechino, impose all’imperatrice reggente l’umiliante
protocollo del 16 gennaio 1901. In seguito a quest’ultimo ulteriori “concessioni”
dovettero essere assegnate a potenze straniere, mentre il pagamento di una pesante
indennità finanziaria veniva imposto. 9.Il Tibet fu una delle ultime regione ad essere
poste sotto il controllo di fatto da parte degli occidentali: nel 1903 le forze inglesi
invasero la regione, costringendo il Dalai Lama a rifugiarsi ad Urga.
Agli inizi del XX secolo, quindi, l’Impero cinese versava nelle condizioni più
umilianti, per certi versi paragonabili a quelle dell’Impero ottomano. Una serie di
sconfitte militari, le rivolte interne e i contrasti fra le fazioni della burocrazia ne
mettevano in luce la debolezza, e ne facevano ritenere imminente la dissoluzione.
Carica di debiti per le indennità, con una bilancia commerciale sempre in passivo, la
Cina sembrava avviata verso la spartizione e lo smembramento, dopo le recenti
annessioni giapponesi e russe. Non ridotta ancora allo stato di una vera e propria
colonia, forse a causa della sua estensione, non ancora frazionata per l’abilità della sua
burocrazia e per la rivalità fra le potenze, la Cina era nella condizioni di una
americano, sullo sfondo di una acuita tensione tra le potenze ormai entrate in gara per il controllo
imperialistico sull’Estremo Oriente. Il Giappone ancora debole per affrontare una guerra con gli
occidentali, dovette restituire il Liaotung alla Cina, in cambio di un’ulteriore forte indennità
9
La posizione degli Stati Uniti, in queste circostanze, si distinse da quella delle altre potenze. Essi,
dal 1899, contrapposero alla corsa per la spartizione e all’accaparramento di vantaggi regionali, la
cosiddetta politica della porta aperta. Infatti le mire espansionistiche statunitensi in estremo oriente
erano emerse relativamente tardi rispetto a quelle delle altre potenze, e gli Stati Uniti avevano tutto
l’interesse a che fosse consentito a tutti di accedere alle ricchezze della Cina. La politica della porta
aperta fu quindi di vantaggio anche al mantenimento dell’integrità territoriale dell’Impero e contro
ogni tipo di monopolio coloniale o commerciale sulla Cina.
27
semicolonia, sempre più esposta alle interferenze straniere sia sul piano politico che su
quello economico.
Tutto, forse, a causa di quel rifiuto.
28
Alla ricerca delle fonti della potenza europea
L’Impero che disprezzava il mondo, nel giro di qualche decennio, fu costretto con
amarezza a venire a conoscenza della propria debolezza, perifericità, arretratezza. Lo
shock causato dalla potenza e dalla avanzamento tecnologico dei barbari, pose alla
classe dirigente cinese l’assillo di affrontare il problema dando l’avvio a una profonda
speculazione alla ricerca delle sorgenti della potenza dell’occidente, per carpirne il
segreto e ridare alla Cina quella forza e quel posto nella gerarchia delle nazioni che le
competeva.
Una risposta del tutto particolare fu quella di Hong Xiuquan, il fondatore e guida
spirituale del movimento del Taiping. In seguito ai contatti avuti con i missionari e alla
lettura dei testi di propaganda cristiana, aveva elaborato una propria dottrina religiosa,
una complicata sincresi di elementi cristiani, buddisti, taoisti e menciani. Proclamatosi
fratello minore di Gesù Cristo, diede vita alla Società degli Adoratori di Dio, riuscendo
ad unire sotto la sua guida numerosi aderenti a società segrete, battellieri, artigiani
rovinati dalla concorrenza dei minatori e disertori. Tale società predicava il
monoteismo e una lotta contro le milizie dei proprietari terrieri, per poi passare allo
scontro aperto con le truppe imperiali. Non si trattò di una delle tante insurrezioni ma
di una grande rivolta che istaurò un nuovo Stato, il Regno Celeste della Grande Pace
(Taiping tianguo), con capitale a Nanchino fra il 1853 e il 1864
Ciò che, forse, è più rilevante è un aspetto particolare della teologia Taiping:
proclamandosi Hong Xiuquan, figlio di Dio e fratello minore di Gesù Cristo, dava vita
ad una particolare interpretazione della trinità cristiana; in questo modo egli non solo
rivendicava la parità tra cinesi ed occidentali, ma riteneva anche di essersi appropriato
del segreto della loro superiorità: la religione di Cristo.
Altri invece, i cosiddetti occidentalisti, ripudiavano completamente il passato cinese
per individuare nell’adozione in toto dei valori e della visione occidentale la chiave del
riscatto. Fra i maggiori esponenti di questa corrente si può annoverare Wang Tao,
esule ad Hong Kong per l’accusa di connivenza coi i Taiping, e quindi collaboratore di
James Legge nella sua nota traduzione dei Classici confuciani, e con quest’ultimo in
Francia e in Gran Bretagna. Al suo ritorno ad Hong Kong, nel 1873, Wang Tao, fondò
29
uno dei primi quotidiani, il “Giornale dell’Evoluzione” (Xunhuan ribao), nel quale si
fece promotore dello sviluppo del commercio, ed esaltò le istituzioni politiche
dell’Occidente. In esse individuava la causa prima della ricchezza e della potenza dei
paesi occidentali: da queste istituzioni faceva derivare quell’armonia fra governo dei
sudditi, e la comunione degli sforzi che riteneva essere alla base del successo
occidentale. Dell’origine della potenza occidentale si occupò un altro occidentalista,
Yan Fu, che individuava l’origine del benessere dei paesi occidentali non nella loro
religiosità (come avevano fatto i Taiping), e neppure nelle istituzioni (come aveva
creduto Wang Tao), ma nel loro vitalismo, nel culto dell’energia e della lotta e dello
slancio vitale.
Ma il movimento più interessante è certamente quello dell’autorafforzamento
perseguito per trent’anni (dal 1860 al 1895) dallo stato superiore della burocrazia, che
ormai dominava completamente il regime, lasciando alla nobiltà mancese ed
all’Imperatore Xianfeng una parte solo formale. Il movimento dell’auotrafforzamento
traeva origine dal movimento yangwu (letteralmente “delle cose occidentali”, cioè
straniere) che espresse il tentativo di una parte della burocrazia e della nobiltà cinese di
reagire alle minacce esterne ed interne, potenziando la Cina e sostenendo la dinastia
mancese.
Una delle idee base del movimento dell’autorafforzamento, in modo non dissimile da
alcuni progetti degli slavofili russi, era quella di apprendere e utilizzare la tecnica e la
scienza dell’Occidente in modo strumentale, permettendo, così, alla Cina di resistere
alle aggressioni delle potenze, pur mantenendo la cultura e i valori tradizionali. Il
primo teorico fu il matematico e cartografo Feng Guifen (1809-1874), che per primo
coniò il termine di “autorafforzamento” (ziqiang), per indicare la volontà di
ammodernamento pur fondata sui principi tradizionali.
Uno degli aspetti fondamentali di questo tentativo di “autorafforzamento” consisteva
nello sforzo di cogliere il “segreto” della potenza del mondo occidentale, senza tuttavia
procedere a quelle trasformazioni sociali e culturali che erano in effetti state alla base
della maggiore potenza della società europea rispetto alle società precapitalistiche. Il
segreto che veniva cercato con maggiore zelo era quello che stava alla base della
potenza militare occidentale: il sogno della classe dirigente burocratica di questo
30
periodo sarebbe stato quello di possedere i cannoni, le corazzate e le industrie
occidentali per poterle semplicemente “inserire” nel conteso tradizionale cinese, con i
suoi funzionari confuciani, la cultura orientata all’esigenza degli “esami imperiali” e la
ricchezza dei detentori del potere fondata sulla classe e i fitti pagati dai contadini.
Gradualmente, e con una vivace problematica culturale, ci si rese conto, però,
dell’insufficienza di una semplice politica di acquisto di armi e strumenti militari,
qualora non vi fossero gli uomini capaci di utilizzarli. Fu quindi necessario aggiungere
alla cultura di alcuni funzionari un certo corredo di nozioni occidentali; fu necessario
formare interpreti e diplomatici capaci di trattare con gli stranieri, fu necessario
mandare i giovani a studiare all’estero. Ma questa dottrina occidentale, della quale era
necessario dotare almeno una parte della classe dirigente, doveva rimanere, nelle
intenzioni dei teorici dell’autorafforzamento, soltanto un’appendice estranea e
superficiale, accettata per uso pratico e in forma assai limitata, mentre la personalità, la
moralità, il modo di intendere e di sentire di membri della classe dirigente dovevano
continuare ad essere plasmate dalla dottrina tradizionale confuciana, considerata come
imprescindibile fondamento di ogni vera cultura.
I limiti e le contraddizioni di questa concezione si sarebbero ben presto rilevati
evidenti: i giovani a quali si voleva aggiungere un limitato corredo di nozioni
occidentali risultarono penetrati e orientati da questa aggiunta assai più di quanto
volessero i sostenitori di questa modernizzazione; d’altra parte il carattere ridotto e
inorganico delle nozioni acquisite non mise in grado nessun funzionario così formato
di servirsi adeguatamente né degli strumenti materiali (soprattutto militari) né delle
soluzioni tecnico economiche che costituivano il segreto della potenza straniera.
La crisi della dinastia mancese, al centro ed alla periferia, sul piano militare e su quello
diplomatico, nel campo economico ed in quello amministrativo pose fine al tentativo
artificioso della modernizzazione superficiale e mise chiaramente all’ordine del giorno
la necessità di una ristrutturazione delle istituzioni cinesi.
Il movimento per una più profonda trasformazione del regime politico e
dell’impostazione culturale mosse quindi da quegli ambienti intellettuali che
maggiormente si rendevano conto della gravità della crisi e che non avevano interessi
costituiti da difendere nel sistema di reciproco sostegno tra grandi notabili, feudatari,
dinastia e stranieri.
31
L’uomo che rappresentò il movimento di riforma in modo più tipico fu Kang Yuwei:
un cantonese educato per essere funzionario e riuscito brillantemente negli esami
imperiali, dotato di grande cultura tradizionale, ma ben cosciente della gravità della
crisi che attraversava il suo paese e convinto della necessità di superarla attraverso una
serie di riforme modernizzatici seppure autoritarie ed attuate su iniziativa della classe
dirigente, come quella di Pietro il Grande e, nel caso del più vicino del Giappone di
Meji.
Con il peggiorare della situazione nel 1897 e nel 1898 le pressioni per una politica di
riforme più intensa, si fecero più forti a corte, provocando uno scontro tra conservatori
accaniti ed uomini disposti a cauti tentativi di rinnovamento. Questi ultimi ebbero la
meglio e indussero il giovane Imperatore Kuang Hsu, che aveva capacità modeste, ma
nutriva un certo desiderio di “salvare la Cina”, a prendere contatto nel giugno del 1898
con Khang Yuwei, che divenne il suo consigliere, mentre vari riformatori radicali,
entrarono nel Consiglio Grande, cioè nel governo dell’Impero.
In cento giorni, fino al 21 settembre, i riformatori sostenuti dall’Imperatore
interamente acquisito al loro entusiasmo, proclamarono oltre 40 editti di riforma,
concepiti in termini estremamente avanzati, e miranti a trasformare le istituzioni e la
concezione generale della cultura e della funzione della classe dirigente.
Gli editti proclamati da Kuang Hsu prevedevano: la riforma totale degli esami
imperiali (il che significava lo sconvolgimento completo di tutto il sistema educativo
dell’elite e del sistema di rigenerazione del potere e dei meccanismi di ascensione
sociale proprie di un esame pubblico); la creazione di scuole di tipo occidentale e la
contemporanea chiusura o trasformazione dei templi buddisti in scuole moderne e
l’istituzione di ministeri a carattere tecnico; l’introduzione di un sistema giuridico e di
codificazione di tipo occidentale (allo scopo di eliminare il pretesto con il quale gli
occidentali avevano imposto alla Cina il regime dell’extraterritorialità per gli stranieri);
la formazione di strumenti finanziari moderni (quali una banca centrale ed una serie di
uffici incaricati di apprestare un regolare bilancio); il rinnovamento dell’esercito e
delle forze armate secondo criteri di tipo occidentale e la formazione di quadri militari
sulla base della capacità tecnica effettiva, ma soprattutto la totale abolizione degli
ultimi incarichi apparenti, le sinecure, le prebende, i privilegi delle autorità locali e
centrali.
32
Si può dire che i giovani riformatori volevano attuare ad un tempo le trasformazioni
che in Europa erano state portate dall’Illuminismo e quelle imposte nel primo anno
della rivoluzione francese. Ma alle spalle dell’Imperatore e di Khang Yuwei non
c’erano né la colta borghesia europea del settecento, né il popolo che aveva preso la
Bastiglia.
La burocrazia cinese si attenne alla semplice via d’uscita di non agire, di non attuare le
norme e le ordinanze che uscivano a ritmo turbinoso dagli uffici imperiali, attendendo
che qualcuno, leso anche più gravemente dei burocrati, intervenisse a por fine allo
scandalo. E l’intervento venne dagli ambienti tradizionalisti mancesi, che
controllavano in parte le forze armate e che avevano contatti con alcuni comandanti
che i riformatori consideravano a torto fedeli come Yuan Shinkai, un uomo formatosi
nell’ambiente dell’“autorafforzamento” ma rimasto sempre fedele alla causa della
conservazione. A dirigere la trama del complotto della corte e dell’esercito contro i
riformatori fu l’imperatrice vedova Cixi, che costituiva la roccaforte delle posizioni dei
mancesi e della burocrazia cinese. La vecchia imperatrice, il 21 settembre, riuscì ad
organizzare un colpo di stato militare, al quale Yuan Shinkai diede l’appoggio
decisivo: Khang Yuwei riuscì a fuggire a Tokyo con la connivenza dell’ambasciata
giapponese a Pechino, ma gli altri riformatori caddero nella rete e furono arrestati e
uccisi e le loro teste furono le prime, di una lunga serie, ad essere esposte in pubblico
ad ammonimento contro nuovi ribelli. L’Imperatore ebbe una sorte di poco migliore:
fu relegato in un’isola del parco imperiale è finì i suoi giorni in circostanza misteriose,
proprio poche ore prima della morte della sua potente prozia Cixi, nel 1908.
33
La fine dell’Impero
La svolta conservatrice del colpo di Stato attuato dall’imperatrice vedova Cixi, così
come la repressione dell’insurrezione dei Taiping, non furono in grado di consolidare
il regime in via di disfacimento e neppure di bloccare il processo delle riforme
istituzionali e delle trasformazioni economico-sociali.
L’opposizione si andò organizzando, ed il regime Qing fu costretto a ricorrere a quelle
stesse riforme che pochi anni prima avevano fatto decretare la fine del breve governo
dei cento giorni. Ma la ripresa del programma riformistico dei costituzionalisti e dei
radicali non riuscì a disarmare le opposizioni: troppo tarde per essere credibili, le
riforme non fecero che accelerare il processo di disfacimento della dinastia, acuendone
le contraddizioni interne. Lo stesso invio di un numero crescente di studenti all’estero
fu foriero di ulteriori difficoltà per il governo, perché questi studenti andarono ad
ingrossare le file dell’opposizione.
L’incapacità della dinastia mancese di fare fronte alle difficoltà politiche ed
economiche, e la sua debolezza nei confronti delle aggressioni straniere le fecero
perdere il mandato celeste agli occhi della maggior parte dei cinesi. Il fallimento del
sostegno della nobiltà cinese nella seconda metà dell’ottocento fu l’ultimo banco di
prova, dopo il quale la stessa nobiltà cinese e le nuove élites urbane le voltarono le
spalle, tentando nuove soluzioni e percorrendo nuove vie.
Per tutte queste ragioni, tali cambiamenti portarono a un ulteriore indebolimento degli
organi centrali. La situazione si aggravò poi a causa delle morte, fra il 1980 e il 1909
di alcuni dei maggiori personaggi politici: l’Imperatore Kuang Hsu (che regno dal
1875 al 1908), la regina vedova Cixi e lo statista Zhang Zhidong. Puyi (1906-1967)
sarebbe stato l’ultimo Imperatore della storia cinese (regnando dal 1909 al 1911).
I tradizionali segni della perdita del mandato celeste, questa volta avrebbero significato
la fine di un’epoca e non solo della dinastia Qing. La nuova situazione interna ed
internazionale non rendeva più possibile in Cina il mantenimento del millenario
istituto.
Il primo gennaio del 1912 Sun Yat-sen, venne investito ufficialmente della carica di
presidente della Repubblica Cinese. A simboleggiare il passaggio a una nuova era, fu
34
abolito il tradizionale calendario lunare, e fu adottato quello solare, numerando gli anni
a partire dal 1912.
La rivoluzione repubblicana segnava il crollo di un regime ormai logoro. Tale
rivoluzione però non era legata, come in Europa, all’avvento di una nuova classe:
l’unico strato emergente che iniziò a far sentire il suo peso fu quello dei militari.
Divenne presto evidente che le contraddizioni irrisolte e le grosse difficoltà, la cui
soluzione
non
dipendeva
esclusivamente
dalla
cacciata
dei
mancesi
o
dall’abbattimento della monarchia, sarebbero esplose subito dopo; così pure nuove
incognite si sarebbero presentate con la crescita di quelle forze centrifughe che la
creazione di uno stato nazionale al posto di un Impero universale aveva liberato.
Questo non fu che l’inizio di un travagliato periodo di transizione e di riadattamento di
aperture forzose e chiusure sanguinarie.
A partire dalle Guerre dell’oppio, la Cina ha subito non solo pesanti umiliazioni, ma
amputazioni territoriali, crisi profonde di identità, povertà e miserie per le guerre che
avevano sconquassato il proprio territorio. Nel 1921 quando Mao fonda il partito
comunista cinese, la Cina è sull’orlo della rovina: allora, secondo la formula di Mao
Dun “un cane abbandonato non avrebbe cambiato la sua vita per quella di un cinese”.
La lunga marcia di Mao, fu anche, simbolicamente, la marcia verso la ricerca
dell’orgoglio perduto, alla ricerca di un nuovo splendore imperiale.
Il primo ottobre 1949 viene proclamata la repubblica popolare Cinese, iniziava così un
profondo e drammatico tentativo da parte di Mao di ritorno dell’età dell’oro. Le
frontiere della Cina si chiusero nuovamente e con altri mezzi si cercò di riguadagnare
la ricchezza e lo splendore di un tempo.
Nel decennio successivo al 230 ac, Zheng, prese a continuare l’opera dello zio
Zhaoxing, perseguendo una politica di espansioni e conquiste, distruggendo la potenza
degli altri stati in cui era la Cina era frammentata; nel 230 sottometteva Han, nel 228
Chao, nel 225 Wei, nel 223 Chu, nel 222 Yan e nel 221 Qi. L’unificazione politica
della Cina era compiuta, anche se a prezzo di devastazioni e stragi spaventose. Zheng
abbandonava il titolo regio e assumeva quello di Shi Huangdi, cioè “Primo Augusto
Imperatore”. Mao accettò sempre di buon grado il titolo di “Nuovo Shi Huangdi”.
35
La Cina diventa globale
Questa breve digressione storica può essere un utile ausilio per comprendere il tragitto
su cui la Cina di oggi si è avviata. Come nella fase dell’autorafforzamento, Pechino sta
spingendo all’estero le proprie forze vive (in questo caso le imprese multinazionali),
alla ricerca di quelle ricchezze, ma soprattutto di quelle tecnologie che possano dare
potenza al paese e riportalo in quel al rango che la Cina sente spettargli quasi per
diritto, ma comunque all’interno del sistema.
Pozzi petroliferi in Ecuador, Angola e Nigeria. Banche e boutique finanziarie in
Inghilterra e Stati Uniti. Miniere in Zambia, Cile e Perù. Reti di grande distribuzione
nel Sud-Est asiatico. Raffinerie in Kazakhstan e Corea. Elettrodomestici in Pakistan.
Marchi storici dell'automobilismo in Gran Bretagna. Lo shopping della Cina sul
mercato mondiale prosegue a tambur battente. I recenti colpi grossi di China
Development Bank su Barclays e di Central Huijin su Blackstone sono solo la punta di
un gigantesco iceberg che ormai si è messo in movimento. Ed è destinato in breve
tempo a sconvolgere i vecchi equilibri del capitalismo mondiale.
Il 2005 ha fatto registrare un vero e proprio boom degli investimenti diretti
all'estero, che hanno superato gli 11 miliardi di dollari, dai 2 miliardi del 2004 e
ben superiori al precedente massimo storico di 6 miliardi del 2002 (che,
ricordiamolo ancora, è il primo anno dall'ingresso della Cina nel WTO).
Nel 2006 hanno raggiunto la quota di 21,16 miliardi di dollari.
10
. Nel 2006 più di 5
mila imprese cinesi hanno realizzato 10.000 operazioni di investimento diretto estero
in 172 nazioni. Nel complesso il capitale cinese investito all’estero ammonta a 90
miliardi di dollari. Gli investimenti di tipo finanziario hanno raggiunto nel 2006 la
quota 3,53 miliardi di dollari, nel complesso tali investimenti hanno raggiunto un totale
di 15,61 miliardi di dollari. Nel 2006 le banche commerciali di Stato hanno aperto 47
filiali, 31 istituti di credito e 12 uffici di rappresentanza in 19 paesi, tra cui Stati Uniti,
Giappone e Gran Bretagna, impiegando più di 20.000 persone. Stando ai numeri
10
Stando ai numeri rilasciati dal Mofcom nel 2006 “among which US$ 5.17 billion was incremental
equity investment, UD$6.65 billion was current profits reinvestment and US$ 9.34 billion was other kinds
of investment, accounting for 24.4%, 31.4% and 44.2% of total respectively.”
36
rilasciati dall’ World Investment Report 2006 dell’UNCTAD Pechino si posizione al
13 posto della classifica degli investitori globali. Ben oltre la metà degli investimenti
diretti esteri, sono stati realizzati nell'ultimo lustro, un periodo durante il quale le
acquisizioni oltrefrontiera cinesi sono cresciute del 70% l'anno.
Ancora poco se si pensa che, solo l'anno scorso, la Cina ha attirato capitali stranieri per
70 miliardi di dollari e che, dall'inizio degli anni 90 ad oggi, gli investitori d'oltremare
hanno riversato quasi 700 miliardi di dollari oltre la Grande Muraglia, o se si considera
che gli investimenti esteri del gigante asiatico sono circa un cinquantesimo di quelli
degli Stati Uniti, e rappresentano meno del 2% del totale degli investimenti esteri
realizzati nel 2005 sull'intero pianeta.
Ma la recente storia della Cina dimostra che il Paese ha le capacità per fare le cose
bene e, soprattutto, in fretta. Nonostante vi siano ancora molte restrizioni alle
esportazioni di capitali, aziende come Haier, Lenovo, Tcl, Cnooc ormai si muovono
sui mercati mondiali come delle vere e proprie multinazionali.
La crescita esponenziale degli investimenti esteri cinesi è legata a diversi fattori. In
primo
luogo,
c'è
un
Governo
sempre
più
determinato
a
favorire
l'internazionalizzazione delle aziende domestiche e delle ragioni legate alla struttura
dell'economia cinese e alle strategie di sviluppo delle imprese.
Di poi, la necessità di assicurarsi risorse naturali, materie prime e fonti energetiche di
cui la Cina scarseggia. Il desiderio di espandersi sui mercati esteri. La competizione
sempre più serrata sul mercato domestico che spinge le aziende a delocalizzare in Paesi
a minor costo del lavoro. L'eccesso di liquidità generato dall'aumento dei profitti
societari che stimola il management a trovare allocazioni alternative. La voglia di
costruire marchi cinesi di notorietà internazionale. L'obiettivo di costituire centri di
ricerca e sviluppo nei Paesi industrializzati per acquisire più rapidamente tecnologie e
know how.
Lo shopping cinese in giro per il pianeta sta disorientando il mondo industrializzato.
Da un lato, il ritorno a casa della moneta pesante accumulata da Pechino dal 2004 in
poi, grazie al boom del made in China, è vista di buon occhio dai grandi partner
commerciali della Cina. D'altronde, oltre 1.400 miliardi di dollari di riserve valutarie
sono un'enormità e qualsiasi operazione che contribuisca al loro riequilibrio è un fatto
positivo per l'equilibrio macroeconomico generale.
37
Dall'altro, però, oggi non c'è potenza mondiale che sia disposta a vendere di buon
grado le proprie aziende (soprattutto se sono strategiche) ai paesi in via di sviluppo che
si affacciano sul mercato internazionale con i forzieri stracolmi di liquidità. Il
fallimento del colosso petrolifero Cnooc nella scalata all'americana Unocal (la versione
ufficiale cinese parla di "ritiro dell'offerta") è un chiaro esempio di tale atteggiamento.
Un atteggiamento che cambia radicalmente spostandosi di latitudine: nell'ultimo
biennio molte nazioni in via di sviluppo africane e sudamericane (Nigeria e Venezuela,
solo per fare i nomi di due grandi produttori di greggio) hanno srotolato tappeti rossi
all'arrivo dei capitali cinesi. Che, giorno dopo giorno, continuano a riversarsi copiosi
ovunque nel mondo. In Asia, che per ragioni geografiche e culturali è la meta
privilegiata dell'espansione della Cina, e anche negli altri 4 continenti. E qui emerge un
altro paradosso cinese: quello di una nazione in via di sviluppo che finora ha esportato
i propri capitali per comprare aziende, risorse naturali ed energia in 150 Paesi del
pianeta.
Non ci sono solo i grandi gruppi di Stato che finora hanno fatto la parte del leone
nell'offensiva d'oltremare. Ma anche le società private, come dimostra il calo dal 35%
del 2004 al 29% del 2005 della quota di investimenti esteri realizzata dalle aziende
pubbliche. Si investe in ogni modo: con le classiche operazioni green field, ma anche
con strumenti più sofisticati come il merger & acquisition che nel 2006 è stato
utilizzato nella metà delle incursioni estere dei cinesi .
38
Non solo miniere
L'acquisto da parte della Cina di un pacchetto azionario di una tra le più importanti
banche occidentali segna una nuova fase nelle ambizioni globali del paese,
sottolineando come Pechino stia facendo dei passi da gigante nella modernizzazione
della propria economia ed anche delle proprie capacità di elaborazione ed attuazione di
una strategia globale.
Il processo di espansione mondiale della Cina è andato avanti per un decennio
assumendo dimensioni epiche, ma gli eventi di fine luglio 2007 possono
rappresentarne una svolta importante. L’ acquisto del pacchetto azionario della
Barclays da parte della China Development Bank, una delle “politicy banks”
statalizzate di Pechino , è in se stesso significativo, ma rappresenta anche un
considerevole cambiamento nella percezione dominante del ruolo economico
internazionale della Cina.
Fin dall'entrata della Cina nella Word Trade Organization nel 2001, gli investitori
stranieri hanno scalpitato alla prospettiva di investire in un mercato con uno dei tassi di
risparmio più alti del pianeta ($1.7 miliardi risiedono in conti di risparmio personali
cinesi). La Royal Bank of Scotland e la Bank of America, solo per citarne due, hanno
acquistato pacchetti azionari del valore di miliardi di dollari in banche cinesi, facendo
così venire meno le ipotesi di quanti prevedevano un crack finanziario del sistema
cinese.
Ma, solo fino ad alcuni mesi fa, il pensiero che la Cina con le proprie istituzioni
bancarie potesse intraprendere un’ azione così ardita era inimmaginabile.
La scelta da parte della China Development Bank di acquisire un pacchetto di
minoranza della Barclays è stata, come ha osservato il Financial Times, ben ponderata:
abbastanza modesta da non apparire una minaccia e avvenuta contestualmente
all’acquisto di un pacchetto azionario proveniente dai fondi di investimento statale di
Singapore (Temasek). Allo stesso tempo, altri osservatori vedono tutto ciò come
l'ultima mossa di una tendenza preoccupante in base alla quale lo Stato cinese, sotto
forma di imprese apparentemente innocue, si sta insinuando sempre più
profondamente nelle istituzioni finanziarie ed economiche occidentali.
La spinta verso Ovest
39
La storia economica della Cina raccontata all' estero nell’ ultimo decennio ha
riguardato, più che altro, la straordinaria quantità di investimento diretto straniero
(FDI) confluito nel paese e che, nel 2007, ammonta a più di $700 miliardi in azioni.
Vero è che approssimativamente il 40% di quello deriva dalla regione ad
amministrazione speciale di Hong Kong (SAR) o dalle Isole Vergini britanniche e,
quindi, molto probabilmente, ha origine in Cina. Tuttavia, nonostante questa premessa,
l'abilità della Cina di attirare FDI è stata impressionante; fin dal 1992 si è regolarmente
distinta come una tra le tre migliori destinazioni di FDI.
Da molti anni, il governo cinese denuncia che tutti i soldi investiti in Cina non hanno
apportato la collaborazione tecnica e le abilità attese originariamente. Nel 2006, l’ 88%
delle esportazioni hi-tech della Cina continuavano ad essere prodotte da imprese a
investimento straniero che operavano prevalentemente importando beni semilavorati,
usando manodopera a basso costo e re-esportando successivamente. La Cina aspira
essere un' “economia di conoscenza”, ma, sostanzialmente, il suo attuale regime di FDI
ha fatto poco per aiutare le società locali cinesi ad espandersi e svilupparsi. Le imprese
cinesi hanno pochi leader globali, sono scarsamente innovative e ottengono bassi
risultati riguardo il riconoscimento del marchio. Il governo cinese sa che questo
modello deve in qualche modo cambiare.
Per incentivare questi cambiamenti, il governo, fin dalla metà degli anni Novanta, ha
incoraggiato le società cinesi ad "andare fuori". Questo è un fenomeno senza
precedenti nella storia cinese, in quanto la Cina non è mai stata un esportatore di
capitale.
La situazione è rimasta immutata dopo la rivoluzione del 1949 e durante tutti i primi
anni della Repubblica Popolare Cinese. Solamente negli anni Ottanta, quando il
processo di riforma inaugurato da Deng Xiaoping si è messo in moto e l'economia
cinese si è aperta all’esterno, la Cina ha incominciato a investire nell’ industria
mineraria e nelle materie prime, anche se in piccoli quantitativi.
Il nuovo modello
Oggi, le cose stanno cambiando rapidamente. La Cina è il più grande possessore di
riserve di valuta estera sul pianeta (ha raggiunto il Giappone all’ inizio del 2006); il
70% dei suoi $1.4 triliardi è in dollari statunitensi, di cui $400 miliardi investiti in
40
buoni del tesoro USA. Il resto giace inattivo, attira percentuali basse di interesse ed è
soggetto a fluttuazioni di valuta. Nel 2007, la Cina ha preparato un fondo di
investimento, stanziando una cifra iniziale di $200 miliardi che cerca di spendere in
tutto il mondo. Finora ha investito all'estero $60 miliardi, la maggior parte dei quali in
America Latina e Asia, con ammontari in aumento in Africa. Ma gradualmente, le
società cinesi si stanno avviando ad avere presa anche in Europa e negli Stati Uniti
tramite fusioni e acquisizioni.
È probabile che l’ investimento cinese costituisca ancora meno dell’ 1% della scorta
globale, ma questa percentuale non può fare altro che salire, vista soprattutto
l’accelerazione che il processo di internazionalizzazione delle imprese ha subito negli
ultimi anni, anche rispetto alle altre economie in via di sviluppo, con particolare
riferimento alla Russia che, grazie alle esportazioni di petrolio, gas ed armamenti sta
rimpinguando le proprie riserve di Stato, come ben si evince dal grafico successivo.
Questi
risultati
vanno
inoltre considerati al netto
di una normative del settore
ancora
alquanto
rigida,
nonostante le sempre più
frequenti liberalizzazioni.
Nei
prossimi
assisteremo
dunque
all’arrivo
globali
crescente
anni
sui
di
di
una
mercati
massa
capitali
di
origine cinese, con più o meno dirette connessioni con l’establishment politico, alla
ricerca di profitti e di acquisizioni strategiche. Una massa crescente di capitali che
proprio per la loro origine di Stato, come nel caso della China Development Bank o le
società di energia cinesi, rischiano di creare scompiglio in Europa e negli Stati Uniti.
I cinesi sembrano volere diffondere il messaggio che l’ inversione di rotta
rappresentata dall’ ODI sia un modo per equilibrare le bilance commerciali del resto
del mondo nei confronti di Pechino, che grazie al boom delle esportazioni ha
41
incamerato nei propri forzieri riserve stratosferiche. Il che non esclude che la marcia
del capitale cinese sui mercati internazionali sia anche un modo di accelerare il
processo di crescita e di aumentare lo spessore dell’economia cinese, procurando un
salto dal ruolo da terzisti assemblatori, verso settori a più alto valore aggiunto e di
compensare il mancato trasferimento di tecnologie che le autorità cinesi ricercavano
nel sistema del joint-ventures tra imprenditori locali e esteri. In altre parole potrebbe
diventare un modo per cercare di comprare quelle conoscenze, quelle tecnologie e quei
marchi all’estero, che gli investimenti internazionali non hanno portato in dote ai
cinesi nei passati trent’anni.
Questo, ed il fatto che dietro le quinte si cela lo stato cinese, monopartitico e non
democratico, non è esattamente rassicurante per gli eventuali partner commerciali della
Cina all’estero.
Ma questa, come tutte le storie complicate, è in continuo cambiamento. Altri
investimenti, come quello di Lenovo nella divisione PC dell’ IBM negli Stati Uniti e
dell’ Huawei in Europa, sembrano dare i loro frutti e incrementarne il valore.
L’esempio della speculazione nella Barclays - il pacchetto azionario preso dalla Cina
nell’ equity fund Blackstone degli Stati Uniti – è stato rivalutato da esperti, nonostante
la critica pubblica proveniente dalla stessa Cina, come strategico ed intelligente.
Friedrich Wu, un esperto della ODI cinese con sede a Singapore, sostiene che i soldi
cinesi investiti in fabbriche a bassa prestazione in Europa e negli Stati Uniti possono
essere vantaggiosi per entrambe le parti. Ancora più importante, le imprese cinesi che
vanno all'estero tendono ad assorbire lezioni difficili, dure circa l'importanza della
responsabilità di impresa e dei sistemi di controllo e amministrazione aziendale.
Queste lezioni tornano a vantaggio della Cina stessa, accompagandola nella sua
strategia di diventare un'economia a livello mondiale.
42
Dall’Open door al Go Global
L'apertura economica della Cina inizia negli anni 80 - a imitazione dei "dragoni"
asiatici - allorché anche Pechino comincia ad avvalersi, per l'esportazione, del suo
vantaggio comparato nelle industrie ad alta intensità di lavoro. La caratteristica più
rilevante della strategia cinese, sulla base della liberalizzazione interna e della stabilità
politica, è il ricorso al capitale straniero per realizzare impianti industriali destinati a
esportare la propria produzione. Nel giro di circa vent'anni la Cina ha ricevuto
investimenti stranieri (Ide) per oltre 400 miliardi di dollari, contribuendo per il 20%
alla produzione industriale e al 50% all'export.
Il fenomeno è di dimensioni straordinarie. La politica commerciale di Pechino ha
incoraggiato le operazioni internazionali di assemblaggio e subappalto, esentando dai
diritti doganali le importazioni destinate a essere riesportate dopo la trasformazione.
Alle imprese straniere oggi è imputabile oltre il 75% delle esportazioni di
assemblaggio e del 78% delle importazioni corrispondenti. Le operazioni di
assemblaggio hanno permesso alla Cina di ampliare e diversificare rapidamente le sue
capacità di esportazione e di "sfondare" nei settori dell'elettronica e della
strumentazione di precisione. Più della metà dei lettori di Dvd e degli apparecchi
fotografici numerici, così come più di un terzo dei pc da ufficio e portatili e quasi un
quarto dei telefonini e dei televisori a colori, provengono dalla Cina.
L’apertura dell’economia pianificata avviata nel 1978, meglio conosciuta come Open
door policy, si è fondata, infatti, sull’attrazione degli investimenti internazionali e sulla
parallela spinta delle esportazioni (strategia export-push). Tale politica, per rapidità di
sviluppo e portata dei suoi effetti, ha sollevato una crescente attenzione di media,
studiosi ed operatori. In alcuni decenni, non solo la Cina è diventata uno dei principali
paesi esportatori mondiali, ma ha assunto un ruolo chiave, come si è detto,
nell’acquisire flussi di investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investment - FDI).
Più recentemente, come si accennava in precedenza, il Governo Cinese, alla ricerca di
una maggiore integrazione in ambito internazionale, ha avviato una nuova politica,
nota come Go Global, finalizzata alla promozione degli investimenti all’estero delle
imprese cinesi (Outward Foreign Direct Investment - OFDI). L’incoraggiamento degli
OFDI è indicato come una possibile via di uscita dall’impasse del percorso virtuoso di
43
crescita cinese, che ha indotto ad un accumulo di surplus commerciale, crescita delle
riserve di valuta estera con pressioni fortissime sul tasso cambio, oltre che insofferenza
dei partner commerciali.
Ora la globalizzazione delle imprese, anche di piccole e medie dimensioni, è ritenuto
un fattore critico per l’ulteriore sviluppo economico della Cina e una chiave di volta
della nuova politica di espansione verso nuovi mercati di sbocco, alla conquista di
tecnologie, conoscenze ed altri asset tangibili e soprattutto intangibili ad alto valore.
44
L’evoluzione del quadro regolamentare
L’analisi dei dati relativi agli Ide in uscita effettuati dai residenti cinesi non può essere
condotta indipendentemente da un esame dell’evoluzione del quadro regolamentare a
essi relativo. Diversi studi condotti sull’argomento suddividono in cinque periodi gli
anni che vanno dalla fine degli anni settanta (il momento in cui la politica di apertura
al mercato fu avviata da Deng) ad oggi, sebbene le scansioni proposte dai diversi studi
siano leggermente differenti tra loro. Il primo intervallo, che arriva fino alla metà degli
anni ottanta, vede gli investimenti diretti all’estero ancora quasi del tutto assenti e
comunque attivati esclusivamente dalla programmazione statale. In questa fase, gli
investimenti oltre frontiera sono concessi solo alle trading corporations di matrice
statale o ad aziende di governi locali per la cooperazione in campo economico e
tecnologico. Si tratta nel complesso di un fenomeno di ancora scarsa rilevanza dal
punti di vista quantitativo.
Nel 1984 vengono introdotti clementi di liberalizzazione che si sostanziano
principalmente nella standardizzazione delle procedure di autorizzazione. Si tratta di
una misura rivolta sia ad attrarre investimenti esteri, sia a stimolare quelli delle
imprese cinesi, con le private per la prima volta ammesse ai processi di
autorizzazione per operazioni di investimenti all'estero. Questa politica si riflette in
un rapido ed evidente aumento dei flussi di investimenti diretti in uscita, che si
portano in tempi brevi a ridosso del miliardo di euro, per poi balzare a oltre 4
miliardi nel 1992 e 1993. Siamo di fronte a una vera e propria prima esplosione del
fenomeno. In certa misura, a dare conto di questa brusca accelerazione sono gli
investimenti volti ad assicurare alla macchina produttiva cinese le materie prime,
petrolio in primis, di cui essa scarseggia. In questa fase dunque, per sperimentare
l’apertura all’estero, è selezionato e sostenuto un team di imprese statali dei settori
strategici (minerario, energia, automotive, elettronica, chimico, costruzioni,
trasporti). Sono garantiti incentivi e diritti speciali in tema di autonomia decisionale
e gestionale. Al tempo stesso si dà avvio ad un più stretto controllo degli OFDI, al
fine di evitare speculazioni e ulteriori perdite per le aziende statali. Si tratta, quindi,
come vedremo successivamente, di investimenti in strutture che si localizzano in
45
Paesi esportatori di commodities, principalmente africani. Tale componente
continua a costituire una fetta importante del flusso di capitali in uscita dalla Cina.
A partire dal 1993, anche a seguito della crisi del settore immobiliare ad Hong
Kong, che aveva attratto grossa quantità di capitali, le autorità reintrodussero un
approccio più cauto nel rilascio delle autorizzazioni alle operazioni di investimento
diretto all'estero, con una particolare attenzione a verificare la natura “produttiva”
degli investimenti all’estero e non meramente speculativa o ad alto rischio. La
stretta ha i suoi effetti, e la crescita dei flussi di investimenti diretti si arresta
nettamente.
Sul finire degli anni Novanta, con il progressivo concretizzarsi della prospettiva
dell'ingresso della Cina nel Wto, le autorità di Pechino tornano a premere
sull'acceleratore degli investimenti all'estero, mirando soprattutto a incoraggiare,
tramite tutta una serie di incentivi, gli investimenti da parte delle imprese esportatrici,
in modo da metterle in grado di trasferire almeno alcune fasi della produzione
all'estero. In questa fase, vengono incoraggiati progetti di internazionalizzazione
dell’industria leggera (tessile, macchine utensili ed elettriche) mirati a stabilire
industrie di trasformazione all’estero. Sono garantiti sgravi fiscali in caso di ricorso a
materie prime o componenti cinesi. Reputazione, creazione del marchio, innovazione
e tecnologia diventano fattori strategici.
46
Tra la fine del 2001 e l'inizio dei 2002, il governo ha collocato gli investimenti
all'estero in posizione ancora più centrale nella propria politica economica. E’,
infatti, con il XVI congresso del Partito comunista che viene lanciata la nuova
strategia del Go Global, volta a incoraggiare tutte le imprese cinesi ad andare al di
là del modello basato solo sulle esportazioni e a intraprendere con decisione la
strada dell'espansione internazionale, in modo da uscire da quella che potremmo
definire «la trappola del terzista», e cioè dalla condanna a un ruolo di produttore a
basso costo, senza capacità proprie di sviluppo di prodotti e di brand, destinato a
vedere i propri margini compressi da una fortissima competizione, soprattutto
interna. In altre parole un salto mortale nel percorso di evoluzione di una società,
da subcontractors internazionali a vere e proprie multinazionali.
Fino al 2002 le operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale di società
estere da parte di società cinesi necessitavano di autorizzazioni ad hoc, comunque
complesse da ottenere. Con l'avvio della politica del Going global la procedura è
enormemente semplificata e per molte transazioni vale, in sostanza, un principio di
silenzio-assenso. In linea con questa direttiva, nel dicembre del 2005 sono stati
eliminati i limiti a 200 milioni di dollari annui, vigenti in precedenza a livello di
singola provincia. I risultati, come visto, di tale politica sono di notevole rilievo.
47
Tutto fa pensare, dopo la performance del 2006 e le prime indicazioni relative al
2007, che molto presto la Cina dovrebbe entrare nel novero dei primi dieci paesi.
Nel complesso, queste cifre mostrano come l’invito delle autorità e le misure
messe in atto stiano effettivamente intervenendo a modificare l'atteggiamento delle
imprese cinesi di fronte alla sfida dell'internazionalizzazione.
Proprio a seguito delle prime significative liberalizzazioni si verificano quei primi
tentativi di acquisizioni di società estere da parte di compagnie cinesi che tanto
spazio hanno conquistato sulla stampa internazionale, come si evince dalla tabella
che segue:
Principali acquisizioni da parte di società cinesi - gennaio 1999 – gennaio 2006
Data
Status
Partecipazi
Valore
Società
one in %
in m di
acquisità
Sede
Società
acquirente
€
2005
Fallita
(100%)
15,255
Unocal
USA
CNOOC
2005
Completata
100%
3,204
PetroKazakhstan
Canada
PetroChina
2006
In sosteso
45%
1,894
Akpo oil field assets
Nigeria
CNOOC
USA
2004
Completata
100%
1,303
IBM (PC)
2001
Completata
100%
1,154
Hyundai
Technology
Sud
2005
Fallita
(100%)
1,050
Maytag
USA
Hai'er
2002
Completata
86%
672
Repsol-YPF (
Indonesia
CNOOC
2003
In sosteso
13%
593
Gorgon
Australia
CNOOC
2003
Completata
67%
450
Thomson SA (prod
Francia
TCL
2004
Completata
49%
419
Ssangyong Motor
2005
In sosteso
100%
370
PetroChina
International
CNPC
2005
Completata
100%
72
MG Rover
UK
Display
Liquefied
Corea
Lenovo
del
BOE Technology
Natural Gas Field
di televisori)
Corea
del
Nanjing Auto
Sud
Indonesia
PetroChina
Nanjing Auto
Non bisogna trascurare il fatto che le procedure per poter compiere un investimento
all’estero sono ancora complesse e soggette ad un nulla osta politico, che se da un lato
deve accertare la solidità dell’investimento, dall’altro può trasformarsi in una regia di tali
investimenti, secondo ben precise logiche di politica economica internazionale del paese.
Nuovi passi in avanti sono stati fatti di recente nell’opera di snellimento delle procedure e
di agevolazioni per le imprese.
48
Dal primo luglio del 2006, le aziende cinesi non hanno più limitazioni all'acquisto di
valuta estera, a condizione che la moneta pesante serva per realizzare investimenti oltrefrontiera. In precedenza vigeva un sistema di quote piuttosto articolato che modulato sulla
base della dimensione e del settore di attività, disciplinava le quantità di yuan che le
imprese potevano cambiare in valuta estera. Ad aprile dello stesso anno la People's Bank
of China aveva autorizzato i privati a convertire yuan in moneta pesante fino a un
controvalore di 20mila dollari per effettuare investimenti sui mercati finanziari esteri.
L’ultimo atto risale al maggio del 2007. Le autorità cinese hanno dato il via libera alle
banche del Paese all’acquisto di azioni all'estero, il che potrebbe dirottare per la prima
volta parte dei 35mila miliardi di yuan (3.381 miliardi di euro) di risparmi delle famiglie
cinesi sulle Borse internazionali.
Inoltre, l’authority cinese dei cambi ha, di recente, garantito quote pari a 4,8 miliardi di
dollari a 3 QDII (qualified domestic institutional investor). Il cosiddetto schema QDII
consente a istituzioni o privati cinesi di affidare alle banche commerciali cinesi di
investire una certa quantità di denaro (fino al 50%) in prodotti finanziari esteri e alle
società assicuratrici di investire parte dei loro assets in prodotti esteri a rendimento fisso.
In questo modo le sorti dell’economia e della prosperità cinese sono ancora più legate ai
mercati internazionali.
49
La distribuzione geografica e settoriale degli IDE cinesi
Il 71% degli investimenti diretti esteri cinesi rimane infatti in Asia (con una forte
concentrazione su Hong Kong), seguita dall'America Latina (20%) e dall'Africa (3%).
Una percentuale consistente (anche fino al 30%) degli investimenti in Asia, come
accennato sopra, può essere spiegata con il fenomeno del round tripping, ovvero con
capitali che escono dal Paese per beneficiare di agevolazioni finanziarie e fiscali e poco
hanno a che fare con veri investimenti produttivi. Lo stesso discorso vale, in certa
misura, anche per l'America Latina, dove buona parte degli investimenti si dirige
verso i paradisi fiscali delle isole caraibiche.
Country/Region
Hong Kong
Cayman Islands
British Virgin Island
South Korea
Australian
USA
Russia
Indonesia
Sudan
Total
2003
Amount
(US$100M)
11.5
8.1
2.1
1.5
—
0.7
0.3
0.3
—
24.4
% of
Total
40.4%
28.3%
7.4%
5.4%
—
2.3%
1.1%
0.9%
—
85.8%
2004
Amount
(US$100M)
26.3
12.9
3.9
0.4
1.3
1.2
0.8
0.6
1.5
48.7
% of
Total
47.8%
23.4%
7.0%
0.7%
2.3%
2.2%
1.4%
1.1%
2.7%
2005
Amount
(US$100M)
34.2
51.6
12.3
5.9
1.9
2.3
2.0
—
1.0
88.6%
77.0
% of
Total
27.9%
42.1%
10.0%
4.8%
1.6%
1.9%
1.6%
—
0.8%
90.7%
Fonte: China FDI Statistics Report, Ministry of Commerce and China Statistics Bureau
Diverso è il quadro per quello che riguarda l'Africa, dove gli investimenti sono
50
pressoché esclusivamente di natura produttiva e dove la maggior parte delle
operazioni sono effettuate da imprese statali o a partecipazione statale che contano
ancora per circa l'80% degli investimenti all'estero. Più interessanti in prospettiva
sono, invece, le destinazioni Nord America ed Europa, dove le motivazioni che
spingono all'investimento sono di natura più strettamente collegata al business privato:
acquisizione di competenza tecnologica, acquisizione e diffusione di un marchio forte
e riconosciuto a livello internazionale, acquisizione di reti di distribuzione e
rafforzamento della presenza commerciale, acquisizione di capacità manageriali e
organizzative, oltreché valvola di sfogo per la capacità produttiva in eccesso sul
mercato interno.
51
I campioni nazionali cinesi
Gli scudieri del made in China partono
alla conquista degli sconfinati territori
stranieri con due armi nelle mani. Il
merger & acquisition, oppure il classico
investimento diretto di tipo green field.
La prima è di gran lunga la preferita.
Oltre tre quarti dei 60 miliardi di
investimenti diretti stranieri realizzati da
gruppi cinesi dal 1980 a oggi è avvenuta
sotto forma di acquisizioni dirette.
L'identikit di questi gruppi industriali è
Fonte: Asia Pacific Foundation of Canada
pressoché identico. Sono controllati dallo Stato, anche se spesso una piccola quota del
loro capitale è quotata in Borsa. In patria operano in condizioni di semi-monopolio.
Hanno accesso libero al credito, visto che le banche in Cina sono possedute dal
Governo centrale. Il loro management viene nominato dal potere politico.
Imprese con potenziale globale
Fonte: Company Websites, IBM Institute for Business Value analysis 2005.
52
Ancora all´inizio di questo decennio nessuna azienda cinese poteva aspirare ad
avvicinare la capitalizzazione di Borsa di giganti americani come la General Electric e
la Microsoft. Ora la compagnia petrolifera PetroChina vale più della somma di General
Electric e della Exxon (525 miliardi di dollari). Sia il gruppo telefonico China Mobile
che l´istituto di credito Industrial & Commercial Bank of China (Icbc) superano il
valore azionario di Microsoft, di Citigroup e della Bank of America. E la China
Construction Bank, la terza banca del Paese, dopo ICBC e Bank of China, in cui la
Bank of America deteniene una quto dell’8,2%, ha raccolto ben 7,7 miliardi di dollari
in un giorno di offerta in Borsa: solo qualche anno fa era talmente disastrata che era
dovuto intervenire il governo centrale per evitare la bancarotta.
Nel settore delle telecom, China Mobile detiene il primato mondiale con una
capitalizzazione di oltre 346 miliardi di dollari, rispetto agli oltre 200 dell’americana
AT&T e, nel settore aereo, Air China vale più dei suoi concorrenti asiatici, Singapore
Airlines e Cathay Pacific, messi insieme. La compagnia assicurativa China Life (240
miliardi di dollari) pesa più della AT&T, di Procter & Gamble e di Electricité de
France.
Con un indice azionario di Shanghai che è quasi triplicato dall´inizio di quest´anno, la
Borsa della Repubblica popolare attrae una quota crescente dei risparmi privati,
dall´immenso giacimento di ricchezza accumulato nelle famiglie cinesi: oltre 2.300
miliardi di dollari. Stufi dei magri rendimenti offerti dai libretti di risparmio, ben 50
milioni di risparmiatori hanno aperto dei conti-titoli per operare in Borsa. Sono loro il
vero motore del boom delle quotazioni. In massima parte il denaro che affluisce sulle
aziende quotate a Shanghai viene dal "parco buoi" degli investitori individuali, mentre
per gli operatori stranieri resta molto più semplice acquistare azioni quotate a Hong
Kong. Il mercato finanziario cinese non è totalmente liberalizzato, la moneta nazionale
(renminbi o yuan) non gode della piena convertibilità. Questo rende ancora marginale
il ruolo dei capitali stranieri. Ma la ricchezza delle famiglie è bastata a sospingere il
capitalismo cinese verso il primato assoluto delle Borse. Nella top ten si sono piazzati
cinque gruppi cinesi e solo tre americani. Se si allarga lo sguardo alle venti società con
la massima capitalizzazione, vince sempre la Cina (otto aziende) seguita da Stati Uniti
(sette), Unione europea (quattro) e Russia (una).
53
Le multinazionali cinesi pesano per il 41% del valore delle Top 20, le americane il
38%, tutto il resto del mondo deve accontentarsi del 21%. Vecchie potenze del
capitalismo occidentale come Gran Bretagna e Francia fanno fatica a piazzare una o
due società nel vertice dominato dagli asiatici. E la tendenza sembra destinata ad
accentuarsi vista l´alluvione di nuovi collocamenti in Borsa che avvengono a
Shanghai.
La travolgente avanzata del capitalismo cinese trasforma i rapporti di forze sia
all´intero che all´esterno del paese. A Pechino l´ultimo congresso del partito comunista
ha visto l´aumento degli imprenditori miliardari eletti nel comitato centrale: sono
ormai venti. Nel mondo un ennesimo segnale dei tempi che cambiano si è avuto con la
storica decisione di Bear Stearns di aprire il proprio capitale alla banca cinese Citic:
«l´equilibrio del potere si sposta» ha commentato il New York Times, di fronte al
matrimonio cinese celebrato da una delle più antiche istituzioni dell´establishment
finanziario di Wall Street. Per la Citic l´investimento è quasi modesto - un miliardo di
dollari - in confronto al colpo messo a segno dalla sua concorrente Icbc. La Industrial
& Commercial Bank of China, controllata dallo Stato, ha acquisito per 36,7 milioni di
rand, circa quattro miliardi di euro, il 20% della Standard Bank di Johannesburg. Il
gruppo cinese, che diventa primo azionista, avrà il diritto di nominare due
amministratori nell'azienda di credito africana, dei quali uno sarà vicepresidente.
Non è solo una grande operazione, però. la Icbc è quotata - Goldman Sachs, per
esempio, ha il 4,9% - e ha annunciato di recente risultati trimestrali in crescita del 76%
annuo. Sta inoltre tentando di diversificare le proprie attività all'estero, sia pure con
l'obiettivo di aprire la strada anche ad altre società cinesi. È alla sua terza operazione
oltrefrontiera, dopo l'acquisizione dell'80% della Seng Heng Bank di Macao e della Pt
Bank Halim Indonesia.
Per le azioni Standard Bank - in parte esistenti, in parte di nuova emissione - Icbc ha
quindi offerto un premio del 30% rispetto al prezzo medio ponderato dell'ultimo mese
rispetto al mese precedente l’investimento. È la conferma del forte interesse per un
gruppo creditizio fortissimo nel continente ma che ha controllate anche in 21 altre
nazioni tra cui l'Argentina, presto l'India e, forse, la Russia.
Nell’ agosto del 2006 la China Construction Bank acquista le filiali di Hong Kong e
Macao della statunitense Bank of America, per 1,2 miliardi di dollari. Sono solo i
54
primi effetti di una politica del go global che si applica anche alle istituzioni finanziari
cinesi, spinte dal Governatore della Banca del popolo cinese, Zhou Xiaochuan, ad
andare fuori “in modo che possano meglio servire alle aziende cinesi orientate
all'estero».
Alcune delle maggiori società cinesi per capitalizzazione
Società
Capitalizzazione in $
Quota statale
Petrochina (petrolio)
1.000 miliardi
86%
China mobile (telefonia)
346 miliardi
75%
ICBC (banche)
338 miliardi
85%
Sinopec (petrolio)
270 miliardi
71%
China Life insurance
241 miliardi
72%
(assicurazioni)
Bank of China (banche)
180 miliardi
70%
China communitations costructions
40 miliardi
75,5%
(ingegneria e infrastrutture)
Baoshan Iron Steel
38 miliardi
78%
(acciaio)
China telecom (telefonia)
32 miliardi
71%
Il ruolo dello Stato, nella gestione dei campioni nazionali, è ancora preponderante,
come di evince dalla precedente tabella, controllando tra il 70 ed il 90 percento del
capitale delle imprese. I dirigenti di queste imprese sono a tutt’oggi nominati dal
Consiglio di Stato che conferisce loro persino il rango di ministro. E non è raro
che qualche amministratore passi disinvoltamente da un incarico manageriale a
uno politico.
Ma la classifica dei big cinesi potrebbe riservare in futuro ulteriori sorprese. All’ombra
dei giganti di Stato, si stanno consolidando i primi gruppi in mano a ricche famiglie. Ci
sono istituzioni finanziarie coma China Minsheng Bank, l’unica banca privata cinese
fondata dal miliardario Liu Yonghao (attualmente China Insurance ne deteniene la
partecipazione di maggioranza con il 6,17%), che capitalizza circa 30 miliardi di
dollari sulla borsa di Shanghai. E’ stato il primo istituto di credito cinese ad acquistare,
nell’ottobre del 2007, una quota strategica di una banca americana (il 9,9 percento dei
UCBH Holdings inc.). Ma ci sono anche gruppi tecnologici come Alibaba, che
gestisce il maggiore portare di e-commerce in Asia e vanta una capitalizzazione di 26
miliardi di dollari; e poi aziende navali come la Sinotrans Shipping che, se la sua
quotazione avrà successo, raggiungerà a quattro anni dalla nascita il podio delle
maggiori del suo settore, con investitori del pari di Li Ka Shing.
L’ultimo colpo di Li Ka Shing, risale al gennaio del 2006 quando ha acquistato
55
Marionnaud, la più grande catena di profumerie d´Europa con 500 negozi in Francia e
altre centinaia di punti di vendita diffusi tra Italia e Spagna, Svizzera e Austria.
L´impero di Li Ka-shing trascende le frontiere del «miracolo cinese», cominciò a
estendere le sue ramificazioni globali prima che Hong Kong tornasse dalla Gran
Bretagna alla Cina: oltre a essere il primo operatore mondiale nel trasporto di container
e uno dei più grandi costruttori in Cina, con la sua Hutchinson Whampoa è anche uno
dei protagonisti della telefonia mobile in Europa. L´operazione Marionnaud è finita in
prima pagina su Le Monde, anche perché il prezzo ha fatto scalpore: quasi un miliardo
di euro. Un prezzo eccessivo secondo molti esperti francesi. La conferma che per i
grandi gruppi cinesi le risorse finanziarie non sono un limite. La scalata di Li Ka-shing
ebbe inizio negli anni 60, quando molti inglesi stanno lasciando Hong Kong spaventati
dalla rivoluzione culturale. I prezzi degli immobili crollano e lui compra. Nei primi
anni '70 colloca in borsa la società immobiliare Cheung Kong, che resta tuttora la
chiave di controllo del suo impero.
Nel 79 il grande balzo in avanti con l'acquisizione di Hutchison, una delle grandi
società di trading e di servizi portuali dell'ex colonia britannica. Il grande merito del
magnate asiatico è quello di essere stato il primo a capire che a Hong Kong non si
fanno affari senza o contro la Cina. Egli, infatti, per ingraziarsi il governo, regala alla
sua provincia un ospedale e un'università ed eroga milioni di dollari in beneficenza,
proprio mentre quasi tutte le grandi aziende si trasferiscono a Singapore.
Hutchison, insieme all'altra trading company Jardine Matheson, entra nel settore
energetico (Hong Kong Electric) e in quello petrolifero (Husky Oil) e si aggiudica la
costruzione e la gestione dei nuovi terminali portuali lungo la costa, da Shenzhen a
Xiamen. L'investimento permette alla società di rendersi indipendente per quanto
riguarda le infrastrutture: ben presto Li Ka Shing comincia a investire all'estero. Le
acquisizioni si estendono in Messico, Argentina, Thailandia, Arabia Saudita, Tanzania,
Australia, Corea del Sud.
Tra il 1985 e il 1989 il tycoon asiatico entra nel business delle telecomunicazioni
europee attuando una serie di alleanze strategiche: in ognuna delle aree in cui arriva, la
Hutchison sceglie un partner su cui appoggiare la sua forza finanziaria.
Con la liquidità accumulata grazie alle sue innumerevoli attività, Li Ka Shing è
presente alle aste UMTS in Germania, Francia, Olanda, Belgio, Italia, Gran Bretagna,
56
Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda e Svezia, oltre che ad Hong Kong, Israele, India e
Australia. Non sempre è tutto filato liscio però Nel 2003 il gruppo aveva concordato di
offrire 250 milioni di dollari per acquisire il 61,5% di Global Crossing, società
statunitense della fibra ottica. L’offerta era stata bloccata dal Governo americano
anche in questo caso per motivi di sicurezza nazionale. Al termine di una lunga
inchiesta, il Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti, composto da 11
membri del gabinetto tra cui il Ministro della Difesa e il Ministro del Tesoro, aveva
concluso, infatti, che il potente presidente della Hutchison Whampoa Ltd. era troppo
vicino al governo cinese per poter acquisire il controllo su un network di
telecomunicazioni di importanza strategica per gli Stati Uniti.
Le attività di Hutchison
Attività e servizi portuali
La Hutchison Port Holding (HPH) è tra le maggiori società portuali del mondo, con investimenti, gestioni e servizi in
Asia, Medio Oriente, Africa, Europa e America. HPH gestisce 169 moli in 30 porti oltre a numerose società di
trasporti.
Telecomunicazioni
Hutchison Telecommunications gestisce una vasta rete di servizi integrati di TLC in tutto il mondo ed è tra le
maggiori società di TLC mobili del pianeta. Hutchison possiede le licenze 3G in Germania, Francia, Olanda, Belgio,
Italia, Gran Bretagna, Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda e Svezia, oltre che ad Hong Kong, Israele, India e
Australia.
Immobili e Hotel
Hutchison Whampoa Property gestisce la vendita e l'affitto di immobili commerciali e residenziali. La divisione
alberghiera del gruppo possiede e gestisce hotel sotto il marchio Harbor Plaza Hotels and Resorts.
Commercio e largo consumo
La società A S watson gestisce tre catene di negozi al dettaglio in Asia (i supermercati Park'n'shop, la catena di
profumerie e negozi d'igiene Watson's Personal Care e la catena di elettrodomestici Fortress electrical appliances),
oltre alla catena Savers in Gran Bretagna. La divisione largo consumo acque minerali e marchi di bevande in Asia
ed Europa.
Energia e infrastrutture
Il gruppo Hutchison Whampoa Limited possiede importanti partecipazioni nella Cheun Kong Infrastructure, una
società di grandi costruzioni, nella Hong Kong Electric, monopolista elettrico di Hong Kong e di Lamma Island e
nella Husky Oil, uno dei maggiori gruppi energetici canadesi.
57
Le più grandi imprese cinesi classificate per investimenti diretti esteri nel 2006
N.
Anno 2004
Anno 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
China Mobile
China National Petroleum Corp.
China National Offshore Oil Corp.
China Resources (Holding) Co. Ltd.
COSCO
CITIC
SINOPEC
China Telecom
Guangdong and Hongkong Investment Holding
China Merchant Group
China NetCom
China Construction Corp.
Lenovo Holding
China Aviation Group
China Power Investment Group
China Minmetals
SinoChem
China National Cereal, Oil and Foodstuff
China Shipping
Sino Transportation Group
Shanghai Auto Group
China Huaneng Group
China National Petroleum Corp.
China National Offshore Oil Corp.
China Mobile
China Resources (Holding) Co. Ltd.
COSCO
SINOPEC
CITIC
China Merchant Group
China National Cereal, Oil and Foodstuff
China Construction Corp.
China Aviation
China Telecom
SinoChem
Chine NetCom
China Shipping
Guangdong and Hongkong Investment
Shanghai Auto Group
Shum Yip Holding Company
Lenovo Holding
China Power Investment Group
China Minmetals
Sino Transportation Group
23
24
25
26
27
Beijing Orient Electrics Group
China World Best Group
TCL Group
Guangdong Hangyun Group
Shanghai BaoSteel
TCL
Beijing Orient Electrics Group
China Huaneng Group
China Poly
Shanghai BaoSteel
Anno 2006
China Petrochemical Corporation
China National Petroleum Corporation
China National Offshore Oil Corporation
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
China Mobile Communications Corporation
China Ocean Shipping (Group) Company
CITIC Group
China National Cereals,Oils & Foodstuffs Corp.
China Merchants Group
Sinochem Corporation
China State Construction Engineering Corporation
China National Aviation Holding Corporation
China Telecommunications Group Corporation
China Shipping (Group) Company
China Network Communications Group Corporation
GDH Limited
China Power Investment Corporation
Shanghai Automotive Industry Corporation
China National Chemical Corporation
China Minmetals Corporation
Legend Holdings Ltd.
Shum Yip Holdings Company Limited
China National Foreigh Trade Transportation (Group)
Corporation
Huawei Technologies
Shanghai Baosteel Group Corporation
China Huaneng Group
SinoSteel Corporation
58
28
Beijing Jade Bird Group
China Shou Gang Group
29
30
China Nonferrous Metal Mining Group
China Road and Bridge Corp.
China Nonferrous Metal Mining Group
China North Industrial Group
China Poly Group Corporation
China Nonferrous Metal Mining & Construction
(group) Co.,Ltd.
Haier Group
Fonte: China FDI Statistics Report, Ministry of Commerce and China Statistics Bureau
59
Le principali 30 società in base agli assets
posseduti all’estero (parte finanziaria esclusa), 2006
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nome società
China Mobile Communications Corporation
China Network Communications Group Corporation
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
China National Offshore Oil Corporation
China National Petroleum Corporatio
China Petrochemical Corporation
China Ocean Shipping (Group) Company
China Unicom Corporation
Shanghai Overseas United Investment Co.,LTD
China State Construction Engineering Corporation
China Merchants Group
China National Cereals,Oils & Foodstuffs Corp.
Legend Holdings Ltd.
Sinochem Corporation
GDH Limited
China Shipping (Group) Company
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Par
CITIC Grou
Huawei Technologies
China Power Investment Corporatio
China Minmetals Corporation
Shanghai Automotive Industry Corporation
Shum Yip Holdings Company Limited
TCL Corporation
China National Aviation Holding Corporation
China National Chemical Corporation
China Poly Group Corporation
China Telecommunications Group Corporatio
China Huaneng Group
China National Foreign Trade Transportation (Group) Corporation
Le principali 30 società in base ai proventi ricavati dall’estero (parte finanziaria esclusa), 2006
N.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Nome società
China Petrochemical Corporation
China Mobile Communications Corporation
Sinochem Corporation
China National Petroleum Corporation
Legend Holdings Ltd.
China National Offshore Oil Corporation
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
China Network Communications Group Corporation
China Ocean Shipping (Group) Company
Zhuhai Zhenrong Company
China National Cereals,Oils & Foodstuffs Corp.
TCL Corporation
China Minmetals Corporation
China Shipping (Group) Company
Shanghai Baosteel Group Corporation
China State Construction Engineering Corporation
Huawei Technologies
Shanghai Automotive Industry Corporation
Anshan Iron & Steel Group Corporation
China National Aviation Fuel Group Corporation
Shougang Group
60
Haier Group
SinoSteel Corporation
China Merchants Group
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park
GDH Limited
China National Chemical Corporation
China National Aviation Holding Corporation
China Power Investment Corporation
CITIC Group
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Il governo cinese ha fissato come obbiettivo prioritario del proprio operato anche in
occasione del XVII Congresso del Partito la crescita dei propri campioni nazionali e
dei loro marchi nonché l’inclusione di almeno 50 aziende cinesi nell’elenco Fortune
500 entro il 2010. Obiettivo quest’ultimo che appare quasi a portata di mano di
Pechino se si pensa che nel 2006 erano 20 le società nella classifica di fortune 500 e
nel 2007 sono balzate a 24.
In
Utili
Città
graduatoriain milioni di $
1 Sinopec
17
131,636.0
Pechino
2 China National Petroleum
24
110,520.2
Pechino
3 State Grid
29
107,185.5
Pechino
4 Industrial & Commercial Bank of China170
36,832.9
Pechino
5 China Mobile Communications
180
35,913.7
Pechino
6 China Life Insurance
192
33,711.5
Pechino
7 Bank of China
215
30,750.8
Pechino
8 China Construction Bank
230
28,532.3
Pechino
9 China Southern Power Grid
237
27,966.1
Guangzhou
10China Telecommunications
275
24,791.3
Pechino
11Agricultural Bank of China
277
24,475.5
Pechino
12Hutchison Whampoa
290
23,661.0
Hong Kong
13Sinochem
299
23,109.2
Pechino
14Baosteel Group
307
22,663.4
Shanghai
15China Railway Engineering
342
20,520.4
Pechino
16China Railway Construction
384
18,735.7
Pechino
17China FAW Group
385
18,710.7
Changchun
18China State Construction
396
18,163.2
Pechino
19Shanghai Automotive
402
18,010.1
Shanghai
20COFCO
405
17,953.2
Pechino
21China Minmetals
435
16,902.2
Pechino
22Jardine Matheson
457
16,281.0
Hong Kong
23China National Offshore Oil
469
16,038.9
Pechino
24China Ocean Shipping
488
15,413.5
Pechino
Società
In grassetto le imprese di Stato
La produzione sta migliorando rapidamente in termini di qualità e capacità, molte
aziende avranno risorse finanziarie, formeranno associazioni con altre imprese,
diventeranno fornitrici e, in seguito, potranno considerare di acquistare le
aziende-clienti.
61
I desiderata cinesi per quanto riguarda il numero di multinazionali nella classifica
Fortune, non sono campati in aria. Da una analisi condotta dal centro studi della IMB
(si veda il grafico di seguito), sono sessanta le imprese cinesi che sono in grado di
aspirare al rango di attori globali sui mercati internazionali e tra queste ben 47 sono
imprese di Stato.
Grazie alla politica di incoraggiare alcuni “campioni nazionali” a competere con
aziende globali, gli investimenti cinesi all’ estero stanno incrementando ad un ritmo
superiore al 50% dall’inizio del nuovo secolo. Alcune aziende, come Haier, Huawei e
Lenovo, si stanno posizionando come brands globali. Altre aziende cinesi, che operano
nei settori dell’energia e dell’industria estrattiva (non petrolifera), come China
Shenhua Energy, CNPC (China National Petroleum Corporation), Sinopec e
Chinmetals, partecipano attivamente in contrattazioni internazionali per acquisire
risorse supplementari e sicure di materie prime che la Cina consuma avidamente.
La massa crescente di quattrini riversata da Pechino sui mercati esteri segnala un
fenomeno preciso: la volontà delle aziende cinesi di diventare globali. I grandi attori
del made in China (ma non solo quelli) aspirano ad espandersi fuori dai patri confini
per diverse ragioni.
62
Perché i loro margini di espansione sul mercato domestico sono ormai ridotti. Perché
hanno avuto successo dentro le mura di casa e pensano di poter fare altrettanto in terra
straniera. Perché hanno le casse che traboccano liquidità. Perché ci sono altri Paesi in
via di sviluppo (per esempio i vicini Vietnam e Cambogia) dove il costo del lavoro è
più basso. Perché ci sono dei fondi di venture capital esteri che li convincono ad
internazionalizzarsi (senza la regia determinante di tre istituzioni finanziarie
americane, probabilmente l'operazione
Ibm-Lenovo non avrebbe mai visto la
luce).
Il
Governo, forte delle sue enormi riserve
valutarie
da
re-impiegare,
sta
sostenendo in tutti modi l'aggressione
del
sistema corporate al mercato globale.
Sia che si tratti di operazioni strategiche
finalizzate
al
supremo
nazionale,
come
acquisizioni
di
le
fonti
interesse
numerose
di
energia
realizzate in tempi recenti dalle Tre
Sorelle dell'oro nero, Petrochina, Cnpc
e
Cnooc. Sia che si tratti di incursioni
effettuate da gruppi cinesi del largo consumo finalizzate a rafforzare la presenza di
questi ultimi sui mercati d'oltremare; oppure, ad acquisire marchi stranieri che hanno
63
già notorietà internazionale (è il caso delle operazioni concluse da Lenovo e Tcl), ma è
soprattutto il settore dell’IT che guida, insieme alle materie prime, la classifica del
maggior numero di investimenti cinesi all’estero.
64
Fusioni ed acquisizioni
Come si accennava in precedenza le acquisizioni da parte di imprese cinesi di marchi
storici del capitalismo è un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni. Il caso
più eclatante è forse quello della divisione personal computer della Ibm, ceduta a
Lenovo per 1,75 miliardi di dollari nel 2004. Ma non si tratta di un caso isolato. Pochi
mesi prima, la cinese Tcl aveva rilevato la produzione di televisori della francese
Thompson, mentre è dell'anno scorso il passaggio a Nanjing Automobile della MG
Rover, un tempo fiore all'occhiello dell'industria automobilistica britannica.
Nella tabella che segue è riportata una sintesi delle acquisizioni da parte di gruppo
cinesi di marchi internazionali.
Principali imprese protagoniste del Go Global
Risorse naturali: Baosteel, Chalco, China Huaneng, CNOOC-China National Offshore Oil Corporation (Repsol
YPF, Indonesia; Gorgon Liquified Natural Gas Field, Aus), China Minmetals Corp, China National Petroleum
Corporation (PetroChina Int.l, Indonesia, con PetroChina), Sinopec, PetroChina (PetroKazakhstan, Can; Devon
Energy Corp., Aus)
Alimentari : Chalkis (Conserves de Provence, F), Qingdao Beer
Automotive: Nanjing Automotive (MG Rover, UK); SAIC-Shanghai Automotive Industry Corporation (Sssangyong
Motor, S. Korea); Qianjiang Group (Benelli, I), Anhui Jianghuai Automobile Co., Lifan, Chery
Chimica e Farmaceutica: China National Blue Star Group Corp. (Adisseo, Luo Sulphadiazine Company F), Lizi
Industrial Group, Shanghai Dongbao Biopharmaceutical (Ferring's Malmö Manufacturing Operation, SV),
Sinochem, Lld, Suzhou Huasu Plastic Co Ltd, Baolige Taican Chemical Ind’l Co, Guan Zuodun Yuanyang Laquer
Co, Shanghai Naikeming Pharmaceutical Co
Elettronica: TCL (Schneider Electronics, D; Thomson, F); BOE Technology (Hunday Display Tech Hydis, S.
Korea), Shriro (Hasselblad, SV, Shanghai IC R&D Design Centre, SVA Group, CHINT Group, Skyworth
Elettrodomestici: Changhong, Haier (Meneghetti, I); Galanz; Konka, Midea Group, Hisense, SVA
Logistica: COSCO, China Ocean Shipping Company, China Classification Society, Huagang Hi Speed Passenger
Ship Co
Meccanica: Xi’an Electric Motors Works, Shenyang Machine Tool Group (Schiess), China's Huapeng Trading
(Welz Gas Cylinder), SGSB Group (Durkopp Adler,D), Luoshan Scana Machine Manufacture, Huayi Group
(Moltech Power Systems Inc, USA)
Telecoms & IT: Lenovo (IBM PC, Usa), Huawei Technologies, ZTE Corporation
Tessile: D’Long, Sail Star Shanghai (Boewe Textile Cleaning, D), Sinatex, LDG Sock, Hembly International
Holdings (Sergio Tacchini, Ita)
Ricerca: Suntar Membrane Techology (Hoechst, D), ChangAn Automobile Group
L’8 dicembre del 2004 viene annunciata l’acquisizione dell’intera divisione PC e
hardware di IBM da parte di Lenovo, azienda cinese leader del mercato nazionale. La
Lenovo è stata fondata nel 1981 da undici ingegneri cinesi ed è oggi il terzo produttore
mondiale di pc, grazie all'acquisizione, nel 2005, della divisione pc di IBM. In Cina
l'azienda ha una leadership schiacciante, con il 37% del mercato. Nel resto del mondo
65
si avvale della rete di vendita e del personale ereditati da Ibm. Fattura circa 13 miliardi
di dollari l'anno.
Con questa operazione, IBM abbandona un settore non più considerato profittevole per
concentrarsi su altri business, mentre Lenovo diventa il terzo produttore mondiale di
Personal Computer dopo HP e Dell, rispetto alla nona posizione occupata in
precedenza. L’acquisizione di società occidentali da parte di compagnie cinesi è un
fenomeno cominciato già da qualche tempo, ma l’annuncio che una delle più grandi
aziende americane ha ceduto la sua attività simbolo a un concorrente dell’Impero di
Mezzo, ha in qualche modo rappresentato uno spartiacque riguardo al modo in cui
viene percepita la realtà economica cinese dall’opinione pubblica internazionale.
Anche il gruppo TLC è venuto alla ribalta per l'accordo industriale stipulato con la
francese Thomson, di cui ha acquisito una quota del 67% dando vita al primo
produttore mondiale di televisori e lettori Dvd (20mila addetti in tutto il mondo e una
produzione prevista a regime di 18 milioni di tv). Ma già nel 2002 aveva acquistato la
società tedesca Schneider in stato di fallimento. Il 27 aprile 2004 è stata annunciata,
inoltre, la realizzazione di una joint venture tra Alcatel e Tlc , in base alla quale
quest'ultima ha acquisito le attività di produzione di telefoni cellulari.
Tlc deterrà una partecipazione del 55% , con una opzione quinquennale per l'acquisto
del restante 45% nelle mani di Alcatel.
Eppure solo nel 1981 Tcl era un piccolo fabbricante di videocassette basato a Huizhu,
nel Sud del Paese. Oggi in Cina il gruppo Tcl, produttore di elettronica di consumo, è
presente alla grande in tutti i settori: dalle tv, ai lettori di Dvd, dai telefoni cellulari ai
computer portatili.
L’avvocato Agnelli era solito dire che produrre automobili, per la complessità logistica
e tecnologica, è un lavoro da titani. Nonostante ciò, la Cina sta entrando a marce
forzate nel settore automobilistico. Il 2006 è stato, infatti, un anno record per l'export
di auto cinesi che ha raggiunto le 340 mila unità, in pratica più del doppio rispetto al
2005. Le statistiche segnalano un aumento per l'export di veicoli cinesi del 120%, con
un volume d'affari di un miliardo e mezzo di dollari. E nei prossimi dieci anni, la Cina
conta di aumentarlo fino a 120 miliardi, vale a dire il 10% del totale mondiale, tanto
che, trainata dal Giappone, ma, soprattutto, dalla Cina, l'Asia ha superato nel 2006
66
l'Europa nella produzione di auto: 18,07 milioni contro 17,98. A trainare le vendite nel
paese della grande muraglia, le tre compagnie locali, la Faw, la Saic e la Dongfeng
Motor che si attestano alle prime tre posizioni consegnando nel 2005 rispettivamente
983.100, 917.500 e 729.000 unità. Nella top ten, che conta oltre l'80% dell'intero
mercato cinese delle quattro ruote, per la prima volta sono entrate di diritto anche la
Chery e la Geely che durante lo scorso anno hanno venduto rispettivamente 189 mila
(+118%) e 149 mila unità (+49%). Un trend di crescita che ha già portato ad alcune
acquisizioni strategiche da parte dei marchi cinesi.
La casa automobilistica cinese Saic ha lanciato il 24 ottobre del 2006 ufficialmente
Roewe, la prima auto completamente prodotta e disegnata in proprio dall'azienda. Il
modello è stato sviluppato sulla base della piattaforma della Rover 75, di cui la Saic
aveva acquisito i disegni, insieme a quelli della Rover 25, al momento del fallimento
del gruppo Mg Rover
Bmw ha deciso di vendere lo storico nome Rover alla Shanghai Automotive Industry
Corporation (Saic), la società controllata da Pechino. La vendita, per circa 11 milioni
di sterline, o 21 milioni di dollari, dovrebbe essere completata in settembre, appena
verranno finalizzati alcuni dettagli.
Saic lo scorso anno aveva acquistato i diritti al design e alla tecnologia di due modelli
Rover per 67 milioni di sterline, prima del fallimento del gruppo oberato da 1,4
miliardi di sterline di debiti, ma Bmw aveva finora mantenuto la proprietà del marchio
con la caratteristica nave vichinga stilizzata.
L'unico altro contendente in lizza per acquisire il nome è un'altra società
automobilistica cinese rivale di Saic: Nanjing Auto, che nel 2005 aveva rilevato la
società in amministrazione controllata. Il colosso americano Ford, che in virtù di un
accordo siglato con Bmw quando aveva acquistato Land Rover nel 2000 ha il diritto di
prelazione sul nome, non ha interesse a esercitarlo. Per Ford l'importante è mantenere
l'esclusiva al nome nel segmento: i cinesi non potranno quindi comunque utilizzare il
nome Rover per fuoristrada e 4x4.
Con la vendita anche del nome si chiude l'ultimo capitolo della storia di Mg Rover, che
fino a poco fa era rimasta l'ultima società automobilistica indipendente in Gran
Bretagna. La battaglia tra Rover si sposta ora in Cina, uno scenario imprevedibile fino
a poco fa. Saic ha infatti diritti alla tecnologia e al design dei modelli 25 e 75 della
67
Rover e ha detto di volerli utilizzare per delle auto proprie ancora in fase di
progettazione. Il gruppo cinese, controllato dallo Stato, ha da poco creato una nuova
divisione, Saic Motor Manufacturing, proprio per produrre auto in proprio.
Anche la rivale Nanjing Auto ha già fatto sapere che produrrà alcune auto Rover in
Cina, utilizzando il marchio Mg che aveva acquistato lo scorso anno per 53 milioni di
sterline insieme alla fabbrica Mg Rover di Longbridge e ai diritti ai modelli Mg. I due
storici marchi inglesi si troveranno quindi in concorrenza diretta per la prima volta dal
1968. Allora Mg e Rover erano state fuse nell'unica società British Leyland, che poi
era fallita, era stata nazionalizzata e poi venduta "a pezzi".
Mg Rover era stata acquistata da Bmw che nel 2000 l'aveva poi venduta per una cifra
simbolica di dieci sterline ai cosiddetti "Phoenix Four", un gruppo di imprenditori
inglesi che miravano a rilanciarla e hanno invece presieduto al suo fallimento. Bmw
aveva però mantenuto la proprietà dello storico nome e marchio Rover.
Nanjing ha anche annunciato che stabilirà una nuova fabbrica negli Stati Uniti, in
Oklahoma. Il 60% delle auto prodotte negli Usa verranno vendute sul mercato
americano e il resto esportato in Europa. Sembrano esserci spiragli anche per il futuro
di Rover in Gran Bretagna: il gruppo cinese infatti si è impegnato a investire almeno
10 milioni di sterline nel rilanciare la fabbrica abbandonata di Longbridge, vicino a
Birmingham, e in febbraio ha acquistato il lease di 33 anni sulla struttura. Nanjing
aveva inizialmente promesso di salvare 2mila posti di lavoro, ma per ora meno di
cento persone hanno trovato impiego nella fabbrica che produrrà il modello sportivo
della Rover a un ritmo di 15mila auto all'anno. Seimila persone erano rimaste
disoccupate l'anno scorso in seguito al crollo di Rover e decine di migliaia avevano
perso il lavoro nell'indotto.
Altra acquisizione degna di nota è quella del 24 maggio del 2007 quando China
Mobile, il maggiore operatore mondiale di telefonia cellulare per numero di utenti11, ha
fatto il suo primo deal all'estero, acquisendo, per 284 milioni di dollari, l'88% di una
piccola compagnia wireless pakistana, Paktel Ltd, del valore di mercato di 460 milioni
di dollari. Da diversi anni China Mobile strava cercando di inserirsi nei mercati
internazionali emergenti. Ma nel 2005 ha perso la gara per l'acquisizione di un'altra
11
Attualmente China Mobile ha oltre 300 milioni di utenti registrati
68
compagnia pakistana e nel 2006 ha fallito nell'operazione di acquisto di Millicom.
69
I fondi sovrani
Il Governo di Pechino ha lanciato il 29 settembre del 2007 la China Investment
Corporation, il fondo sovrano creato per investire in modo più redditizio i 1.400
miliardi di dollari di riserve valutarie. Con un portafoglio iniziale di 200 miliardi di
dollari, il fondo statale servirà anche come testa di ponte per le acquisizioni di società
straniere ed è candidato a diventare uno dei maggiori al mondo.
Il nuovo colosso finanziario, la China Investment Corporation, diventerà presto il
numero due al mondo, dietro solo all'Adia, il fondo sovrano degli Emirati arabi uniti, e
davanti al Gic, il fondo di Singapore e al Government Pension Fund del Governo
norvegese nella speciale classifica dei magnifici otto del settore». La previsione è
contenuta in un rapporto di Chatham House, il think-tank britannico specializzato in
politica ed economia internazionale, in uno studio sui flussi di capitale e sui mercati
emergenti.
«I fondi sovrani diventeranno sempre di più dei veri protagonisti della scena
finanziaria trasformandosi da pigri gestori di fondi a basso rischio e basso ritorno
finanziario in più dinamici veicoli simili al fondi pensione e perfino agli hedge funds»,
scrive il rapporto di Chatham House.
La Cina non fa mistero delle sue strategie: il Cic servirà a diversificare una porzione
delle ricche riserve valutarie tramite investimenti più profittevoli (e ovviamente anche
un po' più rischiosi) dei Treasury Bond americani. In sostanza, la nuova holding
servirà a sostenere la massiccia campagna acquisizioni che Pechino si prepara a
scatenare in giro per il mondo. Per evitare critiche, le autorità cinesi hanno messo le
mani avanti: il fondo si muoverà con la massima trasparenza nel rispetto di
consuetudini e norme commerciali internazionali, ha promesso il management del Cic.
Vent'anni fa, il Governo di Margaret Thatcher si trovò alle prese con una spinosa
questione, con quello che oggi chiameremmo un "fondo sovrano". Il crollo delle Borse
mondiali, il "lunedì nero" del 19 ottobre 1987, aveva trasformato in un clamoroso
fallimento la privatizzazione dell'ultimo 31% del colosso petrolifero Bp ancora in
mano pubblica. L'operazione era la più grande offerta di azioni mai realizzata, a oltre
sette milioni di sterline, e il Governo aveva deciso di procedere nonostante il tracollo
70
dei mercati azionari. Non era passato nemmeno un mese che gli abili investitori del
Kuwait Investment Office – il fondo di proprietà del Governo del Kuwait, che avevano
un ufficio nella City di Londra e agivano nella massima segretezza – avevano
cominciato a rastrellare azioni Bp, fortemente sottovalutate dopo la crisi delle Borse.
Nel giro di qualche settimana, i kuwaitiani si ritrovarono con una quota superiore al
20%, una posizione decisamente inaccettabile per Londra, che ne intravedeva il
potenziale per ingerenze da parte di uno Stato estero con interessi petroliferi non
necessariamente allineati con quelli della Bp e della Gran Bretagna.
Ci volle più di un anno, l'intervento dell'Antitrust, un riacquisto di azioni proprie da
parte di Bp per oltre due miliardi di sterline, per chiudere un affare la cui importanza
politica, oltre che economica e finanziaria, fu di tale rilevanza da tenere impegnato a
fondo il Governo di Sua Maestà. Non è un caso che il cancelliere dello Scacchiere di
allora, Nigel Lawson, gli dedichi ben due capitoli delle sue memorie, quasi quanto ad
altri episodi più celebrati della politica economica dell'era Thatcher.
La vicenda Bp racchiude in sé molti degli elementi che animano la controversia
scoppiata negli ultimi mesi sui fondi sovrani.
Come testimonia il caso Bp, l'attività di questi fondi sui mercati internazionali non è un
fatto nuovo. Il primo ha superato da poco i cinquant’anni e fu creato nel 1956 nelle
Gilbert Islands, in Micronesia, con parte della valuta che arrivava grazie
all’esportazione dei fosfati. Oggi vale 520 milioni di dollari. Il grosso lo hanno messo
insieme i paesi petroliferi Abu Dhabi (che si dice abbia un patrimonio di 875 miliardi di
dollari), l’Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar, ma anche la Novegia, con il suo Norway’s
Pension Fund, che ha ora in cassa 367 miliardi di dollari in partecipazioni. Poi
Singapore, con i suoi due fondi, Tamasek e Gic, ha aperto la strada ai paesi che
accumulano riserve in valuta pregiata non grazie all’esportazione di materie prime ma di
manufatti e il suo esempio è stato seguito dalla Korea e dall’Australia, ma anche dal
Canada, che esporta sia petrolio che manufatti.
La creazione dell'Abu Dhabi Investment Authority da parte degli Emirati Arabi risale
al 1978, ancor prima del secondo boom petrolifero, quella della Kuwait Investment
Authority (che controllava il Kio, responsabile dell'operazione Bp) addirittura al 1960.
A cavallo degli anni 70 e 80, i capitali arabi creati dai petrodollari investirono in molte
aziende europee e al loro arrivo venne spesso dato il benvenuto da gruppi in cerca di
71
sostegno finanziario: basti pensare all'ingresso dei libici della Lafico nella Fiat, o degli
stessi kuwaitiani nella Daimler e in altre aziende tedesche.
La chiave è la bilancia dei pagamenti: i paesi che hanno un surplus strutturale, sia
questo dovuto alle materie prime che alla capacità di collocare nel mondo i propri
prodotti, accumulano montagne di valuta. Messa da parte la quantità necessaria a
garantire la stabilità del cambio e a proteggersi dalle crisi di liquidità (le due funzioni
tipiche delle riserve ufficiali), sempre più spesso decidono di destinare la valuta in
eccesso a fondi di proprietà dello stato che hanno la funzione di investire all’estero con
una strategia di lungo termine e l’obiettivo di avere un reddito più elevato rispetto a
quello che la gestione prudente e liquida delle riserve ufficiali può consentire.
Le ragioni per costituire un fondo sovrano non molteplici: la prima è evitare di inondare
il mercato con una liquidità in eccesso che creerebbe inflazione più che crescita; la
seconda è accantonare risorse finanziarie per i momenti difficili o per quando i pozzi di
petrolio saranno esauriti.
Fino alla primavera scorsa di questi fondi non s’è preoccupato nessuno. A farli
diventare ombre inquietanti sono stati due fatti. In primo luogo, rispetto al passato,
quello che è cambiato recentemente sono le dimensioni, ormai gigantesche, di questi
fondi: la stima più citata è quella di Stephen Jen, di Morgan Stanley, secondo cui i fondi
sovrani ammontano oggi a circa 2.500 miliardi di dollari, quasi la metà delle riserve
ufficiali di tutti i Paesi del mondo, e potrebbero balzare, da qui al 2015, addirittura a
12mila miliardi di dollari. Il più grande, l'Abu Dhabi Investment Authority, avrebbe,
secondo la Ing, un patrimonio di oltre 500 miliardi di dollari. I condizionali sono
d'obbligo perché le cifre ufficiali che riguardano questi organismi sono assai scarse. Con
qualche notevole eccezione, come la Norvegia, che pubblica nel sito internet del suo
Fondo pensione governativo, alimentato dagli introiti petroliferi, la lista di tutti gli oltre
3mila investimenti realizzati.
La Cina ha creato a sua volta un veicolo ad hoc, la China Investment Corporation,
dotandolo di 200 milioni di dollari, e ha messo 3 miliardi di dollari nella Blackstone12,
la società di private equity americana che si è recentemente quotata in Borsa. L'arrivo
12
3 miliardi $ è quanto la Central Huijin Investment, la superholding pubblica costituita solo qualche
mese prima dal Governo cinese, ha investito a fine maggio 2007 in Blackstone, uno dei più aggressivi
fondi di private equity americano. Alla Cina è andata la quota maggioritaria di partecipazione esterna,
anche se non votante.
72
sulla scena della Cina, per le dimensioni delle sue riserve e il suo peso geopolitico, è
quello che ha fatto scattare più di un campanello d'allarme. Al pari dell'aggressività
della Russia, non solo attraverso il suo Fondo di stabilizzazione, ma attraverso gruppi a
controllo pubblico come Gazprom.
L’allarme per l’azione di questi fondi ha subito un crescendo. Angela Merkel ha
proposto una legislazione che metterebbe Berlino in condizioni di bloccare gli
investimenti esteri in una società tedesca ‘strategica’ quando questi superino una certa
quota di capitale. Ma anche Alistair Darling, il cancelliere allo scacchiere della
liberista Inghilterra e persino George Bush hanno dato l’allarme. Il G7 ha chiesto al
Fondo Monetario di studiare delle linee guida che i fondi sovrani dovrebbero poi
seguire e il segretario al Tesoro di Washington, Henry Paulson, ha incontrato i
responsabili dei maggiori fondi sovrani per chiedere loro maggiore trasparenza.
I problemi sono complessi. L’unico fondo che rivela come investe il suo patrimonio e
con quali criteri è quello norvegese, che pubblica dati trimestrali e ogni anno rende nota
la lista delle sue partecipazioni. E’ un fondo ‘democratico’ ed è indicato come quello
che tutti dovrebbero imitare. L’Arabia Saudita comunica l’ammontare del suo
patrimonio, ma non come è investito. Tutti gli altri sono tesori segreti, dei quali si sa
pochissimo o nulla. La prima questione è quindi la trasparenza, senza la quale se apre
subito un’altra: gli obiettivi. La logica finanziaria comune vorrebbe che gli investimenti
fossero finalizzati ad ottenere il migliore rendimento possibile ad un accettabile livello
di rischio, ma se la trasparenza non c’è è possibile che le parole vadano in una direzione
e i fatti invece da un’altra. Si può ipotizzare per esempio che un fondo sovrano
acquisisca il controllo di una impresa per appropriarsi della sua tecnologia, oppure per
condizionare le sue scelte strategiche, il che in alcuni settori, come le infrastrutture, può
condizionare lo sviluppo di un paese. E’ questo che le grandi capitali dell’Occidente
temono e vogliono evitare.
Ma non è finita qui. Finché i paesi esportatori accumulano riserve valutarie e le
impiegano per comprare titoli del Tesoro americano, come da anni fanno Cina e
Giappone, per gli Stati Uniti non c’è problema. E’ quando questi paesi da creditori
dell’America, o di paesi europei, si trasformano in proprietari di beni presenti in quei
paesi, che il rapporto cambia. Tanto più che a comprare, in questo caso, non sarebbero
imprese private cinesi, giapponesi o russe (il che comunque ha creato più di una
73
tensione negli anni scorsi), ma lo stato cinese oppure lo stato russo. Il timore è che il
dilagare delle acquisizioni da parte di fondi sovrani possa scatenare un nuovo tipo di
protezionismo, questa volta non chiudendo i mercati delle merci ma i mercati finanziari.
Il rischio è che, se alla fine i fondi sovrani non verranno a patti con la comunità
internazionale in materia di trasparenza e reciprocità, possono ritrovarsi in un braccio di
ferro con i Paesi destinatari dei loro investimenti, come avvenne fra lo sceicco Ali
Khailifa e Nigel Lawson nel caso Bp. Allora la spuntò Lawson.
I governi si preoccupano, ma per le imprese e coloro che fanno i gestori di professione,
è una sorta di bengodi. Quanto ai gestori, Merrill Lynch calcola che dalla parte dei fondi
sovrani che sarà affidata alle loro cure potranno incassare commissioni per circa 8
miliardi di dollari l’anno. E quanto alle imprese è stato ben gradito alla Blackstone
quando la Cina ha deciso di comprare il 10% per cento del suo capitale, mentre nessuno
ha protestato quando Cina e Singapore hanno annunciato di voler fornire munizioni alla
Barclay’s per la scalata ad Abn Amro.
Ora è tutto da dimostrare che i mercati dei Paesi avanzati possano fare a meno dei
capitali degli emergenti. Non solo, ma gli investimenti all’estero delle imprese cinesi,
se, come più volte accennato, non fanno altro che legare politicamente Pechino, ai
mercati internazionali, dall’altro sembra che siano usati come strumento per lenire i
timori e gli umori anti-cinesi. Un caso interessate è proprio l’investimento in
Blaskstone.
Perché Central Huijin Investment, la superholding pubblica costituita un paio di mesi
fa dal Governo cinese, ha scelto di realizzare il suo primo investimento proprio su
Blackstone? Probabilmente perché il fondo di private equity Usa è riuscito a dare le
più ampie garanzie di ritorno e di profittabilità. Ma la cosa più importante è un'altra. È
il fatto (non casuale) che il primo investimento della superholding sia finito negli Usa,
cioè nel Paese che ha accumulato il maggiore disavanzo commerciale con Pechino e
dove l'aggressione del made in China è diventato un problema politico di prima
grandezza. È un segnale importante che arriva in concomitanza con l'aumento dei tassi
d'interesse e l'ampliamento della banda di oscillazione dello yuan nei confronti del
dollaro. Ed è un segnale di collaborazione per risolvere le questioni che maggiore
preoccupazione stanno destando a Washington.
74
Gli investimenti nei paesi in via di sviluppo
Infrastrutture contro materie prime
75
Petrolio e non solo
Per decenni, dal 1949, anno di fondazione della Repubblica Popolare, le
preoccupazioni energetiche di Pechino sono state un fattore di secondaria importanza
nel bilancio della sicurezza nazionale. Il giacimento petrolifero di Daquing, scoperto
nel 1959, ha prodotto abbastanza petrolio per garantire l’autosufficienza di
combustibile per l’intera nazione. Ma la situazione è cambiata in coincidenza con il
grande boom del Paese. Dall’inizio delle riforme economiche nel 1978, il tasso di
crescita annua della Cina si è aggirato sul 9% e anche oltre. Con il 1993 la Cina ha
assunto le vesti di importatore di petrolio a tutti gli effetti. E nel 2003, con una
domanda giornaliera di 5,5 milioni di barili, ha superato il Giappone, per divenire il
secondo maggior consumatore di oro nero al mondo, alle spalle solo degli Stati Uniti.
Nonostante le dimensioni sterminate del suo territorio, la Cina è infatti povera di
giacimenti petroliferi. Per questa ragione, il nuovo colosso dell'economia planetaria è
stato costretto orientarsi su un combustibile naturale di cui invece è piuttosto ricco, il
carbone. Ciò spiega perché il secondo consumatore di energia del mondo abbia un
portafoglio tanto sbilanciato: 65% carbone, 25% petrolio, gas 3%, nucleare 1,4% e
altre fonti 5,6 per cento.
Oggi l'energia è senza dubbio una delle priorità strategiche del Governo cinese. Per
due buone ragioni. In primo luogo, perché il peso del carbone nel portafoglio
energetico nazionale deve essere ridotto dal momento che quest'ultimo è troppo
inquinante, e anche perché la continua moria di minatori sta diventando un serio
problema sociale. A questo scopo Pechino ha varato un ambizioso piano di sviluppo
dell'energia nucleare che entro il 2020 contribuirà per il 2,8% alla copertura del
fabbisogno cinese contro lo 0,7% odierno; e ha varato un programma quinquennale da
2,5 miliardi di dollari per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili.
In secondo luogo, perché la Cina nuova superpotenza economica e politica globale,
non può permettersi di essere troppo dipendente dalle bizze dei Paesi produttori di
petrolio. E in particolare di un'area ad alta instabilità come il Medio Oriente, da dove
oggi arriva circa la metà del petrolio importato da Pechino.
76
Attualmente, si ipotizza che nel 2020 la Cina potrebbe produrre 3,65 milioni di barili al
giorno. Ma che per soddisfare i propri bisogni, ne sarebbero necessari più del doppio.
Se da un lato gli osservatori cinesi prevedono che le importazioni di petrolio
assicureranno il 60% della sete energetica del Paese, l’International Energy Agency
valuta una percentuale più elevata. E per quanto gli esperti discutano sulle cifre,
unanime è il consenso nel ritenere che la sete di petrolio non possa fare altro che
aumentare.
Per sostenere una crescita economica di oltre il 9% annuo, la Cina tenta di assicurarsi
giacimenti esteri di petrolio e di gas con contratti decennali che la mettano al riparo
dalla fluttuazioni dei prezzi dei prodotti energetici.
Vista la scarsità domestica di oro nero, per sostenere l'esplosione dell'economia
nazionale negli ultimi anni Pechino ha aumentato in misura esponenziale gli
approvvigionamenti di greggio dall'estero. Anche a questo riguardo i dati e le stime
dalla Iea rendono bene la portata del fenomeno. Nel 2006, la Cina ha incrementato di
oltre il 31% le proprie importazioni di petrolio. E in futuro lo shopping oltremare di
oro nero lieviterà sempre di più: se oggi l'import di petrolio copre circa poco più di un
terzo del fabbisogno di greggio cinese, entro il 2030 questa quota supererà l'80%,
sostiene l'agenzia parigina.
77
Nell'ultimo biennio la necessità della Cina di ampliare e di diversificare (anche
geograficamente) il proprio portafoglio energetico ha causato un doppio terremoto su
scala globale. A livello industriale, perché all'improvviso i vecchi signori del petrolio
si sono trovati a fare i conti con le "Tre Sorelle" cinesi (Sinopec, Cnpc e Cnooc) che
hanno iniziato a comprare a peso d'oro giacimenti in tutto il pianeta.
E a livello geopolitico perché Pechino è diventata una delle più attive interlocutrici
di molti Paesi africani e sudamericani ricchi di materie prime, ma da sempre dimenticati
dalle diplomazie occidentali. Il modello di penetrazione di Pechino nei paesi in via di
sviluppo è abbastanza semplice e funzionale. La Cina riesce ad ottenere le concessioni e
le forniture di cui ha bisogno attraverso la leva politica la protezione in sede di
Consiglio di Sicurezza, e soprattutto la leva economica: prestiti, aiuti economici,
agevolazioni importazioni di prodotti dei paesi in via di sviluppo in Cina, fornitura di
armi e soprattutto investimenti per le infrastrutture: la Cina sta sviluppando ovunque un
importante programma di costruzione delle infrastrutture. La Cina è favorita per
l’attuazione di tali programmi dalla proprietà statale delle principali imprese cinesi, sia
petrolifere che minerarie, dalle loro dimensioni e dalle enormi riserve valutarie di cui
dispone. Lo Stato anticipa, sotto forma di prestiti spesso a tasso zero, il costo delle
infrastrutture alle grandi società cinesi, che saldano i loro debiti con gli introiti delle
materie prime e dei prodotti agricoli (come la soia brasiliana ed argentina), il cui
sfruttamento è stato reso possibile proprio da tali infrastrutture. Tale metodo non è
praticabile dagli Stati occidentali, le cui multinazionali sono private, la concessione di
78
crediti pubblici è sempre più limitata e il sistema bancario si trova ostacolato da
sanzioni e embarghi o dal fatto che le società private non possono accettare rischi
politici, come possono invece fare le società dello Stato, braccio economico della
politica estera cinese.
Negli ultimi mesi le compagnie petrolifere statali hanno acquistato partecipazioni in
importanti giacimenti, offrendo altissimi prezzi. Ma la Cina vorrebbe svincolarsi dalle
tattiche politiche dei Paesi mediorientali, produttori di oro nero, che la riforniscono
attraverso canali che non controlla. Così, nell’agosto 2006, la China National
Petroleum Corp ha acquistato petrolio dal Kazakistan per 4,2 miliardi di dollari, che
arriverà tramite un oleodotto inaugurato di recente. Si è introdotta poi nel mercato
nigeriano, con una partecipazione di 2,3 miliardi e ha investito altri 576 milioni di
dollari per giacimenti siriani, acquistati insieme a una compagnia indiana.
79
Ma la fame di approvvigionamenti energetici è solo uno degli aspetti che la crescita
cinese sta comportando. Tale crescita ha infatti trasformato Pechino in una vera
fornace di un gran numero di materie prime.
Alle materie prime Pechino applica la stessa strategia per gli approvvigionamenti
energetici al fine di garantirsi le sue forniture e lungo termine. Anche in questo caso le
compagni di Stato svolgono un ruolo da protagonista, i mercati di azione abbracciano
in cinque continenti: acciaio in Brasile, ferro in Argentina, rame in Cile, nichel a Cuba,
uranio in Australia.
Nella tabella che segue, a cura del servizio studi della Deutsche Bank, sono indicati i
maggiori mercati di materie prime per Pechino
80
81
Cina-Africa
Nel primo semestre 2007, il flusso degli investimenti diretti di Pechino nel continente
nero hanno raggiunto quota 480 milioni di dollari, una cifra di gran lunga superiore
all'intero ammontare dell'anno precedente (370 milioni).
Nel frattempo, l'interscambio commerciale è cresciuto del 25% rispetto al primo
semestre 2006 portandosi a 32 miliardi di dollari. «Entro l'anno, gli scambi con l'Africa
supereranno sicuramente 65 miliardi di dollari», ha annunciato di recente il ministero
del Commercio cinese.
Il boom delle relazioni economiche tra due aree del mondo, che fino a mezzo secolo fa
si erano ignorate, è frutto di una congiuntura particolare. Oggi la Cina è una
superpotenza economica e politica che scoppia di liquidità.
Ma ha un tallone d'Achille, come si è detto: pur essendo un Paese sconfinato, non
dispone di energia e materie prime sufficienti a sostenere la sua crescita economica.
L'Africa è l'esatto contrario. È un continente povero, sottosviluppato, dilaniato da
conflitti tribali e, soprattutto, dimenticato dalle potenze occidentali. Ma è ricca di
combustibili e risorse naturali.
La Cina è stata abilissima a far quadrare
l'equazione. Nel giro di qualche anno, il
Dragone
è
diventato
l'acquirente
privilegiato delle risorse naturali africane.
Oggi, Pechino è la terza destinazione (dopo
Stati Uniti e Francia) del petrolio del
Gabon, assorbe il 25% dell'oro nero
angolano e circa la metà di quello sudanese.
Paga ciò che acquista in denaro sonante,
cosa di cui le povere nazioni africane hanno
estremo bisogno. Vende ai Governi locali
tecnologie, know how industriale e armi che
difficilmente troverebbero altrove a costo prossimo allo zero. Finanzia la costruzione
di grandi opere infrastrutturali. Invia missioni di pace e personale sanitario.
82
Non solo. Offre un sostegno politico incondizionato, anche in sede ONU. Non pone
questioni e non protesta per le sistematiche violazioni dei diritti umani nel nome del
principio della non ingerenza (la sostanziale indifferenza di Pechino per i massacri
operati dal regime sudanese nel Darfur è emblematica). Chiede agli africani una sola
cosa: di non intrattenere rapporti con Taiwan.
Pechino ha, inoltre, rafforzato i propri vincoli con i paesi africani attraverso la
cancellazione del debito.
Alcuni progetti finanziati da questi prestiti hanno avuto uno straordinario successo,
come l’esplorazione di giacimenti petroliferi in Sudan, il rinnovamento della rete
ferroviaria in Botswana, lo sviluppo dell’agricoltura in Guinea, la sfruttamento delle
foreste e l’industria del legname nella Guinea equatoriale, la Mulungushi Textile Mill
(una joint venture) in Zambia e una fabbrica di cemento in Zimbabwe.
Durante il suo viaggio in Africa nel febbraio del 2004, il presidente Hu Jintao ha
richiamato l’attenzione sulla necessità di una più stretta e ampia collaborazione fra
Africa e Cina nella ricerca di giacimenti di gas e petrolio. La visita di Hu in Algeria e
Gabon, due importanti produttori di petrolio, è stata considerata una tappa essenziale
del rinnovato impegno cinese per garantirsi il rifornimento di fondamentali materie
prime. In Gabon, Hu ha firmato un accordo per la creazione di imprese comuni di
estrazione, raffinazione ed esportazione del petrolio. Grazie al contratto firmato tra la
Total Gabon e la Sinopec il petrolio del Gabon comincerà ad arrivare in Cina.
83
La partecipazione della Cina nella sudanese
Greater
Nile
Petroleum
Operatine
Company (che nel 1996 è stato il primo
tassello delle operazioni petrolifere cinesi
in Africa), di cui possiede già il 40% delle
azioni, sarà ulteriormente rafforzata con
l’apertura di nuovi giacimenti petroliferi
nella
regione
Attualmente,
a
la
ovest
Cina
di
è
il
Karthoum.
maggiore
importatore di petrolio sudanese e i
funzionari cinesi ritengono che il Sudan
giungerà presto a soddisfare il 9% del loro
fabbisogno complessivo.
La concentrazione degli interessi delle compagnie cinesi nei paesi in via di sviluppo
per assicurarsi diritti estrattivi ed approvvigionamenti di materie prime e petrolio è
probabilmente una conseguenze indiretta delle barriere che nei paesi sviluppati sono
stati posti all’acquisizione di compagnie petrolifere occidentali, come nel caso della
Unocal.
Pechino, in altre parole, dopo il caso Unocal sembra aver cambiato strategia, lanciando
le proprie imprese di Stato alla conquista dei mercati energetici soprattutto nei paesi in
via di sviluppo, maggiormente allettati dalle conseguenze di un rapporto di affari con
un la Cina, sempre molto discreta sul piano politico quanto generosa su quello
economico.
E’ anche per questo che in Africa che Cina opera in cinquanta Paesi con circa 750
imprese, ha realizzato molte delle infrastrutture necessarie che la cooperazione
internazionale e gli organismi multilaterali avevano trascurato a vantaggio degli
investimenti in sanità e nei programmi sociali. II governo cinese prevede, inoltre, di
duplicare l'attuale miliardo di dollari di flussi di investimento annuale nel continente
africano entro il 2010.
84
85
Dettagli sugli investimenti cinesi in Africa
Negli ultimi cinque anni gli scambi commerciali tra Cina e Africa sono decuplicati. Se nel 1999 il volume degli
scambi era di 5,6 miliardi di dollari, per il 2006 il ministero del Commercio cinese prevede di superare i 50
miliardi di dollari. Sono ottocento le aziende cinesi presenti in 28 Paesi africani, dove hanno investito 6 miliardi di
dollari solo nel 2005 per progetti che vanno dalle costruzioni all'energia, dal petrochimico all'agricoltura. Ma la
presenza cinese è molto più articolata e diffusa in tutto il continente. Le relazioni economiche vanno spesso di pari
passo con i rapporti diplomatici e i valori crescono in maniera più rapida dei dati aggregati. Ecco una mappa, per
forza di cose parziale, della presenza cinese in Africa.
Paesi del Maghreb, edilizia e commercio
Marocco. Nel 2005 il volume del commercio fra Cina e Marocco ha raggiunto 1,484 miliardi di dollari; le
esportazioni cinesi verso questo Paese sono cresciute del 30% rispetto all'anno precedente e le importazioni del
121% (principalmente la Cina importa fosfato e metalli di cobalto). In Marocco i cinesi sono i primi costruttori di
infrastrutture, imbattibili per la rapidità e il basso costo della mano d'opera. Lo scorso anno si sono aggiudicati
importanti gare d'appalto per la costruzione di case popolari e di reti ferroviarie. La Cina preme, però, soprattutto
per la creazione di un'accordo di libero scambio con il Marocco, porta d'ingresso per il mercato dei Paesi arabi e
della stessa Europa.
Algeria. Oltre alle aziende del settore delle costruzioni, qui sono presenti anche i giganti cinesi del petrolio che si
sono assicurati la gestione dei pozzi più grandi del Paese. Sinopec ha già firmato un contratto da 525 milioni di
dollari per sviluppare il giacimento di Zarzatine, nel sud dell'Algeria, e China National Petroleum Corporation ha
ottenuto un contratto simile del valore di 350 milioni di dollari per importare il petrolio algerino. Dal canto suo, la
Cina è il quarto fornitore dell'Algeria con 954 milioni di dollari spesi nei primi otto mesi del 2006. Nel 2005
l'interscambio commerciale fra i due Paesi era stato di 1,77 miliardi di dollari.
Tunisia. La Tunisia è un Paese in cui la presenza cinese è ancora debole e gli scambi commerciali con il gigante
asiatico ancora marginali. Privo di grandi risorse naturali ma uno dei primi produttori tessili dell'Africa, la Tunisia
ha ancora poco da offire alla Cina. Nel 2005 l'interscambio è stato solo di 340 milioni di dollari, ma la Cina non
dispera di rilanciare una cooperazione più fruttuosa. All'inizio di quest'anno ha siglato un accordo per erogare
prestiti preferenziali alla Tunisia per un valore di 37,5 milioni di dollari, ed ha già iniziato la costruzione di una rete
di telefonia mobile.
Libia. Nel 2005 il volume del commercio totale con la Cina è stato di 1,3 miliardi di dollari, una larga parte del
quale rappresentato dalle importazioni di petrolio. Ma gli umori instabili del governo libico rendono più difficile la
penetrazione cinese. La Cina sta da lungo tempo corteggiando la Libia con investimenti in infrastrutture e nelle
telecomunicazioni (è la cinese Zet che sta fornendo il sistema di telefonia di terza generazione alla compagnia
telefonica Libyana) e visite bilaterali, l'ultima effettuata a gennaio dal Ministro degli Esteri Li Zhaoxing.
Mauritania. Recentemente la Cina ha accordato alla Mauritania un prestito senza rimborso di 4,5 milioni di dollari,
che come molti altri di questo genere erogati ai paesi africani, sono in parte spesi per la costruzione di infrastrutture
da parte di compagnie cinesi. Nel 2005 l'interscambio commerciale fra i due paesi e' stato di 78 milioni di dollari.
Africa dell’Est, armi e materie prime
Egitto. La Cina diventerà nei prossimi 5 anni il primo partner commerciale dell'Egitto, fonte di investimenti e di
trasferimento di tecnologie. Nel 2005 l'interscambio commerciale ha raggiunto i 2,145 miliardi di dollari, e per
quest'anno gli iinvestimenti previsti in Egitto dovranno assestarsi intorno ai 2 miliardi di dollari. Lo scorso
settembre le grandi compagnie cinesi sono riuscite a strappare contratti milionari per la costruzione di infrastrutture
(500 milioni di dollari per un centro congressi alla periferia de Il Cairo) e acciaierie (da 100 milioni di dollari)
finanziate dal governo egiziano che utilizzeranno esclusivamente tecnologia cinese. Durante il forum l'Egitto
chiederà alla Cina il sostegno per l'avvio di un programma nucleare ad uso civile, per il quale si aspetta anche di
firmare contratti di trasferimento tecnologico e aiuti economici.
Eritrea. Pur mantenendo buoni rapporti con tuttii paesi del Corno d'Africa, la Cina ha nel corso degli anni
alimentato il conflitto fra Etiopia ed Eritre attraverso la vendita di armi ed equipaggiamenti militari ad entrambe le
parti, accompagnata da frequenti consultazioni delle alte gerarchie dell'esercito. Oltre a ciò essa è presente nel
settore delle costruzioni, nella vendita di macchine industriali e di prodotti medici. Nel 2005 l'interscambio
commerciale e' stato del valore di 8,41 milioni di dollari.
Etiopia. Solo all'inizio di quest'anno il ministro del Commercio etiopiano aveva dichiarato che «la Cina è il partner
più affidabile», essendo l'Etiopia, assieme al Sudan, il principale beneficiario degli investimenti cinesi nella regione.
Prestiti a basso tasso di interesse, cancellazione del debito e tariffe preferenziali sono la strategia di Pechino per
lusingare un partner che non ha grosse potenzialità energetiche ma ha una posizione strategica di sbocco sul mare
per i ricchi vicini come Sudan ed Egitto. Le compagnie cinesi oggi si aggiudicano le costruzioni di quasi tutte lel
infrastrutture, collegamenti stradali e ferroviari, aeroporti e così via. Nel 2005 l'interscambio commerciale fra i due
paesi è stato di 370 milioni di dollari.
Sudan. È il secondo fornitore africano di petrolio per la Cina, secondo solo all'Angola, che per questo il gigante
asiatico difende su tuttii forum internazionali dalle accuse di violazione dei diritti umani e di genocidio nella
86
regione del Drafour. Recentemente la Cina si è opposta alla proposta dell'Onu di sanzioni contro il regime sudanese
e ha minacciato l'uso del veto contro l'invio di una forza internazionale nella regione. Dal canto suo il governo
cinese ha inviato 4 mila soldati dell'Esercito di liberazione nazionale per controllare le zone di suo interesse e
vegliare sugli oleodotti costruiti e sfruttati dalle compagnie cinesi, esprimendo oltretutto l'intenzione di voler
rafforzare la cooperazione militare con l'esercito locale. Oltre alla fornitura di armi, la Cina ha anche aiutato il
governo sudanese nella costruzione di 3 industrie belliche. Tutto ciò per difendere gli interessi asiatici nel settore
petrolifero: il Sudan fornisce da solo il 7% di tutte le importazioni cinesi di petrolio, il 50% della sua produzione
finisce in estremo oriente e beneficia i piu' consistenti investimenti nella regione. Tredici delle 15 compagnie
petrolifere straniere presenti in Sudan sono cinesi, la China National Petroleum Corporation (Cnc) possiede il 40%
della Greater Nile Petroleum Operating Company, che controlla i giacimenti petroliferi del paese, e ha investito 3
miliardi di dollari nella costruzione di raffinerie e eoleodotti. Nel 2005 l'interscambio commerciale fra i due paesi ha
raggiunto 3,9 miliardi di dollari.
Uganda. Nel 2005 il volume complessivo del commercio con la Cina è stato di 99,37 milioni di dollari, dovuto
soprattutto agli investimenti cinesi nei settori delle costruzioni e delle infrastrutture. China Petroleum Pipeline
Engineering Corporation costruirà un oleodotto di 320 km a collegare l'Uganda con il vicino Kenya produttore
dipetrolio. Al forum il governo ugandese intende chiedere l'aiuto cinese per la costruzione di una linea ferroviara
che collegherà il paese con il Sudan.
Kenya. Dopo il passaggio di Hu Jintao lo scorso aprile, la Cina ha concluso nuovi accordi la ricerca di giacimenti
petroliferi in Kenya, una regione in cui le compagnie occidentali non vogliono più investire. La compagnia
petrolifera Cnooc condurrà i lavori di esplorazione in mare e sulla terra ferma, oltre a fornire tecnologia e
formazione. Altra merce di importazione sono il cemento e i minerali. Lo scorso anno la Cina ha elargito prestiti per
36 milioni di dollari al governo kenyano per la modernizzazione dell'industria energetica, l'impiantazione d
iindustrie per beni di consumo e la costruzione di infrastrutture. I lavori sono poi stati condotti dalle grandi aziende
cinesi presenti anche qui, la cui ultima opera è stata la costruzione della strada che collega Mombasa a Nairobi. Nel
2005 l'interscambio commerciale è stato di 475 milioni di dollari.
Somalia. È un altro porto di sbocco per i prodotti petroliferi provenienti dall'entroterra, che la Cina intende
ammodernare con la costruzione di infrastrutture, strade, porti e ferrovie. Vista la crescita del settore delle
telecomunicazioni somalo, le imprese cinesi, come Huawei, investono nel paese per erigere le infrastrutture
necessarie e fare ingresso nella telefonia mobile. La Cnooc, il gigante petrolifero statale, ha siglato un accordo con
il traballante Governo di transizione della Somalia per condurre esplorazioni petrolifere nella regione settentrionale
di Mudug, che si trova nella relativamente stabile provincia del Puntland, a 500 chilometri dal caos di Mogadiscio.
Secondo quanto anticipato dal quotidiano britannico Financial Times nel mese di settembre, il contratto, che
assegna il 51% dei profitti petroliferi al Governo somalo di Ali Mohammed Gedi, sarebbe stato definito lo scorso 24
giugno a Nairobi, in un vertice tra il ministro dell'Energia somalo Abdullahi Yusuf Mohamad e il direttore esecutivo
di Cnooc Africa, Chen Zhuobiao. Alcuni analisti stimano tra i cinque e i dieci miliardi di barili all'anno la
produzione petrolifera potenziale della provincia del Puntland.
Africa dell’Ovest, petrolio, edilizia e tecnologie.
Senegal. Il governo cinese ha appena annullato un debito di 20 milioni di dollari al Senegal e accordato un prestito
di 7 milioni di dollari per la costruzione di scuole, strade e centrali elettriche. L'accordo include la clausola di
realizzazione dei lavori da parte di imprese costruttrici cinesi, nonostante gli asiatici non godano di buona
reputazione presso la popolazione locale. Da alcuni anni, infatti, è in corso una battaglia dei senegalesi contro
l'invasione di prodotti cinesi a basso costo che distruggono l'industria locale specializzata anch'essa nei beni di
consumo. Nel 2005 l'interscambio commerciale fra i due paesi è stato di 141 milioni di dollari.
Mali. La Cina è saldamente insediata nei settori delle costruzione e dell'industria leggera (zucchero, farmacia
tessile), dal 1994 possiede l'80% della più grande industria cotoniera del paese, la Comatex (il restante 20% è
detenuto dal governo malese). Ma anche qui l'invasione di prodotti cinesi e di manodopera a basso costo ha
destabilizzato l'equilibrio del paese. Nel 2005 il valore totale del commercio tra i due paesi è stato di 145 milioni di
dollari, principalmente dovuto alle importazioni cinesi di oro.
Congo. Nel 2006 il Congo ha esportato quasi un milione di metri cubi di legname, di cui il 66% di tronchi,
nonostante una legge imponga di trasformare in loco l'85% della produzione. La Cina è il primo cliente: importa il
60% dei tronchi congolesi, soprattutto okoumé, per farne impiallacciature. L'Italia ne importa 30mila metri cubi (4,7
per cento). La maggiore società è la Sino-Congo-Foret (Sicofor). Pechino ha inoltre accordato un prestito accordato
alla Repubblica democratica del Congo di cinque miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro), con la possibilità di altri
3,5 miliardi.
Niger. Come anche in Mali, qui la Cina finanzia un progetto di esplorazione di giacimenti petroliferi, nonostante la
rentabilità' non sia assicurata, e prevede di allargare la cooperazione economica. Nel 2005 il commercio
complessivo è stato solo di 34 milioni di dollari.
Ciad. Ha scelto di abbandonare il fronte taiwanese e riallacciare i rapporti diplomatici con la Cina appena ad agosto
di quest'anno, ma nonostante ciò l'interscambio commerciale nel 2005 ha ragiunto 206 milioni di dollari. I legami
del paese con Taiwan non hanno impedito alla China National Petroleum Corporation (Cnpc) di sviluppare progetti
per lo sfuttamento dei giacimenti petroliferi del Chad.
Guinea. I paesi del Golfo di Guinea, che producono 5 milioni di barili al giorno, sono la risorsa pretrolifera più
promettente della regione su cui la Cina ha già messo gli occhi. La compagnia cinese CNOOC ha firmato un
87
accordo, all'inizio del 2006, per l'estrazione di petrolio in una piattaforma al largo della costa della Guinea, su una
superficie di 2.300 km quadrati. Nel 2005 l'interscambio commerciale è stato di 147 milioni di dollari.
Liberia. La Cina è stata ripetutamente accusata di alimentare il traffico di armi in Liberia e negli stati vicini della
Costa d'Avorio e Sierra Leone, per ottenere in cambio le risorse naturali della regione, quali legno e diamanti. Ma
dal 2003 la Cina partecipa alla forza di pace dell'ONU stanziata in Liberia con 550 uomini, la sua più grande
missione all'estero. Nel 2005 l'interscambio commerciale fra i due paesi ha raggiunto 164 milioni di dollari.
Costa d’Avorio. Nel 2005 gli scambi totali con la Cina hanno raggiunto 222 milioni di dollari, costituiti
essenzialmente dall'esportazione verso l'Asia di materie prime (oro, alluminio, rame). Per l'esplorazione petrolifera
la Costa d'Avorio è già stata indicata da Pechino come zona di interesse per futura cooperazione.
Togo. Paese destinatario di prestiti agevolati da parte del governo cinese, che negli ultimi hanni ha finanziato e
costruito il palazzo presidenziale ed altri uffici governativi. All'inizio di quest'anno i due governi hanno firmato
accordi per la costruzione da parte della Cina di una centrale idroelettrica e di altri progetti nel settore delle
telecomunicazioni. In cambio la Cina riceve dal Togo materie prime importanti come cemento, fosfati e cotone. Nel
2005 l'interscambio commerciale ha raggiunto 570 milioni di dollari.
Benin. La Cina è diventata il primo partner commerciale e primo investitore del Benin, con un interscambio che nel
2005 ha raggiunto 1,09 miliardi di dollari. Imprese cinesi hanno rilevato parti delle più importanti industrie del
paese, da quella cotoniera a quella della pesca e dell'agroalimentare. Grandi aziende come Zet e Huawei forniscono
le tecnologie per l'installazione di una rete di telecomunicazioni GSM e telefonia di terza generazione. Nel 2004 il
Benin ha esportato verso la Cina cotone per un valore di 110 milioni di dollari.
Nigeria. È il terzo fornitore africano di prodotti petroliferi alla Cina. Lo scorso anno Petro China ha concluso un
accordo da 800 milioni di dollari con la Nigerian National Petroleum Corporation per l'acquisto di 30 mila barili di
petrolio al giorno per un anno. All'inizio di quest'anno è stata Cnooc a siglare un'intesa con il governo nigeriano per
una partecipazione del 45% in un giacimento offshore. La Cina ha anche realizzato il primo satellite nigeriano per le
telecomunicazioni che è stato lanciato all’inzizio del 2007, costruito dalla China Great Wall Industry e finanziato
dalla banca cinese Eximbank. Dal punto di vista politico, la Cina sostiene nei forum internazionali il conferimento
alla Nigeria di un seggio permanente all'Onu. Nel 2005 l'interscambio commerciale e' stato di 2,83 miliardi di
dollari. Nel gennaio del 2006 Pechino ha anche firmato un contratto, conquistato dalla China Civic Engineering
Construction Corporation, da 8 miliardi di dollari per la costruzione di una linea ferroviaria. Il tratto ferroviario che
verrà costruito collegherà le due maggiori città nigeriane: Lagos (metropoli costiera con 8 milioni di abitanti) e
Kano (3 milioni di abitanti vicino al confine con il Niger). La linea sarà lunga 1.315 chilometri e andrà a sostituire
quella esistente, ormai fuori uso. La Cina ha accordato alla Nigeria un prestito di 2,5 miliardi di dollari, la maggior
parte del quale sarà utilizzato proprio per finanziare il progetto ferroviario.
Camerun. Lo scorso anno la Cina ha elargito al Camerun un prestito di 2,5 milioni di yuan in cambio di accordi
con imprese locali per l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas naturale. Nel 2005 il volume degli scambi
commerciali fra i due paesi è stato di 197 milioni di dollari.
Quali conseguenze politiche?
L'Africa delle materie prime, l'Africa che ha un minimo di peso e di potere contrattuale
in economia, rischia di voltare definitivamente le spalle agli europei, ai loro egoismi,
alle loro promesse mai mantenute di apertura dei mercati, e di andare incontro
all'abbraccio soffocante della Cina. In Paesi come Angola, Nigeria, Sudafrica ed
Etiopia, Pechino non va solo a caccia di materie prime da dare in pasto alle voraci
fabbriche del Guangdong.
In queste aree i cinesi hanno l'astuzia di proporre un modello di sviluppo forse poco
nobile, sicuramente viziato da standard minimi e agevolato dalla corruzione, ma
maledettamente veloce. Gli uomini che arrivano dal Far East finanziano progetti che
saranno realizzati da imprese cinesi, costruiscono infrastrutture a costi da saldo,
88
offrono prodotti a prezzi accessibili, mettono in moto il commercio bilaterale. E
soprattutto mantengono le promesse.
L'ultima mossa di Pechino per ipnotizzare gli africani è stata quella di permettere, dal
primo gennaio del 2007, lo sbarco a dazio zero di circa 200 prodotti, dal tessile ai
prodotti agricoli, in provenienza da 25 Paesi africani. Il premier Wen Jiabao lo aveva
promesso un anno fa, e adesso ha mantenuto, senza ritardi o esitazioni. E così la
leggenda cinese si consolida a Lagos come a Luanda, in un'Africa che patisce ancora
l’erosione della concorrenzialità dei proprio prodotti sui mercati europei a causa della
Politica Agricola comune.
Presenza aggressiva, rapporto da Governo a Governo, prezzi inferiori almeno del 3040% rispetto alla concorrenza europea, finanziamenti per la realizzazione di
infrastrutture indispensabili. Sono le strategie attraverso cui la Cina, offrendo un
modello di sviluppo rapido e a basso costo, sta spiazzando l'Europa nella cooperazione
economica con i Paesi dell'Africa subsahariana ricchi di materie prime e di petrolio.
In altre parole, la Cina procede a tappe forzate in Africa, occupando gli spazi lasciati
vuoti dalla distrazione di una comunità internazionale che si è illusa di poter fare a
meno del continente per molti anni. La leadership di Pechino, in sordina, stringe da
ormai un decennio forti relazioni economiche e commerciali con i Paesi africani sotto
la spinta delle proprie necessità energetiche e di approvvigionamento di materie prime.
Risultato scontato a fine di ogni missione: stanziamenti per svariati milioni di dollari
che Pechino si impegna a investire nel continente africano, accordi commerciali,
dichiarazioni di partnership, di amicizia e di sostegno reciproco.
Il refrain è quello di una partnership fondata sull’ “uguaglianza”: uguaglianza tra Paesi
in via di sviluppo, accomunati da un passato di sofferenze e umiliazioni ad opera delle
potenze straniere. Ma alla base del crescente interscambio economico giacciono
logiche più prosaiche che non la fratellanza fra popoli oppressi, che spesso viene citata
dai responsabili politici cinesi. Pechino investe in Africa per poter colmare la propria
sete di petrolio e di materie prime. A tal fine ha adottato una strategia tanto semplice
quanto spregiudicata: investire, generosamente, senza interferire negli affari interni dei
propri clienti e, all'occorrenza, difendere questi ultimi davanti alle condanne della
Comunità internazionale.
Le aspirazioni politiche della Cina in Africa
89
Se la priorità è economica il fine potrebbe, dunque, essere politico. La sete di petrolio è
solo una delle motivazioni che spingono Pechino verso l’Africa. Altrettanto forte è la
necessità di mettere a punto un modello di cooperazione da esportare nei paesi
“naufraghi della globalizzazione”. Quando Fukuyama teorizzava la “fine della storia”
intendeva dire che il crollo dell’Unione Sovietica non lasciava nessuna alternativa al
modello liberal-democratico di gestione degli affari umani. Oggi in Africa la Cina sta
sperimentando un modello socio-economico da contrapporre a quello occidentale.
Pechino predica sviluppo facile e scarsa tutela dei diritti dell’uomo. E questa dottrina,
nata per essere esportata nei paesi “traditi” dall’Occidente e dalle politiche della Banca
Mondiale, rappresenta il livello più alto dell’impegno cinese nel continente africano.
L’interesse più profondo di Pechino è legare a sé gli Stati africani per allargare la
propria sfera di influenza geopolitica. Se nel medio periodo la Cina mira al profitto
economico e ad assicurarsi materie prime ad un prezzo competitivo, nel lungo periodo
persegue l’obbiettivo politico di ampliare il numero dei Paesi che le gravitano intorno.
Quando il Primo ministro Wen Jiabao dichiara che Pechino intende tutelare le nazioni
più deboli contro le ingiustizie dell’Occidente, di fatto propone ai Paesi emergenti un
nuovo modello di sviluppo. Per i paesi che hanno patito le regole del Fondo monetario
e della Banca mondiale, che mal sopportano le condizionalità espresse per la
concessione di prestiti e di aiuti, Pechino rappresenta il sogno dello sviluppo facile, del
consumismo a buon mercato, il riscatto dalla povertà, senza i limiti della cooperazione
occidentale e senza la supponenza degli ex Paesi coloniali, e soprattutto rappresenta il
più grande paese in via di sviluppo che si prodiga per aiutare tutti i paesi in via di
sviluppo.
La Cina, dunque, in Africa sta testando un suo soft power, le cui caratteristiche si
riducono essenzialmente ad uno sviluppo economico forzoso e ad un modello di
gestione politica autocratico ed elitario.
L’applicazione di un modello esterno in Africa, rischia però di avere degli effetti
collaterali generati dall’innesto su un terreno che non è quello di origine. I leader che
importano lo schema, potrebbero non avere la necessità di “comprare” la fedeltà
politica al partito al potere attraverso il benessere economico diffuso.
Inoltre, i rapporti tra i due partners avvengono tra “regimi”, la qual cosa potrebbe
indurre all’arricchimento esclusivo delle elites al potere, rafforzandole ulteriormente e
90
radicando ancora più in profondità nelle società africane le logiche più perverse e
distorte tipiche dei rentier state.
91
Cina-America Latina
“Pur continuando a coltivare interessi nell'America Latina
i cinesi non vogliono essere visti dagli Stati Uniti
come una minaccia in
quell'area, ciò potrebbe
essere controproduttivo",
Robert Zoellick
Fino ad un decennio fa, l’“impero di mezzo” era assente dall’America Latina, eccetto
in Cile ed in Messico. Le relazioni fra la Cina e il Cile divennero molto strette già
all’inizio degli anni ’80. La Cina fu uno dei primi paesi a riconoscere il Cile di
Pinochet. Non solo per il suo rame, ma anche per il modello di sviluppo in cui il
liberalismo economico conviveva con l’autoritarismo politico. Tale modello fu
giudicato molto interessante da Deng Xiaoping e ne influenzò le riforme. Oggi la Cina
è presente ovunque in America Latina, soprattutto in Cile e Perù, ma anche in Brasile e
Venezuela.
L’interesse di Pechino verso il continente sudamericano è un fenomeno che si è andato
sviluppando nel corso degli ultimi anni. Ha avuto inizio con il tour di 13 giorni in
diversi paesi della regione compiuto nell’aprile del 2001 dal presidente Jiang Zemin
seguito poi dalla visita di Hu Jintao nel novembre dello scorso anno in Argentina,
Brasile e Cile, dalla visita, nel febbraio del 2005, del vice presidente Zeng Qinghong in
Messico, Venezuela e Perù, e sempre nel 2005 con il passaggio di Hu Jintao ancora in
Messico. In mezzo vi sono stati altri scambi reciproci, come la missione commerciale
brasiliana a Pechino, capeggiata dal presidente Lula da Silva, e l’analoga visita del
presidente venezuelano Hugo Chavez di dicembre.
La cooperazione politica ed economica tra la Cina e il continente sudamericano ha
continuato a svilupparsi tramite i rapporti con le organizzazioni regionali come il
forum Cina-America Latina, il dialogo per un mercato comune Cina-Sud America, la
consulta Cina-Comunità andine e ultimo - ma non meno importante - l’ammissione
della nazione asiatica nella Organizzazione degli Stati Americani (Oas), il 26 maggio
2004, in qualità di osservatore.
92
Da circa una decade, la grande potenza asiatica non dissimula il suo crescente interesse
verso la regione, come indicano le cifre degli scambi commerciali. Tra il 2000 e il
2004, le relazioni commerciali sono aumentate del 250 per cento, a un punto tale che la
Cina è oggi il secondo socio commerciale del Brasile ed il maggiore consumatore del
rame cileno. Le vendite di petrolio venezuelano alla Cina sono raddoppiate tra il 2004
e il 2005, arrivando ai 3 mila milioni di dollari. L'inesauribile capacità di consumo di
risorse della Cina ha l'effetto di mantenere elevati i prezzi delle materie prime
essenziali per molti paesi dell'area, convertendosi in un polmone insostituibile per le
economie della regione. La Cina assorbe il 50 per cento del cemento che produce
l'America latina, il 47 per cento della soia, il 40 per cento del rame ed il 25 per cento
del nichel. La Cina è, inoltre, il quinto investitore straniero in America latina, subito
dopo gli Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Francia. La Cina, infine, ha
sottoscritto diversi protocolli di investimento con vari paesi della regione, per un
importo che supera i 50 mila milioni di dollari.
Nel periodo precedente le importazioni cinesi dai paesi dell’America Latina sono
cresciute dai quasi tre miliardi di dollari del 1999 ai 21,7 miliardi del 2004, un
incremento di quasi il 600% in cinque anni. Lo stesso discorso vale per le esportazioni
del gigante asiatico verso il Sud America passate dai 5,3 miliardi del 1999 ai 18,3
miliardi del 2004. Nel periodo che va dal 1999 al 2005 il valore delle importazioni
cinesi dall’America Latina è aumentato in misura siderale (+783%) e la Cina è
diventata il secondo più importante partner commerciale del Brasile e del Perù, il terzo
per il Cile e il quarto per l’Argentina. Ma le distanze nei confronti dell’interscambio
dell’area con gli Stati Uniti restano molto forti.
L’America Latina rappresenta il terreno ideale per sostenere la pressante necessità di
Pechino di risorse minerarie ed energetiche. La penetrazione cinese può contare su due
fattori. In primo luogo le condizioni economiche della regione. Venti anni di
applicazione di politiche economiche neoliberiste secondo i suggerimenti di istituzioni
internazionali come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale invece di
favorire la crescita e la distribuzione della ricchezza tra le nazioni sudamericane ne
hanno causato il graduale impoverimento, indebitamento e frustrazione verso le
prospettive future.
93
Oggi i paesi dell’America Latina hanno un estremo bisogno di finanziamenti per
infrastrutture e liquidità. Basti pensare che nel 2005 gli investimenti diretti stranieri
sono crollati a 36,7 miliardi di dollari rispetto agli 88 del 1998. Il secondo fattore è
rappresentato dalla notevole sfiducia di questi paesi verso l’intervento statunitense.
Sebbene le fallimentari politiche neoliberiste siano da attribuire alle decisioni di
organizzazioni internazionali, la popolazione e la maggior parte delle classi dirigenti
delle nazioni sudamericane le percepiscono come il frutto di indirizzi statunitensi.
Inoltre la prolungata attenzione dell’amministrazione Bush verso la guerra al
terrorismo, al Medio Oriente e al miglioramento dei rapporti con gli alleati europei
fanno apparire la Casa Bianca sempre più distante dal continente latinoamericano.
Negli ultimi anni gli stessi investimenti di Washington verso le nazioni sudamericane
hanno subito una forte flessione. La stessa iniziativa statunitense volta a stipulare
accordi di libero scambio con le nazioni del sud è stato considerato da queste come un
mero tentativo di tutelare gli interessi economici propri e degli agricoltori del Middle
West. I problemi economici uniti alla sfiducia verso gli Stati Uniti hanno spinto molte
nazioni sudamericane a cercare nuovi punti di riferimento internazionali. In un
contesto simile la crescente attenzione cinese è giunta a proposito. Il crescente
coinvolgimento cinese in America Latina costituisce una logica conseguenza del
graduale disinteresse degli Usa verso la regione.
Le nazioni sudamericane guardano alla Cina non solo come a un potenziale partner
commerciale, in grado di assorbire grandi quantità di materie prime in cambio di
liquidità, ma anche ad un potenziale benefattore disposto, come sostenne Hu Jintao lo
scorso novembre, a investire nel continente oltre 100 miliardi di dollari in dieci anni.
Se gli Stati Uniti sono disposti a dare finanziamenti finalizzati solo alla lotta alla droga
e al narcotraffico, la Cina con le sue proposte di investimenti diretti in infrastrutture
viene considerata come un punto di riferimento ben più rilevante di Washington.
Dopo l’offerta di Hu Jintao, dunque, a fronte di una prolungata e macroscopica assenza
degli Stati Uniti, coloro che in Sud America sono interessati a migliorare ferrovie,
autostrade, porti e passi montani guardano alla Cina come a un sostegno a lungo
termine. Al riguardo si può fare l’esempio del passo del Cristo redentore tra Argentina
e Cile. Questo importante valico tra le due nazioni viene attraversato ogni giorno da
migliaia di camion che trasportano in Cile merci provenienti da Argentina, Brasile e
94
Paraguay, tuttavia ogni inverno diviene impraticabile per la neve, con gravi
ripercussioni economiche per tutti i paesi interessati. Per risolvere il problema la Cina,
durante i negoziati commerciali intrapresi con il Cile, si è detta disposta a costruire un
tunnel coperto che possa evitare la chiusura del passaggio per neve accollandosi una
spesa che nessun paese del luogo, nemmeno l’Argentina, potrebbe sostenere.
Questa e altre iniziative analoghe hanno aumentato la considerazione delle nazioni
latinoamericane verso Pechino. Con l’acquisto di materie prime e la volontà di
investimenti in infrastrutture la Cina appare come un possibile motore dello sviluppo
economico della regione e inoltre l’America Latina guarda al gigante asiatico come
alla propria immagine speculare: il subcontinente cinese viene visto come un esempio
lampante di cosa possano realizzare nazioni economicamente arretrate, ma ricche di
materie prime.
Malgrado il carattere fortemente ricettivo dei paesi latinoamericani alle proposte di
investimento cinesi, Pechino, al di là di dichiarazioni programmatiche dalla valenza
squisitamente politica come quella di Hu Jintao dello scorso novembre, nella realtà
appare molto più cauta nello spendere i miliardi di finanziamenti promessi in una
regione che è così culturalmente distante dalla Cina. Attualmente una buona parte
degli investimenti diretti dell’ex impero di mezzo si dirige verso i paesi dell’Asia
orientale, in particolare l’Indonesia dove vi è maggiore familiarità di pratiche e culture.
Gli imprenditori del paese asiatico conoscono poco il Sud America e quando hanno
iniziato a pensare di investire in quella regione hanno incontrato molte difficoltà.
Se il fattore culturale è certamente un elemento importante, ve ne sono altri,
ugualmente rilevanti, che continuano a spingere la Cina verso l’America Latina.
Accanto alla necessità di diversificare l’accesso del proprio sistema economico alle
risorse minerarie ed energetiche mondiali, in una sempre più marcata competizione
con l’India, a determinare il crescente interesse di Pechino verso l’America
meridionale è anche la continua rivalità con Taiwan e l’intenzione cinese di riunificare
alla madrepatria quella che le autorità continentali considerano una vera e propria
provincia ribelle. Per ottenere il suo scopo Pechino deve isolare politicamente
Formosa, in modo da soffocare la sua capacità di azione a livello globale e indebolire
così il suo status internazionale.
95
In questo momento nel mondo solo 25 paesi intrattengono formali relazioni
diplomatiche con Taiwan e di questi ben 12 si trovano in America Latina. La Cina
intende convincere questi ultimi a ritirare il loro riconoscimento diplomatico a Taiwan
per favorire invece quello della Repubblica Popolare. Per raggiungere questo obiettivo
le autorità di Pechino non hanno esitato a utilizzare molteplici leve di
condizionamento, dal campo economico a quello politico. Basti fare l’esempio del
Brasile. Dei 12 paesi latinoamericani che hanno regolari relazioni con Formosa, quello
più grande è il Paraguay ed è proprio su quest’ultimo che si è concentrata l’iniziativa
diplomatica cinese.
Durante il tour del 2004 nella regione, Hu Jintao non ha esitato a far balenare alle
autorità brasiliane la possibilità di un possibile sostegno cinese alla candidatura del
Brasile a membro permanente del riformato Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
in cambio di pressioni diplomatiche di Brasilia verso Asunciòn affinché rompesse le
relazioni diplomatiche con Taiwan e riconoscesse diplomaticamente la Repubblica
Popolare. Più di recente alla leva politica Pechino ha affiancato quella economica
concludendo con il Brasile sostanziosi accordi petroliferi e investendo nel settore
brasiliano delle infrastrutture ad alta densità tecnologica come quelle delle
telecomunicazioni.
Ma vi è anche una ulteriore ragione. La è estremamente cauta nell’adottare politiche che
potrebbero portarla in rotta di collisione con gli USA. Il suo interesse maggiore sta nella
globalizzazione e nel libero mercato. Significativamente, limita, ad esempio, il sostegno
ai fautori della c.d. “rivoluzione bolivariana” in America Latina – quali il Presidente
venezuelano Chàvez e quello boliviano Morales – mentre, in quel continente, sviluppa
la collaborazione economica con i governi sostanzialmente favorevoli agli Stati Uniti,
come il Brasile, il Perù e soprattutto il Cile.
La presenza cinese nell’America Latina avrebbe finalità prevalentemente, se non
esclusivamente, economiche: la garanzia dei rifornimenti energetici e di materie prime
minerarie e agricole, nonché l’apertura dei mercati ai prodotti cinesi. Non avrebbe
invece fini politici, come quello di “esportare la rivoluzione”, obiettivo di Mao Zedong
fino al 1970. Se la Cina perseguisse tale obiettivo, la collaborazione con i paesi sudamericani diventerebbe difficile, se non impossibile.
96
in America Latina la Cina è molto più cauta. Non ha organizzato dei forum simili a
quello che ha riunito a Pechino, nel 2006, 48 capi di Stato e di governo africani, non
agisce con la sua Banca d’investimento e di sviluppo e, nonostante le “infiammate”
dichiarazioni del Presidente venezuelano Chàvez di voler vendere il suo petrolio alla
Cina anziché agli Stati Uniti, ha rallentato notevolmente il progetto della costruzione di
oleodotti fra il Venezuela e la costa del Pacifico – da dove il petrolio verrebbe poi
instradato verso la Cina. Il comportamento cinese è più geopolitico che geoeconomico e
tiene conto della convenienza di non creare tensioni con gli USA, che tra l’altro sono il
maggior importatore di prodotti cinesi.
Questo potrebbe implicare che Pechino non ha aspirazioni anti-sistema, ma che stia solo
predisponendo i mezzi che ritiene più opportuni per evitare che patisca un nuovo secolo
di umiliazone. Talune preoccupazioni derivano dal fatto che Pechino segue, nel settore
della sicurezza energetica e dei rifornimenti di materie prime, un “approccio strategico”,
non uno “di mercato”13. Pechino intende infatti assicurarsi le materie prime necessaria
alla propria crescita “direttamente alla fonte”, acquistando diritti di estrazione ed assets
e accordi di fornitura pluriennale, piuttosto che acquistarli sui mercati internazionali.
Pechino è ancora persuasa che sia pericoloso dipendere da mercati mondiali che non
controlla, ma che sono regolati dai centri finanziari di Londra e di New York.
Continuerà quindi a seguire almeno parzialmente l’attuale “approccio strategico” – cioè
“autarchico” o “neo-colbertista” – soprattutto in campo energetico, fino a quando non si
convincerà che esso è troppo costoso rispetto a quello “di mercato”, derivante
dall’“interdipendenza liberale” propria del mondo globalizzato, a meno che le tendenze
protezioniste, mercantiliste e di intervento diretto dello Stato nell’economia non si
diffondano in tutto il mondo.
13
Philip Andrews-Sped, Xuanli Liao and Roland Daunreuthe, The Strategic Implications of China
Energy’s Needs, International Institute for Strategic Studies, Adelphi Papers n. 346, London 2002; vds.
anche Steven Lewis, Beijing Oil Diplomacy, Survival, Spring 2002, pp. 15-34.
97
Progetti infrastrutturali cinesi in America Latina
98
È però errato pensare che tale politica persegua obiettivi ostili agli Stati Uniti, oppure
che sia dovuta a timori cinesi sulla possibilità di un embargo del tipo di quello deciso
dagli USA contro il Giappone negli anni trenta, dopo la sua invasione della Manciuria.
Il vero “pericolo giallo” in America Latina, così come già sostenuto per l’Africa, resta
il blocco della democratizzazione, attraverso l’avallo e l’incremento di corruzione,
clientelismo e resistenza alla modernizzazione.
Ma dal più vasto punti di vista strategico né gli Stati Uniti né l’Europa hanno perso
l’America Latina. Dal punto di vista strategico-militare, l’aumento della presenza
economica cinese in America Latina è irrilevante. Per generazioni ancora, la Cina non
può sperare di sfidare la potenza della U.S. Navy, che conferisce a Washington un
dominio globale.
99
Cina e Medio Oriente.
I paesi del Golfo fino al 1994 esportavano in Cina una quantità di petrolio
corrispondente a meno del 40% dell’importazione totale cinese, a partire dal 1996 la
proporzione è più che raddoppiata. Al giorno d’oggi, l’Iran e l’Arabia Saudita
riforniscono di petrolio la Cina per quasi i due terzi delle sue importazioni totali.
Ma i crescenti legami economici con i ricchi emirati del Golfo Persico non hanno
preso una direzione unilaterale. Nel luglio del 2004, i ministri delle Finanze dei sei
Paesi del GCC Consiglio di Cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar,
Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman) hanno fatto visita alla Cina per siglare un accordo
di massima per la cooperazione e gli scambi commerciali di informazioni tecniche
industriali, al punto che molti hanno previsto la futura creazione di una vastissima area
di libero scambio tra le due realtà.
La strategia di Pechino non si è limitata all’importazione di petrolio e all’incremento
della propria capacità di raffinazione, ma ha incluso anche una crescente cooperazione
bilaterale nella produzione del Medio Oriente.
Nel 2004, la Sinopec e la saudita Aramco hanno firmato un accordo per l’esplorazione
e lo sviluppo del gas naturale ad Ar-Rub‘ al-Khali, il cosiddetto “Empty Quarter”. La
Sinopec è titolare dell’80% del pacchetto azionario.
Pechino vede il Medio Oriente non solo come fonte di energia petrolifera, ma anche
come un potenziale e immenso mercato di servizi indotti. Nel 1979, alcune compagnie
cinesi specializzate entrarono nel mercato del Gulf Cooperation Council. Ma bisogna
attendere il 2001 per vedere la Cina che sigla circa tremila contratti di settore nei sei
Paesi del GCC, per un valore totale di 2,7 miliardi di dollari. L’inizio di questa
operazione a tappeto si ebbe nel 1983, quando la Sinopec cominciò una serie di
trattative con il Kuwait. Da allora, la Cina ha investito sempre più nei servizi
petroliferi dei Paesi arabi, con particolare riguardo vero l’Egitto, il Qatar e l’Oman.
Al momento la Cina e il mondo arabo sono uniti soprattutto dal petrolio: il 44% del
greggio importato da Pechino arriva infatti dai Paesi arabi. Da gennaio a novembre
2005 Pechino ha importato ben 50,52 milioni di tonnellate di petrolio dai Paesi arabi e
gli scambi commerciali tra questi ultimi e la Cina hanno raggiunto un volume pari a
46,38 miliardi di dollari, circa il 39% in più rispetto al 2004. Negli ultimi tempi,
100
inoltre, i Paesi arabi sono divenuti l’ottavo partner commerciale di Pechino e il settimo
mercato di importazioni ed esportazioni per la Cina.
Arabia Saudita e Paesi del Golfo
Nel 2005, l’import cinese dal Medio Oriente è aumentato del 44%. Al tempo stesso, la
Cina ha aumentato di oltre il 34% le esportazioni verso la stessa regione. E se all’inizio
degli anni Novanta, la Cina era il decimo partner commerciale dell’Arabia Saudita,
adesso si sta affermando come terzo interlocutore di Riad. Un dato confermato dalla
visita ufficiale a Pechino che il sovrano saudita, re Abdallah, ha effettuato all’inizio del
2006. La prima in assoluto nella storia per un re saudita, in particolare da quando i due
Paesi hanno ristabilito reciproche relazioni commerciali nel 1990. Un evento dagli alti
contenuti strategici, nel campo energetico e per gli scambi commerciali.
L’accordo tra il secondo consumatore di combustibili al mondo e il leader di
produzione del settore ha aperto una frenetica fase di “shopping” da parte delle “tre
sorelle” cinesi (Petrochina, CNPC e CNOOC) nella Penisola arabica. Ma l’ingresso in
modo così irruento in Arabia potrà permettere alla Cina di partecipare anche ad alcune
costose operazioni di sviluppo e alla costruzione di impianti di raffinazione.
Non è un caso allora che, nell’aprile 2006, nell’ambito delle forniture energetiche, il
presidente Hu Jintao abbia siglato un accordo sempre con l’Arabia Saudita per la
creazione di una riserva strategica di petrolio alimentata nella sua maggior parte dal
governo di Riad. Un’operazione che vede come prima protagonista una delle più
grandi società petrolchimiche del mondo, la SABIC, che sta pianificando un impianto
del valore di 5,3 miliardi di dollari, oltre che l’apertura di nuove succursali. La
multinazionale saudita ha spedito in Cina, solo nell’arco del 2005, fertilizzanti, tessuti
sintetici e materie plastiche per circa 2 miliardi di dollari. A sua volta la cinese
Sinochem Corporation si occuperà dello sviluppo di un giacimento offshore di gas
negli Emirati.
All’inizio del 2005, i sauditi fornivano il 14% delle importazioni petrolifere cinesi: 450
mila barili al giorno. Nei primi undici mesi del 2005, la Cina ha importato oltre 20
milioni di tonnellate di greggio dai sauditi. In questo stesso periodo, secondo le cifre
fornite dal ministero degli Esteri cinese, il commercio bilaterale è cresciuto del 59%
per un totale di 14 miliardi di dollari.
101
La recente crescita nelle importazioni cinesi di petrolio proveniente dall’Arabia
Saudita ha meno a che fare con la politica che con le questioni legate alla tecnologia e
alla ricerca nel settore. Il petrolio saudita tendeva ad avere un contenuto di solfuri
troppo alto rispetto alle capacità di raffinazione della Cina. Il governo cinese ha
trasformato questo impedimento in un vantaggio, facendo in modo di coinvolgere i
sauditi non solo politicamente ma anche economicamente. Pechino e Riad stanno
lavorando per avviare efficienti raffinerie petrolifere. I due Paesi stanno lavorando
congiuntamente per creare due raffinerie petrolchimiche: Il governo cinese ha già
approvato un progetto chimico e petrolifero sino-saudita nella provincia orientale
cinese del Fujian, dopo che già aveva incluso l’accordo riguardo la raffineria di
Qingdao nella provincia orientale cinese del Shandong nel suo decimo piano
quinquennale terminato con il 2005. Il 27 febbraio 2007 la China Petroleum and
Chemical Corporation (Sinopec) ha siglato un contratto per la creazione di una joint
venture con la saudita Aramco e la statunitense ExxonMobil per raffinare e processare
il greggio nella provincia del Fujian, nella parte sudorientale della Cina. Nella joint
venture la Sinopec, la Aramco e la ExxonMobil avranno rispettivamente il 50, il 25 e il
25% delle quote. Il progetto sarà operativo a partire dal 2009, quando la produzione di
petrolio dovrebbe attestarsi intorno ai 240.000 barili al giorno, ovvero 12 milioni di
tonnellate di oro nero all’anno. Il greggio, proveniente dall’Arabia Saudita, verrà
processato dalla raffineria di Quanzhou. I tre colossi del settore petrolifero creeranno
anche un’azienda per la distribuzione di cui la Sinopec controllerà il 55% delle quote,
mentre la Aramco e la ExxonMobil ne possiederanno ognuna il 22,5%. Mentre il 7
marzo 2004 la SINOPEC in partnership con la saudita Aramco, ha firmato un contratto
per l’esplorazione di gas nell’area del Rub al-Khali in Arabia Saudita.
Le importazioni cinesi di petrolio dall'Arabia Saudita sono cresciute dai 12,5 milioni di
tonnellate nel 2002 ai 22 milioni di tonnellate nel 2005.
Di particolare rilievo risulta essere la visita a Pechino del re saudita Abdullah, il 24
gennaio 2006, durante la quale i due Paesi hanno firmato un nuovo accordo sulla
cooperazione energetica. Visita ricambiata ad aprile 2006 dal presidente Hu a Riad (da
dove il presidente cinese si è poi recato anche in Marocco). Durante la visita Hu ha
incontrato - tra gli altri - re Abdullah bin Abdul-Aziz e con la leadership saudita ha
concluso una serie di importanti accordi per rafforzare la cooperazione in diversi
102
settori, tra i quali la difesa, la sicurezza e il commercio (il volume dell’interscambio
commerciale ha fatto registrare una crescita annuale del 41% dal 2001 al 2005 e solo
nei primi due mesi del 2006, il volume del commercio bilaterale ha raggiunto i 2,7
miliardi di dollari). Al centro della sua visita, tuttavia, vi è stato stato comunque il
petrolio.
A febbraio 2007 una delegazione cinese ha partecipato al Forum economico di Gedda
e ha colto l’occasione per lanciare un invito alle banche saudite ad aprire proprie filiali
in Cina, annunciando che allo stesso tempo le banche cinesi sono intenzionate ad
aprire succursali nella penisola arabica. Diverse banche e aziende cinesi hanno già
aperto succursali a Dubai.
Nel maggio 2006, il ministro degli Esteri cinese Li Zhaoxing ha visitato Kuwait, Qatar,
Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Durante la sua permanenza in Qatar, il ministro degli
Esteri ha partecipato al quinto incontro dei ministri degli Esteri dell’Asia Cooperation
Dialogue.
Nel giugno seguente per la prima volta una delegazione delle forze armate del Qatar si
è recata in Cina, dove è emerso un impegno per rafforzare la cooperazione militare trai
due Paesi, mentre la Cina si è detta particolarmente soddisfatta del sostegno del Qatar
alla politica estera di Pechino.
Infine, nello scorso dicembre, la Cina ha chiesto all'Opec di aprire negoziati diretti al
fine di assicurarsi una stabile offerta di petrolio. Lo ha annunciato Zhaui Jun, alto
funzionario del ministero degli esteri cinese nel corso dell’Arab Strategy Forum.
Allo stesso tempo Pechino non perde occasione per rimarcare alcune delle sue linee
guida nella politica internazionale: nel 2006 ad esempio ha protestato con gli Emirati
Arabi Uniti perché hanno semplicemente concesso all’aereo del presidente taiwanese
di fare scalo ad Abu Dhabi per rifornimento, dopo che la Cina era riuscita a far
revocare analogo permesso concesso dal Libano.
Iraq
Pechino conserva un atteggiamento meno interventista verso l’attuale complessa
situazione irachena, probabilmente perché la condizione di insicurezza non consente
ancora di operare con profitto nel paese, mentre c’è il rischio di scontrarsi con gli attori
principali sulla scena, quali Stati Uniti ed Iran, con entrambi i quali la Cina intrattiene
103
delicati rapporti. Ma questo non vuol dire che Pechino sia assente o distratta sullo
scenario iracheno. Nel gennaio 2006 l’allora sottosegretario agli Esteri iracheno ha
ricevuto Li Huaxin, ambasciatore cinese nel Paese mediorientale. Al termine
dell’incontro, le due alte personalità hanno annunciato la volontà comune di espandere
le relazioni politiche e commerciali tra Iraq e Cina, già buone durante il governo
provvisorio. L’occasione concreta si è verificata durante il secondo forum di
cooperazione arabo-cinese a Pechino. In occasione dell’evento, è stato avviato un
organismo politico di consultazione reciproca tra i governi dei due Stati.
Siria
Tra le maggiori operazioni economiche che i cinesi hanno effettuato in Medio Oriente
tra il 2005 e il 2006 c’è proprio quella in Siria.
Risale a dicembre 2005 l’acquisizione congiunta, da parte di due compagnie petrolifere
cinese e indiana, del 37% delle azioni di tutto il petrolio siriano. Cina e India sono
Paesi in aspra competizione economica, soprattutto per quanto riguarda la
distribuzione delle risorse petrolifere. Tuttavia, la CNPC (che ha investito
nell’operazione 576 milioni di dollari) e la ONGC si sono accaparrate insieme alla
Petro-Canada una forte quota che permette loro il controllo del sito di al-Furat, in Siria.
Ed è stato stabilito che le due compagnie deterranno entrambe metà del capitale
azionario acquisito. La produzione è già in corso, per cui potranno disporre di 60 mila
barili di greggio al giorno senza dover prima investire in ricerche.
In realtà, la decisione non nasce dal nulla. Bensì si tratta di una joint venture che vede
la partecipazione delle cinesi CNPC e SINOPEC e dell’indiana ONGC già in altri
Paesi produttori di petrolio. Il giacimento iraniano di gas a Yadavaran , per esempio, è
controllato all’80% da questo tandem sino-indiano (51% SINOPEC, 29% ONGC). Le
stesse compagnie hanno deciso inoltre di investire insieme 850 milioni di dollari per la
Omimex de Colombia, in modo da avere voce in capitolo per il petrolio sudamericano.
Libano
Il Libano costituisce forse il migliore e più chiaro esempio del nuovo interventismo
politico cinese in Medio Oriente. Contrariamente alla sua tradizione, la Cina non solo
ha inviato Caschi Blu nel Paese dei cedri, ma è addirittura uno dei maggiori
104
contributori della missione UNIFIL-2 con oltre mille militari. Si tratta della quarta
unità in assoluto dell’Esercito popolare di liberazione che viene inviata in missione
all’estero. La missione era già cominciata ad aprile 2006, quindi prima della guerra,
con la partecipazione ad UNIFIL-1. Un incremento di altri 275 soldati cinesi è stato
annunciato a gennaio. I militari cinesi sono soprattutto genieri e sminatori all’opera nel
sud del Paese, ma si occupano anche della ricostruzione di ponti e strade, in parte al di
fuori dell’area di competenza UNIFIL, scelta non casuale per attecchire nel Paese. La
decisione di partecipare così significativamente al dopoguerra libanese è stata presa
nonostante il 25 luglio, durante la crisi israelo-libanese, un peacekeeper cinese sia stato
ucciso in un raid delle forze armate dello Stato ebraico che ha colpito una postazione
dell’Onu.
Israele
Con
le
relazioni
sino-israeliane
in
crescita, celebrato l’anniversario della
normalizzazione delle relazioni diplomatiche, e aperto un nuovo consolato israeliano
nel Guangdong, Olmert ha parlato soprattutto di economia. Nel 2006 l’interscambio
commerciale tra i due Paesi è stato di 3 miliardi di dollari, ma come il premier Olmert,
in occasione della visita di Stato che si è svolta nel gennaio del 2007, ha ricordato che
già un anno e mezzo fa Cina e Israele si sono posti l’obiettivo di raggiungere almeno i
5 miliardi nel 2008.
In quella occasione sono stati siglati una serie di accordi bilaterali in diversi settori.
Negli stessi giorni, inoltre, vennero firmati diversi contratti tra le aziende cinesi e
quelle israeliane. Si tenga conto infine che nel 2005 Israele ha esportato nel “gigante
asiatico” prodotti per 725 milioni di dollari, mentre le importazioni hanno raggiunto
quota 2,3 miliardi di dollari, mentre nel 2006 le esportazioni in Cina sono aumentate
del 24%.
Ma come detto i rapporti tra Israele e Cina non sono del tutto idilliaci, anche per
l’interesse di entrambi i Paesi a tenere i piedi in più staffe. Se Israele dal canto suo ha
un’alleanza privilegiata con gli Stati Uniti, di cui Pechino non può non tenere conto, e
comunque non si perita di cancellare relazioni commerciali e anche militari con realtà
ostili alla Cina, come Taiwan, dal canto suo la Cina ha avviato questa sua politica di
nuove forti relazioni con i Paesi arabi, spostando il suo asse di interesse tradizionale.
105
Inevitabilmente, più Pechino si avvicina per necessità e per scelta ai Paesi arabi, più
diventano difficili le relazioni con Israele.
Iran
Negli ultimi anni, la partnership economica sino-iraniana si è intensificata e
consolidata. Se nel 1994 l’Iran riforniva la Cina soltanto per l’1% delle sue
importazioni totali di oro nero, dieci anni dopo Pechino ha acquistato due miliardi di
dollari di petrolio iraniano. Una quantità pari al 15% delle importazioni totali del 2002.
Teheran è oggi il primo partner commerciale di Pechino in Medio Oriente, e ha
contratti giganteschi in molti campi, compreso il gas ma anche appalti per la
costruzione di infrastrutture. Nell’ottobre del 2004, i due Paesi hanno firmato un
memorandum di intesa su una cooperazione energetica bilaterale. È stato stabilito che
il governo cinese avrebbe comprato dieci milioni di tonnellate di petrolio iraniano ogni
anno per i prossimi venticinque anni. In cambio, la SINOPEC avrebbe dovuto avviare i
lavori di estrazione nell’area di Yadavaran, nel Kurdistan iraniano, che con i suoi 17
miliardi di barili stimati sta incrementando del 50% la disponibilità di petrolio
importato in Cina. Yadavaran così rappresenta per la Cina il più grande investimento
petrolifero in Medio Oriente. Costituisce inoltre l’occasione per l’Iran di ricevere
l’aiuto concreto cinese, in termini di investimenti colossali ma anche di tecnologie e di
know-how, per ammodernare le sue strutture. In contropartita i cinesi otterranno a
partire dal 2009 un accesso privilegiato al gas naturale iraniano per un quarto di
secolo.
La Cina ha aumentato la sua importazione di greggio e prodotti petroliferi dall’Iran sin
dalla metà del 1990. Nel 1987 un Decreto della Repubblica Islamica ha permesso al
Ministero del Petrolio ed alla società petrolifera statale, National Iranian Oil Company
(NIOC) di stipulare contratti anche con compagnie straniere attraverso il sistema “buy
back”.
Pechino sta supportando gli sforzi delle compagnie cinesi per vincere appalti nel Paesi
del Golfo attraverso regolari visite ufficiali di alto livello nella regione. La Cina,
inoltre, sta espandendo attraverso l’esportazione di importanti beni manifatturieri e
capitale nella regione. In Iran, per esempio, la NORINCO sta aiutando Teheran alla
realizzazione della metropolitana urbana, inoltre alcune società cinesi sono attive nel
106
Paese per l’installazione di fibre ottiche per la comunicazione e per la produzione di
autovetture e televisori. Sotto l’aspetto strategico, tali investimenti danno un’immagine
positiva della Cina a Teheran, in un Paese in cui i rapporti commerciali con gli Stati
Uniti sono assenti.
Pakistan
Il 21 maggio 2006, le autorità pachistane e cinesi hanno celebrato i 55 anni di relazioni
diplomatiche tra i due Paesi. I rapporti tra la Cina ed il Pakistan sono sempre stati
piuttosto amichevoli, tanto che le prime relazioni diplomatiche condotte tra gli USA e
la Cina nel 1971 hanno visto il Pakistan come principale intermediario nelle trattative.
Negli ultimi anni la cooperazione economica tra i due Paesi è stata particolarmente
intensa. Nel luglio 2006 è stato inaugurato un porto a secco alla periferia di Sust, che
fa da collegamento fra il Karakorum e il porto di Gwardar – anch’esso realizzato con
un importante contributo della Cina – nella regione a Sud del Belucistan. La
costruzione del porto è iniziata nel 2004, dalla collaborazione fra Pakistan e Cina, con
l’obiettivo di ottimizzare e rendere più efficiente il commercio sui confini dei due
Paesi. Il presidente Musharraf ha affermato, durante l’inaugurazione del porto, che il
progetto potrebbe diventare la vera pietra miliare dell’amicizia fra Pakistan e Cina.
Questo potrebbe essere uno strumento per nuove strategie di commercio della Cina e
nel contempo permette di aiutare il Pakistan a sviluppare il suo potenziale, come fulcro
del commercio regionale.
Durante una riunione del Patto di Shanghai nel giugno 2006, il presidente pakistano
Musharraf ha offerto il suo Paese come un “corridoio energetico”, per un possibile
oleodotto dall’Iran alla Cina, e comunque anche come ponte naturale tra il Medio
Oriente e la Cina.
Il Pakistan, infatti, potrebbe diventare un corridoio di energia e commercio fra la Cina
e le regioni dell’Asia Centrale, l’Afghanistan, l’Iran, l’India e il Golfo Persico. A
riguardo, Musharraf ha annunciato la realizzazione di un oleodotto che attraverserà il
Belucistan.
La volontà del Presidente pakistano di rafforzare le relazioni economico-politiche con
la Cina è stata espressa con parole chiare e inequivocabili: “Noi siamo capaci di creare
107
l’ottava, la nona e la decima meraviglia del mondo, sotto forma di collegamenti
ferroviari o gasdotti/oleodotti fra Pakistan e Cina”.
La Cina, tra l’altro, è già coinvolta nella costruzione di infrastrutture in Pakistan:
grazie all’aiuto di Pechino, infatti, sono stati realizzati o sono in fase di costruzione
importanti progetti come il citato porto di Gwadar, la Karakoram Highway (che unisce
i due Paesi passando per l’Himalaya) e l’impianto nucleare di Chashma (i lavori del
secondo impianto atomico nella provincia nordorientale pakistana del Punjab sono
iniziati alla fine di dicembre 2005).
Le visite dei due presidenti erano state precedute nell’aprile 2005 da quella del primo
ministro cinese Wen Jiabao ad Islamabad: in quell’occasione furono siglati diversi
accordi di cooperazione, tra i quali importanti intese nel settore del commercio e della
difesa. In particolare, il Trattato di amicizia, cooperazione e buon vicinato entrato poi
in vigore il 4 gennaio successivo.
Sebbene non siano stati resi noti molti particolari delle intese raggiunte da Musharraf a
Pechino nel febbraio 2006, esse hanno riguardato molteplici aspetti fondamentali in
politica economica, commerciale, agricola, energetica, nucleare, militare e
internazionale.
Nel corso della visita si è anche deciso che la Cina fornirà al Pakistan due nuovi
reattori nucleari, per fare fronte al crescente fabbisogno di energia del Paese. E’ stato
definito un accordo di principio del valore di 1,2 miliardi di dollari; i due reattori
avranno una capacità di 325 Megawatt. La Cina aveva già fornito al Pakistan la
tecnologia per costruire un reattore da 300 megawatt di Chashma, e sta assistendo
Islamabad nella costruzione del secondo reattore sempre nella stessa centrale.
Chashma-2 sarà operativo entro cinque anni, e avrà la stessa capacità del primo.
Il volume degli scambi commerciali tra la Cina ed il Pakistan è passato dai 3 miliardi
di dollari del 2004, ai 4 del 2005, con l’obiettivo di arrivare a 8 nel 2008 e a 15 nel
2012. Questi obiettivi sono stati perseguiti anche grazie ai successivi accordi firmati a
Islamabad durante la prima visita di un capo di Stato cinese dopo più di 10 anni. Sulla
base di quanto preparato da Musharraf a Pechino, Hu Jintao a Islamabad ha concluso
“accordi senza precedenti”, e soprattutto la creazione di una zona di libero scambio,
108
oltre ad aver siglato molte altre intese di carattere politico e strategico. Oltre
all'accordo di libero scambio, i due Paesi hanno firmato un accordo di sviluppo
reciproco quinquennale, che è il primo del genere mai firmato dalla Cina con un Paese
straniero e che dovrebbe determinare un notevole e significativo incremento nelle
relazioni economiche tra Cina e Pakistan. Tra le diciotto intese siglate ve ne sono varie
anche nei settori delle telecomunicazioni, della cultura, della scienza e tecnologia,
della sanità, dell'istruzione e della difesa. In particolare, Cina e Pakistan hanno siglato
un MOU (memorandum of understanding) per una collaborazione di lunga durata nel
settore della difesa, comprendente la produzione di un sistema di sorveglianza aerea,
che dovrebbe portare presto entrambi i paesi a dotarsi di aerei di tipo Awacs. I due
Paesi inoltre collaboreranno nello sviluppo della produzione di aeroplani e nei settori
correlati. Hu ha anche assicurato alle autorità di Islamabad lo scambio di tecnologia
nucleare e il contributo cinese allo sviluppo del programma nucleare del Pakistan, pur
senza arrivare, come temuto dall’India, all’annuncio di un accordo di cooperazione
nucleare tra Cina e Pakistan sulla falsariga di quello tra India e Usa.
109
110
Italia e Go Global
Nel luglio del 2005 il Sole24ore riportando la presenza di manodopera cinese nelle
risaie piemontesi titolava “Sono ritornate le mondine”. E’ probabilmente questa la
chiave di lettura più appropriata per leggere la crescente presenza di investimenti cinesi
in Italia. Investono di solito in settori in crisi ma che continuano a mantenere un grosso
potenziale di competenze e di visibilità del marchio, appianano i debiti, richiamano i
cassa integrati e fanno ripartire la produzione. Interventi che, almeno per ora, lasciano
cadere le paure e le perplessità di quanti hanno timore di investimenti esteri provenienti
da Pechino, ma ad oggi, in un paese come il nostro, non sempre ricco di capitali da
investire in attività non puramente finanziarie, i si cinesi stanno ritagliando il ruolo del
“cavaliere rosso” che riesce a dare linfa finanziaria ad alcune attività dal grande passato.
Non solo ma il nostro resta un Paese che attrae pochi investimenti internazionali. Anche
se nel 2006 la crescita complessiva è stata del 38%, come risulta del rapporto UNCTAD
sugli investimenti internazionali, ma per l'Italia è stata del 96%, quasi un raddoppio dei
flussi in entrata. La nostra quota come Paese ricevente dei flussi mondiali è così salita al
3% (dal 2.4% di due anni prima), superando di gran lunga la Spagna e quasi
raggiungendo la Germania.
Guardando ai flussi cumulati dal passato, la quota italiana resta, però, ancora nettamente
inferiore a quella dei maggiori Paesi europei, inclusa la Spagna. Lo stesso rapporto
dell'Unctad continua a collocarci al terz'ultimo posto fra i Paesi avanzati in base a un
indice composito di "transnazionalità": il rapporto tra la presenza di imprese a capitale
estero nel Paese ricevente e Pil, investimenti interni, occupati e valore aggiunto. Il saldo
fra nuovi investimenti e disinvestimenti è peggiorato rispetto agli anni 90, secondo i dati
del rapporto annuale "Italia multinazionale" (Ice-Politecnico di Milano). Eppure
sappiamo che le imprese a capitale estero contribuiscono a quasi il 15% degli
investimenti, il 17% del valore aggiunto, il 26% delle spese in ricerca e sviluppo, il 24%
delle esportazioni, il 34% delle importazioni del settore manifatturiero italiano. E
sappiamo anche che queste imprese sono caratterizzate da maggiore produttività del
lavoro, maggiori investimenti in capitale (sia in macchinari che umano), intensi scambi
di conoscenze scientifico-tecnologiche e di innovazioni organizzative, struttura
finanziaria più solida. E tutto ciò non solo perché gli investimenti diretti esteri tendono a
111
collocarsi nella parte più avanzata e dinamica del sistema produttivo. Negli anni recenti
emerge un'altra interessante tendenza degli investimenti esteri in Italia: l'hi-tech "di
niccha" nell'industria e nei servizi.
Ormai lontana nel tempo la stagione delle dismissioni di grandi pezzi "nobili"
dell'industria privata e pubblica italiana (Olivetti, Farmitalia, Montedison, Enichem,
Ansaldo, Italtel, Telettra...), l'attenzione si dirige verso produzioni manifatturiere a
media e medio-alta tecnologia, su nicchie con grande potenziale di mercato globale e
con forti economie di scala: prodotti di largo consumo (come alimentari, detergenti e
cosmetici, elettrodomestici) ma ancor più beni strumentali e prodotti intermedi (come
principi attivi farmaceutici, plastiche e ausiliari chimici per l'industria, metallurgia,
elettromeccanica, meccanica di precisione, cavi, apparecchiature di trasmissione,
componenti auto).
Accanto a queste produzioni manifatturiere, destinate al mercato interno ma anche
all'esportazione (che per quasi metà nasce da scambi con le case madri e loro affiliate in
altri Paesi), le imprese a capitale estero stanno consolidando una presenza capillare in
larga parte dei servizi a organizzazione complessa, da informatica e telecomunicazioni a
logistica, grande distribuzione commerciale, energia, servizi professionali e di
ingegneria, struttura alberghiera).
Anche se passati talvolta in secondo piano rispetto ai clamori dei casi di italiani sbarcati
in Cina, i recenti investimenti diretti cinesi nella penisola sono rilevanti e di assoluto
interesse. Seppur abbiano, per stock e flussi, un peso marginale rispetto sia alla forza
della presenza all'estero della Cina, sia al valore degli Ide totali in Italia (oltre 135 mld
di euro a fine 2005 i flussi), il fenomeno registra una netta espansione. Dati Ufficio
Italiano Cambi (Uic) dimostrano che dal 2001 al 2005 il valore dei flussi è cresciuto del
160%, con un incremento netto negli ultimi due anni (+120% dal 2004 al 2005).
Integrando varie fonti, italiane e cinesi, è possibile delineare una prima mappa dei
principali investimenti diretti con soggetto proprietario o comproprietario cinese
(escludendo iniziative di Taiwan ed Hong Kong, spesso erroneamente incluse). Si tratta
prevalentemente di investimenti greenfield o joint venture, anche se l'acquisizione di
società italiane si sta rapidamente diffondendo. Attuale protagonista è il Nord Italia.
112
Ricerca e sviluppo, attività commerciali e logistiche di supporto alla casa madre,
meccanica e trasporti i settori privilegiati.
Noti i casi dei centri di ricerca e sviluppo nel settore automobilistico, costituiti in
Piemonte; qui la finalità strategic asset seeking è evidente. E voci di mercato riportano
che altri importanti gruppi starebbero progettando la costituzione in Italia di simili
centri, in aree strategiche individuate per specifiche conoscenze e competenze locali.
Come quello, sempre in Piemonte, che nasce dalla collaborazione tra la Huawei
Technologies Co. e Telecom Italia con l'obiettivo di sviluppare insieme applicazioni
avanzate attraverso il sistema Mic (Mobile network applications) destinato a operare
nella sede di Torino (dove Huawei ha aperto l'anno scorso gli uffici commerciali
lasciando il centro R&S in Germania, a Dusseldorf.) e destinato a fare da motore di
nuove tecnologie broadband.
La ricerca di asset ad alto valore aggiunto ha guidato anche iniziative non greenfield,
finalizzate all'appropriazione o del marchio (come nei casi Benelli ed Elios) o di
vantaggi di localizzazione, affiancati alla disponibilità di know-how e conoscenza degli
standard europei, in settori ad alta competitività (come per Haier nell'elettrodomestico).
Infine vi è il settore spedizioni e logistica, particolarmente fertile per joint venture.
L'Italia, infatti, considerata punto di snodo cruciale verso l'Europa, diventa oggetto di
interesse crescente per imprenditori cinesi alla conquista del business delle rotte
commerciali marittime (si vedano i colossi Cosco e China Shipping).
Pochi, dunque, i casi di società cinesi in Italia, ma in costante crescita. Non
sottovalutando le denunciate difficoltà burocratiche e amministrative di accesso alla
penisola.
Le motivazioni del ritardo con cui l'onda di investimenti cinesi sta giungendo in Italia
vanno ricercate, probabilmente, nella graduale maturazione della strategia di
penetrazione internazionale della Cina. Dall'iniziale espansione resource seeking per
approvvigionamento di materie prime scarse, tipicamente ad opera delle grandi imprese
statali, si è passati a motivazioni market seeking e, ancor più recentemente, ad
investimenti strategic asset seeking. L'Italia, scarsa di risorse naturali, è ampio mercato
di sbocco e ricca di competenze distintive nei settori manifatturieri. È divenuta dunque
solo negli ultimi anni target interessante per l'internazionalizzazione cinese e
113
specificamente per le medie imprese, attratte da risorse ad alto valore aggiunto
(immagine, marchi, ricerca, innovazione) e dalla ridotta e più abbordabile dimensione
delle imprese-obiettivo.
Se a livello corporate il fenomeno degli investimenti cinesi in Italia è in aumento ma
ancora acerbo, la presenza di imprenditori - persone fisiche - sta ormai esplodendo. Dati
Unioncamere (nazionalità degli imprenditori attivi) mostrano che la presenza cinese è
cresciuta a ritmi maggiori rispetto al totale degli extracomunitari e, soprattutto, in modo
eclatante in rapporto al tasso di crescita delle imprese attive in Italia (di poco superiore
all'1%). Alla fine del 2005, le regioni in cui è prevalente la presenza di imprenditori
cinesi sono Lombardia (21%), Toscana (20%), Emilia Romagna e Lazio (10%), Veneto
(9%).
A livello settoriale, risaltano sia la netta predominanza dei cinesi rispetto agli
extracomunitari nel tessile-abbigliamento e calzature, sia l'espansione nel commercio.
Due i trend interessanti. Primo: la tendenza dei cinesi a localizzarsi in modo sempre più
diffuso su tutto il territorio, privilegiando aree a tipica vocazione distrettuale, anche nel
Sud della penisola. Secondo: l'espansione forte del commercio al dettaglio di beni per la
persona e la casa, importati. La produzione è delegata a fornitori in Cina, in grado di
adattare il prodotto alle specifiche europee, mantenendo competitività sul prezzo ed
evitando problemi e burocrazie del contesto italiano.
In precedenza si sono esaminati sinteticamente obiettivi perseguiti e strumenti adottati
dal governo cinese per espandere la presenza all’estero delle imprese nazionali. Si è
visto che tra le iniziative più recenti intraprese vi è la firma di accordi bilaterali con
singoli
governi,
per
agevolare
in
modo
ancor
più
incisivo
e
mirato
l’internazionalizzazione attiva cinese. In questa logica, anche il Governo italiano ha
avviato un percorso di collaborazione, in cui lo sviluppo delle attività d’investimento
bilaterali risulta centrale. La Cina si è impegnata a sostenere progetti specifici, non
solo nei settori industriali tradizionali ed anche al sud. Ciò lascia prevedere una
crescita considerevole della presenza di capitali cinesi in Italia nel prossimo futuro.
L’analisi si sposta, dunque, sul contesto nazionale, nel tentativo di comprendere
l’impatto che sta avendo la politica Go Global, le potenzialità di sviluppo e le possibili
conseguenze sul tessuto produttivo nazionale. In tal senso, un primo aspetto da
114
indagare riguarda l’effettiva presenza in Italia di imprese/imprenditori cinesi. Le
difficoltà, al riguardo, non sono poche, a causa della frammentazione dei dati e della
molteplicità delle fonti, non sempre concordanti, disponibili. Per poter realizzare una
prima mappatura del fenomeno, quanto più aggiornata e completa possibile, si fa
ricorso a tre tipologie di informazioni:
•
i flussi di investimenti diretti in Italia, provenienti dalla Cina, rilevati
dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC, d’ora in poi). Realizzando, il monitoraggio dei
movimenti valutari che hanno origine, in toto o in parte, dall’estero, l’UIC segnala gli
afflussi ed i deflussi valutari contropartita di eventuali operazioni di investimento.
Questo dato però risulta non significativo se preso in modo asettico ed isolato. Oltre ai
problemi di completezza e tempestività dei dati, con riferimento specifico al caso
cinese va considerato che, spesso, gli investimenti vengono realizzati da gruppi che
detengono società all’estero, tramite le quali le operazioni sono fatte transitare.
L’investimento sfugge, di conseguenza, alla nazionalità cinese e non emerge dai dati
disponibili. In tal senso, le informazioni UIC sono integrate con le altre fonti, di
seguito descritte;
•
l’elenco delle società italiane partecipate da soggetti cinesi, sia costituite ex
novo in Italia (investimenti greenfield, anche nella formula della joint venture) sia
controllate a seguito di operazione di acquisizione di imprese italiane preesistenti
(investimento non greenfield). Le informazioni sono state acquisite da banche dati
diverse, in parte italiane, in parte cinesi, integrate poi opportunamente anche mediate
notizie comparse sui periodici economici nazionali. Sono state escluse dall’analisi tutte
le iniziative di Taiwan ed Hong Kong, spesso erroneamente catalogate come “cinesi”;
Alcune prime riflessioni sul fenomeno cinese sono sollecitate dai dati dell’UIC. Da
una lettura dei dati emerge, innanzitutto, la crescita considerevole e persistente degli
afflussi, negli ultimi anni, verso il Veneto, oltre che verso il Lazio, specie nel 2004. In
secondo luogo risalta il progressivo ridimensionamento della Toscana, che tuttavia
compare sempre, negli anni esaminati, tra i destinatari di nuovi afflussi di risorse.
Dall’esame dei deflussi valutari è, invece, interessante notare la riduzione
particolarmente consistente nel 2004 degli investimenti in Emilia Romagna (-3.567
mila euro) e la continua, seppure ridotta, fuoriuscita di risorse dalla Lombardia (-136
mila euro nel 2001, - 549 mila euro nel 2004 e – 356 mila euro nel 2005). A livello
115
settoriale, dal confronto tra flussi del 2001 e del 2005 scaturisce una riduzione degli
investimenti nei servizi al commercio, probabilmente a testimonianza di una
penetrazione, consistente nel passato, che ha saturato le varie piazze commerciali.
Questo dato va, tuttavia, letto in modo integrato con le indicazioni sulle singole
iniziative imprenditoriali di soggetti cinesi (dati Unioncamere), in cui il fenomeno
appare in controtendenza. In via generale, è interessante sottolineare come gli
investimenti di operatori cinesi in Italia rappresentino una quota molto ridotta rispetto
sia agli ODI della Cina, sia in relazione agli investimenti (per stock e flussi) di paesi
esteri in Italia. Tuttavia, il fenomeno è in netta espansione, con una crescita, dal 2001
al 2005, del valore dei flussi pari al 160% ed un incremento molto netto negli ultimi
due anni (+120% dal 2004 al 2005).
Investimenti Diretti in Italia – Dati di Flusso (importi in migliaia di €)
116
Nel complesso sono tre le fasi della "invasione" di investimenti diretti da Russia, India
e Cina (Ric) in Italia, secondo la ricostruzione dello studio A.T. Kearney.
Fase uno. Si svolge a cavallo degli anni 60 e si può definire "di bandiera", cosiderato
che le sole ad arrivare sono le compagnie aeree. Air China aprire i suoi uffici
commerciali nel 1986.
Fase due. Sono arrivi "episodici" tra la seconda metà degli anni 80 e gli inizi degli anni
90. Quattro operatori entrano per motivi diversi: nel 1986 arriva la Nanjing
Automotive Corporation (Nac) che apre un ufficio di rappresentanza per tenere i
rapporti con Iveco dopo l'accordo per la produzione in Cina di veicoli commerciali
Gamma S, poi evolutosi nel 1995 in una joint venture. Nel 1988 è la volta della Cmec:
117
con due soci italiani dà vita a un ufficio per commercializzare macchine utensili cinesi
in Italia.
Fase tre. Fine anni 90, tempo di acquisizioni. Arrivo dei nuovi player globali cinesi,
come Baosteel, Cosco, Haier etc.
Le società costituite o acquisite in Italia
Per comprendere, più da vicino, la situazione degli investimenti cinesi in Italia, è
opportuno passare dalla visione “macro” dei flussi UIC alla verifica delle imprese a
capitale cinese costituite o acquisite in Italia. Questa analisi, come accennato, è resa
possibile dall’integrazione di diverse fonti (Sviluppo Italia, su dati Reprint, Camera di
Commercio Cinese per la promozione internazionale, AIDA Bureau Van Dick) dalle
quali, pur non avendo la certezza di riuscire ad ottenere un quadro completo, è
possibile percepire la portata del fenomeno.
Attualmente, risultano attive in Italia 25 società con soggetto proprietario o
comproprietario
cinese.
Solo
per
alcune
è
possibile
definire
la
natura
dell’investimento. Si tratta in prevalenza di iniziative greenfield, localizzate nel Nord
Italia e legate all’espansione di grandi gruppi cinesi, anche di origine pubblica. Sono
comunque in crescita i casi di acquisizione di imprese, tipicamente di piccole e medie
dimensioni. In prevalenza, le società costituiscono filiali commerciali, che svolgono
attività di analisi di mercato, studio di posizionamento e di prodotto, marketing per il
gruppo di riferimento. Questo potrebbe essere letto come primo step, volto
all’esplorazione del contesto italiano e soprattutto europeo, rispetto ad una strategia più
ampia di internazionalizzazione.
118
Talvolta, alle società costituite in Italia viene anche delegato lo svolgimento di attività
di ricerca e sviluppo, come accade nella provincia di Torino, nel settore
automobilistico. In questo caso, la finalità strategic asset seeking emerge in modo
netto, data la presenza di conoscenze consolidate, sedimentate in loco, in ambito sia
industriale, sia accademico. Peraltro, anche altri importanti gruppi starebbero, secondo
i rumor di mercato, progettando la costituzione in Italia di centri di ricerca e sviluppo,
in aree strategiche per la conoscenza e le competenze possedute dalle risorse umane
italiane.
L’espansione degli ODI cinesi in Italia potrebbe anche essere ricondotta alla
progressiva internazionalizzazione delle medie imprese cinesi. Queste ultime, molto
più delle imprese statali o delle grandi imprese multinazionali, tendono a trovare un
fertile terreno in Italia per alleanze ed acquisizioni. Esse si focalizzano, infatti,
maggiormente su risorse ad alto valore aggiunto ed immateriale (immagine, marchi,
ricerca, innovazione), in settori produttivi tradizionali di cui il nostro paese è
sicuramente ricco. Le medie imprese cinesi, attirate dalla qualità e dal brand di molte
119
produzioni del made in Italy, potrebbero sempre più vedere nelle risorse possedute
dalle imprese italiane una modalità di crescita “esterna” rapida, per affrancare la
propria immagine di produttori low cost e di bassa qualità. Inoltre, la disponibilità di
imprese – target di dimensioni ridotte tende a facilitare la penetrazione e l’ingresso nel
mercato italiano. L’investimento finanziario richiesto è sicuramente alla loro portata,
rispetto a quanto necessario in caso di acquisizioni di quote di grandi imprese.
La Haier ha acquisito l’italiana Meneghetti. Nato nel 1984 a Qingdao (Cina), a circa
400 Km da Pechino, in soli 20 anni il Gruppo Haier, da semplice impianto produttivo
di frigoriferi, è diventato il 4° produttore al mondo di elettrodomestici: il 2° per quanto
riguarda i frigoriferi e addirittura il 1°, sempre nel “freddo”, come Marchio
(Euromonitor 2003).
A ulteriore dimostrazione dei grandi successi ottenuti dal gruppo Haier, lo scorso
Gennaio 2004 il marchio Haier è stato eletto come uno dei 100 marchi globali più
famosi nel mondo, nella classifica stilata dal World Brand Laboratory, ed in particolare
al 95° posto dopo marchi del calibro di Coca-Cola, McDonald e Nokia.
Un successo, quello di Haier, dovuto in gran parte al suo fondatore, Zhang Ruimin, e
attuale Presidente del Gruppo, definito dal Financial Times uno dei 30 migliori capi
d’azienda del mondo (dicembre 1999). Zhang è stato membro del partito comunista ed
ha preso parte alla CLYC, è anche stato membro non permanente del 16esimo
congresso nazionale del partito.
Prima azienda cinese a conquistare il mercato globale, Haier, con 30.000 dipendenti, è
presente in 165 Paesi, con 96 linee di prodotto e 15.000 referenze: dagli
elettrodomestici ai televisori, dai condizionatori d’aria ai DVD, dai telefoni cellulari
agli esclusivi wine cooler. Haier Europe coordina il marketing e le vendite di
elettrodomestici a marchio Haier in 17 Paesi europei: Gran Bretagna, Irlanda,
Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Portogallo,
Svizzera, Austria, Italia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia.
Con sede a Varese Haier Europe gestisce anche tutte le attività logistiche attraverso 4
centri di distribuzione che servono tutto il mercato europeo, localizzati rispettivamente
in Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Italia.
120
La scelta dell’Italia come sede centrale europea, è determinata non solo da motivi di
carattere logistico ma soprattutto dalla nostra lunga tradizione nel settore degli
elettrodomestici, che vanta figure professionali con un forte know-how e una forte
spinta competitiva.
Il rapporto del Gruppo Haier con l’Europa, per quanto concerne la divisione del
bianco, ha inizio più di 10 anni fa con l’introduzione dei primi prodotti nel mercato
europeo. La spinta di un successo sempre crescente ha portato l’azienda a compiere un
autentico balzo in avanti per culminare, nel 2000, nella realizzazione della prima
gamma di elettrodomestici concepiti specificatamente per soddisfare le esigenze e il
gusto dei consumatori europei.
Per seguire appieno le tendenze del mercato e talvolta anticiparle con prodotti dal
design e dalla tecnologia innovativa, nel 2001 Haier ha acquisito dalla Meneghetti spa
(PD), il 100% del ramo d’azienda che produce frigoriferi.
Grazie alla costituzione della nuova società, Haier (Italy) Appliances spa, l’Italia è
divenuta il polo di riferimento nella produzione di frigoriferi combinati per l’Europa.
In Italia è presente anche Li Ka-shing, che con la Hutchison Whampoa controlla la 3,
quarto gestore di telefonia mobile e primo ad aver puntato tutto sulla "terza
generazione" (Umts).
Il gruppo Zhejiang Qianjiang motorcycle (Zqm), realtà con un fatturato consolidato di
900 milioni di euro - 500 dei quali nel settore moto - e una produzione di ampia
gamma che interessa bici elettriche, idropulitrici, tagliaerba, quad e caddie per il golf:
12mila dipendenti che lavorano nello stabilimento di 670mila metri quadri a Wenling,
a 400 chilometri da Shanghai, dal quale, ogni anno, escono un milione di motociclette.
è invece sbarcato a Pesaro nel 2005 con l’acquisto della Benelli. L'accordo per
acquisire la Benelli, siglato nel settembre scorso, ammonta a 52,7 milioni di euro (seisette milioni più l'assunzione dei debiti per il periodo 2002-2004), corrisposti dal
gruppo Qianjiang alla Fineldo, finanziaria della famiglia di Vittorio Merloni. Previsto
il mantenimento del marchio a Pesaro, la riassunzione dei 48 dipendenti (12 gli
amministrativi) e la conferma di tutti i diritti acquisiti: assorbita la botta del passaggio
in mano cinese, in questi tre mesi le maestranze dello stabilimento pesarese si sono
rimboccate le maniche per preparare al meglio l'avvio del new deal cinese atteso da
121
metà gennaio. Confermati o stretti nuovi contratti per la fornitura di materie prime con
aziende soprattutto italiane specializzate nella meccanica di qualità, pezzi e accessori
per motori ad alte prestazioni. Per quanto concerne invece la produzione dei
ciclomotori da 50 cc nello stabilimento pesarese è previsto il solo assemblaggio dei
pezzi provenienti dalla Cina.
Secondo il piano industriale presentato dalla nuova proprietà è programmata una
produzione di 3mila moto di alte prestazioni nel 2006, 5mila nel 2007 e 10mila nel
2008, volumi di produzione che, come ha spiegato il presidente del gruppo, Ling Hua
Zang, «sarà supportato da un centro R&S tecnologia e design da insediare proprio a
Pesaro e ridare così impulso alla locale tradizione dell'industria motociclistica».
È, inoltre, previsto l'avvio di cinque nuove linee di produzione per motori Tornado da
900 e 1.200 cc, di due modelli "Enduro" da 250 e 600 cc e, infine, l'atteso ritorno della
"Velvet". La nuova proprietà ha dichiarato di voler puntare con decisione sul mercato
europeo, in particolare Italia, Germania e Francia.
La Società Benelli nasce a Pesaro nel 1911. A fondarla, impegnando tutto il capitale di
famiglia, fu la vedova Teresa Benelli, desiderosa di offrire una stabile occupazione ai
suo sei figli: Giuseppe, Giovanni, Francesco, Filippo, Domenico e Antonio. Agli inizi,
si trattava solo del "Garage Benelli" che effettuava principalmente riparazioni di
macchine e motocicli ma che era già in grado di fabbricare tutti i pezzi di ricambio
necessari alla riparazione. Il primo motore nasce nel 1920: si trattava del
monocilindrico due tempi da 75cc che fu adattato al telaio di una bicicletta.
Nel 1921 la Benelli costruisce la sua prima motocicletta chiamata Motoleggera da
98cc, immediatamente apprezzata dal pubblico. L'eccezionale capacità di sviluppo e di
produzione della società si rivelò vincente anche nel mondo delle competizioni con la
versione da 175cc. I tecnici Benelli decisero quindi di sfruttare la loro esperienza con
la produzione nel 1936 del modello 250, un prodotto di successo sia commerciale che
sportivo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale ci fu la completa
distruzione della fabbrica, l'entusiasmo e la passione dei sei fratelli portarono alla
realizzazione di un modello destinato a far parlare a lungo di sé, il Leoncino 125, che
fece risorgere economicamente l'azienda e che ottenne nella versione da corsa infiniti
successi. Nel 1962, la Benelli e la Motobi (fondata nel 1949 da Giuseppe Benelli in
seguito a disaccordi coi fratelli e successivamente riassorbita dalla Benelli stessa)
122
contavano 550 dipendenti e producevano circa 300 moto al giorno; tra queste la
gamma da 50cc e le 125-175 "Serie Oro" 4T con distribuzione ad aste e bilancieri.
Alla fine degli anni sessanta venne presentato l'ultimo prodotto della gestione della
famiglia Benelli, il Tornado 650 con motore da 50 CV a 7000 giri, che superava i 170
km\h.
All'inizio degli anni settanta Benelli cambiò proprietà ma lo sviluppo della gamma
moto continuò con la produzione delle 6 cilindri (750cc e 900cc) fino ai primi anni
ottanta, quando la concorrenza dei costruttori giapponesi portò la casa a concentrarsi
solamente sui veicoli di piccola cilindrata.
Questo fino al 2003, quando è iniziata la produzione della Tornado Limited Edition,
progenitrice della gamma Tornado.
Con la commercializzazione della TnT poi, avvenuta nel corso del 2004, la Benelli è
tornata a pieno titolo nel mercato delle moto sportive di grossa cilindrata.
L’acquisizione da parte cinese viene dunque nella fase del rilancio del marcio, e visti
gli accordi, riassunzioni e pagamento dei debiti, è probabile che il capitale cinese possa
dare nuovo slancio allo storico marchio
Altro caso di acquisizione di un marchio di prestigio è quello che riguarda la Sergio
Tacchini. Sergio Tacchini è un marchio con una lunga storia: fondato nel 1966 a
Bellinzago (Novara) da un ex tennista professionista, Sergio Tacchini appunto, ha
introdotto molte novità nel mondo del tennis e dello sportswear. A cominciare dalle
prime divise colorate (negli anni Sessanta era di rigore il bianco integrale). Ma con
l'emergere dei grandi colossi americani ed europei, l'azienda ha vissuto, a partire dagli
anni Novanta, momenti difficili e dal 2006 sta tentando il rilancio.
I fondi di private equity hanno mostrato interesse nel marchio, conosciuto in tutto il
mondo e presente in ogni settore sportivo (ha anche sponsorizzato +39, una delle tre
barche italiane che hanno partecipato all'America's Cup). Ma il "soccorso" è arrivato
dalla Cina. La società cinese H4T, controllata da Billy Ngok, presidente della Hembly
International Holdings Ltd, principale operatore nella distribuzione di prodotti fashion
in Cina, quotato alla Borsa di Hong Kong. L'accordo ha previsto, in un primo tempo,
l'affitto del complesso aziendale e, in seguito, il suo acquisto, subordinato
123
all'accettazione della procedura concordataria da parte dei creditori dell'azienda
novarese.
In precedenza, per salvare la Tacchini era intervenuto il gruppo finanziario Orlando
Italy, proponendo di rilevarne il controllo. Attualmente l'azienda è esposta verso il
sistema bancario per circa 70 milioni, a fronte di un fatturato di 100 milioni.
Nel 2005 Hisense Group, la più grande impresa dell'Est della Cina (nella provincia di
Shandong) specializzata nel settore dell'Ict, si è insediata a Torino. Qui ha collocato,
nel signorile quartiere della Crocetta, in corso Montevecchio, il suo ufficio
commerciale per l'Italia.
Hisense serve già le grandi strutture di vendita italiane con i suoi apparecchi, dai
televisori fino ai climatizzatori: si tratta di un'ulteriore tappa di avvicinamento
dell'azienda cinese al mercato europeo. Non a caso, Itp, l'agenzia pubblico-privata nata
per attrarre gli investimenti a Torino e in Piemonte e protagonista di questo
insediamento strappato a Milano, sta trattando con la società cinese per portare nel
territorio subalpino anche la base di distribuzione dei suoi prodotti di elettronica da
consumo per tutta l'Europa dove Hisense ha solo uno stabilimento di assemblaggio e
produzione, in Ungheria. Il quartier generale torinese conta attualmente una decina di
persone, quasi tutte italiane, a supporto di un gruppo di cinesi guidato da una donna.
Quello di Hisense Group è il terzo, significativo, insediamento di aziende cinesi a
Torino. Tre anni fa giunse Chang An, quarto produttore di auto in Cina, che,
appoggiandosi alla torinese Idea Institute, specializzata in design e in engineering, ha
approfondito la sua attività in Piemonte e qui sta cercando il suo vero e proprio
quartier generale per l'Italia con funzioni di rappresentanza per tutta l'Europa. Risale
poi a qualche mese fa l'arrivo a Torino del primo centro di ricerca e sviluppo all'estero
di un'altra importante azienda automotive cinese, la Jac Anhui Janghuai.
124
La questione dei porti
125
Dopo essere stati estromessi de facto dalle rotte del commercio globale per scarsa
competitività, ne stiamo ridivenendo il centro per felice geografia. Il mare nostrum è
tornato il mare dei commerci, in questo peculiare fenomeno di globalizzazione di
ritorno, di riorganizzazione della logistica mondiale che conta, in cui, per posizione
geografica l’Italia ha la possibilità di giocare un ruolo fondamentale, a patto che impari
a dotarsi di una moderna rete di infrastrutture e di logistica. Sono questi gli effetti
geopolitici della globalizzazione. Globalizzazione che ha prodotto uno sconvolgimento
pari a quello post scoperta dell’America, quando la corsa al nuovo mondo tagliò fuori
dalle grandi rotte del commercio mondiale l’Italia e il mediterraneo. Oggi, infatti,
l’ingresso nei mercati mondiali dei giganti asiatici, cioè i traffici lungo l’asse Cina
Usa, hanno rimesso al centro delle rotte il nostro mare, vera e propria neoporta tra
Oriente ed Occidente. In grado di poter dare una nuova vita ai porti della penisola e
questi sono sia i porti regionali (Genova, La Spezia, Livorno, Napoli…, Trieste,
Venezia, Ravenna, Ancona...) che i porti di transshipment (Gioia Tauro, Taranto e
Cagliari) dove si scaricano le merci su navi di media taglia che a loro volta risalgono i
due canali d’acqua strategici per Genova e Marsiglia (Tirreno) o per Trieste
(Adriatico), i veri cancelli sui mercati del nord Europa. Per quanto riguarda invece i
porti regionali diviene fondamentale la questione delle grandi opere e dei corridoi
infrastrutturali. In particolare il Corridoio 24 da Genova al Mare del nord, a Rotterdam,
e il Corridoio numero 5.
126
I porti italiani godono di un vantaggio competitivo formidabile per via della loro
posizione geografica rispetto ai porti dell’Europa del Nord. Transitando dal canale di
Suez e dal Mediterraneo, infatti, i tempi di trasporto di un container dalla Cina verso
una destinazione europea – sbarcando in un porto italiano – potrebbero ridursi di 5-7
giorni, con risparmio di tempi e costi sia per il destinatario che per il vettore, facendo
recuperare al sistema italiano efficienza e rilevanza di natura geopolitica.
E proprio per questo che negli ultimi anni, senza conquistare le prime pagine dei
quotidiani, si è svolta una vera e propria guerra per la conquista dei porti italiani. Ma i
porti commerciali italiani ammainano sempre più il tricolore e issano le bandiere di
Germania, Danimarca, Cina, Singapore e Taiwan. Dal 2000 a oggi una vera e propria
battaglia navale senza esclusioni di colpi sta caratterizzando la gestione diretta dei
terminal container degli scali mediterranei e l'Italia è sempre più terra di conquista per
la sua centralità nella geografia d'area e mondiale.
Nel 2004 - secondo il ministero delle Infrastrutture - 19 Autorità portuali avevano in
corso 1.286 concessioni commerciali. Di queste 271 erano appannaggio dei
terminalisti, 888 erano destinate ad attività commerciali e 94 riguardavano i magazzini.
Un numero enorme e crescente che, oltretutto, non tiene conto di cinque Authority:
Genova, Catania, Civitavecchia, Palermo e Trapani, oltre a Manfredonia che si è
aggiunta alla lista negli ultimi mesi.
Il business commerciale - che riguarda sempre di più la movimentazione e lo
sdoganamento dei container dall'Asia e in particolare da Cina e India - è quasi tutto
nelle mani dei gruppi stranieri che dal 1996 continuano a essere scossi da alleanze,
acquisizioni e fusioni, destinate nel prossimo futuro a lasciare sulle rotte solo un pugno
di imprese mondiali con ingenti capitali e risorse. Le prime dieci società al mondo già
controllano il 55% della domanda globale (era il 33% nel '95) e hanno in mano il 65%
dell'handling (era il 30% nel '96). Sullo sfondo ci sono le previsioni di traffico delle
merci verso l'Europa che, nel prossimo decennio, crescerà senza soste.
Italia in ritardo, Europa e Africa in rimonta. L'Italia, nelle mappe di navigazione,
giocherà un ruolo fondamentale. Già ora, attraverso i porti, passa l'80% dell'importexport. La capacità complessiva dei terminal container italiani è stata stimata da Ocean
shipping consultants in circa 13 milioni di Teu. Se si considera il volume di traffico
registrato nel 2005 - 9,7 milioni - la saturazione dell'insieme dei porti è del 73%:
127
valore vicino alla soglia critica del 75-80% oltre il quale il terminal rischia di operare
in diseconomia.
Se le risposte del sistema portuale italiano sono incerte, certe sono invece le risposte
dei Paesi competitori nel Mediterraneo, per non dire del Nord Europa. In Egitto, Port
Said è entrato in funzione rispettando i tempi, così come i lavori dei nuovi terminal di
Tangeri, in Marocco, stanno rispettando il calendario. La Tunisia prevede la
realizzazione di due nuovi terminal container e l'Algeria presto privatizzerà i porti.
Barcellona sta realizzando un nuovo terminal container su un'area di 93 ettari e con
una linea di banchina di 1.500 metri (l'entrata in funzione del primo lotto è prevista nel
2008). E’ noto che i cinesi preferiscono avere la gestione diretta dei terminals, questo li
ha attirati nei porti spagnoli anche se sono più lontani dalla traiettoria più breve SuezGibilterra come porti hub.
A fronte di ciò, continua la netta supremazia dei porti del nord Europa dovuta a fattori
ben definibili. Il nord Europa ha un mercato alle spalle di import-export maggiore di
quello dell’Europa meridionale. In particolare c’è una maggiore capacità di export dei
paesi del nord Europa. Questo è importante anche per il fatto che nell’imbalance
esistente fra import dalla Cina (ed il Far East) ed export europeo verso la Cina, i
containers che rimangono vuoti e che rappresentano un costo per le compagnie, al nord
sono meno numerosi che al sud. La delocalizzazione in Cina di alcune fasi di
produzione di diverse grandi società vede un rapporto diretto di tipo industriale del
nord Europa con quel paese. Sono numerose le linee cinesi e le concessioni a società
cinesi nei porti del nord Europa. Amburgo, tradizionale porto per gli scambi colla
Cina, offre il maggior numero di scali dei porti del nord alle linee Cosco, China
Shipping Container Line e Sinotrans. La Coscon e l’Hanijn dal 2005 fanno scali su
tutti i porti del nord dall’Inghilterra alla Germania con 31 navi da 5500 teu.
Per Anversa, nel contesto di una ulteriore concessione ai vettori marittimi, la PSA di
Singapore ha stipulato un accordo che assicura alla Yang Ming coreana, alla Hanjin
cinese ed alla K Line ormeggi dedicati presso il proprio terminal PSA HNN
Deurganck. La Cosco ha acquisito il terminal concorrente Antwerp Gateway sull’altro
lato del Deurganckdok, nel quale già dispone di una quota del 20%: (Fonte:
Containerisation International, ottobre 2005); i porti del nord Europa hanno la capacità
di attirare i containers non solo del nord Italia ma di tutti i paesi a ridosso delle Alpi
fino ai nuovi paesi dell’est . Questi paesi, invece, come numero di kilometri via terra
sarebbero più vicini ai porti di Genova e Trieste a loro volta più vicini via mare
128
all’Oriente; dato il gran numero di teu, i porti del nord Europa hanno la capacità di fare
notevoli economie di scala e dunque costi totali più bassi, ma sanno anche organizzare
i viaggi inland dei contenitori in tempi affidabili e brevi sia coi treni che coi camion.
Questo non avviene assolutamente nei porti italiani tanto che un container sbarcato a
Genova arriva a un interporto piemontese via treno dopo 13 giorni. In sostanza i
costosi giorni in più via mare per raggiungere i porti nord europei vengono in gran
parte o totalmente recuperati nel viaggio di distribuzione via terra che pure, come
abbiamo detto, per un certo arco geografico vedrebbe i porti italiani più vicini; infine
ci pare molto rilevante il fatto che per attirare in particolare merci cinesi bisogna curare
altri elementi. Per primo agevolare concessioni nei porti sia a terminal operators che a
compagnie cinesi, ma anche favorire gli investimenti cinesi in tutta la catena logistica
inland. Queste ultime, come le compagnie di qualsiasi nazionalità, sono in genere mal
viste in Italia come gestori dei porti. Solo la Cosco ha con MSC in concessione un
terminal a Napoli. Secondo, è necessario un elemento più complesso: le
compagnie/terminal operators europee, come quelle di tutto il mondo, hanno una
politica di notevolissimi investimenti infrastrutturali nei terminals cinesi insieme coi
soggetti pubblici o privati cinesi. Compagnie e terminalisti offrono anche la loro lunga
esperienza gestionale nei porti che manca ai cinesi. Dopo di che le compagnie o i
terminal operators si assicurano gli scambi in gran crescita da quei porti e portano in
Europa i teu nei terminals e/o che sono gestiti da loro e/o che offrono i migliori tempi e
costi totali mare-terra. Un chiaro esempio della partecipazione finanziaria e gestionale
nei maggiori porti cinesi lo offrono la grande China Merchant di Hong Kong (presente
nei porti a Shekou e Chiwan in Shenzhen e Quindao in Zhanzhou…); la Hutchison
Wampoa di Hong Kong. La terminalista Hutchison è la società con le più numerose
partecipazioni finanziarie nei porti cinesi (Shanghai, Shanghai Pudong, Quingdao,
Shenzhen….); la Dubai ports che acquisì nel 2004 l’americana CSX (Ningbo…); la
francese CMA-CGM (Ningbo, Chiwan….); la PSA di Singapore (Dalian,
Guangzhou….); la Maersk a Hangzhou il faraonico porto davnti a Shanghai, Chiwan
etc. In Italia non ci sono compagnie di linea (il Lloyd triestino è ora di Evergreen,
taiwanese) o grandi terminal operators che offrono expertise e investimenti, ma non se
ne attira neppure la presenza concentrando gli investimenti pubblici nelle facilities
portuali e inland di pochi porti per abbassare tempi e costi del transito dei teu.
Puntualizziamo che l’incapacità italiana di abbassare i costi e tempi totali mare-terra si
129
riflette sui noli che, per arrivare dalla Cina non differiscono molto per i porti del nord
Europa o per il Mediterraneo, anzi possono essere più bassi al nord.
Tutti questi aspetti ed altri ancora parrebbero schiacciare le possibilità dei porti italiani
Comunque ci sono aspetti positivi che possono rilanciare i porti italiani e soprattutto
Genova e Gioia Tauro. L’aspetto positivo più importante è costituito dal fatto che i
traffici containerizzati dal Far East e dalla Cina cresceranno e passeranno in gran
numero da Suez.
Altri due aspetti importanti sono costituiti dal fatto che il Mediterraneo, che è su uno
dei principali flussi di traffico mondiali dal Far East all’Europa, è oggettivamente
interessante dal punto di vista dei traffici e che i due più importanti operatori del
mondo nel campo dei containers (Hutchinson Wampoa Limited HWL di Hong Kong e
Singapore Port Authority SPA, ma anche terminal operator come Contship, che è il più
presente nei porti italiani, ed altri) hanno sia sul versante Sud dell’Unione Europea
come sul versante Nord una importante costellazione di terminal containers in
concessione. Questo significa che, se vedessero che è più conveniente, potrebbero
dirigere più traffico nel Mediterraneo. Infatti sono i grandi players come gli accordi fra
di loro che fanno le scelte di base circa i porti.14
E’ anche per questo che la competizione nei principali porti italiani ha subito, negli
ultimi anni, una forte accelerazione. Il gruppo tedesco Eurogate, attraverso la società
Contship, fa la parte del leone in Italia, dove ha investito oltre 550 milioni in questi
anni. Da solo questo gruppo "muove" 5,2 milioni di Teu sul totale di 9,7 (dati 2005).
A Gioia Tauro e Cagliari gestisce i terminal container con Maersk Sealand, socio
danese di minoranza. Alla Spezia il socio di minoranza è Msc mentre a Ravenna
l'alleanza è con il gruppo italiano Sapir (che detiene il 70% delle azioni) e a Livorno la
gestione è con la locale Compagnia Portuale. A Salerno - porto in grande ascesa Contship è socio di minoranza. Questi sei porti complessivamente nel 2005 hanno
movimentato 6,1 milioni di Teu: il 64% del totale.
Il caso Liguria. Contship ha presentato un reclamo a Bruxelles e un ricorso al Tar
contro la procedura di assegnazione del Sesto modulo del porto di Genova Voltri a Vte
spa (gruppo Pso di Singapore) che controlla al 100% il gruppo Sinport (ex gruppo
14
D. Cazzaniga Francesetti, Il futuro della portualità italiana: una scommessa difficile, 2006.
130
Fiat). Il contenzioso tra i due gruppi prosegue e ora le carte bollate continuano a
piovere sui tavoli dei giudici.
Genova - che nel 2005 ha movimentato 1,6 milioni di Teu - fa gola a molti. Finemme
spa (Gruppo Messina) ha deciso, a esempio, di vendere il 51% della "Meccanica
generale" a Portek international di Singapore attraverso la controllata Portek system &
equipment Pte. In questo porto, comunque, la prima a sbarcare fu l'italiana Sech (1993)
e poi Messina spa (1996).
Complessivamente gli investimenti dei tre gruppi in impianti, macchinari e attrezzature
è stato di 215 milioni di cui ben il 65% del gruppo Vte di Singapore.
Nel vicino porto di Savona Vado - che nel 2005 ha movimentato 223mila Teu a fronte
degli 86mila del 2004 - opera dal 2000 una società tutta italiana: Reefer terminal che fa
capo alla divisione logistica di Gf group che grazie all'acquisizione delle flotte di Costa
container lines (1998) e Grandi traghetti/Gilnavi (2004) è ai vertici dell'armatoria
italiana.
L'incrocio Taranto-Trieste. Il gruppo Evergreen (Taiwan) gestisce il Tct, Terminal
container di Taranto (716mila Teu nel 2005) che è di fatto monocliente. Evergreen è
anche protagonista nel terminal che gestisce il molo VII di Trieste e ha una quota nel
Roma container terminal.
La storia di Evergreen si incrocia con quella del gruppo Sisam (famiglia Maneschi)
presente a Taranto dal giugno 2001 ma, soprattutto, gestore dello scalo di Trieste 201mila Teu movimentati nel 2005 ma porto dalle enormi potenzialità - dalla fine del
2003, allorché la società ha formalizzato l'acquisto del 100% della Trieste international
container terminal, oggi Tmt.
Lo scalo triestino fa gola anche da altre compagnie straniere. È il caso della Schenker
& Co. Ag di Vienna, attiva dal 2002, che ha annunciato di rilanciare l'attività di
logistica nell'area. A svolgere attività di terminalista punta anche Steinweg
Handelsween B.V. di Rotterdam. Intanto i capitali russi sono entrati nel terminal
triestino Ferriere di Servola, con il magnate siderurgico Alexey A. Mordashov che
avendo acquistato la maggioranza della società Lucchini, proprietaria della Ferriera,
controlla di fatto lo scalo.
Lo sviluppo di Napoli. Il gruppo cinese Cosco è invece presente a Napoli (molo
Bausan) con il 50% del consorzio Conateco. Il restante 50% è di Msc, il gruppo italosvizzero alla cui guida c'è Gianluigi Aponte. Il consorzio si è anche candidato alla
gestione della costruenda darsena a Levante che, entro quattro anni, sarà in grado di
131
movimentare oltre 1,2 milioni di Teu, portando il totale a circa due milioni all'anno.
Tra quattro anni, quando saranno ultimati i lavori del terminal Levante, Cosco e Msc
(che metteranno 230 milioni di euro per le infrastrutture) abbandoneranno l'attuale
terminal Conateco per andare a gestire le nuove.
Un trasloco che aprirebbe scenari inaspettati. E che potrebbe favorire proprio China
Shipping, l'altro operatore cinese presente in Italia, finora attivo però solo come cliente
dei terminal di Napoli e Genova e non come gestore. Molti, nel settore, ritengono che,
quando si aprirà una gara per la gestione del terminal Conateco, si creerà un pool di
compagnie armatoriali che in joint venture con operatori italiani parteciperà alla gara.
Il Consorzio lascerà l'attuale banchina e la gestione sarà messa a gara. C'è da
scommettere che sarà ancora appannaggio di stranieri. Gli investimenti a Napoli sono
ingentissimi. Conateco punterà 216 milioni per il nuovo scalo ai quali si aggiungono i
190 dell'Autorità portuale.
Ogni tanto, qualche capitale estero fugge, soprattutto a causa della burocrazia, dei
tempi lunghi con i quali vengono prese le decisioni e delle incertezze sugli
investimenti in infrastrutture di parte pubblica. È il caso di Brindisi, dove era presente
fino allo scorso anno la società Malta freeport con un suo terminal.
Per in Nord-Est lo snodo di tutto è il porto di Venezia con le sue vaste aree di
retroporto, ma soprattutto una Marghera che, messa da tempo in discussione come polo
industriale pur con l'impegno a recuperare lavorazioni innovative e un ciclo di chimica
compatibile, potrebbe tornare a pieno titolo alla sua denominazione originale di Porto
Marghera. Anche per Ravenna si profila un crescente interesse da parte dei cinesi, non
però per il traffico dei container ma il traffico convenzionale. Nel dettaglio si profila,
infatti, l'apertura di un terminal per lo sbarco di prodotti siderurgici.
132
Conclusioni
Il fenomeno dell’internazionalizzazione del capitalismo cinese è ancora nelle sua fasi
iniziali. E’ pertanto azzardato dare una connotazione positiva o negativa a tale
internazionalizzazione in assoluto.
In prima battuta si può dire che in alcuni casi gli effetti economici di tali investimenti
sono estremamente positivi, si pensi ad alcuni casi italiani come quello della Benelli,
meno positivi appaiono gli effetti politici derivati che si stanno avendo in Africa e che
rischiano di verificarsi in America Latina.
Pechino è senza dubbio impegnata a conquistare quegli assets materiali ed immateriali
che possano aumentare la propria potenza economica, ma non per questo si può
giustificare un isterismo da invasione o da svendita dei gioielli dell’industria occidentale
ad un paese che potrebbe usarli per sostenere le proprie aspirazioni di egemonia
regionale o globale.
Quello che maggiormente conta, a nostro avviso, è che Pechino non stia dando avvio,
con quei capitali, ad una politica di impost-substitution né sta varando una politica di
potente riarmo delle proprie forze armate, se non per prepararle a sostenere una
eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan. Al contrario le autorità
cinesi, spingendo le proprie imprese e i propri capitali oltreconfine, manifestano la
propensione a legare sempre più la Cina a quell’ambiente economico internazionale da
cui già oggi dipende la propria crescita economica e che potrebbe essere turbato
profondamente da un cambiamento di atteggiamento da parte cinese nei confronti
dell’attuale ordine internazionale.
Pechino quindi aspira ad utilizzare le proprie risorse economiche secondo le logiche
economiche del potenziamento dei propri campioni nazionali e dell’acquisizione di
marchi che possano aprire i ricchi mercati internazionali alle produzioni cinesi. Non sta
quindi adoperando a fini politici e di potenza quelle ricchezze.
Che fare? L’isterismo manifestato da alcuni paesi è disfunzionale sia da un punto di
vista economico, privando da una parte i propri mercati di una importante liquidità non
speculativa, dall’altra rischiando di intaccare la strategia di integrazione della Cina in
funzione costruttiva nell’attuale ordine internazionale. Chiudere le porte agli
investimenti cinesi può essere infatti in primo passo per provocare un cambiamento di
133
atteggiamento a Pechino ed alterare la percezione della propria sicurezza e delle proprie
aspettative di sviluppo.
Più saggio sarebbe quello di disegnare una griglia normativa che regolamenti questi
investimenti, dichiarando, sin dall’inizio, quali sono i settori ed i campi non scalabili e
quali meccanismi possono scattare per evitare acquisizioni di tecnologie che possono
avere ampie e pericolose ricadute nel campo della difesa.
L’eventualità dell’istituzione di una golden-share appare alquanto pericolosa, sia perché
tale clausola rischia di essere applicata in maniera umorale o preconcetta sull’onda di
campagne stampa o di pressioni lobbystiche sia perché, lasciando una ampia dose di
discrezionalità ai governi rischia, di toccare con ancora più forza la suscettibilità cinese,
con il rischio di causare gravi ricaduta strategiche sull’atteggiamento cinese nei
confronti dei mercati internazionali.
In questo campo il nostro paese può farsi promotore, a livello europeo, di una
regolamentazione “preventiva” di tali investimenti ed in particolare dei fondi sovrani,
con l’obiettivo di regolare l’isterismo di alcuni con uno sguardo teso agli interessi della
nostra economica.
E’ noto che il nostro Paese patisce una penuria di fondi di investimento non speculativi
ma a respiro industriale. Tale dato va considerato insieme anche alla nostra penuria di
imprese multinazionali, che per strutture, dotazioni finanziarie e potenzialità di mercato,
abbiano respiro globale. Non solo, ma il nostro Paese ha negli ultimi trent’anni patito un
declino industriale tanto grave quanto insensato, come descrive Luciano Gallino nel suo
libro “La scomparsa dell’Italia industriale”. Ultimo elemento è quello della posizione
geografica del nostro Paese, che, dopo esserlo stato relegato in posizione periferica nei
traffici internazionali dopo la scoperta dell’America, ora ritorna al centro dei flussi
commerciali. Quella stessa centralità che, in parte, fece le fortune di Venezia e Genova.
Sulla base di questi elementi, l’Italia potrebbe essere uno dei paesi a trarre maggiore
utilità dagli investimenti cinesi, regolamentati da una legislativa del tipo che si diceva
poc’anzi. Come nel caso della Benelli quegli investimenti potrebbero ridare vita a
importanti settori industriali, in immeritata crisi. Il dato fondamentale è, infatti, che da
quanto sin qui rilevato gli investimenti cinesi tendono a “trarre vantaggio” soprattutto di
quegli assets immateriali del nostro paese dovuti soprattutto alla conoscenza.
A ciò si aggiunga che anche il mezzogiorno d’Italia per la sua posizione geografica
potrebbe trarre grande vantaggio dagli investimenti cinesi che puntano a creare, in
134
collegamento con i porti del sud, degli insediamenti produttivi di lavorazione delle
merci che arrivano dall’Asia.
In conclusine ci pare che il flusso crescente di risorse che dalla Cina, si riverseranno sui
mercati internazionali, siano una occasione da non perdere, in questa fase di
globalizzazione di ritorno, per cercare di trarne vantaggio da un punto di vista
industriale e di incremento della competitività anche del nostro paese, alla luce
comunque di una chiare normativa di regolamentazione.
Perdere tale occasione significa, da una parte porre un freno al processo di integrazione
di Pechino nel sistema internazionale e quindi di una sua normalizzazione, e dall’altro
autoestromettersi da questa nuova fase dei commerci internazionali.
135
Allegati
China's outward FDI flow by countries and regions,2003-2006(Non-Finance Part)
(millions of US $)
136
137
138
139
140
China's outward FDI stock by countries and regions,2003-2006(Non-Finance Part)
141
142
143
144
145
146
147
Distribution of Chinese outward FDI flow by industry,2004-2006
(millions of US $)
148
Distribution of Chinese outward FDI stock by industry,2004-2006
(millions of US $)
149
Chinese outward FDI flow by province,2003-2006(Non-Finance Part)
(millions of US $)
150
Bibliografia
Accenture, (2005) China spreads its wings –Chinese companies Go Global,
Amighini A., Chiarlone S. (2003), “Rischi e opportunità dell’integrazione commerciale cinese
per la competitività internazionale dell'Italia”, CESPRI Working Papers, 149.
APEC Economic Committee (1995) Foreign Direct Investment and APEC Economic
Integration, APEC Secretariat: Singapore.
Areddy J.T., Karmin C., Phillips M. (2006), China Eases Investment Ban, Washington Post, 14
aprile.
Areddy, James T. “China Boosts GDP Rates to Reflect Services Gains.” The Wall Street
Journal. January 10, 2006.
Arndt S.W., Kierzkowsky H. (2001), Fragmentation. New Production Patterns in the World
Economy, Oxford University Press, Oxford.
Asia Pacific Foundation of Canada, (2005), China Goes Global: A Survey of Chinese
Companies’ Outward Direct Investment Intentions, Asia Pacific Foundation of Canada.
Asia Pacific Foundation of Canada, (2006), China Goes Global – II, 2006 Survey of Chinese
Companies’ Outward Direct Investment Intentions, Asia Pacific Foundation of Canada.
Asia Pacific Foundation of Canada. “Bid for CP Ships Again Raises the Issue of Chinese State
ownership.” Asia Pacific Bulletin. No.220, August 5, 2005. 23 November 2005.
http://www.asiapacificbusiness.ca/apbn/pdfs/bulletin220.pdf
Asia Pacific Foundation of Canada. “China is Becoming a Global Investor. Can Canada
Benefit?” Asia Pacific Bulletin. No.175, September 10, 2004. 23 November 2005.
http://www.asiapacificbusiness.ca/apbn/pdfs/bulletin175.pdf
Automotive World, “Latin America: Chinese firms anticipate strong regional growth.” January
23, 2006. Automotive World.
Baltagi, Badi H., Chihwa Kao, and Long Liu, 2007, “Asymptotic Properties of Estimators for
the Linear Panel Regression Model with Individual Effects and Serially Correlated
Errors: The Case of Stationary and Non-Stationary Regressors and Residuals,” Center
for Policy Research Working Paper No. 93, Syracuse University.
Battat J. (2006), China’s Outward Foreign Direct Investment, FIAS, World Bank Group.
BDA, “Huawei and ZTE: Going Forth, Can they Conquer?” BDA research report. March 2005.
Beebe A., Hew C., Yueqi F., Dailun S. (2006), Going global. Prospects and challenges for
Chinese companies on the world stage, IBM Institute for Business Value.
Bellabona P., Spigarelli F. (2006), Corporate China va in Italia, Il Sole 24 Ore, 21 novembre
2006.
Berner, Robert, David Kiley, et al. “Special Report: The Best Global Brands.”
BusinessWeek/Interbrand. August 1, 2005.
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_31/b3945098.htm
Berner, Robert, David Kiley, et al. “Special Report: The Best Global Brands.”
BusinessWeek/Interbrand. August 1, 2005.
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_31/b3945098.htm
Billington, Nicholas, 1999, “The Location of Foreign Direct Investment: An Empirical
Analysis,” Applied Economics 31, 65-76.
Borsari S., Ceccagno A., Gallo A., Gaudino S. (2006), I cinesi e gli altri. L’imprenditoria
extracomunitaria in Italia, Consorzio Spinner (www.spinner.it).
Branstetter L., Lardy N. (2006), China’s embrace of globalization, Working Paper 12373,
National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w12373
151
Buckley P.J. (2004), The role of China in the global Strategy of Multinational Enterprises,
Journal of Chinese Economic and Business Studies, vol 2, No.1
Cai, Kevin G. (1999), “Outward Foreign Direct Investment: A Novel Dimension of China’s
Integration into the Regional and Global Economy”, The China Quarterly, 160: 856880.
Cheng, Leonard K. and Zihui Ma, (2007), “China’s Outward FDI: Past and Future,”
manuscript, Hong Kong University of Science and Technology.
China Ministry of Commerce and National Bureau of Statistics. China Outbound Investment
Statistics Report 2004, September, 2005.
de Ramon, Abe,From “Walls to Bridges: How Chinese Companies are redefining international
M&A.” CFO China. November 2005. http://www.cfoasia.com/archives/200511-02.htm
Donaddio M. (2005), L’Italia è lontana, ma la Cina avanza, IlSole24Ore, 16 novembre
Donaddio M. (2005), Sulla via dell’Italia c’è troppa burocrazia, IlSole24Ore, 16 novembre
Downs, Erica S., 2007, “The Fact and Fiction of Sino-African Energy Relations,” China
Security 3, 42-68.
Economist (The), “Chinese firms abroad: Spreading their wings,” 6 September 2003, p.57.
Economist Intelligence Unit (2006), World investment prospects, The Economist, London.
Economist, The struggle of the champions, Jan 6 2005
Editorial Board of the Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade, 2002,
Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade , China Foreign Economic
Relations and Trade Publishing House.
Evens, Peter C. and Erica S. Downs, 2006, “Untangling China’s Quest for Oil through StateBacked Financial Deals,” Policy Brief #154, The Brookings Institution.
Frost S. (2004), Mainland Outward Direct Investment in Asean: a new form of regional
bilateralism, SEARC, City University of Hong Kong, working paper, n. 67.
Fubini F. (2006), Il distretto di Prato? Salvato dai cinesi, Corriere della Sera, 7 luglio.
Geoff Dyer and James Mackintosh. “Chinese rev up industrial capacity to assail global vehicle
market.” Business Day (South Africa). June 2, 2005.
Gilmore, Fiona and Serge Dumont (2003), Brand Warriors: China Creating Sustainable Brand
Capital. London: Profile Books Ltd.
Goldstein A., Bonaglia F., Mathews J. (2006), Accelerated Internationalization by Emerging
Multinationals: The Case Of White Goods, OECD Paper.
Guidi P. (2001), E a Varese sbarcano i cinesi, IlSole24 Ore, 14 dicembre.
Guidi P. (2001), Shopping cinese in Italia, IlSole24 Ore, 23 giugno.
Gunter, F. R. (2003), “Capital Flight from the People’s Republic of China: 1984-2001”, China
Economic Review, forthcoming.
Hess W. (2006), Going Outside, Round tripping and dollar diplomacy: an introduction to
outward direct investment, Global Insight Inc..
Hill, Hal (1996) ‘People’s Republic of China-Recent Economic Developments’, Staff Country
Report No. 96/40, Washington, D.C.
Hong E., Sun L. (2004), Go overseas via Direct Investment. Internationalization strategy of
Chinese Corporation in a comparative prism, Discussion Paper 40, Center for financial
and management studies, SOAS University of London.
Hong E., Sun L. (2004), Go Overseas via Direct Investment: Internationalisation strategy of
Chinese Corporations in a Comparative Prism, Department of Financial Studies,
SOAS, University of London.
Jacobs S. (2002), An OECD Perspective on Regulatory Reform in China¸ in China in the
World economy: the domestic policy challenges, OECD.
Jadeluca P. (2006), Uno stabilimento di R&S in Italia. Procede l’avanzata della Huawei, Affari
e Finanza, 26 giugno.
152
Jiang W. (2006), Survey: Firms achieve goals abroad, in China Daily, 14 giugno.
Li A. (2005), The Internationalisation of Chinese Enterpises Compared with Japanese
Enterprises, Master Thesis – Master Programme in Asian Studies, Center for East and
South-East Asian Studies, Lund University
Li Chao and Cui Haiyan. “Report on Huawei’s Internationalization.” IT Times Weekly. October
9, 2004.
Long G. (2005), Does Foreign Direct Investment Promote Development?,China’s Policies on
FDI: Review and Evaluation.
Maddison, Angus, 1998, “Chinese Economic Performance in the Long Run,” Paris:
Organization for Economic Cooperation and Development.
Manning, Chris and Pang Eng Fong (1990) ‘Labour Market Trends and Structures in ASEAN
and the East Asian NIEs’, Asian Pacific Economic Literature, Vol. 4, No. 2 (September
1990), pp. 59-81.
Martyn, Davies. “Emerging markets.” March 7, 2005. Business Day (South Africa).
Mcdermott, Michael and Huang, Chun Hua (1996), “Industrial State-owned Multinationals
from China: The Embryonic Years, 1985~92”, Asia Pacific Business Review, 3(1): 115.
Mizra, Hafiz (2000), “The globalization of Business and East Asian Developing-Country
Multinationals”, in Hood, Neil and Stephan Young (eds.), The Globalization of
Multinational Enterprise Activity and Economic Development, London: Macmillan,
pp.202-224.
Morelli A. (2004), Cina alla conquista degli oceani, Altraeconomia, luglio-agosto.
OECD, 2003, Investment Policy Review of China: Progress and Reform Challenge, Paris:
Organization for Economic Cooperation and Development.
OECD, 2005, OECD Economic Surveys - China 2005, Paris: Organization for Economic
Cooperation and Development.
People's Daily Online, 2006, “China-Africa Energy Co-op, Why the West Pokes Nose,”
http://english.people.com.cn/200604/30/print20060430_262310.html.
Rossi M. (2005), “L’economia cinese si proietta verso l’estero”, Relazioni internazionali, n. 19,
febbraio (http://www.ispionline.it/it/documents/ispiri19rossi.pdf).
Schüller M., Turner A. (2005), Global Ambition: Chinese Companies Spread Their Wings,
China Aktuell, n. 4.
Sicular, Terry (2000), “Capital Flight and Foreign Investment: Two Tales From China and
Russia”, World Economy, 12(5): 589-602.
Sung, Yun-Wing (1996), “Chinese Outward Investment in Hong Kong: Trends, Prospects and
Policy Implication”, OECD Development Centre Technical Papers 113.
Tan W. (2005), Culture Conflicts in Sino-Foreign Ventures, Beijing Review, 23 giugno.
Tan, Rosalina (2001), “Foreign Direct Investment Flows to and From China”, in Palanca, Ellen
H. (ed.), China’s Economic Growth and the ASEAN, Manila: Philippine APEC Study
Center Network and the Philippine Institute for Development Studies.
Tang, Xu and Kui-Wai Li (1997) ‘Money and Banking in China’. In Financing China Trade
and Investment, (ed.) Kui-Wai Li, Praeger: London.
Tateishi, Yoji (1998) ‘The Current State of Foreign Direct Investment in China’, Journal of
Asian-Pacific Studies, No. 3, December 1998.
The Economist, 2006, “More of Everything: Does the World Have Enough Resources to Meet
the Growing Needs of the Emerging Economies,” September 14th 2006,
http://www.economist.com/surveys/displaystory.cfm?story_id=7878050.
Toccafondi D. (2005), Ombre cinesi nel distretto di Prato, Economia & Management, n. 5.
153
Tseng, Choosin (1996), “Foreign direct investment from the People’s Republic of China”, in
Henri-Claude de Bettignies (ed.), Business transformation in China, London:
International Thomson Business Press. pp. 85-114.
Tseng, Choo-sin and Simon K.M. Mak (1996) ‘Strategy and Motivation for PRC Outward
Direct Investments with Particular Reference to Enterprises from the Pearl River Delta’.
In Economic and Social Development in South China, (eds.) Stewart MacPherson and
J.Y.S. Cheng, Edward Elgar.
UNCTAD, “World Investment Report.” 2006.
UNCTAD, 2003, China: An Emerging FDI Outward Investor, E-Brief, United Nations, New
York and Geneva.
UNCTAD, 2004, Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational
Corporations, 2004-2007, The Global Investment Prospects Assessment (GIPA).United
Nations, New York and Geneva.
UNCTAD, 2005, Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational
Corporations, 2005-2008 - The Global Investment Prospects Assessment (GIPA)
.United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD, 2006, World Investment Report, United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD, 2007, Asian Foreign Direct Investment in Africa: Towards a New Era of
Cooperation among Developing Countries, United Nations, New York and Geneva.
Wall, David (1997), “Outflow of Capital from China”, OECD Development Center Technical
Papers 123.
Wang, Jian-Ye, 2007, “What Drives China’s Growing Role in Africa?” IMF Working Paper,
WP/07/21.
Wang, Mark Yaolin (2002), “The Motivations behind China’s Government-Initiated Industrial
Investment Overseas”, Pacific Affairs, 75 (2): 187-206.
Wells, Louis T. Jr. (1983), Third World Multinationals: The Rise of Foreign Investment from
Developing Countries, Cambridge, MA: MIT Press.
Wong J., Chan S. (2003), China’s outward direct investment: expanding worldwide, China: An
international Journal, 1(2).
Wong, John and Chan, Sara (2003), “China’s Outward Direct Investment: Expanding
Worldwide”, China: An International Journal, 1(2): 273-301.
Woo, Wing Thye (1999) ‘The Real Reasons for China’s Growth’, The China Journal, No. 41,
pp. 115-137.
Wu F. (2005), China Inc.: How Chinese companies have discretely internationalized their
operations, International Economy, Fall.
Wu F. (2005), The Globalization of Corporate China, NBR Analysis, vol. 16, n. 3
Wu, Friedrich (1993), “Stepping out the door”, China Business Review, 20(6): 14-19.
Wu, Friedrich and Yoeo Han Sia (2002), “China’s Rising Investment in Southeast Asia: Trends
and Outlook”, Journal of Asian Business, 18(2): 41-61.
Wu, Hsiu-Ling and Chen, Chien-Hsun (2001), “An Assessment of Outward Foreign Direct
Investment from China’s Transitional Economy”, Europe-Asia Studies, 53(8): 12351254.
Xinhua, “Chinese companies backed to go global.” Xinhua China Economic Information
Service. March 5, 2006.
Xinhua, China’s overseas investment becomes potential source of South-South cooperation:
UN Offical, 11 settembre 2006.
Zeng, Ming and Petter J. Williamson (2003), “The hidden Dragons”, Harvard Business
Review, 81(10), Oct 2003, pp. 92-99.
Zhan, James Xiaoning (1995), “Transnationalization and outward investment: the case of
Chinese firms”, Transnational Corporations, 4(3): 67-100.
154
Zhang K. (2005b), Going Global. The Why, When, Where and How of Chinese Companies’
Outward Investment intention, Asia Pacific Foundation of Canada.
Zhang, Hai-Yan and Daniel van den Bulcke (1996a), “International management strategies of
Chinese multinational firms”, in John Child and Yuan Lu (eds.), Management Issues in
China: Volume II, International Enterprises, London: Routledge.
Zhang, Hai-Yan and Danny van den Bulcke (1996b), “China: rapid changes in the investment
development path”, in Dunning, J. H. and Rajneesh Narula (eds.), Foreign Direct
Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, London:
Routledge.
Zheng, Yiyong (1988) Business Guide to China’s Coastal Cities, Foreign Languages Press:
Beijing.
155