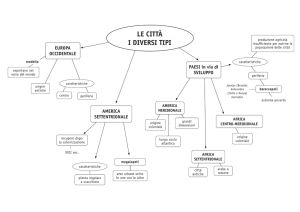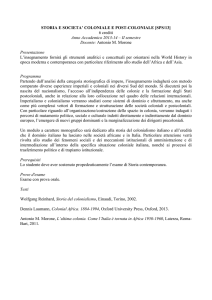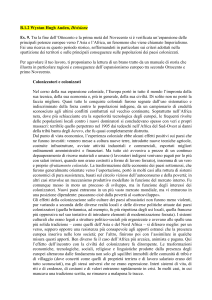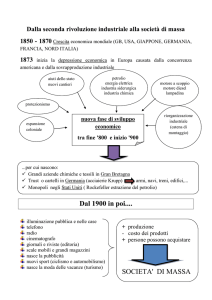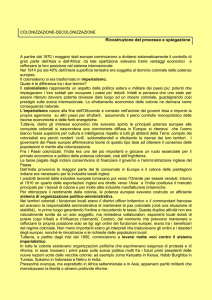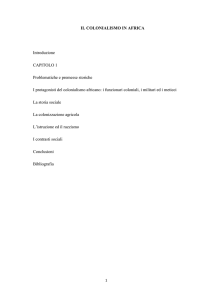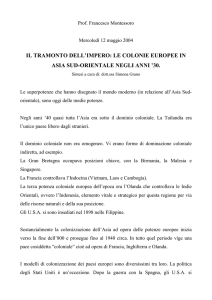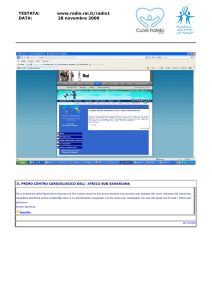ISSN 1826-7920
7-8
I SENTIERI DELLA RICERCA
� 30,00
78
I
SENTIERI
DELLA RICERCA
rivista di storia contemporanea
Del Boca
Gregori
Scaglione
Cresti
Clodomiro
Lenci
Baccelli
Pipitone
Morone
Zilio
Dondi
Costa
Boggero
Fabei
Rochat
Labanca
Benardelli
Fontana
Romandini
Capra Casadio
Germinario
settembre 2008
EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO
I SENTIERI DELLA RICERCA
rivista di storia contemporanea
EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO
I Sentieri della Ricerca
è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo.
Direttore
Angelo Del Boca
Condirettori
Giorgio Rochat, Nicola Labanca
Redattrice
Severina Fontana
Comitato scientifico
Marina Addis Saba, Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian
Mario Bravo, Marco Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro,
Basil Davidson, Jacques Delarue, Mirco Dondi, Angelo d’Orsi, Nuruddin
Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo Franzinelli, Sandro Gerbi, Francesco
Germinario, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi, Lutz
Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram
Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco
Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini,
Alain Rouaud, Gerhard Schreiber, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia,
Jean Luc Vellut, Bahru Zewde
La rivista esce in fascicoli semestrali
Direttore Angelo Del Boca
Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi
Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)
Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli
Via Jenghi, 10 - 28877 Ornavasso (VB)
e-mail: [email protected]
N. 7/8 - 1° Sem. 2008
Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005
Poste italiane spa
Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1
Prezzo di copertina � 30,00
Abbonamento annuale � 25,00
Abbonamento sostenitore � 100,00
C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi
via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)
causale abbonamento: ISDR
La pubblicazione di questa rivista
è stata possibile grazie al contributo di:
Provincia del
Verbano Cusio Ossola
Comune di Crodo
Sommario
7
L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano
di Angelo Del Boca
guerre e guerriglie
17
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco (1911-12).
La campagna di stampa sul «Times»
di Barbara Gregori
41
La mia campagna d’Africa
di Giuseppe Scaglione
81
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale in alcuni documenti d’archivio inediti
di Federico Cresti
la politica coloniale
103
161
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo (1916-1919)
di Vanni Clodomiro
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana.
Un primo sondaggio
di Marco Lenci e Sergio Baccelli
183
Foto di gruppo.
Ritratti di ufficiali coloniali
di Cristiana Pipitone
205
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
di Antonio M. Morone
241
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
di Francesca Zilio
il razzismo
281
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio
e sulla stampa (1935-36)
di Mirco Dondi
333
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’:
la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
di Pietro Costa
Africa e dintorni
353
Omar El Mukhtar.
La costruzione della sua memoria ed il gruppo insurrezionale che ne porta il nome
di Marco Boggero
379
La marcia del Marocco verso l’indipendenza.
Il nazionalismo marocchino dalle origini alla seconda guerra mondiale
di Stefano Fabei
423
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
di Giorgio Rochat
439
Un Oltremare wikizzato
di Nicola Labanca
445
L’isola che non c’è: Libertalia
di Mainardo Benardelli
rassegna bibliografica
449
Schede
467
notizie sugli autori di questo numero
L’Africa in copertina
e un nuovo modello di italiano
di Angelo Del Boca
1. Questo numero doppio della rivista è dedicato interamente all’Africa
e al colonialismo, vecchio e nuovo. Ancora una volta, in questa prima metà
del 2008, il continente nero ci inonda di notizie, raramente positive, quasi
sempre a convalidare la convinzione che sia un’autentica polveriera e un
terreno di scontro fra potenze straniere e multinazionali che si contendono
il controllo delle risorse energetiche e dei metalli preziosi.
Il rapporto della Banca Mondiale per il 2007 annunciava, con grande
risalto, che 44 Paesi del continente africano rivelavano per la prima volta
di seguire «lo sviluppo economico del resto del mondo progredito». Anche per il 2008 la Banca Mondiale si mostrava ottimista prevedendo una
crescita del 5,4 per cento. In effetti era la prima volta dal 1960, l’anno
delle indipendenze africane, che il continente nero faceva parlare di sè in
maniera positiva. Ma c’era da fidarsi della Banca Mondiale che in Africa,
notoriamente, ha fatto più guasti che benefici?
È vero che in qualche angolo del continente si sta registrando qualche
progresso. Nel Mali, ad esempio, i Comitati civici nati nei villaggi stanno
combattendo la corruzione e lottano per costruire la democrazia dal basso.
È vero che Soweto, la più miserabile delle township ai tempi della segregazione razziale, si sta miracolosamente trasformando. È anche vero che
la Dakar di Abdulaye Wade è un cantiere infinito e che Kigali, la capitale
del Rwanda, il paese del genocidio, sta diventando la città più ordinata e
pulita del continente. È anche vero che i casi di aids diminuiscono e che è
più facile rifornirsi di medicinali a buon mercato. E che almeno tre Paesi,
Nigeria, Angola e Malawi, sono riusciti a cancellare i propri debiti.
Ma l’ottimismo della Banca Mondiale è eccessivo e sospetto. In realtà
all’origine della crescita sono il petrolio e le materie prime, i cui prezzi hanno subito una formidabile impennata. Ma se ciò può aumentare il potere
d’acquisto di ristrettissimi ceti urbani, non offre alcun beneficio alle grandi
7
Angelo Del Boca
masse contadine e urbane. Purtroppo non c’è un reale sviluppo quando
quasi tutti i Paesi del continente africano continuano a subire il peso del
debito con l’estero e sono strangolati dagli interessi esosi. La vera rinascita
dell’Africa non è per oggi e neppure per domani. Possiamo parlare di un
continente in movimento, ma non di un’Africa sfiorata dal benessere. Si
tenga sempre presente che l’Africa è ancora molto lontana dalle grandi
economie del pianeta. La sua partecipazione al commercio mondiale non
supera il 2 per cento. Ha dunque ancora bisogno dell’aiuto dei paesi più
evoluti. Ma un sostegno sincero, disinteressato, non motivato da calcoli
spregevoli.
Al contrario, come ricorda il sociologo senegalese Aly Baba Faye, le
responsabilità e gli appetiti dell’Occidente sono molto evidenti. «L’elevata
conflittualità – riferisce – è alimentata da fattori di diversa natura e caratterizzata sovente dalla presenza di scontri armati di respiro regionale. Le
ricchezze del continente attirano gli appetiti di grandi potenze straniere
e delle multinazionali. Sul suolo africano si gioca una partita geopolitica
diversa da quella della Guerra fredda. Sono cambiati i termini della contesa. In campo non ci sono più le ex potenze coloniali ma le potenze globali
come gli USA e la Cina. L’oggetto del contendere è il controllo delle risorse
energetiche, il petrolio soprattutto»1. Secondo alcune Ong britanniche, le
guerre locali, che hanno coinvolto 23 dei 53 paesi africani, hanno bruciato
un totale approssimativo di 284 miliardi di dollari, in pratica il totale degli
aiuti forniti all’Africa nello stesso periodo.
L’elenco dei conflitti in atto nel 2008 è nutrito, inquietante. Nel Darfur, dove nel totale silenzio sono state uccise centinaia di migliaia di persone, sta per arrivare, ma con troppo ed ingiustificato ritardo, la missione di peacekeeping dell’Unione europea e dell’Unione africana. In Kenya,
l’annuncio della netta vittoria di Mwai Kibaki nelle elezioni presidenziali
ha scatenato una lotta intertribale che ha causato mille morti e decine di
migliaia di feriti. Nella Somalia continuano gli scontri fra le truppe etiopiche, giunte in soccorso al governo transitorio di Nur Hassan Hussein, e
le Corti islamiche. Nella sola Mogadiscio si contano, in un anno, oltre 7
mila morti, mentre l’esodo dei civili, che investe mezzo milione di somali,
non cessa. Si aggiunga, per completare il quadro di questo paese in pieno
sfacelo, che le coste della Somalia sono infestate da bande di pirati che nel
solo 2007 hanno messo a segno 31 attacchi.
Nel Ciad il governo del presidente Deby è sempre contestato. Il 2 feb8
L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano
braio colonne motorizzate di ribelli che partivano dal confine con il Sudan
hanno investito la capitale N’djamena provocando un bagno di sangue.
Nello Zimbabwe, nonostante che il dittatore Robert Mugabe abbia perso
le elezioni, è riluttante a cedere il potere e lancia i suoi sostenitori contro le
fattorie ancora gestite da bianchi. Incerta, poi, la pace in Costa d’Avorio,
dopo cinque anni di guerra civile. Così come è in pericolo la «pace armata» fra Etiopia ed Eritrea, entrambe scontente dei risultati dell’armistizio
siglato ad Algeri. Si continua anche a combattere nelle province congolesi
che confinano con Uganda, Ruanda e Burundi, nonostante l’accordo di
pace del 2006.
Agli scontri tribali e confessionali si aggiunge, in questi ultimi mesi, lo
spettro della fame. Il raddoppio, in un anno, del prezzo del grano e del riso, pone in estrema difficoltà almeno venti paesi dell’Africa sub-sahariana,
già penalizzati dall’aumento del petrolio che incide sul costo dei trasporti.
Ma anche l’Africa del Nord, seppure con economie più sviluppate, risente
della crisi alimentare, come denunciano le rivolte scoppiate in Tunisia e
in Egitto. La Libia, nonostante abbia incrementato la produzione agricola
grazie al «Grande fiume artificiale», sta trattando con l’Ukraina un accordo
che garantisca a Tripoli i cereali prodotti su 100 mila ettari del Bassopiano
del Dnepr. La fame e le guerre stanno spingendo le popolazioni contadine
nei grandi centri urbani, creando nuovi ed irrisolvibili problemi. Nel 1960,
in tutta l’Africa sub-sahariana, c’era una sola città con più di un milione di
abitanti, Johannesburg. Oggi le megalopoli africane sono una quarantina
e Lagos, in Nigeria, ha superato gli 11 milioni di abitanti. A complicare
la situazione, l’Africa, nonostante tutti i mali di cui è afflitta, sta vivendo
una crescita demografica unica al mondo. Secondo John May, il demografo della Banca Mondiale, la popolazione africana passerà, entro il 2050,
da 769 milioni a 2 miliardi, vale a dire il 19 per cento della popolazione
mondiale2. Si aggiunga, ai mali endemici dell’Africa, quelli provocati dagli stessi africani, con la diffusa corruzione dei potenti e il loro indebito
arricchimento. Da un’inchiesta aperta a Parigi sui lussi francesi di alcuni
capi di Stato africani, è emerso che il presidente del Gabon, Omar Bongo
Ondimbo, possiede in Francia trentatre beni immobiliari, fra i quali un
alloggio sui Champs-Elysées del valore di 18 milioni di euro. L’inchiesta
menziona anche la moglie del presidente del Congo, Sassou Nguesso, che
ha acquistato a Parigi, per i figli, appartamenti per 6 milioni di euro. Non
sfuggono al censimento della brigata finanziaria anche i presidenti della
9
Angelo Del Boca
Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang, del Burkina Faso, Blaise Campaoré,
dell’Angola, Eduardo Dos Santos. Alle ville, ai castelli, agli appartamenti vanno aggiunte le automobili di lusso: Ferrari, Aston Martin, Bugatti,
Mercedes, Maybach, Rolls Royce3.
Com’era diverso, da questi meschini reucci africani, il martinicano
Frantz Fanon, l’autore dell’indimenticabile Les damnés de la terre, un autentico manifesto politico del Terzo Mondo. A pochi giorni dalla morte per
leucemia, scriveva all’amico Roger Tayeb: «Ciò che mi avviliva, qui a letto,
mentre sentivo andarsene col sangue le mie ultime forze, non era il fatto di
morire, ma di morire a Washington di leucemia, mentre avrei potuto morire tre mesi fa davanti al nemico, poichè sapevo di avere questo male. Noi
non siamo nulla su questa terra, se non siamo anzitutto i servi di una causa, della causa dei popoli, della causa della giustizia e della libertà. Vorrei
che lei sapesse che anche quando i medici mi avevano già condannato, io
continuavo ancora nella nebbia a pensare al popolo algerino, ai popoli del
Terzo Mondo, e se ho resistito, è stato per loro»4. Fanon aveva previsto, con
estrema chiarezza, l’affermarsi in Africa di una borghesia di compradores,
che si sarebbe accordata con il colonialismo rallentando l’emancipazione
delle popolazioni africane. E non aveva risparmiato denunce e condanne.
2. Il numero 7/8 di «Sentieri della ricerca» comprende sedici saggi divisi
in quattro sezioni Guerre e guerriglie, La politica coloniale, Il razzismo, Africa e dintorni. Tra gli interventi più rilevanti segnaliamo quello di Antonio
M. Morone dedicato ai lavori dell’AFIS (Amministrazione Fiduciaria Italiana) per portare in un decennio la Somalia all’indipendenza. Il compito
era sicuramente difficile, perchè l’Italia aveva fatto ben poco per sviluppare
la più povera fra le sue colonie. Ma anche il mandato dell’ONU, che si poteva giudicare come un esame di riparazione, non ha dato i risultati sperati.
E gli effetti disastrosi si vedono soprattutto oggi che la Somalia ha perso la
qualifica di Stato sovrano ed è diventata il terreno di uno scontro furioso
fra truppe etiopiche e Corti islamiche.
Di notevole interesse sono anche le memorie dell’artigliere Giuseppe
Scaglione, detto «Pinot», raccolte da Marco Cavallarin. Con grande umiltà, unita ad una straordinaria lucidità venata di autoironia, questo contadino di Santo Stefano Belbo racconta i suoi cinque anni di guerra (prima sul
fronte francese, poi nell’Africa del nord) e la prigionia negli Stati Uniti. Il
periodo più difficile lo vive ad El Alamein, quando si accorge che i cannoni
10
L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano
degli inglesi hanno una gittata di 12 chilometri e quelli italiani soltanto di
9. «Noi, per arrivare a sparare addosso a loro – ricorda – dovevamo fare tre
chilometri sotto il loro tiro». «Pinot» rivela una grande ammirazione per il
generale Rommel, che vedeva quasi ogni giorno «in piedi sulla macchina
scoperta, in piedi col binocolo, e guardava gli inglesi e non si abbassava,
entrava nel fumo delle granate che gli scoppiavano intorno. Niente, era
immortale quell’uomo».
Lavorando sui documenti inediti dell’Archivio politico del ministero
degli Esteri della Repubblica Federale Tedesca, Francesca Zilio ha potuto
ricostruire, per la prima volta, la politica di Bonn nei confronti dell’Africa,
in modo particolare delle sue ex colonie, il Togo e il Camerun. «Gli africani – sosteneva il cancelliere Brandt – sanno valutare che noi cooperiamo
con loro senza porre condizioni politiche. Noi capiamo che essi vogliono
organizzare il loro ordinamento interno sulla base delle loro particolarità
africane. Capiamo anche il loro desiderio di perseguire una politica estera indipendente, senza farsi trascinare nei conflitti delle grandi potenze.
Ci aspettiamo però altrettanta comprensione per la questione essenziale
del popolo tedesco, l’unità nella libertà»5. In altre parole Bonn usava la
cooperazione bilaterale per difendere e favorire la riunificazione delle due
Germanie, applicando la dottrina Hallstein.
Viaggiando nel Medio Oriente e lavorando negli archivi di alcune università americane, Marco Boggero ha potuto valutare l’immensa fortuna
di cui gode ancora oggi Omar al-Mukhtàr, il capo della resistenza antiitaliana in Cirenaica, fatto impiccare da Graziani nel 1931, nel lager di
Soluch, alla presenza di 20 mila confinati fatti affluire dagli altri campi
di concentramento. Nel nome di Omar si combattono oggi nel Vicino
Oriente le lotte più sanguinose, ma non sempre interpretando i veri valori
sostenuti dal vicario di re Idris as-Sanusi.
Fra i saggi più singolari citiamo inoltre quello di Marco Lenci, dedicato
alla toponomastica coloniale in Italia, e quello di Mirco Dondi sulle tecniche impiegate dal fascismo per imporre il mito della razza. Nicola Labanca,
dal canto suo, viaggiando su Wikipedia, si è accorto che la voce sulla storia
del colonialismo italiano pecca di omissioni e di storture e andrebbe riscritta. Per finire Stefano Fabei ci informa, nel suo saggio ricco di sorprese,
che a tenere a battesimo il nazionalismo marocchino sono stati i nazisti, in
funzione anti-alleati, nel corso della 2ª guerra mondiale.
11
Angelo Del Boca
3. Anche se questo numero della rivista è dedicato all’Africa, non possiamo sottacere il significato delle ultime elezioni politiche del 13-14 aprile
2008, che possono impartire una decisa svolta dai risultati inquietanti.
Ci permettiamo quindi di formulare alcune riflessioni a caldo. Come ha
titolato in prima pagina «l’Unità», il 15 aprile, Torna Berlusconi, comanda
Bossi. Il PD sfiora il 34%. Crolla l’Arcobaleno6. Dieci parole per annunciare una disfatta, che supera le previsioni più pessimistiche. E non ci può
confortare il fatto che Veltroni abbia sfiorato il 34 per cento dei voti e
che alla Camera i partiti siano scesi da 30 a 4, quando pensiamo che per
anni (cinque o forse dodici se il Cavaliere vorrà scalare anche il Quirinale)
saremo tormentati dalla sua immagine, ripetuta in maniera continua, ossessiva, orwelliana, nei telegiornali, nei quotidiani, nei settimanali, con il
corredo di dichiarazioni e poi di rituali smentite, di promesse e di battute
da cabarettista.
Ciò che ci stupisce e ci ferisce è che diciassette milioni di italiani abbiano potuto dare il loro voto ad un multimiliardario padrone di tv, di modestissima cultura, dagli atteggiamenti clowneschi, che intende la politica
come puro e cinico esercizio del potere, e che ha dedicato un’intera legislatura a varare leggi ad personam per scansare i giudici e tutelare i propri
interessi. Come ricorda l’autorevole «Wall Street Journal», un quotidiano
sicuramente non «comunista», Berlusconi «è stato al centro di più di una
dozzina di inchieste giudiziarie e ha subito almeno sei processi per reati che
vanno dall’evasione fiscale alla corruzione di giudici. Altrove vicende giudiziarie di questo genere avrebbero messo fine ad una carriera politica»7.
Ma non c’è bisogno di rivangare il passato per stabilire l’assoluta inaffidabilità dell’uomo di Arcore. È sufficiente osservare come si è comportato
durante quest’ultima campagna elettorale. Il 10 marzo, in mezzo alle ovazioni dei suoi sostenitori, faceva a pezzi il programma del Partito Democratico. Il 2 aprile attaccava duramente il Quirinale ipotizzando che la sua
vittoria alle urne avrebbe potuto portare all’uscita di scena del capo dello
Stato Giorgio Napolitano. Il giorno dopo chiedeva la perizia psichiatrica
per i magistrati che indagano. Ma il fatto più clamoroso e rivoltante era
la proclamazione ad eroe di Vittorio Mangano, il finto stalliere di Arcore,
condannato all’ergastolo per associazione mafiosa, per il motivo che non
aveva fatto il suo nome e quello di Dell’Utri durante i processi subiti. Per
questi e molti altri episodi siamo sempre di più convinti che abbia ragione
il «The Economist» quando sostiene che Berlusconi è assolutamente ina12
L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano
datto (unfit) a governare una nazione.
La vittoria del Partito del popolo delle libertà è tanto più pericolosa in
quanto si basa sul netto e determinante apporto della Lega nord, che sogna
una Padania inesistente, venera l’ampolla del dio Po, vanta il legame storico e culturale con i celti, ed è sicuramente un partito populista, xenofobo,
secessionista e antieuropeo. Il 6 aprile, dopo aver minacciato di imbracciare i fucili contro la «canaglia romana», Umberto Bossi soggiungeva: «La
sinistra è fatta di canaglie, luride canaglie. Delinquenti, state molto attenti,
che i padani non hanno paura di voi, vi pigliamo per il collo. Carogne,
tornate nella fogna, lì è il vostro posto»8. C’è gente pronta a giurare (Berlusconi compreso) che dietro a questo Bossi becero e delirante c’è un politico
di razza, al quale si può affidare anche un ministero. Ci permettiamo di
dubitare quando ricordiamo a quale miserabile ufficio ha delegato la nostra
bandiera nazionale.
È ben difficile con alleati del genere (fra l’altro hanno già presentato un
conto salatissimo al PDL e ottenuto ben quattro ministeri), che Berlusconi
possa raggiungere l’obiettivo che ha illustrato a «Sky TG-24»: «Voglio restare nella storia del mio paese come uno statista che lo ha cambiato»9. Per
ora, dello statista, non ha proprio nulla, a partire dal linguaggio, che spesso
scade nel turpiloquio. E comprendiamo l’amaro sfogo di Luciano Comida,
quando scrive all’«Unità»: «Sono stufo di venir insultato da questo ometto
arrogante che nel corso degli anni ci ha definiti coglioni, ladri, falsificatori di elezioni, stalinisti, dementi, faccia di merda, prostitute e comunisti,
idioti [...]. Basta, per favore, basta. Diamoci un paese civile»10.
A pochi giorni dalle elezioni è giunto il 25 aprile, una festività nazionale che abbiamo sempre atteso con gioia, e non soltanto perchè abbiamo
dato il nostro modesto contributo alla guerra di liberazione. Ma quest’anno, più che in passato, si è cercato in tutti i modi di infangare questa data e
la resistenza nel suo complesso. Basti guardare le prime pagine dei giornali
vicini al PDL. «Il Giornale» titola 25 aprile, in piazza con rancore. «Libero»
titola La festa dei banditi. E «Il Secolo» scrive: Il 25 aprile si è abolito da
solo. E che dire di Berlusconi che esalta «chi combatté per la libertà contro
la tirannia»11 e poi, nello stesso giorno, riceve Ciarrapico che vanta pubblicamente la sua nostalgia per il fascismo.
Per fortuna, a difendere la resistenza dagli insulti e dalle negazioni, è
intervenuto il capo dello stato, Giorgio Napolitano, che ha precisato, fra
l’altro, nel suo intervento a Genova «È possibile e necessario raccontare
13
Angelo Del Boca
la Resistenza, coltivarne la storia, senza sottacere nulla, “smitizzare” quel
che c’è da “smitizzare”, ma tenendo fermo un limite invalicabile rispetto
a qualsiasi forma di denigrazione o svalutazione di quel moto di riscossa
e riscatto nazionale cui dobbiamo la riconquista anche per forza nostra,
dell’indipendenza dignità e libertà della Nazione italiana»12.
Sessantatre anni fa, in un mattino livido e piovoso, componevo nella
cassa la salma di Nino Botti, un partigiano ventenne assassinato dai fascisti
alle porte di Piacenza, mentre la libertà del paese era a portata di mano. Se
il bibliofilo Dell’Utri manterrà la promessa, «i libri di storia, ancora oggi
condizionati dalla retorica della Resistenza, saranno revisionati. Questo è
un tema del quale ci occuperemo con particolare attenzione»13. Il che significa, caro Nino, tu che hai affrontato da solo un carro armato balzando
fuori dal Canale della fame, che dovrai uscire dai libri di storia per far
posto ad un altro eroe, lo stalliere Vittorio Mangano, che ai processi a lui
intentati si cucì la bocca. Abbiamo proprio toccato il fondo!
Post-scriptum - Con il rituale, italico servilismo, molti commentatori ci
rassicurano che il Berlusconi-ter sarà più liberale, più conciliante, disposto
a dialogare con l’opposizione, molto diverso dal presidente del consiglio
del 2001. Insomma, un autentico uomo di Stato, che giura «di non andare
a letto la sera senza aver realizzato qualcosa di positivo per gli italiani»14.
Ci permettiamo di dissentire dai giudizi di questo esercito di chiosatori,
che si affanna per salire sul carro del vincitore, mentre condividiamo il
parere della «Suddeutsche Zeitung», quando scrive: «Le sue affermazioni
in campagna elettorale fanno temere che Berlusconi voglia nuovamente
usare il suo potere per combattere la giustizia, rendere sicuro il suo potere
mediatico, coltivare il suo ego. In campagna elettorale ha promesso di voler
risanare il Paese, ma l’esperienza insegna a non credergli»15.
Altrove abbiamo espresso la nostra viva preoccupazione che Berlusconi
possa portare a termine il suo disegno di creare un nuovo modello di italiano, un chiaro prodotto del consumismo, dell’ignoranza e dell’egoismo16.
Questo modello di italiano predilige, tra i programmi politici, quello che
contempla la riduzione (per non dire l’estinzione) delle tasse, quasi esse
fossero una punizione e non il contributo del cittadino alla vita e al miglioramento del Paese; il blocco dell’immigrazione, in maniera drastica e
selvaggia; una decisa riforma del sistema giudiziario, in modo particolare
per la sua azione inquisitoria; il mantenimento ad oltranza della sicurezza,
14
L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano
anche a costo di ricorrere a ronde abusive. E poiché non viene incoraggiato
a dare importanza all’integrità, alla trasparenza, all’onestà dei leader politici, non è neppure interessato al rinnovamento morale del Paese e a una
legge che blocchi il conflitto di interessi. Gli strumenti mediatici, e ora
anche politici, per costruire questa nuova identità nazionale Berlusconi
li ha tutti. Ed ora ha anche il tempo dalla sua parte. E lo sconcerto e lo
smarrimento degli sconfitti.
«Le rauche invettive di Beppe Grillo – commenta dal canto suo Eugenio
Scalfari – completano il quadro di una società che sembra avere smarrito
ogni bussola, ogni orientamento, ogni immagine di sè, ogni memoria del
suo passato ed ogni progettualità del suo futuro. Si va avanti alla giornata
senza timone e senza stelle»17.
Torino, 1° maggio 2008
Note al testo
1
«l’Unità», 31 dicembre 2007. Cit. nell’articolo di Toni Fontana, Africa. 300 miliardi di dollari
inghiottiti per farsi la guerra.
2
«Le Monde», 17 dicembre 2007: Afrique: le grand rattrapage démographique.
3
«Le Monde», 31 gennaio 2008.
4
Cit. in Renate Zahar, il pensiero di Frantz Fanon e la teoria dei rapporti tra colonialismo e alienazione, Feltrinelli, Milano l970, p. 16.
5
Francesca Zilio, La cooperazione allo sviluppo tedesca a livello bilaterale e comunitario durante
la Guerra fredda, a servizio della riunificazione, tesi di Storia delle relazioni internazionali, Università degli studi di Trieste, anno accademico 2005-2006, p. 35.
6
«l’Unità», 15 aprile 2008.
7
«The Wall Street Journal», 8 aprile 2008.
8
«Corriere della Sera», 7 aprile 2008. Il 29 aprile, giorno di riapertura del Parlamento, Bossi
reiterava le sue minacce: «Questa è l’ultima occasione: o si fanno le riforme o scoppia un casino. Se la sinistra vuole scendere in piazza, abbiamo trecentomila uomini, trecentomila martiri
pronti a battersi. E non scherziamo, mica siam quattro gatti. Verrebbero giù anche dalle montagne. E verrebbero con i fucili, che son sempre caldi» («Corriere della Sera», 30 aprile 2008).
9
«la Repubblica», 15 aprile 2008.
10
«l’Unità», 31 marzo 2008.
15
Angelo Del Boca
11
«la Repubblica», 26 aprile 2008: Berlusconi: «Festa di pacificazione, ma vanno capiti i ragazzi
di Salò».
12
«l’Unità», 26 aprile 2008: La Resistenza salvò l’Italia.
13
«la Repubblica», 9 aprile 2008.
14
Ivi, 15 aprile 2008: Il Cavaliere trionfa in TV: «Ora voglio passare alla storia».
15
«Suddeutsche Zeitung», 14 aprile 2008.
16
Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza editore, Vicenza 2005, pp. 302-03.
17
«la Repubblica», 27 aprile 2008: Lo specchio d’Italia è sempre più rotto.
16
guerre e guerriglie
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
(1911-12). La campagna di stampa sul «Times»
di Barbara Gregori
1. Sin dagli anni ottanta del XIX secolo l’Italia, delusa per la perdita
della Tunisia che la Francia si era accaparrata, aveva rivolto le sue aspirazioni alle regioni nord africane della Tripolitania e della Cirenaica, allora
province ottomane. La vicinanza all’Italia, la presunta fertilità del suolo e
abbondanza di risorse minerarie, la necessità di trovare uno sbocco all’emigrazione, la congiuntura internazionale e il desiderio di dimostrare il proprio status di grande potenza, assieme al fatto che quelle regioni africane
erano le uniche non ancora colonizzate da Europei, furono le ragioni principali che persuasero il governo italiano a conquistare la cosiddetta «quarta
sponda».
Inviato il 28 settembre 1911 un ultimatum di ventiquattrore ore alla
Porta, non avendo ricevuto risposta tale da soddisfare le richieste italiane
ivi contenute, s’intrapresero subito le prime operazioni militari nell’Adriatico seguite pochi giorni dopo dallo sbarco del contingente italiano a Tripoli. La guerra si protrasse per dodici mesi e fu caratterizzata da una rapida
conquista dei maggiori centri costieri e da una lunga fase di stasi e d’incertezza, in cui il nostro esercito tentò invano di accattivarsi le simpatie della
popolazione araba e di penetrare l’interno. Dopo l’occupazione italiana del
Dodecaneso e l’attacco ai forti dei Dardanelli, nel luglio 1912, in Svizzera, le delegazioni italiana e turca avviarono i negoziati di pace. Questa fu
firmata il 15 ottobre 1912 ad Ouchy e sancì la perdita della sovranità turca sulle regioni della Tripolitania e Cirenaica, già annesse unilateralmente
dall’Italia nel novembre 1911.
Oltre che sul piano militare, la guerra procurò all’Italia seri problemi
sul piano internazionale, dove l’opinione pubblica delle maggiori potenze
europee s’indignò di fronte all’azione italiana e mantenne un atteggiamento decisamente ostile per tutta la durata del conflitto, ponendo in serio
17
Barbara Gregori
imbarazzo i rispettivi governi. Le grandi potenze giudicarono la dichiarazione di guerra italiana un «atto di pirateria», indignandosi per il mancato
preavviso concesso dall’Italia e l’infondatezza delle sue pretese; d’altro canto, offrirono fin dall’inizio i loro buoni uffici per mediare tra i belligeranti
e valutare le basi per potenziali accordi di pace, ma reciproci sospetti e
gelosie invalidarono ogni proposta sul nascere. L’Inghilterra, in particolare,
tentò di mantenere quell’attitudine di rigorosa neutralità dichiarata sin
dall’inizio del conflitto e il Foreign Office si rifiutò di prendere in considerazione qualunque proposta potesse indispettire l’uno o l’altro degli avversari. L’opinione pubblica, invece, non risparmiò le sue critiche al modo in
cui la guerra fu condotta e la stampa europea fu prodiga di giudizi affatto
lusinghieri sull’esercito italiano.
Questo saggio, parte di un più ampio lavoro di ricerca volto a chiarire
il ruolo della Gran Bretagna durante il conflitto italo-turco del 1911-12, si
propone di analizzare l’atteggiamento del governo e della stampa britannici di fronte a quello che fu considerato un vero e proprio «colpo di mano»
italiano.
2. Durante l’estate del 1911 il ministro degli esteri italiano, il marchese
di San Giuliano, tentò di capire quali sarebbero state le reazioni delle principali potenze europee di fronte ad un conflitto italo-turco. Ebbene, fino
allo scoppio del conflitto, le potenze manifestarono più o meno apertamente il loro consenso alla guerra di Libia, ma quando essa venne effettivamente dichiarata, la stampa, l’opinione pubblica, nonché i governi europei
rimasero esterrefatti ed irritati verso l’Italia e reagirono violentemente.La
stampa europea, soprattutto inglese e tedesca, si accanì contro l’Italia, la cui
azione fu giudicata aggressiva e riprovevole, se non addirittura ripugnante.
Il giudizio dei governi, anche quelli che si erano mostrati più benevoli verso l’Italia, rispecchiava in sostanza quello della stampa: innanzitutto erano indignati perché l’Italia si era limitata ad avvisarli poche ore
prima dello scoppio del conflitto, in particolare si era guardata bene dal
consultare le alleate della Triplice, violandone in questo modo lo spirito;
in più, questa dichiarazione appariva assolutamente infondata, anzi, un
vero e proprio «atto di pirateria», data la disponibilità turca a concedere
qualunque beneficio economico l’Italia avesse desiderato in Tripolitania.
Invano di San Giuliano cercò di giustificare l’intervento italiano davanti
all’opinione pubblica e rimuovere tutte le paure riguardo uno sconvolgi18
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
In questa e alle pagine seguenti
Cartoline di propaganda.
Raccolta Angelo Del Boca
mento dello status quo in Europa: il 28 settembre aveva informato gli stati
balcanici che l’Italia avrebbe appoggiato l’integrità della Turchia europea e
aveva inviato alle grandi potenze una lunga lista di lagnanze nei confronti
della stessa. L’Europa, però, rifiutò di essere rassicurata e continuò a criticare il comportamento italiano1.
Vediamo ora nel dettaglio la posizione assunta dalle maggiori potenze
europee prima e soprattutto, dopo la dichiarazione di guerra alla Turchia.
Le prime rassicurazioni alle preoccupazioni del ministro vennero proprio dal governo inglese2. In luglio, il loro ministro degli Esteri Grey, aveva
affermato che se l’Italia fosse stata costretta a tutelare i suoi diritti e ad
agire, l’Inghilterra non solo non sarebbe intervenuta, ma le avrebbe concesso simpatia ed appoggio, ovviamente solo morale. Inoltre, Grey aveva
19
Barbara Gregori
avvertito l’ambasciatore inglese a Costantinopoli che le lagnanze italiane
erano pienamente giustificate e l’Italia non avrebbe dovuto subire un trattamento più sfavorevole rispetto alle altre nazioni. A quanto pare poi, il
sottosegretario agli esteri Nicolson, aveva dichiarato all’ambasciatore turco
a Londra che la Turchia non avrebbe potuto contare sull’appoggio inglese
in un eventuale conflitto con l’Italia.
Anche l’ambasciatore inglese a Roma, Rodd, aveva mostrato più volte
di sostenere la causa italiana e il 4 settembre in un colloquio con Grey
aveva dichiarato: «Dobbiamo prepararci all’eventualità di un intervento in
Tripolitania e la direzione che [...] le simpatie dell’Italia prenderanno dopo
l’avvenimento, con il conseguente importante impatto sulle questioni mediterranee, dipenderà dall’atteggiamento che le potenze assumeranno nei
confronti dell’azione»3.
Il 28 settembre, subito dopo l’invio dell’ultimatum alla Turchia, l’ambasciatore italiano a Londra, Imperiali, era corso ad informare il Foreign
Office e a chiedere quel «sostegno morale» che era stato promesso all’Italia
in luglio, ma sia Grey che il suo sottosegretario Nicolson si meravigliarono
di aver fatto simili promesse. Grey replicò: «può darsi che abbia usato le
parole ‘sostegno morale’ , ma non le ricordo»; poi aggiunse che l’Inghilterra non poteva permettersi di appoggiare un colpo di mano italiano in
Libia «che avrebbe probabilmente provocato grande scompiglio» e le cui
indirette conseguenze erano imprevedibili4.
Dopo questa reazione indicativa di una certa sorpresa da parte inglese5,
Grey trovò presto una sua linea e il 29 settembre informò Imperiali che
l’Inghilterra non si sarebbe opposta ad un’azione italiana in Libia, ma si affrettò a precisare che la sua approvazione alle aspirazioni italiane non includeva comunque un’annessione con la forza. La Gran Bretagna considerava
quest’ultima «una misura estrema» le cui conseguenze indirette avrebbero
potuto causare serio imbarazzo alle altre potenze, in primo luogo se stessa
dato il pericolo di rivolte da parte dei sudditi di fede islamica6 e per questo sperava che l’Italia avrebbe agito in modo da causare meno imbarazzo
possibile agli altri paesi.
Imperiali, riferendo di questa conversazione a Giolitti, disse che: primo,
l’Inghilterra non aveva intenzione di intervenire nel conflitto; secondo,
l’Inghilterra dati gli accordi stipulati con l’Italia, riconosceva l’importanza
degli interessi italiani in Tripolitania; terzo, per l’amicizia che legava Gran
Bretagna e Italia, la prima desiderava che l’altra ricevesse soddisfazione;
20
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
quarto, il conflitto avrebbe potuto incrinare la pace europea e creare imbarazzi alle potenze, in primis all’Inghilterra che aveva un gran numero di
sudditi musulmani, dunque l’Inghilterra sperava si trovasse una soluzione
che non creasse difficoltà alle altre potenze7. Anche il re Giorgio V e il primo ministro Asquith non erano del tutto compiaciuti dell’iniziativa italiana e il secondo dubitava che fosse davvero possibile localizzare il conflitto.
Probabilmente sono due le ragioni fondamentali per cui il governo inglese decise poi di accantonare le sue preoccupazioni per la pace europea
e mostrare benevolenza all’Italia. Anzitutto per la Gran Bretagna avere dei
vicini italiani piuttosto che turchi era meno rischioso, dato lo stretto legame che univa Turchia e Germania. In secondo luogo, l’appoggio inglese
all’Italia avrebbe potuto indebolire la Triplice Alleanza e creare notevole
imbarazzo alla Germania nei suoi rapporti con la Turchia.
Eppure, nonostante il favore mostrato dal governo inglese, il marchese
di San Giuliano «sapeva quanta influenza esercitasse sul governo l’opinione
pubblica e come questa fosse influenzata dai maggiori giornali»8, quindi
temeva che una campagna di stampa anti-italiana avrebbe modificato l’atteggiamento del governo britannico. Per questo consigliò a Imperiali di
informare i maggiori organi di stampa inglesi sullo stato dei rapporti italoturchi e dei continui soprusi subiti dai nostri connazionali in Tripolitania.
Imperiali, raccolte le informazioni necessarie, informò di San Giuliano
che certamente ostili alla nostra impresa sarebbero stati il «Daily Graphic»
e i fogli ultraradicali, il «Daily News» e il «Manchester Guardian»9. Effettivamente, le critiche più accese all’impresa tripolina vennero proprio dalla
stampa britannica. I giornali, sia liberali che conservatori, condannarono
in modo unanime l’azione italiana che metteva in pericolo la pace europea
e minacciava di seminare zizzania nell’impero con il maggior numero di
sudditi musulmani, quello inglese.
Il «Daily Mail» di Northcliffe il 29 settembre descriveva l’ultimatum
come «crudo e violento nel tono». Il 25 settembre il liberale «Westminster
Gazette» di Spender riteneva che l’Italia avesse imbarazzato le sue alleate
e annunciava che l’Inghilterra non aveva alcun interesse nel tenere l’Italia
fuori da Tripoli, ma già il 30 settembre si dichiarava allarmato e dispiaciuto. Il liberale «Manchester Guardian» fu severo nel condannare l’Italia
e il 29 settembre scrisse: «Ci sono sicuramente pochi casi nella storia paragonabili all’indifferenza verso l’opinione e la coscienza di stati civilizzati
come l’aggressore ha dimostrato nell’iniziare questa lite»10. Il 27 settembre
21
Barbara Gregori
il «Times», temendo uno scoppio del fanatismo musulmano, dichiarò che
la pace in Europa non era mai stata così in pericolo dall’annessione della
Bosnia in poi e ammonì che «anche in questo paese, dove l’Italia ha amici
così veri e dove la leale amicizia della nazione italiana è così cordialmente
apprezzata, la pubblica opinione sarà unanime nella sua disapprovazione»11. Forse i commenti più duri apparvero nel liberale «Nation»: «È la
più cinica trasgressione della legge pubblica e della politica pubblica che i
nostri tempi abbiano visto […]. È slealtà alla Triplice Alleanza, il principale membro della quale coltiva l’amicizia della Turchia, ed è tradimento
contro la pace d’Europa. […] Una nazione che annovera la Calabria e la
Puglia tra le sue province non ha bisogno di andare all’estero per una missione civilizzatrice. L’Italia l’Africa ce l’ha in casa12».
22
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
Il 30 settembre di San Giuliano avvertì Rodd che gli italiani erano
molto sensibili verso l’opinione inglese e che sarebbe stato un peccato se
si fosse creata una certa freddezza nei rapporti tra i due paesi. Disse poi
di aver indotto il capo dell’ufficio stampa a censurare certi telegrammi
indicanti l’ostilità dell’opinione pubblica inglese e che la Gran Bretagna
avrebbe dovuto ricordare l’attitudine italiana manifestata durante la guerra
anglo-boera13. Del resto anche alcuni membri del Foreign Office deploravano l’atteggiamento della stampa inglese, che avrebbe fatto perdere alla
Gran Bretagna la simpatia italiana e allo stesso tempo incoraggiato la Turchia. Così decisero che era necessario compiere qualche sforzo per indurre
alcuni editori a mantenere una decente neutralità14.
Grey mostrò il telegramma di Rodd a Braham del «Times» e il 2 ottobre
fu in grado di informare l’ambasciatore italiano che il «Times» non aveva
nulla contro l’Italia. Certo l’ultimatum italiano aveva colto tutti di sorpresa, disse, e solo la forte amicizia per l’Italia aveva trattenuto i commenti
della stampa dall’essere più aspri15. Entro il 4 ottobre i giornali inglesi assunsero un tono più moderato verso l’Italia. L’ambasciatore italiano Imperiali sembrava soddisfatto della disposizione d’animo inglese e il Foreign
Office notò il 7 ottobre che la stampa, ad eccezione del «Daily Mail»,
sembrava più sensibile.
Grazie alla continua vigilanza del Foreign Office l’attitudine della stampa liberale e conservatrice probabilmente fallì nel riflettere l’indignazione
della maggioranza degli inglesi verso la guerra16, se pur non furono risparmiate pungenti critiche alla spregiudicatezza e temerarietà dell’azione
italiana.
Il 6 ottobre il liberale «Manchester Guardian» dichiarava che «la legge
ha solo una risposta – che l’Italia non ha un’ombra di diritto al possesso»,
condannando le crescenti richieste dell’Italia di annettersi Tripoli17. Il «Nation» prevedeva una guerra nei Balcani se la Turchia avesse continuato a
resistere all’Italia e una rivoluzione interna se invece avesse deciso per la
pace. Chiedeva poi a Inghilterra e Germania di agire congiuntamente per
salvare la Turchia da questo dilemma. Il liberale «Westminster Gazette» il
17 ottobre ricordava all’Italia il suo dovere morale verso l’Europa di non
protrarre una situazione pericolosa.
Dopo l’episodio di Sciara Sciat, in ottobre, quando l’11° reggimento
dei bersaglieri subì un attacco letale di forze turco-arabe congiunte alla popolazione dell’oasi, con conseguenti rappresaglie, deportazioni e fucilazio23
Barbara Gregori
ni di nativi da parte italiana, la stampa europea inasprì i toni della critica
per l’asserita crudeltà italiana verso donne e bambini. La stampa britannica
fu come sempre molto dura nel giudicare questi avvenimenti. Metternich,
l’ambasciatore tedesco a Londra, riportò al suo governo il 6 novembre che
la stampa britannica oscillava tra la speranza che l’Italia fosse allontanata
dalla Triplice e l’indignazione per le atrocità commesse. L’Italia, dal canto suo, amareggiata per il trattamento riservatole dalla stampa inglese e
dall’atteggiamento dell’opinione pubblica che faceva più affidamento sulle
notizie provenienti dalla Turchia piuttosto che dall’Italia, si adoperò per
ottenere una reazione più favorevole dalla Gran Bretagna. Così il 6 novembre apparve sul «Daily Telegraph» un’intervista del generale Caneva
in cui si negavano le atrocità in discussione e s’insisteva piuttosto sulla
24
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
buona condotta del nostro esercito, prodigo nel soccorrere la popolazione
araba. Una dichiarazione di Giolitti secondo la quale soltanto gli arabi in
possesso di armi o colpevoli di atti criminali erano stati giustiziati apparve
sul «Times» il 2 novembre.
Nonostante queste dichiarazioni molti giornali liberali si rifiutarono di
credere che l’Italia fosse innocente. Il «Westminster Gazette» il 6 novembre
concluse che «forse il verdetto più misericordioso è che un folle fanatismo
è infuriato su entrambe le parti in quelle tristi giornate a Tripoli».Da sottolineare che vi fu anche chi azzardò un commento positivo: ad esempio il
«Morning Post» e il «Daily Telegraph», entrambi conservatori, si rifiutarono di credere l’Italia colpevole di simili crudeltà e dichiararono di ritenere
che, tutt’al più, non avesse avuto altra alternativa18.
Anche nella House of Commons vi fu chi espresse indignazione per i
fatti di Tripoli. Il 2 novembre Leach chiese a Grey di usare i suoi buoni
uffici per fermare l’uccisione di uomini, donne e bambini arabi da parte
italiana. Grey poté soltanto rispondere che l’Italia aveva negato la veridicità
di simili dicerie. Più volte nel mese di novembre si tornò a parlare delle
atrocità italiane alla Camera dei Comuni. Il fatto che McCullagh, inviato
del «New York World» e del «Westminster Gazette» e Gottberg, del «Berliner Lokal-Anzeiger», si fossero dimessi dai loro incarichi a Tripoli in segno
di protesta, sembrò una conferma delle responsabilità italiane.
La paura che gli eventi di Tripoli avrebbero potuto causare rivolte tra
i sudditi musulmani dell’impero britannico può essere utile a spiegare lo
scoppio di indignazione nella stampa inglese e in Parlamento. La lega musulmana indiana esortò l’Inghilterra a proteggere l’integrità dell’impero
ottomano. In alcune città indiane scoppiarono manifestazioni di protesta
e si decise di boicottare le merci italiane. Vi furono disordini anche ad
Alessandria. Alcuni caffè e negozi europei furono distrutti, dei poliziotti
rimasero feriti. Dimostrazioni anti-europee ebbero luogo anche al Cairo
e in altre città egiziane19. A questo proposito Winston Churchill, allora
primo lord dell’ammiragliato, affermò: «non dobbiamo dimenticare che
siamo la più grande potenza musulmana del mondo [...] abbiamo più da
guadagnare dall’amicizia turca che da quella italiana?»20.
Il regio decreto del 5 novembre con cui l’Italia si annetteva la Tripolitania e la Cirenaica, infrangendo le speranze di pace, non fece che accrescere questo sentimento. Di nuovo vi furono commenti sfavorevoli all’Italia.
L’Inghilterra, come del resto la Francia e l’Austria, era interessata agli effetti
25
Barbara Gregori
del decreto sui trattati internazionali e i diritti di commercio. Grey condannò il decreto perché temeva avrebbe prolungato la guerra: al Foreign Office
si pensava, infatti, che l’Italia avesse agito avventatamente e avesse reso
ancor più difficoltosi i tentativi di conciliazione presso il governo turco21.
Il decreto italiano apparve ingiustificato anche agli occhi dell’opinione
pubblica europea, primo perché l’Italia si annetteva un territorio che non
aveva ancora conquistato, secondo perché violava apertamente le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 190722. Un altro episodio che irritò notevolmente l’opinione pubblica inglese potendo provocare sommovimenti in
altre regioni dell’impero ottomano fu il bombardamento italiano di Beirut
del febbraio 1912. Il bombardamento iniziò a causa del rifiuto di due navi
da guerra turche di arrendersi; l’Italia affondò le navi, danneggiò alcuni
edifici della città e uccise oltre cinquanta abitanti. I turchi reagirono distribuendo armi agli indigeni che si accanirono contro i cittadini stranieri
presenti in città; molti rimasero uccisi e si dovette ricorrere alla legge marziale per prevenire disordini ancor più gravi.
Il «Daily Telegraph» di Londra esortò alla conclusione di un armistizio e di un compromesso, in modo da prevenire future operazioni navali
italiane. Qualcun altro temeva che queste azioni avrebbero aumentato le
probabilità d’insurrezione in Macedonia e Albania.
Altra fonte di preoccupazione per le grandi potenze era il possibile attacco italiano ai Dardanelli, punto nevralgico dell’impero ottomano che,
con tutta probabilità, avrebbe costretto la Turchia a cedere. Un simile
evento sarebbe stato ancor più rischioso per la pace europea, primo perché
un’eventuale sconfitta italiana avrebbe screditato il prestigio degli eserciti
europei agli occhi dei musulmani; secondo, l’eventuale blocco degli stretti da parte turca avrebbe danneggiato il commercio neutrale attraverso il
mar Nero; terzo, avrebbe potuto causare disordini nei Balcani o addirittura
provocare un intervento russo.
Imitando la stessa politica italiana, ossia appellarsi alle potenze affinché
esercitassero pressioni sul nemico, la Turchia minacciò il 18 febbraio di
chiudere gli stretti e di espellere gli italiani residenti in Turchia alle prime avvisaglie di operazioni belliche nella Turchia europea. La minaccia
turca di chiudere gli stretti, con tutte le conseguenze negative che ne sarebbero derivate per il commercio neutrale, ebbe l’effetto di spingere la
Gran Bretagna ad agire: il 28 febbraio Grey propose alle potenze neutrali
di esigere dall’Italia la promessa solenne di non intraprendere operazioni
26
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
ostili nei Dardanelli e nelle acque limitrofe. La reazione a questa proposta
fu decisamente sfavorevole: l’Austria pensò di accertarsi in primo luogo
della volontà italiana, la quale pretendeva di conservare una certo grado
di autonomia; dopo aver sentito Roma, anche la Germania si rifiutò di
considerare la proposta inglese; la Russia si rifiutò di esercitare pressioni in
modo da conservare l’appoggio italiano alle sue aspirazioni; solo la Francia
si dichiarò disposta ad appoggiare l’iniziativa di Grey. A questo punto Grey
dovette abbandonare il suo progetto, ma quando Imperiali lo informò che
l’Italia desiderava conservare la sua libertà d’azione, egli allo stesso modo si
riservò libertà d’azione se gli stretti fossero stati chiusi alle navi neutrali.
L’Italia fu indubbiamente influenzata dalla posizione di Grey, tant’è
che chiarì immediatamente di non avere alcuna intenzione di estendere le
operazioni navali, specialmente agli stretti23. In realtà, il 18 aprile, la flotta
italiana bombardò i forti esterni dei Dardanelli. Sebbene la flotta italiana si
fosse ritirata immediatamente, la Turchia decise di impedire il passaggio di
navi attraverso gli stretti deponendovi delle mine. Questo provvedimento
provocò disagi e gravi perdite al commercio neutrale.
Anche questa volta l’opinione europea fu unanime nel disapprovare
l’azione italiana. Generalmente si pensò che l’Italia volesse forzare le potenze neutrali a premere sulla Turchia. Il «Times» il 19 aprile concluse che
l’Italia aveva reso la pace più difficile, esasperando i gruppi più intransigenti in Turchia. Il «Daily Telegraph» ricordò all’Italia le sue recenti promesse.
Il «Manchester Guardian» il 20 aprile e il «Westminster Gazette» il 26 lo
considerarono un tentativo di disturbare i paesi neutrali. Quest’ultimo,
poi, invocò la riunione di un concerto europeo per decidere le sorti del
conflitto24. Il marchese siciliano, spaventato dagli effetti di quest’azione
navale, si affrettò a rassicurare le potenze sottolineando il carattere accidentale dell’episodio ed incalzò la Gran Bretagna affinché non pretendesse
assicurazioni imbarazzanti25. Nicolson non solo espresse il suo disappunto
per quanto accaduto, ma rifiutò anche di dare qualsiasi garanzia su ciò
che la Gran Bretagna avrebbe fatto nell’interesse del suo commercio che,
dichiarò, era stato gravemente danneggiato. Chiarì comunque che la Gran
Bretagna non avrebbe protestato per la chiusura degli stretti, ma avrebbe
chiesto alla Turchia che fossero riaperti al più presto26.
Effettivamente Gran Bretagna, Francia e Austria, danneggiate economicamente dalla chiusura degli stretti, consigliarono alla Turchia di riaprirli al commercio neutrale. Essa rispose, però, che esisteva ancora il pericolo
27
Barbara Gregori
di un attacco italiano e aggiunse che una garanzia delle potenze contro
questo pericolo avrebbe facilitato la riapertura degli stretti. Inoltre suggerì
che all’Italia fosse fatto pagare un indennizzo per le perdite procurate.
Le pressioni di un’influente delegazione di armatori per ottenere la riapertura degli stretti spinsero Grey, il 30 aprile, ad esigere dall’Italia la
promessa che non ci sarebbero stati altri attacchi agli stretti per un periodo ragionevole, mentre il commercio neutrale avrebbe potuto transitarvi27. Ricordò poi a Turchia e Italia che gli armatori avevano già perso circa
100.000 lire e che ogni giorno si aggiungeva una perdita di altre 9.000
lire. Grey chiese a Russia, Francia e Austria di supportare la sua richiesta
a Roma, ma la prima rifiutò di aiutarlo dopo aver appreso che l’opinione
pubblica italiana era sensibile verso qualunque sforzo delle potenze di li28
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
mitare la sua libertà d’azione28, la Francia riteneva che chiedere all’Italia
di non colpire gli stretti fosse incompatibile con lo stato di neutralità e
l’Austria, una volta saputo che la Turchia avrebbe riaperto gli stretti, non
si preoccupò di rispondere a Grey. La Turchia, infatti, incalzata dalla minaccia russa di riaprire la questione degli stretti, il primo maggio dichiarò
che li avrebbe riaperti appena le mine fossero state rimosse29, riservandosi
il diritto di chiuderli completamente in caso di necessità.
Un altro episodio chiarificatore dell’atteggiamento inglese è l’incontro
del maggiore Tyrrell con Mahmud Shevket Pascià il 29 aprile. Quest’ultimo sosteneva che la responsabilità di un attacco italiano ai Dardanelli
era da imputare a Francia e Gran Bretagna, le due potenze mediterranee
più forti, cui l’Italia non avrebbe mai disobbedito in caso di opposizione.
Aveva poi aggiunto che lo scopo della benevolenza inglese verso l’Italia era
allontanarla dalla Triplice Alleanza e si chiedeva se un’alleanza con l’Italia
fosse davvero più vantaggiosa di un’alleanza con la Turchia30. Ovviamente
una critica simile, che tra l’altro non era la prima dall’inizio del conflitto,
non poteva che allarmare il governo inglese e spingerlo ad un atteggiamento più freddo verso l’Italia, in modo da non alienarsi totalmente le simpatie
di Costantinopoli.
Tra il 28 aprile e il 21 maggio l’Italia riuscì a conquistare tredici isole a
sud dell’Egeo, le Sporadi meridionali, senza grosse difficoltà.
Il destino di queste isole non mancò di suscitare discussioni e preoccupazioni nelle cancellerie europee. Se l’Italia le avesse trattenute, sicuramente la sua posizione nel Mediterraneo si sarebbe rafforzata, mentre il ritorno
delle isole alla Turchia, avrebbe potuto creare problemi a causa delle aspirazioni indipendentiste dei suoi abitanti che aspiravano all’autonomia, pur
sotto la sovranità nominale della Porta.
L’Inghilterra temeva che la Triplice Alleanza potesse creare basi navali nell’Egeo, minacciando la posizione inglese in Medio Oriente; Grey
nell’agosto 1912 dichiarò all’ambasciatore italiano di sperare che l’Italia
«non avrebbe approvato alcun decreto relativo alle isole, né si sarebbe impegnata in alcun modo in merito ad esse».
Le grandi potenze concordavano che queste isole dovessero essere restituite alla Turchia. Grey condivideva l’opinione dell’ammiragliato inglese
che l’Italia non dovesse trattenerle e Austria e Germania erano pienamente
d’accordo. Anche la Russia suggeriva che tornassero alla Turchia, ma con
adeguate garanzie per il trattamento dei loro abitanti31.
29
Barbara Gregori
Sostenuto dall’opinione pubblica e dalla consapevolezza che le grandi potenze condividevano il suo punto di vista, il 6 agosto Grey mise in
guardia l’Italia apertamente dall’annettersi le isole ed aggiunse che l’installazione di una base navale italiana nell’Egeo avrebbe causato difficoltà.
Imperiali assicurò Grey che l’Italia non aveva alcuna intenzione di annettersi le isole, ma aggiunse che esse non sarebbero tornate alla Turchia senza
garanzie riguardo al trattamento degli abitanti greci. Grey si convinse che
la questione non sarebbe stata risolta se non dopo la fine della guerra e solo
attraverso un accordo delle sei grandi potenze.
Le recenti conquiste italiane e la paura delle potenze dell’Intesa che
l’Italia potesse diventare di nuovo un membro effettivo della Triplice Alleanza, insieme al trasferimento delle navi da guerra inglesi e francesi nel
mare del Nord per far fronte all’aumento di navi tedesche, contribuirono
tutti a risollevare la questione del Mediterraneo, cioè i vecchi antagonismi
per il suo predominio.
Ai tempi in cui la prospettiva di una cooperazione navale austro-italiana
nel Mediterraneo sembrava imminente, l’Inghilterra stava ritirando la sua
flotta mediterranea più potente da Malta a Gibilterra. Il problema per la
diplomazia inglese era rassicurare la Francia che il trasferimento della flotta
non avrebbe esposto le coste francesi al pericolo di un attacco tedesco, ma
allo stesso tempo evitare un accordo navale definitivo con la Francia.
Il piano britannico, esposto dal primo lord dell’ammiragliato Winston
Churchill davanti alla Camera dei Comuni il 18 marzo, era dividere le
navi da guerra in tre flotte. La più imponente doveva consistere in quattro
squadriglie di otto navi ciascuna; la quarta squadriglia doveva avere come
base Gibilterra anziché Malta e quella che prima era stata la flotta atlantica
doveva essere ritirata nei porti britannici32.
Il Foreign Office si allarmò di fronte alla prospettiva di evacuare il Mediterraneo: il proposto trasferimento della flotta avrebbe gettato l’Italia
nelle braccia della Triplice, mettendola definitivamente in una posizione
ostile a Francia e Gran Bretagna. A quel punto la Spagna avrebbe potuto
abbandonare la sua politica di stretta intesa con Francia e Gran Bretagna
e cooperare con la Triplice Alleanza. In più, l’influenza britannica a Costantinopoli si sarebbe indebolita e la Turchia avrebbe potuto unirsi alla
Triplice Alleanza e tentare di riconquistare l’Egitto. La maggior parte di
questi pericoli poteva essere evitata se Francia e Gran Bretagna avessero
cooperato nel momento in cui entrambi i paesi si fossero trovati in guerra
30
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
con la Triplice e se la Francia avesse mantenuto una flotta nel Mediterraneo
in grado di contrastare le forze alleate di Turchia, Austria e Italia.
Di fronte ai toni allarmanti assunti dalla stampa europea riguardo
all’esistenza di un’intesa navale anglo-francese in funzione anti-tedesca e
anti-italiana, Grey tentò di rassicurare Imperiali che non v’era alcuna alleanza con la Francia e che l’Italia non aveva ragioni d’essere preoccupata.
Egli desiderava, una volta concluse le ostilità, pervenire ad un accordo con
Italia e Francia per il mantenimento dello status quo mediterraneo.
In una lunga lettera privata del 13 aprile, Rodd presentò a Grey un quadro piuttosto negativo degli effetti della guerra di Libia sul futuro allineamento dell’Italia in Europa. La Francia non godeva più di una posizione
favorevole in Italia poiché, dopo gli incidenti diplomatici in gennaio, gli
italiani non riponevano più fiducia nell’amicizia francese. Poi, la sfortunata campagna di stampa britannica, aveva scosso la convinzione che la
tradizionale amicizia anglo-italiana avrebbe superato qualunque ostacolo.
La Russia, invece, era al primo posto nelle preferenze italiane, ma avrebbe
perso facilmente questa posizione se i suoi sforzi di pace non fossero andati
a buon fine.
Nel frattempo, Austria e Germania lavoravano incessantemente per
attirare saldamente l’Italia nella loro orbita e la stampa di questi paesi faceva il possibile per procurare detrimento all’Inghilterra. Infine, dopo aver
esaurito le sue risorse in questa guerra, l’Italia si sarebbe ridotta a vassallo
dell’Austria per molti anni, a meno che non avesse trovato supporto morale altrove. La conclusione di Rodd era che Inghilterra, Italia e Francia si
garantissero reciprocamente i loro possedimenti in Nord Africa.
Le obiezioni di Grey riguardo un simile accordo vertevano essenzialmente su tre punti: innanzitutto l’ostilità dimostrata dall’opinione pubblica britannica nei confronti dell’Italia; in secondo luogo l’idea che gli
interessi britannici sarebbero stati serviti maggiormente tenendo l’Italia
nella Triplice Alleanza; terzo, se l’Italia avesse abbandonato la Triplice, una
guerra austro-italiana sarebbe stata inevitabile e l’Inghilterra si sarebbe trovata costretta a soccorrerla.
Infine, l’Inghilterra avrebbe dovuto riconoscere la sovranità italiana
su Tripoli, condizione essenziale per un accordo, ma tale riconoscimento
avrebbe significato, in pratica, supportarla nella guerra contro i turchi e
questo sarebbe stato incompatibile con la neutralità britannica. Grey discusse del patto con Cambon in diverse occasioni e cominciò a prepararsi
31
Barbara Gregori
avvisando la stampa di parlare con cautela dell’Italia33, ma le indiscrezioni
apparse sul «Daily Graphic» il 9 luglio a proposito di un’intesa mediterranea tra Italia, Francia e Inghilterra, resero impossibile la continuazione dei
negoziati: era improbabile che Grey avrebbe rischiato di offendere la sensibilità dei musulmani concludendo un accordo segreto con l’Italia proprio
durante il conflitto italo-turco. Alle rivelazioni del «Daily Graphic» seguirono una serie di smentite: Italia e Francia si preoccuparono di assicurare
Russia e Austria che non v’erano negoziati in corso, mentre l’ambasciatore
inglese a Roma negò all’ambasciatore tedesco che si fosse tentato di concludere un accordo simile34.
Con la pace di Ouchy del 18 ottobre venne meno un ostacolo alla
conclusione dei negoziati, cioè l’ossessione dell’Ammiragliato britannico
che l’Italia potesse cedere parte delle isole del Dodecaneso alla Germania35,
dunque Grey manifestò la sua disponibilità di addivenire ad un accordo
limitato. Fin dall’inizio, però, escluse una garanzia reciproca del territorio
nord africano; desiderava soltanto legare l’Italia all’Intesa con un accordo
di neutralità.
Di San Giuliano rispose a queste iniziative sostenendo che l’Italia non
poteva prender parte ad accordi incompatibili con i suoi doveri di membro
della Triplice Alleanza, ma fece intendere che la Triplice sarebbe stata rin32
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
novata senza variazioni, dunque gli accordi del 1902 potevano considerarsi
ancora validi36.
Per concludere, cerchiamo di riassumere la posizione inglese di fronte a
questo conflitto osservando il comportamento del Foreign Office.
L’atteggiamento di Grey fu determinato principalmente da due considerazioni: da una parte la complessità della posizione italiana, in bilico
tra due schieramenti, la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, tale per cui
qualunque mutamento avrebbe potuto turbare il delicato equilibrio europeo; dall’altra il protrarsi del conflitto con i rischi che questo comportava,
aumentando le possibilità che gli stati balcanici cogliessero l’occasione per
assestare il colpo decisivo all’impero ottomano, con conseguenze inimmaginabili dati gli interessi austro-russi in quella regione.
Considerata la situazione, Grey si convinse che si dovesse evitare di
sfruttare l’occasione per portare l’Italia o la Turchia dalla parte dell’Intesa
e d’altro canto che le cinque potenze dovessero agire di comune accordo a
nome di tutta Europa; dunque escluse a priori un intervento inglese presso
l’uno o l’altro dei belligeranti, credendo che la via più sicura fosse il mantenimento di una stretta neutralità.
Del resto l’interesse britannico per Tripoli era sempre stato marginale:
fin dal 1890 i vari ministri degli esteri avevano dimostrato di considerarla
parte dell’eredità italiana, tant’è che nel 1902 il Foreign Office aveva assicurato all’Italia che se vi fosse stata un’alterazione dello status quo in quella regione, questa avrebbe dovuto essere in conformità con gli interessi italiani.
Le ragioni di questa generosità erano certamente di ordine internazionale: innanzitutto il riavvicinamento franco-italiano, che diminuiva le
chances di dover sostenere l’Italia e in secondo luogo il desiderio inglese
di cautelarsi da ogni accordo franco-italiano, di natura ostile agli interessi
britannici nel Mediterraneo. Non sembra, invece, che fosse determinata
dall’intenzione di staccare l’Italia dalla Triplice Alleanza. Certamente non
c’è nulla che suggerisca che Grey abbia incoraggiato le ambizioni italiane
in Tripolitania per creare problemi in seno alla Triplice Alleanza e i sospetti
tedeschi al riguardo erano del tutto infondati. Infatti, le dichiarazioni di
Grey in luglio a sostegno degli interessi italiani, vanno interpretate considerando il contesto in cui avvennero: fino a quel momento Grey non aveva
ricevuto indicazioni che l’Italia stesse meditando di muovere guerra alla
Turchia e del resto di San Giuliano si era espresso in termini esclusivamente economici. Dichiarando che l’Inghilterra le avrebbe concesso simpatia
33
Barbara Gregori
ed appoggio se fosse stata costretta a tutelare i suoi diritti e ad agire, Grey
pensava di supportare diplomaticamente l’Italia a Costantinopoli in modo
da prevenire una guerra e non certo per incoraggiarla. Fino a settembre
Grey rimase all’oscuro delle intenzioni italiane e tra l’altro conobbe questi
intenti attraverso i giornali, non certo dal marchese di San Giuliano o da
Giolitti, che mantennero uno stretto riserbo.
Grey condivideva le preoccupazioni di Rodd riguardo la direzione delle
simpatie italiane una volta cessato il conflitto: esse si sarebbero indirizzate
verso quelle potenze che avessero sostenuto l’Italia durante la guerra, con
importanti implicazioni per l’assetto mediterraneo. Dunque se i turchi
avessero domandato l’aiuto inglese, avrebbero dovuto essere indirizzati verso Germania e Austria, poiché era molto importante che né l’Inghilterra né
la Francia si mettessero contro l’Italia37. Ciò nonostante, quando la guerra
scoppiò, Grey protestò fortemente presso Imperiali contro l’aggressione
italiana. La spiegazione di questo risiede probabilmente nell’intensità della reazione pubblica in Gran Bretagna: la stampa da destra a sinistra fu
unanime nel denunciare l’azione italiana, sottolineandone l’immoralità e
le possibili ripercussioni nel mondo musulmano; avendo già subito forti
critiche per la politica adottata in Persia e in Marocco, questa reazione ostile della stampa britannica impedì a Grey di esprimere la propria simpatia
verso l’Italia. Così, mentre tra luglio e settembre la neutralità di Grey fu
caratterizzata da una forte inclinazione pro-italiana, da ottobre in poi la
sua politica di non intervento fu genuina. Specialmente dopo l’episodio di
Sciara Sciat e le proteste che esso suscitò sulla stampa e nei dibattiti alla Camera dei Comuni, fu sempre più difficile non tener conto del sentimento
popolare. Sebbene Grey personalmente non sostenne mai i turchi, il sentimento popolare più una crescente irritazione verso l’Italia per aver riaperto
la «questione d’Oriente» furono sufficienti ad eliminare ogni prospettiva di
accordo anglo-italiano fin tanto che la guerra fosse in corso. Dopo il decreto di annessione vennero meno le uniche speranze di trovare rapidamente
una soluzione al conflitto attraverso la mediazione delle grandi potenze, in
più, il protrarsi di esso costituiva una minaccia così grave per gli interessi
inglesi che Grey non poteva continuare a parteggiare per l’Italia. Sebbene
avesse respinto una proposta turca di accordo, ora cercava di non alienarsi
le simpatie turche.
Il bombardamento di Beirut in febbraio e la chiusura degli stretti non
solo interferirono col commercio britannico, ma aumentarono i pericoli
34
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
che il conflitto si estendesse nei Balcani. Il rifiuto italiano di scendere a
compromessi e l’estensione del conflitto alla Turchia europea e all’Egeo,
fecero venir meno del tutto il sostegno inglese all’Italia. Nel marzo 1912
Mensdorff da Londra notò il prevalere di un sentimento pro-turco e perfino il re, che non era mai stato turcofilo, ammise la necessità di considerare
i sentimenti dei sudditi musulmani in India.
3. La reazione inglese da un punto di vista diplomatico fu di «benevola
neutralità» e il Foreign Office, in quel periodo guidato da sir Edward Grey,
si limitò a protestare presso il governo italiano a causa di operazioni belliche che avrebbero potuto compromettere gli interessi economici e commerciali inglesi. Grey si rifiutò fin dall’inizio di esporre la Gran Bretagna al
35
Barbara Gregori
rischio di alienarsi l’amicizia dei contendenti esercitando pressioni nei loro
confronti e preferì proporre un’azione congiunta da parte delle potenze
europee allo scopo di risolvere diplomaticamente il conflitto.
Se questa era la situazione politico-diplomatica in Gran Bretagna, ben
diverso fu lo stato dell’opinione pubblica. Sappiamo che la campagna di
stampa anti-italiana fu una caratteristica comune a tutte le grandi potenze
europee, ma fu in Gran Bretagna che assunse i toni più violenti e critici.
La stampa, infatti, già alcuni giorni prima dell’inizio del conflitto aveva
espresso la propria preoccupazione per le conseguenze che l’azione italiana
avrebbe avuto e si era chiesta se l’Italia avesse valutato attentamente i pericoli che la sua cupidigia avrebbe comportato. Alle prime avvisaglie di operazioni belliche, l’opinione pubblica inglese s’irritò criticando severamente
questo atto di forza italiano, giudicato senza precedenti per l’illegalità e la
sfrontatezza che lo caratterizzarono.
Ciò che impressionò maggiormente il pubblico inglese furono le notizie relative ai presunti massacri perpetrati da soldati italiani nei confronti
della popolazione araba, avvenuti nell’oasi nei pressi di Tripoli tra il 23 e il
27 ottobre. I resoconti e le testimonianze di questi episodi furono agghiaccianti e sollevarono non solo un ampio segmento dell’opinione pubblica
inglese, ma anche una sezione della Camera dei Comuni. I radicali, infatti,
organizzarono delle conferenze e proposero delle mozioni inerenti ai fatti
dell’oasi in cui auspicavano un intervento decisivo da parte del Governo
di Sua Maestà, tale da porre fine alle ostilità in Tripolitania e Cirenaica.
Dunque se il Foreign Office mantenne un certo contegno nei confronti
di questa guerra, altrettanto non può dirsi per la stampa, che ha elargito
insulti ed offese alla dignità e all’onore dell’esercito italiano e non ha mancato di dimostrare un atteggiamento filo-turco e anti-italiano.
A questo proposito è bene aprire una piccola parentesi sul rapporto tra
stampa e politica estera. Il Foreign Office, come d’altra parte altri ministeri
inglesi e non, si è sempre servito della stampa come collegamento con il
mondo esterno. Si trattava però di un processo biunivoco: da un lato, il Foreign Office era conscio dell’utilità della stampa e periodicamente cercava
di influenzarla attraverso contatti privati o pubbliche dichiarazioni; dall’altro, il segretario agli esteri e il suo staff traevano dagli articoli di fondo di
quotidiani e periodici informazioni ancor più dettagliate di quelle fornite
dai propri diplomatici.
I giornali potevano creare o distruggere un particolare stato d’animo,
36
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
ma raramente potevano provocare un cambiamento concreto nella politica
estera del paese. I casi di cedimento alla pressione popolare furono rari,
ma non mancarono oscillazioni della pubblica opinione che complicarono
il processo diplomatico. Se l’opinione della stampa non poteva alterare il
punto di vista del Foreign Office, allo stesso modo v’erano pochi editori
disposti ad accettare i suggerimenti del governo38. In generale il Foreign
Office si astenne dall’elogiare o biasimare la stampa ed intervenne presso
Fleet Street soltanto in momenti particolarmente critici. Data la struttura
della stampa inglese, il segretario agli esteri aveva poche armi nelle sue mani in grado di influenzarla e il Foreign Office, come istituzione, era conscio
delle potenzialità di questo tipo di diplomazia pubblica.
Sono state avanzate numerose ipotesi per spiegare l’atteggiamento
37
Barbara Gregori
dell’opinione pubblica britannica: alcuni hanno sostenuto che la stampa
sia stata influenzata dai circoli finanziari, soprattutto ebraici, che vedevano
nel conflitto un’ottima occasione di speculazione; altri che si sia trattato
dell’influenza dei circoli pacifisti e radicali, contrari alla guerra in generale;
altri ancora hanno sostenuto che i responsabili di questo atteggiamento
siano stati i gruppi economici interessati ad estendere l’influenza britannica nell’impero ottomano, approfittando dell’impossibilità tedesca di intervenire presso l’alleata italiana per indurla a cessare le ostilità. Noi possiamo soltanto aggiungere che questa ostilità non è stata una caratteristica
comune a tutti i giornali inglesi, viceversa lo è stata rispetto alle maggiori
potenze europee; forse dovremmo inquadrarla più nell’ambito dei sistemi
d’alleanze di allora, piuttosto che tentare di spiegarla individualmente.
Note al testo
1
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya 1911-1912, Duke University Press, Durham, North Carolina, 1942, p. 68.
2
In un dispaccio del 28 luglio 1911, Grey scrisse a Rodd che l’ambasciatore italiano gli aveva
comunicato le difficoltà incontrate dagli italiani a Tripoli e la possibilità che l’Italia fosse obbligata a compiere qualche passo. Egli aveva espresso la sua simpatia verso l’Italia, date le ottime
relazioni tra i due paesi e aveva risposto che se davvero, a causa di un trattamento economico
sfavorevole, la mano italiana fosse stata forzata, egli avrebbe espresso ai turchi l’opinione che, di
fronte ad un trattamento simile da parte loro, il governo turco non poteva aspettarsi altro. Sir
Edward Grey to Sir R. Rodd, 28 Luglio 1911, in G. P. Gooch - H. Temperley, British Documents on the Origins of the War 1898-1914 (d’ora innanzi B. D.), Vol. IX, Part I, The prelude;
The Tripoli war, His Majesty’s Stationery Office, London 1933, p. 264.
3
R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers: Italian foreign policy before the First World
War, Cambridge University Press, Cambridge 1979, p.192.
4
R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers cit., pp. 192-193.
5
Dai documenti diplomatici inglesi emerge che Grey non s’aspettava che l’Italia avrebbe agito
così rapidamente; credeva che le minacce italiane fossero solo un modo per premere sul governo turco affinché cedesse alle sue richieste. Vedi per esempio Sir E. Grey to Sir F. Bertie, 5
ottobre 1911, B. D., IX, p. 302.
6
R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers cit., p. 193.
38
La posizione inglese durante il conflitto italo-turco
7
F. Malgeri, La guerra libica (1911-12), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970, pp.
108-110; queste dichiarazioni sono confermate in un dispaccio: Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 29
settembre 1911, B. D., IX, p. 284.
8
F. Malgeri, La guerra libica cit., p. 111.
9
Ivi, p. 112
10
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya cit., p. 67.
11
Ivi, p. 67.
12
Ivi, pp. 69-70
13
Sir R. Rodd to Sir E. Grey, 30 settembre 1911, B. D., IX, p. 288.
14
L. Mallet and A. Nicolson, non datata, B. D., IX, 288; essi sostenevano che la linea adottata
dalla stampa inglese era deplorevole e che l’unico risultato sarebbe stato perdere la simpatia
italiana, dimostrata all’Inghilterra anche durante la guerra boera, e incoraggiare la Turchia ad
aspettarsi supporto materiale e prolungare il conflitto. Bisognava convincere alcuni editori a
mantenere una decente neutralità.
15
Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 2 ottobre 1911, ibidem, IX, p. 296.
16
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya cit., p. 93.
17
Ivi, p. 93.
18
Ivi, p. 103.
19
Ivi, pp. 104-105.
20
C. J. Lowe - F. Marzari, Italian foreign policy 1870-1940, Routledge and Kegan Paul, London
and Boston 1975, p. 116.
21
Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 6 Novembre 1911, B. D., IX, p. 319; Grey aveva risposto al telegramma dell’ambasciatore italiano riguardante il decreto di annessione, che avrebbe dovuto
verificare con le altre potenze se vi era stata violazione di trattati internazionali o di diritti
britannici, specialmente commerciali, derivanti da trattati.
22
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya cit., pp. 107-108.
23
Ivi, pp. 195-196.
24
Ivi, pp. 201-202.
25
Sir R. Rodd to Sir E. Grey, 19 aprile 1912, B. D., IX, p. 386 e Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 22 aprile 1912, ibidem, pp. 388-389; l’ambasciatore italiano sperava che l’Inghilterra non chiedesse al
suo governo di astenersi dal compiere azioni ostili nei pressi degli stretti.
26
Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 19 aprile 1912, B. D., IX, pp. 387-388; Nicolson giustificò la reazione turca, considerando che è compito dei forti quello di proteggere un paese da una flotta
nemica, ma non quella italiana, di cui non comprendeva lo scopo.
27
Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 30 aprile 1912, B. D., IX, p. 390; Grey aggiunse che un’azione
italiana in tal senso sarebbe stata molto apprezzata in Inghilterra.
28
Sir G. Buchanan to Sir E. Grey, 5 marzo 1912, B. D., IX, p. 373; Sazonov riteneva che le potenze, in quanto neutrali, non fossero giustificate nel presentare all’Italia una richiesta simile. Egli
non voleva compiere alcun passo che potesse dispiacere al governo italiano, soprattutto perché
l’Italia controbilanciava l’Austria nei Balcani e sin dagli accordi di Racconigi del 1909 Italia e
Russia si erano tenute in stretto contatto in merito alla loro politica in quella penisola.
29
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya cit., pp. 206-207.
39
Barbara Gregori
30
Major Tyrrell to Sir G. Lowther, 29 aprile 1912, B. D., IX, pp. 392-394.
31
W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya cit., pp. 211-213.
32
Ivi, pp. 215-216.
33
Ivi, p. 222.
34
Ivi, pp. 222-223.
35
Admiralty to Foreign Office, 29 giugno 1912, B. D., IX, pp. 413-416.
36
C. J. Lowe – F. Marzari, Italian foreign policy cit., pp. 120 ss.
37
Sir E. Grey to Sir A. Nicolson, 19 settembre 1911, B. D., IX, p. 274.
38
Zara S. Steiner, The foreign Office and foreign Policy, 1898-1914, Cambridge University Press,
Cambridge 1969, pp. 188-192.
40
La mia campagna d’Africa
di Giuseppe Scaglione1
Mi chiamo Giuseppe Scaglione, detto «Pinot» per abbreviare. Sono nato il 19 agosto del 1916 in questa casa, che è la casa della mia famiglia, che
appartenne prima ai miei nonni e poi ai miei genitori. Il papà, che era della
classe 1891, aveva 11 o 12 anni quando è venuto a vivere qui da Calosso
con i suoi. Gli altri fratelli del nonno rimasero ad abitare a Calosso, nella
località detta Piana del Salto. I miei genitori erano contadini. Qui alla cascina Bauda mio nonno fece il mezzadro per due anni, poi il proprietario,
il signor Bauda, ha pensato di vendergliela. Bauda era cognato del nonno:
entrambi avevano sposato due sorelle, Clementina e Luigina. Così mio
nonno ha venduto casa e terra a Calosso, e dalla Piana del Salto si sono
stabiliti qui. Da allora non ci siamo mai più mossi. Bauda abitò poi per
qualche tempo a Castagnole Lanze, vicino a Canelli di cui era originario.
Quando mio padre fu un po’ cresciuto, il nonno si trasferì a Milano,
dove lui e Bauda aprirono una compravendita di vino. Il nonno aveva già
lavorato nella cantina di Bauda, e così, con la nonna, è andato a Milano,
dove sono sempre rimasti. Questa casa è stata costruita nel 1877.
La cappella qui vicino c’era già da non so quanti anni. Da quando sono
nato l’ho sempre vista così, e così è ancora. È dedicata al santo Efrem, un
santo dal nome ebraico. Forse sarà stato un ebreo che l’ha costruita, e che
ci ha messo il quadro di sant’Efrem. Sul calendario sant’Efrem c’è. Io sono
nato qui, e qui i miei genitori hanno vissuto.
A Casale Monferrato
Sono stato richiamato al servizio militare il 1° settembre del ’39, a Casale Monferrato, a un centinaio di chilometri da casa mia. Facevo l’artigliere radiotelegrafista.
41
Giuseppe Scaglione
10 giugno 1940 dichiara guerra alla Francia e all’Inghilterra.
22-24 giugno 1940: offensiva italiana sul fronte occidentale contro la Francia.
Nel giugno del 1940 da Casale Monferrato ci hanno trasportati a Bardonecchia, e di là sotto al Monte Bianco e al Colle del Piccolo San Bernardo per fare la guerra contro la Francia. Siamo scesi per la Val d’Isere e
così siamo arrivati in Francia. Lì abbiamo combattuto. In Francia è stata
breve: in tre, quattro giorni è finito tutto su quelle montagne. Prima che
Mussolini e Hitler facessero quella guerra, l’Italia e la Francia si consideravano come sorelle. Poi per quella guerra i francesi, quando fummo loro
prigionieri in Africa, ci trattarono male.
24 giugno 1940: viene firmato l’armistizio tra Italia e Francia.
28 ottobre 1940: inizia l’aggressione italiana alla Grecia.
Finita in Francia, abbiamo fatto ritorno a Casale Monferrato, nella caserma in cui io ero in servizio permanente. Lì ci arrivò l’ordine di mobilitarci per partire per la Grecia. Eravamo pronti, ci avevano già dato tutto
Il reticolato confinario con l’Egitto al km. 200, nei pressi di Giarabub, 1931.
Collezione Luigi Goglia, Roma.
42
La mia campagna d’Africa
l’occorrente. In quei giorni in cui si preparava la partenza non davano a
nessuno permessi per andare a casa. Ma la sera della vigilia dell’Epifania
del ’41, era sabato, andai in libera uscita. Presi il treno e, via!, sono venuto
a casa. Dovevo partire per la Grecia, e invece sono venuto a casa, senza
permesso.
Mi hanno trovato però: qualcuno pensò che potessi essere andato a
casa, e così mi hanno telefonato al posto telefonico pubblico. L’ordine fu
quello di affrettarmi a tornare in caserma a Casale perché il mio gruppo
era in partenza. Ma era tardi, non sarei più riuscito a rientrare a Casale in
serata. Al telefono glielo dissi che li avrei raggiunti solo l’indomani mattina
presto, che avrei preso il primo treno alle cinque.
settembre 1940: le truppe italiane occupano, in Egitto, Sollum e Sidi el Barran.
L’ho preso quel primo treno, ma, alla stazione di Valenza Po, ho incontrato la tradotta dei miei compagni che andavano verso sud per imbarcarsi.
E io invece andavo verso nord, verso Casale Monferrato.
In caserma non mi hanno punito, ma mi hanno mandato in Africa.
Il maggiore, quando si è reso conto che non ero partito con i miei compagni, infuriato ha telefonato a un altro ufficiale, che poi me lo ha riferito,
dicendogli: «Portami subito il caporale maggiore Giuseppe Scaglione, che
arrivato in Africa lo voglio legare per tre giorni ad una palma». Sono stato
due anni e mezzo in Africa, in guerra, a Tobruk, a El Alamein, a Marsa
Matruth, a Sidi el Barrani, a Fuka, dappertutto. Sono partito per l’Africa il
giorno successivo all’Epifania del 1941. Era lunedì.
In Africa
Era quindi il principio di gennaio 1941. Ci hanno imbarcati a Napoli
e ci hanno sbarcati a Tripoli. Abbiamo fatto presto: solo tre giorni di navigazione. Non è tanto lontano andare da Napoli a Tripoli.
Di Tripoli non abbiamo visto niente. Abbiamo attraversato tutta la città carichi come somari, con il pastrano, le giberne, la borraccia da due litri,
il tascapane, la sacca di tela che chiamavamo bottino, lo zaino, la maschera
antigas, il fucile, la pistola, e cosa c’era ancora?! Tutte cinghie a tracolla di
qua e di là, stracarichi. È stata una sudata! La gente che ci guardava stava
al fresco e all’ombra, nei giardini della città, e noi a camminare per quelle
43
Giuseppe Scaglione
Testo della canzone A Tripoli.
44
La mia campagna d’Africa
vie sotto il sole. Era bella Tripoli, ma non abbiamo visto niente. Appena
sbarcati ci hanno fatti andare, attraversando così bardati e a piedi, tutta la
città, alla caserma dell’autocentro, dove ci hanno caricati sopra i camion.
Da lì ci hanno portati ad Ain Zara, a 12 chilometri da Tripoli, nel deserto.
Lì non c’era niente, solo qualche palma.
Ain Zara consta del fortino omonimo, del forte Ameglio, e di baraccamenti militari. Poche
palme presso stagni, normalmente asciutti d’estate. Fu occupata dagli italiani il 4 dicembre
1911.
Il 28 giugno del ’40 era morto Italo Balbo, il governatore della Libia.
Gli hanno sparato gli italiani: fuoco amico. L’hanno abbattuto a Tobruk.
Gli hanno sparato dalla San Giorgio, la corazzata, l’unica nave corazzata
che aveva l’Italia. Lo sapevano tutti che Balbo sorvolava spesso Tobruk con
l’aereo per andare in Egitto a osservare le linee inglesi. Passava sovente in
volo da lì, e lo conoscevano bene il suo aereo. È stato certamente un traditore a sparargli. E dalla San Giorgio, lì nel porto di Tobruk, gli hanno sparato e l’hanno abbattuto. Com’è caduto a terra, stando a quanto si diceva,
l’hanno identificato dal berretto. L’aereo si è incendiato, ma il berretto si è
salvato perché è saltato fuori dall’aereo. Erano tutti contenti di non essersi
sbagliati. Questo era successo qualche mese prima del mio arrivo.
Italo Balbo, giugno 1931.
45
Giuseppe Scaglione
Ci hanno portati dunque a Ain Zara, a 12 chilometri da Tripoli, e ci
hanno depositati lì in una grande caserma lasciandoci lì da soli per giorni.
Gli ufficiali non li abbiamo più visti, neanche uno. Erano andati a Tripoli
per tre giorni. E noi, tutta la truppa, eravamo lì senza mangiare, senza bere,
senza niente. Posto strano l’Africa. Faceva un caldo!, più caldo là nel mese
di gennaio che qui al mese di giugno. Ain Zara è vicina al mare, come
Misurata, Homs, e diversi altri paesi della costiera. A Ain Zara entrai a far
parte del 2° reggimento di artiglieria. Eravamo in tanti: diverse batterie, la
13ª, la 14ª, la 15ª, e avevamo le batterie con le mitragliere da 20.
Gli arabi
Di libici, di arabi, non ne abbiamo visti neanche uno. Ne avevamo
incrociati solo nei primi tre giorni a Ain Zara. Da loro compravamo da
mangiare.
Un cammelliere (Homs).
46
La mia campagna d’Africa
In quella caserma non avevamo niente, nemmeno acqua c’era. Cosa
mangiavamo? Datteri verdi, acerbi da non potersi immaginare. Non c’era
altro, niente, niente, niente! Per tre giorni abbiamo mangiato quei datteri,
che compravamo. Ce n’erano delle palme lì a Ain Zara, ma quei datteri
erano verdi, acerbi.
E per andare a prendere l’acqua da bere, una borraccia d’acqua, facevamo tanta strada come da qui fino alla collina di Loazzolo, neh? C’era da
marciare due, tre ore, e altrettante per tornare, per arrivare fino alla sorgente per prendere una borraccia d’acqua. E in quella sabbia, in quel deserto,
si camminava male perché si affondava come nella neve alta, o peggio an47
Giuseppe Scaglione
cora. Faceva caldo. Avevamo la divisa grigioverde di panno, che avremmo
indossato ancora per un anno e mezzo. Dopo ci hanno dato la divisa di tela
marrone, color caki. Ma prima stavamo con quella divisa grigioverde che
avevamo da Casale. Ed eravamo pieni di pidocchi.
Gli ascari eritrei sapevo che erano lì già da prima di quando siamo arrivati noi, ma io non li mai ho visti. Durante la ritirata sono stati tutti presi
prigionieri dagli inglesi, dagli australiani e dai neozelandesi. Tutti presi.
Ascari eritrei (Tobruk).
Ma arabi niente. Li abbiamo visti nella ritirata, quando eravamo andati
per conquistare Tobruk, e invece abbiamo dovuto ritirarci. Abbiamo visto
un solo arabo: aveva un gregge di pecore, e i miei compagni siciliani gli
sono volati addosso a quelle pecore, e ne hanno ammazzate, e le hanno fatte cuocere. Quella volta abbiamo mangiato carne di pecora, bollita senza
48
La mia campagna d’Africa
acqua, senza sale, senza niente. Anche il maggiore che diceva ch’era buona.
Non avevamo niente da mangiare, e tutto quello che trovavamo era buono
anche senza sale.
Indigeni della Sirtica (Misurata).
Gli arabi erano scappati tutti, andati tutti a Tripoli da Bengasi, da tutti
i paesetti che aveva fatto Mussolini, i villaggi del Gebel cirenaico. Sono
andati via tutti, hanno sgombrato tutto.
In Libia è in atto una colonizzazione agricola intensiva a deciso sfondo demografico, che
tende a trasferirvi il maggior numero possibile di famiglie coloniche metropolitane. Tale
politica colonizzatrice cominciò ad attuarsi nel 1932. Svolse la sua prima attività sul Gebel
cirenaico, ove nel 1933 sorsero i villaggi agricoli Razza, Beda Littoria, Luigi di Savoia,
Berta e nel 1936 il villaggio Maddalena.
In quei villaggi c’erano casette tutte uguali, non grandi ma belle, tutte
villette. Ne hanno fatti tanti gli italiani di quei villaggetti, e ce n’erano anche dalla parte di là, oltre Tripoli, verso la Tunisia. Ci abitava gente venuta
della Sicilia, e tanti veneti.
49
Giuseppe Scaglione
La colonizzazione demografica intensiva in Libia del 1938. Il villaggio
Bianchi. Isiao, Roma.
Contadini pugliesi in Cirenaica, settembre 1933.
Isiao, Roma.
50
La mia campagna d’Africa
Il villaggio Cesare Battisti, uno dei villaggi agricoli creati in Libia, 21 ottobre 1939. Isiao, Roma.
La colonizzazione demografica intensiva in Libia: lo sbarco dei ventimila a Tripoli, 2 novembre
1938. Foto Luce. Isiao, Roma.
51
Giuseppe Scaglione
Non so come facevano a viverci perché lì la terra non rendeva mica
niente. Li mantenevano dall’Italia, portavano loro da mangiare. Lì era solo
sabbia, e niente d’altro. Era tutta sabbia, e lì non piove mai, e non viene
mica niente: non un filo d’erba, non una pianta, niente, niente, niente.
Soltanto sabbia e pietre. Pietre ce n’erano tante, e tanta sabbia. Quando
c’è il ghibli, che dura sempre tre giorni, la sabbia brucia anche la faccia.
La sabbia è bollente, acceca gli occhi. Ci avevano dato degli occhiali, ma
non servivano perché la sabbia entrava dappertutto. Quando andavamo in
posizione e tirava il ghibli era brutto perché non si vedeva, come quando
c’è la nebbia. E quando tirava il ghibli erano battaglie ....
La campagna d’Africa
Cartolina di propaganda per la guerra in Africa settentrionale. Anno 1940.
Per tre giorni siamo stati lì, a Ain Zara, da soli, senza mangiare, senza
bere. Poi sono arrivati dei camion, i cannoni, i trattori, la cucina e tutto il
resto. E subito ci hanno fatto salire sui camion per partire immediatamente
verso Tobruk.
52
La mia campagna d’Africa
Africa settentrionale, soldati italiani in marcia, settembre 1940.
Per fortuna, un po’ di chilometri prima di Tobruk, abbiamo incontrato
il generale Graziani. Era in mezzo alla strada e agitando le mani in alto ci
gridava: «Tornate indietro, tornate indietro». Prima di noi a Tobruk erano
già arrivati gli inglesi.
I nostri ci avevano provato: la divisione Sirte, la Sabrata, la Savona, la
colonna Santa Maria, e altre divisioni erano andate tutte prima di noi.
13 settembre 1940: Graziani valica la frontiera egiziana, conquista Sollum e punta su Sidi
el Barrani, cento chilometri dal confine.
Ma a Marsa Matruth incombevano gli inglesi, e Graziani aveva fermato
i nostri soldati in Cirenaica, a Sollum, e a Sidi el Barrani, in Egitto.
Tra di loro c’era il mio amico Garbarino dell’artiglieria contraerea, che
abita qui vicino. Lui era laggiù da sei mesi prima di me, dal giugno del ’40.
Quando siamo sbarcati noi, lui coi suoi erano già a Sidi el Barrani,
pronti ad attaccare gli inglesi a Marsa Matruth, in territorio egiziano.
Mentre gli inglesi ricevevano i rinforzi, gli italiani costruivano la strada,
«la strada dell’Asse». Invece di andare a occupare l’Egitto, lavoravano a fare
la strada.
53
Giuseppe Scaglione
Fronte Africa settentrionale, i generali Cavallero e Bastico insieme alle autorità tedesche all’ingresso della via dell’Asse, agosto 1941.
Aspettavano anche loro che arrivassero i rinforzi. Io facevo parte di quei
rinforzi.
9 dicembre 1940: l’esercito britannico attacca con inaudita violenza le posizioni italiane
di Sidi el Barrani.
Poi gli inglesi attaccarono. Garbarino gli inglesi l’hanno preso prigioniero. Sono stati tutti presi prigionieri, anche un sergente e cinque, sei
soldati del reggimento dell’artiglieria contraerea di Vercelli. Garbarino
l’hanno portato a Suez, poi in Pakistan, e la prigionia l’ha fatta tutta lì. E’
tornato a casa sei mesi dopo di me. Io sono tornato alla fine del ’45. Lui è
ritornato nel ’46. L’ha fatta più lunga.
E così, dopo aver fatto marcia indietro da Tobruk, siamo tornati fino a
el Agheila, fino a Sirte, e abbiamo tenuto tutto fermo a Sirte.
Gli inglesi e gli australiani non li abbiamo lasciati venire avanti. Li abbiamo tenuti fermi, e non hanno potuto avanzare.
54
La mia campagna d’Africa
Fronte Africa settentrionale, mezzi inglesi distrutti presso El Agheila, marzo 1941.
Tobruk
marzo 1941: in Libia, con il sostegno dell’Afrikakorps tedesco al comando di E. Rommel, inizia la controffensiva italo-tedesca. Viene rioccupata la Cirenaica, tranne Tobruk.
Lì abbiamo aspettato più di un mese finché, nel mese di marzo, non
sono arrivati i tedeschi, e dopo siamo partiti tutti insieme, tedeschi e noi,
da Sirte. Coi tedeschi siamo partiti subito verso Tobruk, e siamo andati
avanti fino al confine con l’Egitto, a passo Halfaya e Sollum. Con la divisione tedesca, la 15° leggera tedesca, siamo stati parecchi mesi. Loro facevano fanteria, noi eravamo artiglieria celere, e eravamo sempre assieme.
Eravamo sempre i primi a andare avanti, e nelle ritirate sempre gli ultimi,
a aspettare, tenere, tenere, perché i nostri soldati potessero salvarsi, sennò
rimanevano prigionieri. Noi tenevamo sempre perché i nostri potessero
55
Giuseppe Scaglione
fare a tempo a scappare.
Tobruk l’abbiamo lasciata fuori, siamo passati fuori da Tobruk. Da Tobruk non si poteva passare perché c’era la trincea, il fosso anticarro intorno, profondo quattro metri e largo altrettanto, e di lì non si poteva passare.
Era in cemento armato, di quattro metri di profondità e quattro metri di
larghezza. Se ci volavamo dentro non usciva più nessuno di là.
Con i tedeschi allora abbiamo aggirato Tobruk. I nostri sminatori del
genio hanno tolto le mine dalla strada dell’Asse. Passavano con gli attrezzi
a cercare le mine e le scartavano ammucchiandole ai bordi della strada,
da una parte e dall’altra. E guai a scartare da quella pista, perché sennò si
saltava sopra le mine, caro mio.
Africa settentrionale, spostamento di un pezzo di artiglieria, aprile 1942.
56
La mia campagna d’Africa
novembre 1941: un’offensiva britannica in Cirenaica costringe a un progressivo ripiegamento italo-tedesco.
Ma quella strada l’avevano fatta ancora troppo vicina a Tobruk, e da
Tobruk gli inglesi quando vedevano che passavano colonne di camion che
portavano rifornimenti verso il confine con l’Egitto, a Sollum, sparavano delle cannonate, e sopra quella pista mica si riusciva a passare, perché
loro sparavano coi 152, delle briscole piuttosto grosse. Bisognava passare
dal pericolo, eppure bisognava passare, e quei campi minati erano lunghi
chilometri, chilometri di terra minata. Mine anticarro grosse così, per i
camion. Ma ce n’erano anche di piccole per i soldati, per la gente. Quanti
ne sono morti per causa delle mine! Anche sulla strada asfaltata, una strada
stretta di soli tre metri, dove due camion non si potevano incrociare. Allora
bisognava che uno dei due andasse fuori strada. Ma andando fuori strada
entrava nella sabbia, e nella sabbia i camion si insabbiavano, non andavano
più avanti, e bisognava rimorchiarli con un carro armato. Era una pazzia!
Cartolina di propaganda per la guerra in Africa settentrionale.
Anno 1942.
57
Giuseppe Scaglione
maggio 1942: ha inizio una nuova offensiva italo-tedesca in Cirenaica. Cade in mano
tedesca la base britannica di Tobruk.
Rommel lo vedevo quasi tutti i giorni. Rommel, lui veniva là proprio
come noi. Quando passava sopra in aereo, gli inglesi gli sparavano con la
contraerea. Lui andava via e dopo un po’ di tempo, un’ora, un’ora e mezza,
sentivi la sua cicogna che tornava. E gli sparavano ancora. Ma lui scendeva
là in mezzo a noi, dove noi avevamo le batterie e i cannoni. Era immortale
quell’uomo lì. Passava davanti ai nostri cannoni, alle nostre batterie. E
gli inglesi tiravano, ma decisi eh!, e lui in piedi sulla macchina scoperta,
in piedi col binocolo, e guardava gli inglesi, e non si abbassava, e entrava
dentro nel fumo delle granate che scoppiavano davanti, di dietro, di qua e
di là. Niente, era immortale quell’uomo là.
Il generale Rommel, giugno 1941.
Veniva tante volte a mangiare con il nostro maggiore, Pardi Leopoldo,
al comando, quando eravamo al passo Halfaya. Rommel lo vedevo spesso,
ma non gli ho mai parlato da vicino. Ci hanno bombardati dal mare quando eravamo a passo Halfaya, sul confine con l’Egitto. Ci tiravano bombe
grosse da quelle navi.
A passo Halfaya, quando ci siamo arrivati, sul confine con l’Egitto, era
58
La mia campagna d’Africa
il 15 di maggio. Lì c’era un tendone che sembrava un padiglione come
quelli che si usano per fare le feste da ballo. Era un padiglione che avevano
fatto gli inglesi. Era in una spianata, e quel padiglione giallo, quel tendone
giallo, stagliava. E i tedeschi sono venuti a bombardarlo. Ma c’eravamo
già arrivati noi. Quando i tedeschi avevano avuto l’ordine di bombardarlo
c’erano dentro ancora gli inglesi, ma quando poi sono venuti a bombardare c’eravamo già noi là. Quella volta là ho avuto fortuna: sono saltato
in una buca a due metri di distanza da dov’ero. Quando ho visto che c’era
quella buca ho fatto un volo, tanto che ho preso una botta nella scarpa.
Al piede non mi ha fatto quasi niente, ma mi è venuto tutto nero per
la botta. Non so se sia stata una scheggia o una pietra, non so. Mentre
saltavo dentro alla buca, ho sentito quella botta al piede che era ancora
fuori terra.
Una bomba, la più grossa, non è scoppiata, ed è andata a finire contro
la ruota del camion su cui c’era il comando di gruppo. Se scoppiava, il camion sarebbe volato in mille pezzi. Sono venuti poi i tedeschi, due soldati
tedeschi con la moto, a farla scoppiare, e ci hanno fatto scappare lontano,
lontano un chilometro, e da lì abbiamo ancora sentito delle schegge che,
uuuuuuhhhhhh!, andavano lontano. Era alta così, e grossa così.
16-21 giugno 1942: Rommel supera Tobruk e raggiunge il confine con l’Egitto.
Il 21 giugno fu l’attacco decisivo per prendere Tobruk, per togliere di
mezzo gli inglesi, perché andare sempre per quella strada dell’Asse intorno
a Tobruk era pericoloso. Una volta conquistata Tobruk avremmo potuto
passarci dentro. Abbiamo combattuto tre giorni e tre notti in un fuoco
d’inferno. Ma niente da fare: abbiamo dovuto ripiegare, andare fino a
Marsa Matruth. E non siamo riusciti a prenderla Tobruk.
Poi hanno cominciato i tedeschi con gli Stukas, a cinquanta, sessanta
alla volta. Via quelli, ne arrivavano altri; via quelli, ne arrivavano altri.
Hanno bombardato tanto che il fosso anticarro in tanti punti l’hanno spianato, e ci siamo passati coi camion anche noi, e coi nostri trattori. L’hanno
spianato a forza di buttare bombe, perché sennò non si poteva entrare in
Tobruk. È stata una battaglia tremenda. Dopo che fu finita, era tutto nero di un fumo che non vedevi più niente. A furia di lanciare bombe. Gli
Stukas erano tremendi. Noi li abbiamo bombardati due volte per sbaglio,
neh?!? Per due volte li abbiamo bombardati. E loro venivano, li vedevi, giù
59
Giuseppe Scaglione
Africa settentrionale, partenza di uno Stukas, luglio 1941.
a piombo, per la madonna! Centravano un’autoblinda, un carro armato,
un camion, precisi, e vaaahhhm! E al rumore che facevano ... beh, entravi
sotto terra, neh?!?, dalla paura! Ma noi dovevamo obbedire.
Da Tobruk abbiamo proseguito verso El Alamein. Siamo passati per
Sidi el Barrani, Marsa Matruth, el Dabà, Boufika, Fuka.
Tra le divisioni italiane e le divisioni tedesche all’inizio ce n’era, neh?!?,
ce n’era delle forze. Da Casale eravamo partiti in 24, 25. Ma negli ultimi
giorni eravamo rimasti in quattro. Gli altri, tutti morti. Prima eravamo di
servizio a turni di un giorno, dopo eravamo sempre fissi. Al comando di
gruppo, alle batterie, al settore avanzato, sempre, sempre, sempre. Abbiamo scavato tanta di quella terra per farci dei rifugetti in buche che erano
larghe così e profonde così, per starci dentro, perché sennò tutto era piano
come questa tavola: non una pianta, non un filo d’erba, niente. Ti vedevano da lontano. Che guerra, che guerra tremenda. Noi spingevamo per
combattere a tutta velocità. Le battaglie con gli inglesi duravano quattro,
cinque giorni senza un minuto di tregua. Gli inglesi avevano tanti carri
armati, e anche la loro artiglieria era migliore della nostra: i loro cannoni
sparavano a 12 chilometri, mentre i nostri sparavano solo a 9. Noi per
potere sparare addosso a loro dovevamo fare 3 chilometri sotto il loro tiro.
Nevicava cannonate, eppure bisognava continuare. Avevamo l’ospedale da
60
La mia campagna d’Africa
campo per i feriti. Ma l’acqua non c’era mai.
G. Ciano: «Ogni goccia d’acqua doveva arrivare da Marsa Matruth, per quasi duecento
chilometri di strada battuta dall’aviazione nemica».
Per prendere l’acqua i nostri camion facevano 300 chilometri. Tanta di
quella sete, altro che la fame! Tutti andavano al medesimo posto a prendere l’acqua, perché non ce n’era altra. È piovuto una volta sola, il 18 di
novembre del 1942, e poi non abbiamo mai visto una goccia d’acqua, ma
sempre un sole che bruciava. Gli inglesi ci bombardavano il camion, e
allora ne dovevano prendere un altro, e prendevano l’acqua con dei bidoni
di benzina, ancora sporchi di benzina.
La piccola beduina (Derna).
Verso El Alamein
Mussolini: «La battaglia che ebbe inizio il 26 maggio, e che può essere chiamata la battaglia di Tobruk, è finita ai primi di luglio davanti al caposaldo di Bir el Alamein. Essa
ha avuto risultati grandiosi[ ...] ma gli obiettivi prospettati come raggiungibili – Cairo ed
Alessandria – non sono caduti... La battaglia di Tobruk è chiusa; quella di domani sarà la
battaglia del Delta».
61
Giuseppe Scaglione
A Casale noi non eravamo artiglieria celere, eravamo artiglieria di corpo
d’armata. E invece lì, col 2° celere di Ferrara, siamo andati noi a fare da
primo gruppo di artiglieria celere. Il primo gruppo avrebbe dovuto avere i
cavalli, ma portare i cavalli in Africa non era possibile: non c’era neanche
l’erba da dargli da mangiare. E allora siamo andati noi a rimpiazzare quei
cavalleggeri. Avevamo i trattori, trattori veloci, con le ruote alte, grosse,
che non si insabbiavano mai. Invece gli Spa, i camion Spa 38, quelli si
insabbiavano ovunque e non andavano più avanti. Bisognava rimorchiarli
per tirarli fuori dalla sabbia, coi carri armati, o coi trattori, o con le autoblindo, con quello che capitava più vicino.
Quante volte l’aviazione ci venne a bombardare! Noi ci buttavamo a
terra dal camion, perché il camion andava, e c’erano gli Spi, gli Spitfire,
che ci venivano addosso a mitragliarci. Noi battevamo sulla cabina per dire
all’autista di fermare. Ma lui non sentiva per il rumore del camion, e noi
allora ci buttavamo giù per terra mentre il camion andava. E si vedevano
per terra tutte le pallottole che ci mitragliavano, e la sabbia che saltava. I
più fortunati scampavano, gli altri si prendevano addosso le pallottole e rimanevano là. Una volta hanno mitragliato il camion su cui stavo io, e io mi
rifugiai sotto il camion. Erano tre Spitfire che venivano avanti, mentre noi
andavamo verso El Alamein. Eravamo rimasti dietro a tutto il gruppo, non
so perché: il camion forse si era fermato per qualcosa, e siamo rimasti indietro. Ed eravamo soli su quella strada, la litoranea, per andare a raggiungere i nostri, che erano più avanti e andavano. Ho sentito il rumore, mi
sono sporto fuori dal telone, e ho visto quei tre apparecchi ancora lontani
che ci stavano venendo addosso. Sul camion con me c’erano un sergente
e l’autista. Siamo andati fuori strada col camion, e loro sono scesi, hanno
trovato due buche da ripararsi, e io ero rimasto sopra al camion, dietro nel
cassone, sotto il telone. Ma appena ho visto quello che succedeva mi sono
buttato giù, e mi sono infilato sotto il camion. Non potevo cercare altro
rifugio. Due Spitfire ci hanno mitragliato. Il terzo no, ed è passato così.
Ma quei due hanno piantato una mitragliata nella sponda del camion.
Contro quella sponda del camion c’erano venti fustini di benzina pieni, e sono stati tutti bucati dalla mitraglia, e la benzina ha preso fuoco. Il
camion pendeva un poco indietro per la posizione in cui era, e la benzina
colava tutta in un fuoco che andava giù. Io ero sotto e sentivo un caldo
indicibile dietro. Ho fatto appena appena in tempo a vedere tutta quella
benzina che colava giù per tutta la larghezza del camion, e allora mi sono
62
La mia campagna d’Africa
Africa settentrionale, Spitfire inglese abbattuto sul campo di Sgnali, maggio 1942.
fatto più piccolo in maniera che non mi cadesse addosso alla schiena. Sono
andato sul davanti del camion a quattro gambe. Quando il camion fu tutto
in fiamme non hanno più mitragliato. Hanno cominciato però a esplodere
le nostre cassette con i nastri delle mitraglie. E c’erano ancora tre granate
da cannone su quel camion. Fortuna che ero riuscito ad allontanarmi.
Quando sono scoppiate, il camion ha fatto crack, s’è disfatto. Per fortuna era un camion che avevamo preso agli inglesi, uno Chevrolet, tutto
fatto di lamiera. Non come i nostri che il cassone l’avevano di legno, sennò
io da sotto quel camion non sarei uscito più: sarei bruciato con tutto il
camion. L’avevamo catturato agli inglesi, ne avevamo parecchi di quelli
lì. Abbiamo preso loro anche dei cannoni, i 90, ma li abbiamo lasciati
indietro perché non capivamo come regolare la gradazione, la distanza, la
direzione. E li abbiamo abbandonati. E ce n’erano dei mucchi di granate,
63
Giuseppe Scaglione
dei mucchi là nel deserto, erano tante che potevano stare dentro questa
camera. Granate ammucchiate, abbandonate, che gli inglesi non avevano
portato via. Avevano lasciato anche dei carri armati d’assalto, autoblindo,
trattori. Quando qualcuno dei nostri mezzi si guastava, si fermava, usavamo quelli lì quando li trovavamo. Ma i tedeschi li prendevano ancora per
inglesi, e li bombardavano, e dentro c’erano i nostri. Pensavano che erano
inglesi perché erano verniciati di giallo, mentre i nostri erano verniciati di
verde quasi nero.
A el Dabà gli inglesi avevano abbandonato un forno, e c’era il pane, un
mucchio di pane già cotto, e tanto era ancora nel forno che bruciava. E
c’era una quantità di quintali di farina abbandonati là. Ci siamo fatti una
scorta di pane allora, e siamo andati avanti. Loro l’avevano abbandonato,
erano scappati. A volte, quando si ritiravano non potevano portare via i
magazzini della roba da mangiare perché erano grandi, dei pezzi di deserto
enormi pieni di tutte casse, enormi, pieni, un’estensione enorme. Tutte
casse alte, dei mucchi alti, di tutte le qualità di roba. Quando arrivavamo
noi, loro scappavano, e abbandonavano tutto. Se arrivavamo noi per primi
ne approfittavamo. A volte arrivavano per primi i tedeschi. Una volta siamo stati noi i primi, e allora ci caricammo il camion di roba da mangiare,
di biscotti, un po’ di tutto. Ma se arrivavano i tedeschi prima, loro non ti
lasciavano entrare. I tedeschi prendevano loro, e quando arrivavamo noi, ci
lasciavano prendere qualcosa, ma poi dovevamo andare via e lasciare tutto.
E loro invece prendevano tutto.
Facevamo la guerra per toglierci la fame. Cosa ci davano da mangiare?
Gallette, che quando erano quelle quadre nella carta, due per ogni razione, erano pulite perché erano dentro alla carta della busta. Ma quando ci
davano quelle rotonde erano piene di sabbia, perché le tenevano dentro
dei sacchi da metterci il grano, dei sacchi di tela, e quando c’era il ghibli si
riempivano di sabbia e non c’era una goccia d’acqua da lavarle, e le mangiavano così, ma mangiavi più sabbia che pane.
I tedeschi erano bravi con noi. Tante volte sono andato a prendere da
mangiare da loro, quando arrivava il camion che veniva a portare loro il cibo. Io prendevo la mia gavetta, facevo una corsa, andavo là, e se anche c’era
un ufficiale, non mi faceva andare via, lasciava anzi che prendessi anche io
della roba come gli altri soldati. Loro, soldati e ufficiali, mangiavano tutti
uguale, e ne davano anche a me: la minestra, e le sardine, tutto quello che
mangiavano loro lo davano anche a me. Il pane, quelle pagnotte lunghe,
64
La mia campagna d’Africa
pane vero, me ne davano ogni volta un bel pezzo. Loro bevevano sempre
solo caffè, non vino. E mi davano anche due borracce d’acqua di un litro
l’una, una di qua e una di là, sui fianchi.
A El Alamein «nevicava cannonate»
23 ottobre 1942: battaglia di El Alamein.
El Alamein era il posto più scabroso di tutti. I carri armati inglesi ci arrivavano proprio addosso da tre parti. Noi eravamo sulla sponda delle sabbie mobili: le sabbie mobili erano qui, e noi eravamo piazzati a ridosso.
Ci sparavano da tutte le parti, di qua, di là, e dall’altra parte ancora.
Che posto bastardo quello là! E poi vennero coi bombardieri. Prima veniva l’apparecchio ricognitore che ci girava sopra, girava per un’ora o due,
sempre a girare. Era alto, ma si sentiva, e si vedeva. Quando andava via
quello, sapevamo già cosa sarebbe successo. Quando lui ci girava intorno
noi lavoravamo a farci la buca più profonda per ripararci dalle bombe. Poi
arrivavano i bombardieri, in squadriglie di 25, 30 per volta. Andavano
piano, e non facevano la picchiata quando lanciavano le bombe. Noi li
sentivamo già da lontano quando arrivavano: «Sono là che vengono». E
allora ci piantavamo nelle buche, e di lì, finché non andavano via, non ci
muovevamo. Quando erano passati, guardavi fuori, e vedevi camion in
fiamme, autoblindo bruciate, carri armati distrutti. E la contraerea non ce
l’avevamo perché era in un altro posto. Il fronte di El Alamein era lungo
50 chilometri. Di là c’era il mare, e di qua le sabbie mobili.
A El Alamein è durato parecchi mesi, adesso non ricordo più i mesi che
siamo stati là. È stato sempre un combattimento. Loro, gli inglesi, erano
già ad Alessandria. Noi, se non ci fosse mancata la benzina, saremmo andati a Alessandria, a Suez, e al Cairo. E invece c’è mancata la benzina, e
gli automezzi rimasero tutti fermi. Dopo, se riuscivamo a andare al Cairo,
l’ordine era già di andare su di là, e di andare dopo in Russia. C’era già quel
progetto lì. Ma non c’era più benzina. L’abbiamo cercata in un deposito
che era stato degli inglesi, un’estensione di terra piena di latte, le latte quadrate del petrolio, miliardi di latte c’erano in quel posto, ma nessuna aveva
benzina dentro. Erano tutte vuote. Quelle piene le avevano portate via, e
avevano lasciato quelle vuote, tutte asciutte. E siamo arrivati fin là perché
il maggiore aveva detto: «Andiamo al Cairo, andiamo direttamente al Cai65
Giuseppe Scaglione
ro». E i tedeschi dicevano anche loro: «Andiamo a Alessandria, da Alessandria a Suez, e al Cairo». Dopo invece è mancata la benzina e siamo rimasti
tutti fermi. E invece di mandarci benzina, ci mandavano dell’acqua. Ce ne
sarà stato un litro di benzina in ognuno di quei bidoni che erano pieni di
acqua. E allora nessuno si è più mosso.
A volte trovavamo indumenti inglesi e ci mettevamo anche quelli lì, e
il maggiore, quando ci vedeva con quelle robe inglesi: «Ma cos’è questo?
L’esercito di Francischiello?», gridava. E dopo è venuto il momento in cui
anche lui si mise i pantaloni inglesi, quelli lunghi, come il capitano Avezza,
della 14ª batteria. Avezza, due giorni prima della resa, aveva i pantaloni
tutti stracciati, e mi chiese se ne avevo un paio. Combinazione, avevo nello
zaino un paio di pantaloni inglesi nuovi, e glieli ho dati. Quando una volta
l’ho incontrato a un raduno di reduci, gli ho chiesto se se lo ricordava. Ma
non si ricordava più di quando gli avevo dato i pantaloni.
Non l’auguro neanche a una tigre una vita così. Ne avevamo abbastanza
ufficiali, ma ne è avanzato uno solo, un generale. Gli altri sono morti tutti.
Anche il nostro maggiore, che era partito volontario perché aveva tanti debiti perché sua moglie era una che spendeva tanto. E lui per pagare i debiti
e per guadagnare di più, perché la paga laggiù era diversa che a Casale in
caserma, ha fatto il volontario. L’ha pagata cara. Una volta a uno dei nostri,
che era andato uno in licenza perché era morto suo padre, il maggiore gli
ha dato una lettera da dare a sua moglie. E gli ha raccomandato: «E a mia
moglie non dirci niente, neh?!?, di come stiamo qui. Non dircelo, neh?!?».
Quel ragazzo invece le ha raccontato di tutto. Dopo lei ha scritto al
maggiore, e quando quel ragazzo è tornato, il maggiore l’ha rimproverato:
«Ah, sei qui? Ti avevo detto di non dire niente, e tu invece hai detto». Quel
ragazzo gliela aveva raccontata alla moglie del maggiore la vita che si faceva
lì. Quel maggiore è morto col sergente maggiore che con lui ha fatto «tanta
camorra» da fare star male anche i soldati. Ed è morto nella buca insieme
a quello che «ci faceva camorra» a suo favore.
La morte del comandante
Il mio comandante si chiamava maggiore Pardi Leopoldo; era un volontario, e voleva che noi si fosse tutti come volontari. E ce lo diceva sovente,
neh?!?, e ci gridava forte: «Io sono volontario. E voialtri dovete essere tutti
volontari». A El Alamein ci ha lasciato la pelle. È morto là dove non avreb66
La mia campagna d’Africa
be voluto morire. Ci riparavamo in buche scavate nella sabbia. È successo
lì dentro. Una granata ha centrato la sua buca. C’erano il suo attendente,
un sergente maggiore che lo aveva sempre aiutato a «fare camorra», e il
caporale maggiore telefonista. La granata è esplosa proprio dentro quella
buca. Le schegge sono schizzate di qua e di là. Sono rimasti morti sul
colpo, tutti e tre, tranne Pardi, che, ferito, gridava ancora: «Aiuto, aiuto,
aiuto!». Io e gli altri miei compagni siamo saltati fuori dalla nostra buca,
che era vicinissima alla sua, e l’abbiamo tirato fuori. Quanto era profonda
la sua buca, ben più della nostra! L’abbiamo tirato fuori e adagiato su un
camion vicino. È morto per strada mentre lo portavano all’ospedale da
campo. Non ci è arrivato fino all’ospedale da campo. Questo è successo a
El Alamein, lì in Egitto.
Era la prima volta che quel maggiore era venuto là in prima linea, la
prima volta che è venuto. Non era ancora cinque minuti che era là, ed è
morto. Era un napoletano. Invece di darci a noi da mangiare, la roba la
vendevano. Però dopo... Aveva fatto del male, e così è stato ripagato per
quello che aveva fatto.
La ritirata
ottobre 1942: ha inizio la controffensiva britannica la comando del generale Montgomery.
4 novembre 1942: ritirata delle truppe italo-tedesche, che, in tre mesi, sgombrano dalla
Cirenaica e da parte della Tripolitania.
Il generale Montgomery
67
Giuseppe Scaglione
A El Alamein del nostro gruppo ci siamo salvati in due soli, io e il sergente maggiore Saini, che era di Casale. Di tutto il nostro gruppo, di tutto
il 2° reggimento che eravamo giù in Africa, ci siamo salvati in due. Loro,
gli inglesi, erano sempre superiori, erano sempre di più: con loro avevano
gli australiani, i neozelandesi, gli africani, e gli indiani con la testa fasciata
di bianco. Ce n’avevano un’infinità. Erano sempre superiori di numero.
Uno di noi per ogni tre di loro. Le nostre camice nere arrivarono verso
la fine. In principio non ce n’erano. Arrivarono poi, quando eravamo già
in ritirata.
Africa settentrionale, camicie nere sfilano davanti al maresciallo Graziani, settembre 1940.
Gli inglesi ci avevano presi prigionieri a El Alamein, tre volte in una
notte. Ma siamo scappati sempre! Ci hanno presi una prima volta perché
quelli della fanteria che avevamo davanti, quelli della divisione Brescia, si
sono arresi senza dire niente, e noi, quando è arrivata tutta quella fanteria
inglese, ma ce n’era a vista d’occhio, tutta un’immensità!, ci hanno messo
sotto i piedi.
68
La mia campagna d’Africa
Noi non potevamo più sparare coi cannoni, perché gli inglesi li avevamo già addosso, e allora ci hanno preso tutti prigionieri. Il 16° artiglieria
aveva fatto un po’ di resistenza, ma australiani e neozelandesi, con le loro
scimitarre gli hanno tagliato anche la testa. Erano cattivi, neh?!? Ci siamo
salvati io e il mio amico Saini.
Ma ci hanno catturati. Io e un altro, un mio amico di Isola d’Asti, Zuccaro, ci eravamo fatti un rifugetto lì, e l’abbiamo coperto con le cassette
delle granate per tetto. Poi gli avevamo messo sopra della terra e dei sacchetti di sabbia. Abbiamo lasciato un buco, un passaggio da una parte per
entrare. Io stavo in fondo alla buca, dove era coperto, e non potevo vedere
fuori. Il sergente maggiore era invece lì davanti perché era rimasto a riempire di sabbia un sacchetto vuoto, e ci disse che vedeva passare un mucchio
di fanteria inglese. Ci sono passati di sopra, e noi eravamo lì sotto. Poi,
stufi di star là dentro, siamo usciti: io morivo di caldo sottoterra. Appena
siamo usciti sono arrivati altri inglesi. Ne arrivavano continuamente.
E ci hanno presi, e ci hanno portato con sé. Andavano a prendere posizione, e ci portavano con loro. Ma noi non volevamo andare con loro.
Era quasi notte, ed eravamo in marcia con gli inglesi. Il sergente maggiore ci disse: «Andiamo piano, andiamo piano, vediamo se possiamo perderli,
se possiamo rimanere indietro». Loro avevano fretta di andare forte, e noi
invece volevamo lasciarli andare. Loro, gli inglesi, avevano i fucili attaccati
alla spalla, e con quelli ci davano dei colpi nella schiena: «Come on, come
on», ci dicevano. Era buio e siamo riusciti a perderci. Loro avevano fretta, e
gli inglesi che ci erano dietro, nel buio, non ci hanno riconosciuti che non
eravamo dei loro. Quando sono passati tutti, noi siamo tornati indietro.
Liberi, siamo tornati alla postazione dove ci avevano catturati. Per tutto
il giorno non avevamo mangiato niente. Trovammo qualche cosa da mangiare su un nostro camion. Il sergente maggiore allora ci disse: «Andiamo
a mangiare qualche cosa sul camion». Non abbiamo potuto arrivare fino al
camion: a quel punto vennero altrettanti inglesi, come prima, e ci hanno
preso anche quelli lì, e ci portavano appresso a loro come avevano fatto
i primi. Abbiamo dovuto fare uguale: andare adagio, che passassero, che
avanzassero. Quelli che ci superavano non facevano caso se noi eravamo o
meno dei loro. Era notte, dopo mezzanotte, l’una dopo mezzanotte. E così
ci liberammo per la seconda volta, e tornammo al nostro camion. L’ultima
volta che ci catturarono, la terza, chiedemmo di poter andare al nostro
camion per prenderci il pastrano. Gli dicemmo: «Noi siamo prigionieri
69
Giuseppe Scaglione
e non sappiamo dove andiamo a finire, e il pastrano può farci comodo,
abbiamo bisogno di averlo». Siamo arrivati vicino al camion e, sfuggendo
al loro sguardo, ci siamo buttati nelle buche coperte che avevamo fatto lì
vicino per nasconderci. Ma gli inglesi ci hanno scovati, e abbiamo dovuto
alzare le mani un’altra volta. Ci trovarono tastando ovunque nel terreno
col fucile, con la baionetta. Erano baionette lunghe così. Faceva giorno, era
l’alba. C’era una colonna, una fila, lontano cento metri da dove eravamo
noi, di prigionieri tedeschi e italiani mischiati, e c’erano tre o quattro o
cinque soldati inglesi che li accompagnavano verso le loro linee. Ci hanno
messi insieme a quelli là. E poi in marcia: «Come on, come on, come on», ci
dicevano. Volevano farci andare in fretta perché i tedeschi cominciavano
a tirare cannonate. E loro: «Come on, come on, come on», e noi di corsa. Ci
siamo messi a correre tutti. Abbiamo corso per poco, e l’artiglieria tedesca
sparava sempre più sovente. Da lì non si scappava più. E ci siamo buttati
tutti per terra, tutti per terra. E intanto venivano avanti anche i carri armati
tedeschi che mitragliavano continuamente, un continuo mitragliamento,
e sparavano alto così. Le pallottole ci fischiavano sopra la testa. Tanti che
erano stati feriti si lamentavano. Mentre eravamo ancora tutti stesi per terra, è arrivata una batteria inglese con dei cannoni montati sopra i camion,
una batteria volante, di quelle che venivano, prima di giorno, quasi tutte
le mattine a darci la sveglia e che dopo scappavano: venivano, ci facevano
quelle salve di batteria, e subito scappavano via perché avevano paura che
dopo magari noi reagivamo. Sono arrivati con la loro batteria, e si sono
piazzati. E come si mettevano in ordine! Un ufficiale gli dava ordini a voce
alta. Hanno messo i quattro camion coi cannoni in fila. Una cannonata
tedesca, baaaammm, ha centrato il primo camion. Quelli che erano sopra
al camion e che sparavano sono volati per terra in mezzo a quel fumo.
Un’altra cannonata tedesca ha centrato il quarto camion, e anche lì sono volati tutti per terra. E allora quell’ufficiale ha dato ordine di scappare.
Ma un camion non andava in moto e bisognava trainarlo. E mentre
un gruppo di soldati con una fune aspettava che l’altro camion passasse
loro vicino per agganciarlo e metterlo in moto a spinta, una cannonata,
brabaaaam. Non è mosso più nessuno. Sono morti là, e là sono rimasti i
camion, bruciati. Solo l’ufficiale è scappato zoppicando, zoppicando ormai con una gamba sola. Ce l’ha fatta ad andar via. Quelli che potevano
scappare sono scappati. Abbiamo lasciato passare i carri armati tedeschi
che mitragliavano indietreggiando. Poi ci siamo detti: «Torniamo là dove
70
La mia campagna d’Africa
abbiamo il nostro camion della pattuglia, e vediamo cosa possiamo fare».
Il sergente maggiore, lui era più coraggioso di me, è arrivato prima, e poi
di là mi chiamava, e io avevo paura. Cercavo dov’era una buca. Quando le
granate scoppiavano, prima che ne arrivasse un’altra mi facevo in un buco
e stavo là. Finché non gli sono arrivato vicino, e lui, il sergente maggiore,
era là, dentro a una buca, vicino al camion, e insieme ci siamo saltati dentro: «Che vada come vuole, via!». Il camion lo guidava lui, era lui autista
della pattuglia. Siamo partiti a tutta velocità in mezzo alle cannonate, e
siamo venuti fuori da quell’incrocio di fuoco. Lui era pratico e diceva di
sapere dove andare per trovare il reparto munizioni-viveri del nostro gruppo. Ma nel deserto era facile perdersi perché non c’è punto riferimento,
non c’è niente. E siamo arrivati là quando già i camion, quei tre o quattro camion del reparto viveri, erano già in moto perché andavano via. Se
tardavamo ancora un minuto non li avremmo trovati più. Non sapevamo
dove andare, e siamo andati assieme a loro, a Bengasi, e da Bengasi in un
altro paesetto. Sono tanti di quei nomi che non posso ricordarli tutti! E
aspettavamo che arrivassero dei nostri nuovi per rifare di nuovo il gruppo,
le batterie complete. Nuovi soldati, e poi quando sono arrivati dall’Italia,
hanno formato il gruppo completo. E allora «avanti», di nuovo.
E siamo stati là. Prima, seconda, terza, quarta linea, un fuoco d’inferno.
Mamma mia! Che roba inutile. Ci siamo ripiazzati di nuovo coi nuovi
arrivati, tante divisioni nuove. Ma gli inglesi erano sempre superiori, e noi
abbiamo dovuto ripiegare, da El Alamein fino a Tunisi.
In Tunisia
8 novembre 1942: sbarco anglo-americano in Marocco e in Algeria, al comando del generale D. Eisenhower.
14 novembre 1942: truppe italo-tedesche occupano la Tunisia.
23 gennaio 1943: Tripoli è presidiata dalle truppe britanniche.
3 febbraio 1943: le truppe dell’Asse sono tutte attestate in Tunisia. L’evacuazione dalla
Libia è terminata.
Da El Alamein, dopo che ci siamo ritirati, siamo tornati indietro, non
abbiamo più potuto andare avanti, e abbiamo dovuto ripiegare fino in
Tunisia. Abbiamo combattuto anche in Tunisia. Quanti chilometri, quanti
mila chilometri abbiamo fatto. Abbiamo perso Tripoli, tutto.
E gli ultimi giorni abbiamo combattuto, e non si sapeva più dove stare
71
Giuseppe Scaglione
La caduta di Tripoli.
perché c’erano bombe che cadevano dappertutto. E abbiamo indietreggiato fino in Tunisia, a Menzel Temini, un paesetto vicino a Tunisi.
Ce n’era, neh?!?, di strada! Abbiamo dovuto ripiegare. E lì avevamo da
una parte gli inglesi, nel centro c’erano i francesi, e poi gli americani. E di
lì c’era il mare...
maggio 1943: dopo la capitolazione di Tunisi, le forze anglo-americane completano la
riconquista dell’Africa settentrionale.
Noi eravamo andati a rifugiarci dentro a un marabout, perché a stare
fuori non stavamo più tranquilli in nessun posto. C’erano bombe dappertutto. Ad Hamamet eravamo stati col comando di raggruppamento, di
reggimento, dentro una villa abbandonata del console americano. Eravamo
andati noi a mettere il comando lì dentro. E gli apparecchi inglesi continuavano a bombardare quella palazzina. Fuori c’era l’autista del colonnello
vicino alla macchina, ed è stato morto ammazzato, ad Hamamet, proprio
lì, in quel paese dove hanno sepolto Craxi. C’è stato un bombardamento,
caro mio, che credevamo di non uscirci più nessuno da quella villa.
72
La mia campagna d’Africa
La battaglia di Tunisia.
A Hamamet era dappertutto un bombardamento. Per fortuna mi sono
salvato, perché il pericolo era continuo, giorno e notte, e non si sapeva
dove stare. Poi, due giorni prima che ci prendessero prigionieri, è passato
un aeroplano che buttava giù dei manifestini: «Italiani, smettete di combattere, lasciate combattere soltanto i tedeschi. Noi non ce l’abbiamo con
voi, ce l’abbiamo soltanto coi tedeschi. Ritiratevi dal paese». Noi ci siamo
ritirati un po’, ma di tutti quelli che erano più lontani, nessuno s’è ritirato.
Non potevano. Erano a combattere. E lì, dentro alla caserma, siamo stati
lì, e poi non hanno più bombardato il paese. «Il paese non lo bombardiamo», dicevano i manifestini. Difatti ci siamo salvati. I nostri ufficiali ci
dicevano, ci raccomandavano che nessuno facesse il fiero, di non sparargli
quando arrivavano quegli australiani a prenderci prigionieri: «State calmi»,
ci dicevano. Abbiamo combattuto fino a che abbiamo dovuto farlo.
Prigionieri degli inglesi
maggio 1943: 291mila soldati, italiani e tedeschi, cadono prigionieri.
73
Giuseppe Scaglione
Poi c’è stata la resa totale. E ci hanno fatti prigionieri. Quando sono
arrivati abbiamo fatto un mucchio, là nel cortile, tra fucili e mitraglie e
bombe a mano, e gli arabi, nel prenderli, facevano come le formiche quando portano via il grano. Sempre di corsa, andare e venire, a prendersi i
fucili e le armi. Noi eravamo stufi di averle quelle robe lì. Questo avveniva
a Menzel Temini, nel paese dove ci hanno preso prigionieri.
Menzel Temini: 92 chilometri da Tunisi. Piccolo borgo agricolo specializzato nella produzione di arachidi e di pomodori. Ad agosto e settembre le sue strade sono invase da ghirlande
di peperoni messi a seccare al sole. Possiede una bella spiaggia di sabbia fine, e fondali
rocciosi che fanno di Menzel Temini un indirizzo di sogno per le attività subacquee.
Ci siamo arresi, ci siamo consegnati. Eravamo tutti stufi.
Mi hanno preso prigioniero la sera dell’11 maggio del ’43, me e un mio
amico compagno.
Quel campo d’aviazione di Menzel Temini, quando non era ancora
buio e si vedeva ancora, a vederlo era come un campo di grano. Ci saranno
stati più di centomila prigionieri, tra noi e i tedeschi. Ci hanno tenuto
là quella notte lì. Noi tutti ci siamo buttati giù per terra a dormire. Non
abbiamo più sentito un colpo di fucile quella notte lì. Prima invece non
si poteva stare un minuto in pace. Abbiamo dormito quella notte, che più
bene di così!... Alla mattina ci hanno caricati sopra i camion nostri, italiani, per portarci in Algeria. Abbiamo viaggiato due o tre giorni sopra quei
camion per andare in Algeria. Ci hanno portato in camion a Souk Arras,
un campo inglese in Algeria. Lì siamo stati soltanto due o tre giorni. E poi
di lì ci hanno portati a Costantina, coi camion inglesi. I nostri camion li
hanno lasciati là, dove c’era una pianura, e tutti i camion italiani erano un
mucchio in quel parcheggio. Ci hanno portati a Costantina, una cittadina
dell’Algeria. C’era il treno lì, e la stazione, e lì ci hanno portati. Ci hanno
caricati sopra un treno merci, ma quei vagoni erano un po’ più piccoli che
in Italia. Eravamo cinquanta o più per ogni vagone. Tre giorni e tre notti in
piedi, di lì per andare a Casablanca, nel campo americano di Casablanca.
Tre giorni e tre notti in piedi. Non potevamo muovere una volta un piede
per spostarlo un po’. Eravamo scortati dai gaullisti, quelli di De Gaulle, da
Costantina a andare a Casablanca. Quelli lì ti davano tutti i titoli immaginabili: italiani straccioni, pidocchiosi, tutti i titoli immaginabili. E noi
in silenzio perché non si poteva mica dargli risposta, non sapevamo cosa
dirgli. Ci mettevano contro, in mezzo alle fessure, quelle baionette piccole
74
La mia campagna d’Africa
ma lunghe che avevano loro, e se uno si trovava vicino si feriva.
E siamo stati là 40 giorni, in quel campo di Casablanca. Poi è venuto il
momento che ci portarono in America. Siamo partiti il 5 luglio per andare
in America. Abbiamo fatto 40 giorni nel campo a Casablanca. Era un campo che era enorme. Dicevano che lì eravamo più di 160, 170.000. A ogni
centuria, a ogni cento di noi, davano una di minestra così, tanto così. Un
«addoga» [hot dog], quei salamini, e due patatine che erano grosse così. E
fino all’indomani niente. A forza di andare e venire, in quel campo c’era un
polverone alto così, nero come il carbone, ed eravamo diventati tutti neri:
sembravamo africani. Niente acqua da lavarsi, a Casablanca. Quel campo
di concentramento americano era a due, tre chilometri da Casablanca.
L’ America
Da lì ci hanno portati a New York. 23 giorni abbiamo viaggiato su
quella nave, da Casablanca, fino a New York. Eravamo un convoglio di
70 navi. Erano con noi uno di Mondovì e uno di Calosso, della Piana del
Salto, con cui ci eravamo incontrati quella mattina che eravamo stati fatti
prigionieri. Lui è arrivato al campo dopo di me, quando io già dormivo,
e aveva trovato ancora un posto lì accanto a me. Io non l’ho visto quand’è
arrivato. L’ho visto al mattino quando mi sono svegliato. Poi siamo stati insieme fino alla vigilia della partenza, fino al 4 di luglio. La sera precedente
il 4 luglio a lui è venuto mal di gola. L’hanno ricoverato nell’ospedale del
campo di concentramento e non è partito con noi. Dopo un mese è venuto
a finire nel campo in America, là nel Missouri, a Reingarten, nello stato del
Missouri. Là è stata vita buona.
Dopo sei mesi nel Missouri, ci hanno portati nel Michigan, a Detroit.
Là sono stato due anni. Lavoravo, andavo sempre a lavorare. Gli americani ci davano cioccolata e sigarette. E andavamo allo spaccio, dove c’era
tutto: la birra per esempio. La Coca Cola io l’ho bevuta una volta sola,
quando eravamo nel campo di Reingarten, nel Missouri. Ma la Coca Cola
non mi piaceva, preferivo la birra. Lavoravo nei magazzini, dove c’era tutta
roba di macchine, da mettere assieme macchine. Una enorme quantità di
casse. Quel terminal era una costruzione alta undici piani, piani alti il doppio di questi. Partiva dalla sponda del Detroit river, e veniva in qua.
Era grosso, alto, tutto pieno di materiale. Senza contare quello che c’era
nei cortili intorno: tutte cataste grosse come questa casa, tutta roba per
75
Giuseppe Scaglione
mettere insieme delle macchine, tutti i pezzi. Ho imparato un poco di
inglese, ma adesso l’ho perso tutto: I don’t speak Enhlish anymore. Yeah.
I fascisti li avevano portati nel campo di Monticello: non erano tanto
ben trattati, perché erano fascisti. Quando è morto Roosevelt io l’ho saputo prima degli altri soldati americani. La mattina alle 7, avevo una radio
più piccola di questa che ripeteva: «Roosevelt is dead, Roosevelt is dead».
Sono uscito fuori. C’era un siciliano italo-americano che faceva un po’ da
interprete, ma parlava più siciliano di quanto non fosse capace di parlare
in italiano. «Hai sentito Luigi che è morto Roosevelt?». «Ma che cosa dici?». «Ho sentito alla radio che è morto Roosevelt». Dopo un po’ è venuto
dicendomi: «Avevi ragione!».
In America, dalla radio, sentivamo che qui c’era la guerra partigiana.
Da lì scrivevo a mia moglie due, tre volte a settimana. Una volta una lettera
è arrivata, ma io sono stato un anno e mezzo senza ricevere notizie da lei,
sia che scrivesse o no. Un anno e mezzo senza mai sapere niente. Io continuavo sempre a scriverle, ma da lei non arrivava niente.
Di nuovo a casa
Il 25 novembre del 1945 sono arrivato a Napoli. In America mi hanno
imbarcato nello Stato del Virginia. Dal Michigan ci avevano portati nello
stato del Virginia, e lì ci hanno imbarcati, e siamo sbarcati a Napoli. Da
Napoli ci hanno portati al campo di Afragola, campo in cui raccoglievano
tutti quelli che arrivavamo. Quello era un posto in cui non mi piaceva
stare. Tornando in Italia credevo di far presto ad arrivare a casa. Mi dicevo:
«Ormai sono a casa in Italia». Ma se non c’era quel treno che è arrivato alle
due dopo mezzanotte dalla Calabria... Era già pieno, strapieno di gente.
Era soltanto un treno merci, non era un treno per viaggiatori: vagoni da
merce, scoperti, tutti rotti, e ci pioveva, pioveva dentro.
Il vagone era pieno di calabresi e siciliani che venivano su qui in Piemonte. Si seppe che c’era quel treno alle due dopo mezzanotte che veniva
dalla Calabria. Se uno riusciva prenderlo, ti portava fino a Roma. Sennò
per tre giorni non ce n’erano più. Se non fossi riuscito a prendere quel
treno! Abbiamo tribolato per farci portare da Afragola a Napoli. Poiché
eravamo deportati, là ci hanno pagato la licenza. Ci hanno dato due, o
tremila lire, non so. Erano quei biglietti grossi da 500 lire. Era venuto un
camion a portare qualche cosa al campo. L’autista era vestito coi pantaloni
76
La mia campagna d’Africa
grigioverdi. Aveva solo un pezzo della divisa dell’esercito. Per il resto era
vestito in borghese.
Che razza d’esercito c’era allora! Neanche la divisa completa aveva più.
Gli abbiamo chiesto se ci avrebbe portato a Napoli. Ma lui: «Non carico nessuno, non prendo nessuno». Era uno di là, della bassa Italia. In quel
mentre è passato un colonnello dell’esercito, non so neanche di che corpo
era, ma era un colonnello. Gli facciamo: «Dica a questo autista se può portarci a Napoli». «Io ce lo dico, ma lui fa come vuole. Se vuole lo fa, se non
vuole non lo posso comandare». Capito? Un colonnello che non può comandare un soldato! «Io ce lo dico, ma lui fa come vuole. Se vuole lo fa, se
non vuole non c’è da insistere». L’autista ha poi accettato. E in un minuto
abbiamo buttato sul camion i nostri sacchi. Avevamo sacchi alti così pieni
di roba, né valigia, né altre cose, e siamo saltati sopra. A qualcuno che era
già salito sul camion era rimasto il sacco per terra. Era un manicomio!
Abbiamo caricato tanto quel camion che subito è scoppiata una gomma.
E l’autista ci disse: «Adesso scendete tutti per terra e non porto più nessuno». E difatti siamo scesi tutti, e lui è andato via con la gomma scoppiata. Per andare a Napoli abbiamo lottato fino alle 10 di sera, tutto il giorno
e tutto il dopopranzo, a cercare di trovare un mezzo. Non c’era mai niente.
Passava soltanto qualche biroccio. Poi, alla sera, prima di notte, abbiamo preso un biroccio con un cavallo. Poi abbiamo trovato un camioncino
tutto «sdradicato», che nelle curve faceva un rumore impossibile. «Prima
che siamo a Napoli con questo coso qui, finiamo per terra e non riusciamo
di arrivare», ci dicevamo. Gli abbiamo dato 500 lire, un biglietto di quelli
grossi. Quello ci ha portati fino a davanti la stazione di Napoli. Volevamo
entrare in stazione, ma è arrivato un mucchio di facchini con i loro carretti.
Noi volevamo portarci da noi i nostri sacchi, ma non c’è stato verso.
Loro hanno caricato tutto e correvano che sembravano cavalli, con quei
carretti. E noi gli stavamo aggrappati così, perché non li lasciavamo andare,
perché, caro mio, se sparivano non trovavamo più niente. Altre 500 lire gli
abbiamo dovuto dare per andare da fuori a dentro la stazione. Lì abbiamo
aspettato fino alle due dopo mezzanotte, e pioveva. La tettoia della stazione
era rotta, bombardata, e pioveva. E noi aspettavamo. È arrivato già pieno
quel treno, di donne e bambini, tutti piangevano i bambini, e pioveva, e
non era coperto. Erano vagoni che erano stati mitragliati e bombardati,
tutti fracassati. A mezzogiorno siamo arrivati a Roma. Abbiamo preso un
altro treno viaggiatori per Alessandria. Era pieno così anche quello.
77
Giuseppe Scaglione
Abbiamo dovuto stare in piedi, sempre in piedi. Non c’era un posto.
Arrivato a Alessandria credevo di trovare un treno per Alba. Se arrivavo in
tempo, mi dicevo, avrei fatto presto ad arrivare a casa.
Arrivato lì, ho chiesto se c’era un treno: «Non c’è niente, non c’è proprio niente». «E come faccio ad arrivare a casa? Sono arrivato fino a qui, e
adesso di qui non sono più tanto lontano, una quarantina di chilometri».
Niente da fare. Era sera, dopo le otto. C’era una nebbia che non si vedeva da qui a lì. Allora ho deciso di proseguire in treno fino ad Asti. Arrivato
ad Asti ho chiesto se c’era un treno per Castagnole. E loro si sono messi a
ridere: «Non c’è più neanche il ponte!». Il ponte l’avevano bombardato, era
andato a finire in Tanaro quel ponte. «Come faccio ad andare a casa? Non
vado più!». E allora sono andato a Torino coi miei compagni che andavano
a Bardonecchia, a Torino, in altri paesi intorno a Torino. Sono stato tutta
la notte nella sala d’aspetto di Porta Nuova. La mattina, al primo treno
che c’era per andare a Alessandria, ci sono saltato sopra e sono tornato di
nuovo a Alessandria. Ad Alessandria sono andato dal capostazione e gli ho
chiesto se c’era qualche cosa che andasse verso Alba. «Treni non ce ne sono,
ma oggi alle due c’è una macchina, una locomotiva che va a Castagnole
Lanze a muovere dei vagoni in stazione, solo la macchina. Vai a vedere là
vicino alla casa lunga dove abitano i ferrovieri, e chiedi chi sono questi
due macchinisti che vanno a Castagnole». Mi ha scritto un biglietto con il
numero della macchina. Li ho trovati, e m’hanno detto di trovarmi alle due
alla stazione, vicino alla cabina: «Noi passiamo di lì e ti prendiamo». Ho
aspettato lì fino alle due e quando sono arrivati sono salito con loro. Non
era una macchina da merci, di quelle più grosse. Era una macchina piccola
da treno viaggiatori e c’era poco spazio. Già in due ci stavano stretti, il
fuochista e il macchinista.
Per me c’era poco posto, e dovevo spostarmi quando loro dovevano
buttare una palata di carbone. Sono arrivato con loro fino a Santo Stefano
Belbo, fino al passaggio a livello qui in fondo, dove c’è la casetta del parroco. Hanno fermato la locomotiva nel bel mezzo del passaggio a livello, e io
sono sceso giù, e via! Non mi hanno portato fino alla stazione, mi hanno
lasciato lì, perché io gliel’avevo detto che stavo lì: «Lì c’è la mia collina».
Ero già sposato. Con mia moglie siamo stati cinque anni senza vederci.
Cinque anni in Africa e America. Cinque anni completi. Mia moglie era
rimasta qui con mia mamma e mio papà. Quella sera sono corsi qui tutti,
tutti, e hanno ballato fino alle due dopo mezzanotte.
78
La mia campagna d’Africa
Reduci
Sono andato un po’ di volte ai raduni dei reduci. I raduni dei reduci,
di quelli che siamo rimasti, li hanno fatti a Torino, a Giaveno, a Casale, in
tanti paesi intorno a Casale, a Badoglio, in tanti posti insomma. A Giaveno
sono andato due volte. Lo facevamo tutti gli anni, ma io l’ho saputo tardi,
perché sennò sarei potuto andare anche qualche volta di più già da prima.
Quando l’ho saputo ho cominciato a andare, e dopo sono andato sempre. Poi quello che si occupava di organizzare i raduni non si sentì più di
farlo perché non stava tanto bene. Ha passato l’incarico a un sergente di
Casale, ma lui non si è interessato a niente, e ha lasciato perdere.
Trascrizione, commenti e fotografie di G. Marco Cavallarin
Repertorio immagini
da Angelo Del Boca, Nicola Labanca, L’impero africano del fascismo nelle fotografie dell’Istituto
Luce, Editori Riuniti – Istituto Luce, Roma 2002:
Fronte Africa settentrionale, mezzi inglesi distrutti presso El Agheila, marzo 1941.
Fronte Africa settentrionale, i generali Cavallero e Bastico insieme alle autorità tedesche all’ingresso della via dell’Asse, agosto 1941.
Il generale Rommel, giugno 1941.
Italo Balbo, giugno 1931.
Africa settentrionale, Spitfire inglese abbattuto sul campo di Sgnali, maggio 1942.
Africa settentrionale, partenza di uno Stukas, luglio 1941.
Africa settentrionale, soldati italiani in marcia, settembre 1940.
Africa settentrionale, Compagnia Savoia, anticarro in marcia, maggio 1942.
Africa settentrionale, spostamento di un pezzo di artiglieria, aprile 1942.
Africa settentrionale, camice nere sfilano davanti al maresciallo Graziani, settembre 1940.
da Orio Vergani, Riva Africana, Ulrico Hoepli, Milano 1937. Fotografie dell’autore:
Ascari eritrei (Tobruk).
La piccola beduina (Derna).
Indigeni della Sirtica (Misurata).
Un cammelliere (Homs).
da Silvana Palma, L’Italia coloniale, Editori Riuniti 1999:
Il reticolato confinario con l’Egitto al km. 200, nei pressi di Giarabub, 1931. Collezione Luigi
Goglia, Roma.
La colonizzazione demografica intensiva in Libia del 1938. Il villaggio Bianchi. Isiao, Roma.
79
Giuseppe Scaglione
Contadini pugliesi in Cirenaica, settembre 1933. Isiao, Roma.
La colonizzazione demografica intensiva in Libia: lo sbarco dei ventimila a Tripoli, 2 novembre
1938. Foto Luce. Isiao, Roma.
Il villaggio Cesare Battisti, uno dei villaggi agricoli creati in Libia, 21 ottobre 1939. Isiao, Roma.
dalla Raccolta Cavallarin:
Testo della canzone A Tripoli.
Cartolina di propaganda per la guerra in Africa settentrionale. Anno 1940.
Cartolina di propaganda per la guerra in Africa settentrionale. Anno 1942.
Franz Maria D’Asaro, I datteri matureranno, Unitas, Roma.
Battaglia di Tunisia.
Caduta Tripoli.
Datteri.
Vignetta.
Note al testo
1
Intervista raccolta il 15 maggio. 2007 da G. Marco Cavallarin in Santo Stefano Belbo (CN),
loc. Bauda, presso il domicilio dell’intervistato.
80
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica
alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
in alcuni documenti d’archivio inediti
di Federico Cresti
La prima occupazione inglese della Cirenaica era terminata nel mese di
marzo del 1941: l’apparizione sul campo di battaglia delle truppe tedesche
guidate dal generale Erwin Rommel aveva costretto i soldati britannici
a fare in senso inverso il percorso che quasi due mesi prima li aveva visti
entrare in Libia dalla frontiera orientale sfondando le linee italiane, e raggiungere Bengasi e i limiti della Sirtica. Questa prima occupazione aveva
prodotto danni ingentissimi alle infrastrutture del territorio, soprattutto
a Bengasi e a Derna, e sconvolto le attività della colonizzazione agricola,
che vedeva la presenza in Libia orientale di circa diecimila coloni italiani
dispersi su un territorio piuttosto vasto: si trattava di tutto la spazio dell’altipiano cirenaico (il jabal al-akhdar, o Montagna verde) che fu uno dei
teatri della seconda guerra mondiale1.
I documenti di archivio dell’Ente per la colonizzazione della Libia
(ECL), da me esaminati negli ultimi anni2 e oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, permettono di ricostruire con una notevole precisione non tanto gli avvenimenti bellici di cui la Cirenaica fu il campo di azione durante questa fase del confronto tra le truppe italo-tedesche e quelle
britanniche (che ci sono noti da molteplici altre fonti), quanto l’incidenza
di questi avvenimenti sulla popolazione agricola italiana e sui rapporti tra
questa popolazione e quella libica. L’invito a partecipare a questo numero
della rivista che mi è stato rivolto da Angelo Del Boca, e a cui sono lieto di
rispondere, mi permette di anticipare la pubblicazione di una parte delle
mie ricerche condotte in questi anni sul tema della colonizzazione agricola
della Libia, che spero di far apparire presto in un volume complessivo. Le
fonti primarie di questo saggio provengono per la quasi totalità dall’archivio suddetto (che ho chiamato con la sigla AECL: Archivio dell’Ente per la
colonizzazione della Libia), nella loro collocazione in un cartone designato
specificamente (Seconda occupazione inglese), o da altri documenti elaborati
81
Federico Cresti
a Roma sulla scorta delle informazioni giunte dalla Libia (in particolare nei
Verbali del Consiglio di amministrazione [VCA] e nei Verbali del Comitato
esecutivo [VCE]). Un documento di particolare rilievo per la nostra analisi
è la relazione inviata a Roma poco dopo la fine della seconda occupazione
britannica dal capo della direzione compartimentale di Barce dell’Ente per
la colonizzazione, Loris Giai Via, che abbiamo indicato con la sigla RGV.
* * *
Nel territorio tornato sotto il controllo italiano alla fine del mese di
marzo del 1941 era subito iniziato il lavoro per rimettere in funzione la
macchina della colonizzazione, ma in breve tempo si era dimostrato molto
difficile rimediare ai disastri della guerra. Il raccolto del grano, di cui agli
inizi di febbraio si era prevista una produzione eccellente, era stato fortemente ridimensionato da fattori climatici e dagli avvenimenti bellici. Alla
fine di marzo il ghibli aveva cominciato a soffiare violentissimo, tanto che
in aprile nei comprensori di Maddalena, di Oberdan e di D’Annunzio era
andata totalmente perduta la speranza di ottenere un qualsiasi raccolto
da 1.500 ettari di terreno seminati a frumento. Durante l’occupazione le
greggi indigene avevano iniziato a pascolare nei campi seminati ai limiti dei
comprensori, e il danno aveva compromesso la produzione di ulteriori centinaia di ettari. Con il ritorno delle truppe italo-tedesche gli arabi avevano
allontanato le loro greggi dai terreni coltivati per timore di punizioni, ma
dopo una settimana […] visto che nessuna azione era stata condotta contro di loro per
le malefatte compiute durante il periodo di occupazione britannica, i nativi tornarono
ad invadere i nostri comprensori, entrando col loro bestiame anche dove prima non
avevano osato. Seminati in genere, arboreti, vigneti, ed anche orti, furono soggetti
ad una feroce opera di distruzione che, con un crescendo impressionante, portò alla
perdita totale di alcune migliaia di ettari di grano e a vasti danneggiamenti alle altre
coltivazioni. Quello che non veniva distrutto dal bestiame veniva raccolto dall’arabo;
alcune migliaia di quintali sono state mietute, trebbiate ed asportate senza che vi fosse
la possibilità, da parte nostra, di impedirlo3.
Le insistenti richieste dei funzionari dell’ente alle autorità coloniali di
far rispettare agli allevatori libici i limiti di pascolo imposti dalle leggi erano rimaste inascoltate, e le cabìle avevano continuato a pascolare con le
loro greggi nel territorio della colonizzazione metropolitana. Il risultato
82
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
era stato disastroso: la produzione del grano era stata inferiore ai 9.500
quintali, mentre all’inizio dell’annata agricola si erano previsti circa 60.000
quintali. Il raccolto sarebbe stato appena sufficiente alla semina dell’anno
successivo: si prevedeva in tutti i casi una riduzione dei terreni da seminare
per problemi logistici, in particolare per la mancanza dei mezzi meccanici
requisiti per le operazioni di guerra, distrutti o non riparabili.
Il bestiame delle cabìle aveva danneggiato in uguale maniera la produzione di fieno, gli impianti viticoli e gli arboreti: qui non era stato solamente il pascolo a distruggere le piante, ma, affermavano i tecnici dell’Ente
per la colonizzazione, anche l’opera «dell’arabo, che distrugge la pianta o
ne provoca l’essiccamento perché vede in essa la nostra affermazione su
queste terre un tempo a sua completa disposizione»4.
Il magro prodotto della fienagione aveva ridotto le disponibilità di
mangime per gli animali, e aveva costretto a ridimensionare gli armenti dei
coloni. Anche questo aveva costituito un duro colpo all’economia agricola
e le sue conseguenze erano facilmente prevedibili: i contadini non avevano
più risorse per mantenere una coppia di buoi, cosicché si trovava ridotta la
loro capacità di arare la terra e di seminare, con un impoverimento della
produzione futura dei loro poderi.
La comunità colonica della Cirenaica poteva dividersi in due gruppi
che vivevano in maniera diversa la situazione bellica.
Da un lato i contadini dei comprensori più antichi, che lavoravano le
loro terre da quasi dieci anni in media5 e i cui poderi avevano raggiunto un
discreto livello di produzione: la loro situazione economica era la migliore
ed erano i meno colpiti dalla penuria, dal momento che potevano integrare
le razioni alimentari con i prodotti dei loro campi.
Tra questi contadini si manifestavano segnali di scontentezza nei confronti dell’ente. Essi non volevano continuare a subire il regime di mezzadria che veniva loro imposto dalle autorità della colonia e dalla direzione
dell’ECL malgrado le clausole del contratto ne prevedessero un termine
che era già scaduto: chiedevano dunque l’avvio dell’ulteriore fase prevista,
quella del riscatto, con l’attribuzione di tutti i prodotti dei loro campi,
mentre l’Ente considerava ancora di sua spettanza i prodotti del lavoro
dei coloni. Ne era derivata una situazione conflittuale nella quale i coloni
avevano nascosto e sottratto gran parte della produzione: c’era una forte
richiesta di prodotti agricoli da parte delle truppe italo-tedesche, e gli autocarri dell’esercito andavano a rifornirsi direttamente dai coloni, malgrado
83
Federico Cresti
le proteste dell’Ente presso le autorità militari6.
Il secondo gruppo era costituito dai coloni giunti in Cirenaica negli anni 1938 (una parte dei ‘Ventimila’) e 1939 (una parte degli ‘Undicimila’)7
che vivevano una situazione alimentare piuttosto grave: i loro terreni erano
ancora nella fase iniziale della valorizzazione e la loro produzione non era
sufficiente a coprire il fabbisogno delle famiglie che vivevano quasi completamente delle razioni fornite dall’Ente. Le razioni erano insufficienti e
a volte il loro arrivo ritardava a causa delle difficoltà logistiche create dallo
stato di guerra. C’era peraltro una forte richiesta di manodopera per i lavori militari, e l’Ente aveva autorizzato parte dei coloni ad andare a lavorare
all’esterno dei comprensori, anche per ridurre l’inazione a cui molti di loro
erano costretti nei loro poderi.
In una situazione che con grandissima difficoltà poteva trovare un
equilibrio, con la ripresa delle attività produttive, il problema più grave
per i tecnici dell’Ente per la colonizzazione era costituito dalla vicinanza
ai comprensori agricoli metropolitani delle greggi dei nomadi e dei loro
accampamenti: si registrava lo scoppio di litigi ripetuti e quasi continui tra
nativi e coloni e la presenza dei pastori arabi e del loro bestiame era sempre
più minacciosa8.
Altrettanto minacciosa era la situazione bellica: anche se la propaganda
ufficiale mostrava molto ottimismo dopo la liberazione del territorio dalla truppe britanniche, nell’ultimo trimestre del 1941 la seconda offensiva
condotta dalle truppe italiane con l’ausilio dell’Afrika Korps tedesco aveva gradualmente perduto il suo slancio, lasciando modo alle forze armate
britanniche sotto il comando del generale Auchinleck di organizzare una
seconda controffensiva che seguì grosso modo lo stesso percorso e le stesse
direttrici della prima.
Il 10 dicembre 1941 il prefetto di Bengasi aveva convocato il direttore
tecnico dell’ECL, Loris Giai Via. Informandolo di un probabile ripiegamento delle forze italo-tedesche gli aveva comunicato la necessità di prevedere l’accentramento dei coloni dei poderi maggiormente isolati, che
avrebbero dovuto raggiungere i villaggi o i poderi vicini alle rotabili asfaltate. L’ordine di effettuare il concentramento sarebbe stato dato appena
fosse giunta la notizia del ripiegamento: si sperava di poter disporre di tre
o quattro giorni di tempo per effettuare la manovra. Il direttore dell’Ente
aveva in seguito esposto il suo piano, già preparato in precedenza, secondo
il quale Berta, il piò orientale dei villaggi e dei comprensori della coloniz84
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
zazione italiana in Libia sarebbe stato sgomberato totalmente, spostandone
gli abitanti a Luigi di Savoia e a Beda Littoria, situati ad alcune decine di
chilometri più ad occidente.
Il 17 dicembre il prefetto di Derna, Della Porta, aveva diramato una
circolare ai comandi delle forze di polizia e agli organi amministrativi del
governo coloniale in cui si definiva il piano di concentramento dei coloni: i
carabinieri avrebbero assunto il compito di assicurare la sicurezza e l’ordine
pubblico nelle zone previste, ma si temeva che la misura non fosse sufficiente in caso di attacco degli arabi:
Poiché l’esiguo numero dei carabinieri che si prevede rimarrà in forza nelle stazioni dei
centri colonici non sarà sufficiente, a mio parere, a reprimere eventuali rappresaglie
delle popolazioni arabe armate, nella deprecata ipotesi che quanto sopra progettato
debba avere esecuzione, ritengo opportuno che i coloni validi siano armati9.
Il 18 dicembre il ripiegamento delle truppe combattenti italo-tedesche
si prospettava inevitabile e fu diramato l’ordine di spostamento: fu allora
deciso di iniziare il movimento dei coloni secondo i piani. La distribuzione delle armi inizialmente prevista non poté aver luogo per mancanza
di mezzi di trasporto10. Oltre all’abbandono di Berta da parte dei coloni,
sarebbero stati evacuati anche i due centri secondari di Filzi e Sauro, situati
dalla parte opposta rispetto a Berta, all’estremità occidentale della piana
di Barce, ma anch’essi in una situazione di confine rispetto ai terreni abitualmente percorsi dagli allevatori libici11. Anche i gruppi più isolati nelle
zone agricole periferiche dovevano spostarsi: in particolare, i coloni della
ex concessione Dùmini12 dovevano essere trasportati a Battisti, mentre a
Mameli sarebbero stati inviati i gruppi di Slonta e di Sciaden. Infine, sarebbero ripiegati a Razza una famiglia di Alba (la fam. Iurilli) e l’agronomo
Perosi che vi lavorava13.
Alcuni dei funzionari dell’Ente, non rispettando l’ordine che era stato
loro impartito di rimanere sul posto, avevano deciso di allontanarsi partendo verso Tripoli o cercando mezzi di fortuna per fuggire verso le retrovie.
Dall’osservazione dei comprensori più decentrati si sapeva che erano iniziati movimenti di arabi armati, come nei dintorni di Filzi, dove il 19 un
centinaio di arabi avevano saccheggiato le case coloniche abbandonate14.
A Filzi e a Sauro gli scontri con gli arabi avevano preso una piega drammatica, con l’assassinio di due coloni, mentre il ripiegamento previsto era
85
Federico Cresti
ostacolato dalle piogge che avevano bloccato nel fango gli automezzi inviati per lo sgombero.
Gli assalti della popolazione araba si facevano sempre più numerosi
ed organizzati, e non avvenivano nei centri più vicini alla linea del fronte,
verso Derna, ma proprio a Filzi e a Sauro che come si è detto erano situati
a non grande distanza da Barce, nella zona più occidentale del Gebel. In effetti, come si legge nella relazione che è la nostra principale fonte, a Sauro
la situazione è tragica e non si può intervenire per l’assoluta impraticabilità delle piste
e la presenza di molti arabi armati avvantaggiati dalla boscosità della zona15.
Per liberare i coloni bloccati era stata organizzata una vera e propria
spedizione, con la partecipazione di una decina di bersaglieri e di militi armati di fucili mitragliatori: nelle vicinanze di Sauro la spedizione era stata
accolta da colpi di armi da fuoco, e dopo una sparatoria erano state raggiunte alcune case abbandonate e saccheggiate. La spedizione era tornata a
mani vuote, e i coloni, che erano fuggiti a piedi, erano giunti a Maddalena:
«bagnati e infangati, tremano dal freddo, nei loro visi si legge lo sgomento,
lo spettacolo delle donne e dei bambini stringe il cuore»16.
La situazione era disperata anche a Baracca:
Gli arabi ormai controllano tutto il comprensorio ed alcuni gruppi stazionano a poche
centinaia di metri dal villaggio. I coloni vengono sistematicamente assaliti, depredati
e sovente costretti a portare nel bosco agli attendamenti, adoperando il carro e gli
animali, tutto quanto posseggono pur di aver salva la vita. Una larga distribuzione di
grano effettuata agli arabi per tentare di placarli non ha avuto le conseguenze sperate
[…]. La furia araba ha avuto le sue vittime: 2 coloni morti e 4 feriti17.
Nessuna zona di colonizzazione si era conservata tranquilla: ad Oberdan il villaggio era stato saccheggiato e si contavano due morti, a D’Annunzio l’attacco era stato rivolto alla cooperativa, che tuttavia era già stata
svuotata; anche una casa colonica era stata attaccata e due dei suoi membri
erano stati uccisi18.
Il 22 dicembre le ultime truppe italiane avevano lasciato Barce, e nel
pomeriggio del giorno successivo era arrivato il primo convoglio inglese.
Giai Via aveva incontrato le autorità militari occupanti per la prima
volta a Barce il 24 dicembre, chiedendo la protezione dei coloni e l’invio
di guarnigioni nelle zone più esposte: il comando aveva preso immedia86
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
tamente la decisione di inviare alcune camionette armate e truppe indiane verso Baracca e Oberdan, dove gli ufficiali inglesi avevano trovato una
situazione critica per la sicurezza dei coloni, incontrando lungo le piste
gruppi di coloni di Oberdan che fuggivano terrorizzati dalle loro case sotto
la pioggia e nel fango («donne e bambini, mezzi nudi e scalzi, tremanti dal
freddo, raccontano che vi sono morti e feriti; chiedono protezione. Sono
scene strazianti»19).
Il bilancio del 24 era di 4 morti e 5 feriti a Oberdan e di 3 morti a Baracca. A Sauro era stato assassinato l’assistente edile Tito Togna.
Il 25 era continuata la fuga dei coloni dai villaggi della piana di Barce.
A Maddalena si contava un concentramento di 1.190 persone che avevano
occupato la chiesa, i portici del villaggio e tutti i locali disponibili: nei poderi continuavano gli attacchi ed i saccheggi degli arabi, mentre le truppe
di occupazione non potevano intervenire per l’impraticabilità delle piste.
Il comando inglese, come nel corso dell’occupazione precedente, aveva
decretato lo stabilimento di una Occupied Enemy Territories Administration,
che a Barce era stata posta sotto il comando del maggiore Tulloch (con
il ruolo di Political Officer), mentre la carica di podestà era stata assunta
dal tenente Beard (o Neard, secondo alcuni documenti): quest’ultimo («di
professione baritono – parla bene l’italiano e conosce l’Italia, specie Firenze»20) era già stato in Cirenaica durante la prima controffensiva.
Il 28 dicembre era stato diffuso a Maddalena il testo del primo proclama britannico, firmato a Tobruk il 12 dicembre dall’«Ufficiale generale comandante in capo delle forze di Sua Maestà Britannica in Libia», il tenente
generale Neil Methuen Ritchie, che riprendeva quasi testualmente l’analogo primo proclama delle autorità inglesi emanato durante l’occupazione
precedente. Si intimavano alla popolazione il rispetto dell’ordine e il mantenimento della calma minacciando severissime sanzioni, e si affermava la
continuità dell’amministrazione civile, che sarebbe stata completata e non
sostituita dai poteri delle autorità militari. All’art. 4 si sanciva che
Le Leggi in vigore, i costumi, i diritti e le proprietà nei detti territori verranno pienamente rispettati conforme alle leggi internazionali, per quanto le esigenze militari lo
permettino [sic]. Ogni richiesta di servizi o di proprietà necessari alle esigenze militari
sarà debitamente compensata21.
L’autorità militare aveva imposto il suo controllo sui magazzini dei vi87
Federico Cresti
veri dell’ente, stabilendo a 200 grammi a persona al giorno il razionamento
del grano: in alcuni centri di colonizzazione la situazione alimentare era
critica, le riserve erano scarsissime ed era stato istituito un servizio di rancio per i coloni sfollati.
Intanto continuavano gli attacchi armati della popolazione araba, che
il 30 dicembre avevano preso di mira il comprensorio di D’Annunzio, uccidendo un colono e rubando il bestiame: nel corso dell’attacco, racconta
la relazione, erano state usate bombe a mano per scardinare le porte e le
finestre delle abitazioni. A D’Annunzio solamente diciassette case coloniche rimanevano occupate, mentre il resto della popolazione si era rifugiata
nel villaggio. In seguito a questi avvenimenti le autorità inglesi vi avevano
inviato un distaccamento di truppe indiane.
Il primo gennaio iniziavano a registrarsi episodi di violenza alle donne
italiane da parte delle truppe indiane nel villaggio di Maddalena22.
Nei villaggi più orientali delle provincia di Derna la situazione sembrava più calma: dalle notizia giunte a Barce si sapeva che Beda Littoria era il
centro più minacciato dagli arabi, e che il capo zona, Oronzo Nicolardi,
aveva arruolato 18 giovani coloni che erano stati armati e facevano servizio
di perlustrazione di giorno e di notte23. In altri villaggi la vigilanza era assicurato da arabi stipendiati. Soprattutto a Beda, Razza, Savoia e Battisti il
servizio fornito dagli arabi era stato utile: nel resoconto finale delle spese,
in effetti, si affermava che la spesa totale per la vigilanza era ammontata a
245.000 lire, che equivalevano a 30 paia di buoi e si calcolava che senza
tale spesa il bestiame razziato sarebbe stato cinque volte più numeroso24.
Con minore o maggiore gravità, in quasi tutti i comprensori erano avvenuti saccheggi ed episodi di violenza: oltre ai danni alle abitazioni e al
saccheggio delle fattorie abbandonate si contavano numerosi furti di bestiame. Alcune famiglie che si recavano con i loro mezzi di trasporto e con
le loro masserizie verso i villaggi, secondo l’ordine di raggruppamento, erano state totalmente derubate da bande armate ed erano giunte seminude
e sprovviste di tutto ai centri. La situazione alimentare era molto difficile,
e a Baracca «i coloni trovano da comperare qualcosa dagli arabi a prezzi
proibitivi»25, ma dal 21 gennaio «fanno cuocere la crusca: non c’è altro»26.
In molti villaggi erano stati nascosti militari italiani fuggiti dai campi di
prigionia, come ad Oberdan, dove le autorità inglesi avevano organizzato
una perquisizione meticolosa che aveva dato pochi risultati27. Era stato
ordinato l’arresto di tutti i carabinieri, ma molti erano riusciti a fuggire
88
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
ed erano stati nascosti nei villaggi, dove si assisteva in continuazione a
controlli e perquisizioni per sequestrare le armi e le munizioni e per identificare i prigionieri fuggiti: tuttavia il riconoscimento dei prigionieri non
era facile ed i risultati delle perquisizioni, secondo la relazione, erano poco
importanti28.
A Maddalena le autorità inglesi avevano ordinato che i coloni abbandonassero il villaggio e tornassero nelle loro abitazioni, ma c’era stato un
rifiuto generale di eseguire l’ordine per timore di violenze: nella trattativa
che ne era seguita il comando inglese aveva deciso di stabilire un servizio
di pattugliamento per garantire la sicurezza, limitando il ritorno dei coloni
ad una parte del comprensorio. Per rassicurarli il comando aveva deciso
di affidare ai coloni un fucile per ogni gruppo di quattro fattorie: più che
per difendersi, per dare l’allarme in caso di necessità. Il provvedimento
non era stato attuato, perché proprio in quei giorni si erano manifestati i
segnali del contrattacco italo-tedesco : il 22 gennaio il bollettino di guerra
ascoltato alla radio aveva parlato per la prima volta di offensiva, e il 25
gennaio erano state citate come zone di combattimento Agedabia, Antelat
e Soluch.
Il 26 i funzionari inglesi avevano cominciato a partire da Maddalena
e nei giorni successivi si era assistito al continuo passaggio di colonne e
di mezzi blindati in ritirata. Il 30 era giunta la notizia dell’avvicinamento
delle truppe dell’Asse e Maddalena era diventata
una festa di bandiere […]. Ad Oberdan […] Padre Francesco esce di chiesa in testa
alla banda del paese che suona Giovinezza. Abbraccio commosso quel meraviglioso sacerdote italiano che, insieme al suo confratello, ha dato infinite prove di abnegazione,
sprezzo del pericolo ed italianità. I coloni gridano con me il saluto al Re a al Duce29.
Nei giorni successivi avevano iniziato a tornare le autorità italiane, ed
era giunta una certa quantità di rifornimenti che aveva alleviato la fame
dei coloni.
Il bilancio di Loris Giai Via all’epoca del ritorno delle truppe italotedesche definisce una situazione critica: lo stato di salute dei coloni è
fortemente indebolito a causa dell’alimentazione insufficiente del periodo passato ed è difficile prevedere un ristabilimento rapido di coloro che
hanno sofferto di più la fame, dal momento che mancano sia il latte che la
carne. Tutte le riserve alimentari sono esaurite: sono andati distrutti quasi
89
Federico Cresti
tutti gli animali da cortile e i suini, per cui mancano quasi assolutamente
grassi e proteine.
Nei centri dove si sono raggruppati i coloni è stato effettuato un servizio igienico efficiente, organizzando squadre per la pulizia delle camerate
e spargendo nei dormitori i liquidi disinfettanti: sono state così evitate le
malattie epidemiche, ma l’addensamento delle persone e la mancanza di
acqua per la pulizia personale e il lavaggio degli indumenti hanno facilitato
la diffusione dei pidocchi «che oggi pullulano dappertutto»30. Si incontrano casi di scabbia.
All’epoca in cui la relazione fu stesa era ancora difficile ricevere notizie
precise dai centri di colonizzazione più distanti, per cui il bilancio che se
ne poteva stendere era provvisorio. Per quello che riguarda i danni ricevuti
dalle case coloniche, alcune erano state incendiate e tutte quelle che erano
state abbandonate dai coloni erano state saccheggiate: gli infissi erano stati
fracassati, e spesso portati via e bruciati come legna da ardere. Gli arredi
delle case non esistevano più o erano inservibili, rubati o bruciati o danneggiati; anche gli attrezzi da lavoro erano stati rubati, e sia i carri colonici
che le macchine agricole risultavano in gran parte fuori uso. Quasi tutti i
villaggi, ad eccezione di Beda, Razza e Savoia, avevano perduto totalmente
il loro bestiame, in tutto circa 2.000 bovini e 800 equini, così come gli
animali da cortile ed i suini.
Le coltivazioni avevano subito danni di diverso genere, soprattutto
quelle ortive: l’andamento climatico era stato particolarmente favorevole in quel periodo, grazie all’abbondanza inusuale delle piogge, ma tutte
le coltivazioni erano state danneggiate dagli animali che avevano pascolato sui terreni lavorati, oppure non avevano potuto essere curate a causa
dell’occupazione e dell’abbandono dei poderi.
L’opera di colonizzazione aveva ricevuto un colpo gravissimo, molto
più duro della prima, nel corso della seconda occupazione. Le condizioni
di disagio materiale e morale dei coloni erano terribili, e molti manifestavano la loro disperazione. Il ritorno nelle fattorie abbandonate costituiva
un problema complesso, e probabilmente non si sarebbe potuto giungere
al ripopolamento totale dei comprensori. In effetti, ad eccezione dei vecchi
centri di Razza, Beda e Savoia, le case degli altri centri erano inabitabili
per mancanza di infissi e di mobilio, né si poteva procedere alle riparazioni perché mancavano tutti i materiali, mentre le officine ed i laboratori
dei centri erano stati totalmente saccheggiati. Una parte notevole della
90
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
popolazione, e in particolare i bambini, le persone anziane e le donne, in
generale gli organismi meno resistenti e già duramente provati, avrebbero
dovuto continuare ad affrontare situazioni critiche dal punto di vista alimentare, per la mancanza di carne, di latte e di verdure.
Il fattore morale è pure di somma importanza. I coloni più provati, quelli che abbandonarono le case sotto la diretta minaccia degli armati arabi, non hanno più l’animo
di raggiungere il podere più o meno isolato e non potranno vincere questo istintivo e
giustificato senso di timore che quando avranno raggiunto l’intima certezza che ogni
possibile pericolo è da escludersi nel modo più assoluto. Ed è da tener presente che
i coloni riacquisteranno la calma e la tranquillità non quando gli organi responsabili
diranno che possono essere tranquilli, ma solo quando se ne saranno convinti da soli,
il che è ben differente31.
Solamente nei centri più antichi (Razza, Beda e Savoia) si sarebbero
potuti realizzare in parte i lavori agricoli di maggiore impegno, come l’aratura, e solamente in una parte dei poderi che avevano conservato gli animali da lavoro: essendo praticamente inservibili tutti i trattori, e le altre
macchine irreparabili per mancanza di pezzi di ricambio, si poteva dire che
non si poteva far nessun lavoro nuovo nei comprensori di colonizzazione
del 1938 e del 1939.
Si prospettava la possibilità, ma anche la necessità politica ed economica, oltreché morale, di provvedere a consegnare la piena proprietà ai più
vecchi coloni, quelli che risiedevano nei loro poderi da ormai dieci anni, e
che avevano raggiunto una situazione produttiva e di avvaloramento ben
avanzata.
Per il resto, anche al fine di diminuire le spese dell’Ente, si doveva prevedere il rimpatrio di tutti coloro che in quelle condizioni non erano in grado di riprendere l’attività produttiva: in particolare si dovevano rimpatriare
le persone disabili, i bambini e le donne, lasciando sul posto unicamente
i maschi di più di 15 anni: si poteva prevedere l’inquadramento di questa
forza lavoro attraverso la sua militarizzazione, con il suo spostamento secondo le necessità dei lavori da un centro all’altro ovvero per il suo impiego
in lavori utili alle forze armate32. Si doveva inoltre sgombrare totalmente il
centro agricolo Mameli, dove la superficie dissodata era stata minima e dove si incontravano i massimi inconvenienti per la messa in valore: in effetti,
i poderi del centro erano pochi e dislocati in situazioni distanti tra di loro
in zone boscose ed aspre, con problemi di viabilità che rendevano difficile
91
Federico Cresti
raggiungerli. Il centro, poi, era lontano dagli altri e completamente isolato:
i suoi coloni avrebbero potuto essere spostati in altri villaggi.
Diversi impiegati e coloni erano stati internati dagli inglesi per cause
non conosciute33 o perché avevano compiuto atti di sabotaggio34, ma il
bilancio più grave era quello delle perdite umane: si contavano tra i coloni
42 morti, 40 uccisi dagli arabi, uno da un soldato indiano ed uno durante
un mitragliamento nemico35; i morti tra i dipendenti dell’Ente per la colonizzazione diventavano 43 se si contava anche l’«assistente edile Togna
Tito […] ucciso proditoriamente dagli arabi il giorno 24.12.1941 in località Sidi Alab del C.A. Sauro»36. I feriti erano 26, di cui 24 per mano degli
arabi, uno da un soldato polacco e uno dallo scoppio di una mina. Erano
inoltre enumerati i casi di violenza alle donne (18), 7 ad opera dell’Arab
Legion nel villaggio di Beda Littoria, 7 ad opera di arabi in altri villaggi e 4
ad opera dei soldati indiani37.
Ispezioni successive nei villaggi della Cirenaica avevano confermato lo
stato di estremo disagio delle popolazioni italiane.
Umberto Marroni, direttore del compartimento di Tripoli dell’Ente,
si era recato in Cirenaica per incarico del governo coloniale pochi giorni
dopo il ritorno delle truppe dell’Asse e aveva constatato che per la maggior parte i coloni erano stati uccisi dagli arabi mentre stavano fuggendo
dalle loro abitazioni in ordine sparso: se ne può dedurre che la cattiva
organizzazione dell’esodo ed il ritardo con cui si era realizzato era stata tra
le cause principali degli eccidi. Marroni giustificava in questo modo gli
avvenimenti:
La necessaria riservatezza delle operazioni militari portò come conseguenza che la popolazione colonica solo all’ultimo momento, incalzata dagli indigeni, poté portarsi ai
villaggi. Fu una vera fuga ed in conseguenza i coloni furono costretti a lasciare tutte le
scorte, gli arredamenti, le masserizie e in moltissimi casi anche i corredi personali. Il
maggior numero di assassini di elementi colonici (complessivamente 43) da parte degli
indigeni, si è verificato in occasione del ripiegamento della popolazione nei villaggi38.
All’epoca del viaggio di Marroni la rioccupazione della Cirenaica era
avvenuta da quasi due settimane, ma la famiglie coloniche erano rimaste
concentrate nei villaggi «dove sono sorte camerate in tutti i locali disponibili, non escluse le chiese»39.
La condizione generale dei coloni era quella di un profondo scoraggiamento, ma malgrado le condizioni di promiscuità e di pessima igiene che
92
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
si erano create nei centri di accoglienza tutte le famiglie, ad eccezione di
quelle le cui case si trovavano nell’immediata vicinanza dei villaggi, rifiutavano di tornare nei loro poderi sia perché si trovavano prive di ogni avere,
sia perché temevano nuovi attacchi da parte araba. La demoralizzazione dei
coloni, per superare la quale sarebbe stato necessario un tempo notevole
in un lavoro di riorganizzazione generale, si aggiungeva all’impossibilità da
parte del governo e dell’Ente di ricostituire le scorte necessarie, il bestiame
e le dotazioni delle fattorie: si imponeva dunque la scelta di sgomberare
la popolazione colonica della Cirenaica ad eccezione di circa 200 famiglie
che avrebbero potuto riprendere il loro lavoro consueto nelle fattorie più
progredite dal punto di vista dell’avvaloramento e della produttività: si
calcolava che avrebbero potuto rimanere 60 famiglie a Beda, ed un uguale
numero a Razza e a Luigi di Savoia; altre 20 famiglie avrebbero potuto
tornare nei loro poderi a Maddalena:
Le suddette famiglie, immesse in Cirenaica nei primi anni dal 1933 al 1936, occupano poderi in cui lo stato di avvaloramento è avanzato. In questi casi si tratta anche di
salvare un patrimonio cospicuo di lavoro e di fatica. Per dette famiglie, bisognerebbe,
tuttavia, provvedere senza indugio alla loro sicurezza nei riguardi degli indigeni40.
Per le altre 1.400 famiglie circa si doveva prevedere lo sgombero: i loro
poderi, tutti risalenti alla migrazione di massa del 1938 e 1939, avevano
visto la quasi totalità dei loro impianti arborei distrutti dalle greggi durante
le due invasioni inglesi, mentre le terre seminate a grano erano state in gran
parte usate come pascolo dai nomadi ed il loro raccolto era compromesso.
Si proponeva di lasciare nei centri che sarebbero stati sgombrati un
certo numero di giovani coloni che avrebbero avuto funzione di guardiani;
i coloni in partenza avrebbero potuto essere assorbiti dalla colonizzazione
della Tripolitania, ma in tutti i casi avrebbero dovuto essere mantenuti
con finanziamenti governativi per un certo tempo. Si prospettava l’ipotesi
di mettere a loro disposizione una somma di denaro che avrebbe potuto
considerarsi come un acconto per i danni di guerra.
La drammatica situazione dei coloni della Cirenaica dopo la seconda
invasione inglese è messa in evidenza anche in una breve relazione del presidente Cosimo Manni al consiglio di amministrazione dell’Ente riunitosi
nel mese di aprile del 1942:
Per la Cirenaica […] la situazione è molto peggiorata in quanto, a causa della seconda
93
Federico Cresti
occupazione nemica, che ha portato, soprattutto da parte degli arabi, gravi danni, l’attività dell’Ente può dirsi completamente paralizzata. I coloni dei vecchi centri hanno
potuto resistere meglio di quelli dei nuovi centri ove le case sono molto distanziate le
une dalle altre. Così, mentre i vecchi poderi sono ancora tenuti dai coloni, i nuovi poderi (colonizzazione demografica 1938-1939) sono stati abbandonati ed i coloni, per
salvarsi dagli arabi, sono stati costretti a vivere e vivono tuttora accentrati nei villaggi.
L’Ente ed il Governo si stanno adoperando per normalizzare la situazione, ma intanto
ogni attività agricola è sospesa.
I danni di questa seconda invasione, quando saranno stati definitivamente accertati,
saranno assai più rilevanti di quelli della prima.
Il personale della Cirenaica adesso è veramente logorato, e ciò che aggrava la situazione
è che non è possibile neanche avere quell’avvicendamento che sarebbe tanto necessario
in quanto il personale è ridotto al minimo e chi viene in Italia corre il rischio di non
poter ritornare in Libia a causa della mancanza di posti in aereo.
La situazione in Tripolitania è assai migliore ed i coloni, relativamente alle possibilità
della guerra, continuano la loro attività.
L’Ente sta provvedendo naturalmente per sormontare le non lievi difficoltà perché la
vita in Cirenaica ritorni normale ed i coloni possano riprendere i loro lavori. Si sta anzi
adesso provvedendo alla spedizione in Libia di materiali e macchinari per effettuare
quelle lavorazioni che il bestiame, quasi decimato, non può più compiere41.
Le esigenze dell’economia di guerra avevano sconvolto il normale procedere del lavoro delle aziende agricole. I contadini dei poderi nel corso
dell’estate avevano accettato in gran parte le offerte di lavoro che venivano
da ditte, imprese ed enti militari, che offrivano salari molto più elevati
di quelli dell’Ente, anche per la rarefazione della manodopera dovuta alla
guerra. In Tripolitania il fenomeno era stato preoccupante come in Cirenaica, ed era stato arginato mediante l’applicazione stretta di un decreto
di mobilitazione civile. Anche in Cirenaica tutti i coloni del Gebel erano
stati mobilitati.
Le attività create dalla presenza militare nel territorio libico avevano
«distratto le masse rurali dai lavori», e le avevano portate a cercare entrate
più sicure impiegandosi come manodopera nei lavori di interesse militare.
Nei centri di Garibaldi, Crispi e Gioda, nella Libia occidentale, i lavori
agricoli erano stati sospesi per qualche tempo; da Gioda, che aveva diversi
problemi di difficile risoluzione, in particolare per il cattivo funzionamento delle strutture idrauliche, 26 famiglie coloniche erano state trasferite in
Cirenaica. Dagli ultimi sconvolgimenti risultava che in Tripolitania erano
rimasti vacanti 217 poderi, mentre in Cirenaica il numero era molto più
94
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
elevato (671). Alcuni dei poderi abbandonati erano stati affidati ad una
gestione in economia che si doveva soprattutto occupare di mantenere in
efficienza gli impianti arborei: a Misurata la Gioventù italiana del littorio
aveva assunto la conduzione di alcuni centri con il lavoro dei giovani che
in questo modo si avviavano verso la conoscenza delle attività agricole. In
Cirenaica si proponeva di affidare alle truppe alcuni terreni rimasti abbandonati («naturalmente i prodotti ricavati andrebbero ad esclusivo vantaggio delle truppe interessate al lavoro»42).
Le conseguenze della seconda invasione inglese per i poderi della Cirenaica erano state particolarmente gravi per le coltivazioni arboree: si stimava che dovessero essere rimpiazzate circa 50.000 piante di ulivi e mandorli,
mentre a Luigi di Savoia le gelate degli ultimi anni avevano danneggiato
circa 60.000 viti. La situazione del bestiame era tragica, ed in seguito alla
sua progressiva riduzione la maggior parte delle famiglie coloniche non
poteva eseguire i lavori necessari nei poderi. Tutto ciò aveva avuto come
conseguenza l’aumento dei prezzi del bestiame degli allevatori libici (da 20
a 25.000 lire per capo bovino indigeno, da 10 a 20.000 per i cavalli) e ciò
rendeva impossibile ogni acquisto da parte dei coloni. Dei 3.200 bovini
maremmani che esistevano prima della seconda invasione, 1.800 erano
stati rubati e circa un migliaio avevano dovuto essere macellati a causa della
mancanza di foraggio nel corso della stagione passata.
Dopo il ritorno delle truppe italiane si era cercato di accertare le responsabilità dei furti di bestiame:
Il generale Piatti ha iniziato una energica azione per l’accertamento delle responsabilità di tali furti e rapine, pretendendo indennizzi in danaro e in natura. Al 31 ottobre
l’Ente ha introitato L. 1.000.200 in pagamento di 89 bovini, L. 22.000 per tre cavalli,
L. 9.000 per 17 ovini ed in più sono stati consegnati 57 bovini indigeni e n. 21 equini.
I pagamenti continuano. Rimangono ancora da rimborsare 1.500 bovini per molti dei
quali sono ancora in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dei furti43.
Come dopo la prima occupazione, anche dopo la seconda fu preso in
esame il comportamento dei funzionari dell’Ente che erano incorsi nel
biasimo della direzione o delle autorità della colonia, e si era provveduto
a punire i colpevoli delle mancanze più gravi. L’inchiesta aveva avuto il
risultato di mostrare come nella generalità dei casi si fosse trattato di un
abbandono del posto di lavoro senza il consenso dei superiori, ma aveva tra
l’altro messo in luce un sentimento di sfiducia nei confronti della dirigenza
95
Federico Cresti
dell’Ente e nelle prospettive di un esito favorevole degli avvenimenti bellici
che in precedenza non si era ancora manifestato44.
Lo scoraggiamento dei coloni non era solamente apparente, e nel corso
degli incontri con i funzionari dell’Ente molti dei capifamiglia avevano
espresso il desiderio di essere rimpatriati, o almeno di essere allontanati da
una zona che aveva dimostrato di essere nevralgica per lo svolgimento delle
operazioni di guerra45.
In quella situazione disastrosa l’Ente aveva proposto al governo della
colonia lo sgombero dei comprensori, ma la proposta era stata respinta per
considerazioni di carattere superiore: era stato deciso che l’attività colonica
dovesse essere ripresa e che i coloni dovessero rimanere al loro posto46. Il
governatore aveva affermato che i coloni del Gebel avrebbero potuto essere
armati per difendersi o combattere, completando in questo modo la loro
‘militarizzazione’: sarebbe stato permesso il rimpatrio solamente a quelle
famiglie che avevano avuto lutti nel corso della recente occupazione o per
le quali l’Ente avesse richiesto il ritorno in Italia per ragioni di salute o per
altri motivi giustificati. I bambini dei coloni sarebbero stati inviati nelle
colonie della GIL in Italia, mentre i coloni iscritti alla MVSN sarebbero
stati richiamati in servizio e militarizzati. Il governo si era impegnato a
coprire tutte le spese dell’operazione, e si stava provvedendo all’invio di
materiali da Tripoli per permettere la ripresa dei lavori agricoli47.
La decisione delle autorità aveva messo in qualche modo nell’imbarazzo
i dirigenti dell’ECL, che vedevano aumentare il rischio di una bancarotta,
dal momento che i lavori di valorizzazione dei terreni si erano fermati ormai da tempo (ed era difficile prevederne la ripresa), mentre l’Ente doveva
continuare a sborsare capitali per il mantenimento delle strutture e dei coloni. In una lettera alla direzione centrale della fine di febbraio, Umberto
Marroni faceva notare i rischi della situazione per l’ECL:
La situazione esistente in Cirenaica è solo lievemente migliorata [dall’epoca della rioccupazione …]. I lavori agricoli sono […] sospesi, salvo nei vecchi centri. Anche nel
passato, dalla prima occupazione in poi, i lavori hanno proceduto con molta lentezza.
L’Ente continua così a sborsare inutilmente milioni al mese senza che l’opera di avvaloramento proceda di un passo e senza ottenere produzioni che possano giustificare
in parte le spese sostenute. Anche se i coloni potranno rioccupare presto i loro poderi,
non c’è da attendersi un apprezzabile risultato di lavoro sia perché mancano i mezzi e
i materiali per svolgere una proficua attività agricola e sia perché si tratta di elementi
scossi e depressi moralmente. È una situazione di una eccezionale gravità che deve ri96
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
chiamare tutta l’attenzione dell’Ente. I danni diretti di guerra sono notevolissimi […],
ma il danno indiretto è indubbiamente maggiore per l’inattività dei coloni che ormai
dura da lungo tempo e durerà inevitabilmente ancora48.
Lo sgombero parziale prospettato avrebbe alleggerito il carico dell’Ente,
ma dal momento che per ragioni politiche questa strada non era stata percorsa, la direzione dell’Ente doveva preoccuparsi delle inevitabili ricadute
finanziarie della situazione.
Tuttavia, anche se un ulteriore sgombero parziale dei comprensori era
stato rifiutato dalle autorità di governo, la presenza dei coloni in Cirenaica
era diminuita notevolmente: dall’ottobre del 1941 all’ottobre dell’anno
successivo il trasferimento in Tripolitania o con il rientro in Italia avevano
portato a ridurre di circa la metà il numero degli agricoltori italiani. Mentre nel 1941 si contavano 1.649 famiglie per un totale di 8.426 persone,
l’anno successivo le due cifre erano passate rispettivamente a 1.053 e a
4.163. Nell’ottobre 1942 il comprensorio del villaggio Mameli risultava
totalmente spopolato. Nella stessa data il comprensorio meno abitato era
quello di D’Annunzio, con 116 coloni, e quello con maggior numero di
coloni era Baracca con 67749.
Malgrado la decisione politica del governo coloniale di evitare nella
misura del possibile un esodo massiccio, in effetti, l’ECL si era detto in
linea di massima favorevole a permettere la partenza dei coloni che ne avevano fatto richiesta, e più in particolare ad eliminare la presenza dei «meno
idonei e […] sfiduciati»: questi costituivano un peso morto, e si ricordava
che la loro sfiducia aveva ben ragion d’essere, dal momento che «la guerra
ha seguito a sette mesi l’ultima grande immissione colonica e quindi la
maggioranza dei coloni non hanno di fatto mai avuto efficiente il podere
che è stato strozzato nel nascere dalle condizioni di guerra»; la loro partenza avrebbe tra l’altro alleggerito la situazione alimentare, che in alcune
zone era critica50. Se in parte i poderi evacuati erano stati rioccupati, agli
inizi di novembre del 1941 in Cirenaica si contavano 671 poderi rimasti
abbandonati o occupati dalle truppe51.
L’incertezza sul da farsi con la popolazione rurale della Cirenaica era
durata a lungo, ma il mutare del destino della guerra sul fronte egiziano
(dove il 4 novembre era iniziato il ripiegamento delle truppe italiane e
tedesche che non erano riuscite a superare lo sbarramento alleato ad ElAlamein) aveva portato le stesse autorità di governo a cambiare parere e a
97
Federico Cresti
prendere un provvedimento immediato: l’8 novembre del 1942 in un incontro a cui avevano partecipato tra gli altri l’ispettore dell’Ente Marroni,
il governatore Bastico e il vicegovernatore, era stato deciso lo sgombero di
tutti i coloni della Cirenaica52.
Il giorno 11 dello stesso mese era stata inviata a Roma la notizia che una
parte del personale dell’Ente e dei coloni aveva iniziato il viaggio verso la
Tripolitania; il 14, che il ripiegamento interessava tutti i coloni della Cirenaica, che sarebbero partiti per via di terra. Solamente i coloni di Berta e
una parte di quelli di Baracca erano stati spediti per via aerea direttamente
in Italia53.
Il 17 novembre Marroni comunicava alla presidenza romana dell’Ente
che lo sgombero della Cirenaica era ormai totale: gli agricoltori che erano
giunti a Tripoli erano circa 4.000 ed erano stati smistati nei diversi centri
del misuratino, del tarhunese e della provincia di Tripoli
Il presidente dell’Ente, Cosimo Manni, aveva inviato in quell’occasione
una lettera crucciata al Ministero dell’Africa Italiana e al Commissariato
delle Migrazioni interne per dire tutto il suo disappunto di fronte alla
partenza dei coloni. Comunicando di aver saputo del provvedimento dal
suo ispettorato di Tripoli, Manni ricordava che in questo modo tutto il
patrimonio dell’Ente abbandonato agli indigeni poteva considerarsi definitivamente perduto:
I provvedimenti adottati, che sono in completa antitesi con quelli precedentemente
presi in occasione delle precedenti occupazioni nemiche, risultano pertanto dolorosi
ed inspiegabili a questo Ente che, seguendo le direttive di codesto Ministero, aveva
fino all’ultimo giorno impartite riservate istruzioni onde fornire i coloni dei mezzi più
idonei a proteggere il nostro patrimonio agricolo, nel caso di una deprecata temporanea occupazione nemica. Principalmente a questo scopo erano state date disposizioni
per addivenire alla assegnazione dei poderi ai singoli coloni, per far sì che il nemico
trovandosi di fronte a piccoli proprietari diretti coltivatori, si sentisse comunque impacciato in azioni di rappresaglia54.
Il presidente ricordava che «tale dolorosissimo fatto» avrebbe avuto
come gravissima conseguenza la perdita totale del patrimonio investito
dall’Ente in quel territorio, e di conseguenza anche la perdita dei capitali
degli istituti che avevano partecipato al suo finanziamento.
Il problema dei coloni si era posto qualche tempo dopo in Tripolitania,
ma in quell’occasione il governo aveva deciso di seguire un’altra strada. Il
98
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
30 novembre il governatore generale Ettore Bastico aveva inviato all’Ente
una lettera che diceva così:
Nella deprecata eventualità di una occupazione del territorio da parte del nemico, il
Governo intende che nulla sia mutato nella organizzazione dei due Enti di colonizzazione della Libia e intende che essi continuino ad applicare [sic] la loro attività, tanto
nei riguardi della valorizzazione dei poderi quanto nei riguardi dell’assistenza ai coloni
[…]. Sia tenuta in particolar modo presente, in quella eventualità, le necessità di proteggere e conservare il frutto di tanti anni di dure fatiche e delle ingentissime spese
sostenute dal Governo e dagli Enti colonizzatori55.
Note al testo
1
Cfr. F. Cresti, La prima occupazione inglese della Cirenaica e i coloni italiani in un documento
dell’epoca, in «Studi storici», 2007, 1, pp. 241-66.
2
Cfr. F. Cresti, Documenti per la storia della Libia: l’archivio ritrovato dell’Ente per la colonizzazione della Libia. Un inventario provvisorio, in «Africa», LIII, 4, 1998, pp.557-76.
3
ECL, Direzione compartimentale Barce, Situazione del compartimento al 15 agosto 1941-XIX, in
AECL, cart. 44, fasc. 37/III, Situazione del compartimento della Cirenaica al 15.8.1941-XIX.
4
Ivi, p. 10.
5
L’Ente per la colonizzazione della Cirenaica era stato fondato nel 1932 e già dall’anno successivo aveva iniziato a costituire i primi poderi nei comprensori di Beda Littoria, di Primavera (che
poi prese il nome di Luigi Razza), di Luigi di Savoia e di Giovanni Berta ingaggiando contadini
dell’Italia meridionale.
6
ECL, Direzione compartimentale Barce, Situazione del compartimento cit., p. 16.
7
È forse opportuno ricordare che in seguito all’approvazione da parte dell’amministrazione centrale del Piano di colonizzazione demografica intensiva presentato da Italo Balbo, governatore
della Libia, a Mussolini nella prima metà del 1938, il 28 ottobre del 1938 avevano iniziato il
loro viaggio verso la Libia circa 20.000 coloni scelti in prevalenza tra i disoccupati agricoli delle
regioni italiane; il 28 ottobre dell’anno successivo circa 11.000 altri coloni avevano seguito lo
stesso percorso ed erano andati a stabilirsi nei poderi che gli enti di colonizzazione avevano
approntato per loro in Tripolitania e in Cirenaica (cfr. tra altri lavori F. Cresti, Oasi di italianità. La Libia della colonizzazione agraria tra fascismo, guerra e indipendenza (1935-1956), SEI,
Torino 1996, pp. 50-78).
8
ECL, Direzione compartimentale Barce, Situazione del compartimento cit., p. 17.
9
Da Razza, 17 dicembre 194: Della Porta a Comando Superiore CC.RR., ECL, Direzione compartimentale, Maddalena, Seconda occupazione inglese della Cirenaica, relazione di Loris Giai
Via [da adesso: RGV], all. 1 in AECL, cart. 44.
10
RGV, p. 2.
99
Federico Cresti
11
RGV, all. 5. Baracca avrebbe alloggiato i coloni fuggiti da Filzi, concentrando nelle case coloniche centrali le famiglie delle fattorie più periferiche. Maddalena avrebbe ospitato i coloni che
dovevano lasciare Sauro.
12
Amerigo Dùmini, l’assassino di Giacomo Matteotti, aveva ottenuto una concessione a Faidia,
nella provincia di Derna, che era poi stata revocata per decisione di Italo Balbo quando la quasi
totalità dei terreni delle concessioni private della Libia erano stati destinati agli agricoltori che
dovevano giungere dall’Italia secondo il piano di colonizzazione demografica intensiva (cfr.
Giuseppe Mayda, Il pugnale di Mussolini, Il Mulino, Bologna 2004, passim; F. Cresti, Non desiderare la terra d’altri. Coloni e villaggi italiani in Cirenaica (1932-1943), in corso di stampa).
13
RGV, all. 2. Questo allegato contiene le Disposizioni in vista della occupazione del Gebel Cirenaico dal nemico, inviate il 18 dicembre del 1941 da Giai Via ai capi zona dei centri agricoli di
Razza, Beda, Savoia, Berta, Battisti, Mameli e Alba. Veniva disposto che per ordine del governatore generale tutti i funzionari ed impiegati dell’Ente rimanessero al loro posto; che tutte le
famiglie coloniche di Berta ripiegassero «portando seco i viveri e la biancheria indispensabile»
verso il centro Luigi di Savoia, dove sarebbero stati alloggiati negli edifici pubblici e nella cantina, o a Beda, dove avrebbero occupato i locali ex militari. In occasione del ripiegamento il capo
zona di Berta avrebbe dovuto portare con sé tutto il carteggio del centro. A Beda Littoria, Luigi
di Savoia, Razza e Battisti i coloni che abitavano le fattorie più isolate si sarebbero raggruppati
secondo un piano predisposto in precedenza. Battisti avrebbe dovuto ospitare anche i coloni
della ex concessione Dùmini, mentre a Mameli sarebbero ripiegati i coloni di Slonta e di Gasr
Sciaden. Coloro che dovevano lasciare Alba, uno dei villaggi della colonizzazione musulmana
situati o poca distanza dal Mediterraneo tra Derna e Apollonia (Marsa Susa) si sarebbero diretti
a Razza.
14
RGV, all. 6 bis: da Baracca, 19 dicembre 1941, Del Savio a Giai Via.
15
RGV, p. 3
16
RGV, p. 4.
17
Il fatto era accaduto il 21 dicembre (ivi, p. 4).
18
Su questo episodio esiste una testimonianza diretta (all. n. 8): «Ieri mattina alle sei circa la casa
fu fatta segno di tiri di fucileria da parte di arabi […] visto che il numero di arabi era rilevante
– pro[me]ttemmo di dare tutto purché ci lasciassero salva la vita. Gli arabi si avvicinarono – fra
essi ravvisai lo stradino di Castellevia – parte entrarono in casa e parte puntarono i fucili su di
noi. Saccomani chiese di prendere una carriola per adagiarvi sua moglie (Lodi Pietra) che era
senza una gamba. Mentre si accingeva ad adagiare la poveretta su tale mezzo, un colpo di fucile
lo fulminava. La stessa sorte toccò alla moglie. Terrorizzato dalla scena e visto approssimarsi
la mia fine, mi diedi a correre a zig-zag per il bosco per il quale sono stato inseguito e sparato
per più di 5 chilometri di strada. Prima di darmi alla fuga sentii gridare la Saccomani Maria
(figlia) – Basta Alì – Credo l’abbiano anche violentata». Maria Saccomani era stata poi ritrovata
uccisa.
19
Ivi, p. 6.
20
Ivi, p. 8.
21
Ivi, all. n. 10.
22
Casi di violenza alle donne da parte di militari indiani sono segnalati anche a p. 15 (Baracca)
23
RGV, all. n. 13: Nicolardi a Giai Via, da Beda 25 dicembre 1941. Altri allegati contengono
descrizioni molto dettagliate del primo periodo dell’occupazione in alcuni centri: ad es., all. n.
19bis: il capo zona Pietrogrande a Giai Via, Mameli, s.d.
100
Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale
24
Ivi, p. 29.
25
Ivi, p. 15.
26
Ivi, p. 19.
27
Ivi, p. 15. Durante la perquisizione al villaggio Oberdan tutti gli uomini erano stati radunati
sulla piazza principale, mentre le abitazioni, dove erano rimaste le donne e i bambini, erano
state perquisite dai soldati arabi. In una denuncia del capo zona di Oberdan (U. De Monte) alla polizia dopo la fine dell’occupazione britannica si legge che in quell’occasione diversi coloni
si erano visti togliere tutto il denaro che possedevano, capi di biancheria e scarpe. Un tentativo
di violenza carnale non aveva avuto successo (RGV, all. 20).
28
Alla data del 15 gennaio si segnala che i rastrellamenti della polizia inglese hanno avuto come
risultato l’internamento in campo di concentramento di 10 sui 42 militari nascosti a D’Annunzio, di 68 su 220 ad Oberdan, di 1 su più di 100 a Maddalena. A Baracca i 40 italiani e i
tre tedeschi nascosti dai coloni erano riusciti a sfuggire alle ricerche.
29
Ivi, p. 21.
30
Ivi, p. 26.
31
Ivi, p. 31.
32
Ivi, p. 32.
33
Si trattava degli agronomi Terenzio Passalacqua, Giuseppe Perani Galeotti e Francesco Stabile,
del contabile Guelfo Del Frate e del colono Luigi Dicati (AECL, cart. 44: Impiegati e coloni
dell’Ente per la Colonizzazione della Libia internati dagli inglesi, s.a., s.d.).
34
Il colono Bortolo Benedet del villaggio Battisti, di diciotto anni, arrestato perché era stato
sorpreso a danneggiare un carro armato leggero inglese (ibid.).
35
Erano stati assassinati: Giacomo Tanara, Giuseppina Padovani, Vincenzo Matteucci, Giovanni
Campanella, Fedele Campanella, Carlo Rizzi, Luigi Lucchini, Primo Lucchini, Fiore Lucchini,
Maria Lucchini, Emanuele Mazzi, Vittorio Venturi e Vito Tortorello dei comprensori di Baracca e Filzi; un altro colono di Baracca, Eugenio Dernio, era morto probabilmente di paralisi
cardiaca durante l’assalto della casa in cui si era rifugiato da parte di arabi armati di moschetto e
bombe a mano; Teresa Mafro del centro agricolo Sauro; Angelo Saccomani, Pietra Lodi Saccomani, Maria Saccomani e Agostino Vaglica del centro agricolo D’Annunzio; Cristiano Marcolongo, Salvatore Polito, Felice Galiotto, Ernesto Benetollo, Bruno Altisani, Vincenzo Berlino e
Salvatore Malfitano del comprensorio Oberdan; altri due coloni di Oberdan, Costante Sartori
e Pietro Salvegnano, erano morti per paralisi durante attacchi degli arabi alle loro abitazioni;
Ernesto Ceccato, Ferdinando Frassinetti, Giovan Maria Poli, Luigi Pisicchio e Cataldo Lopes
di Beda Littoria; Luigi Romano del centro agricolo Luigi di Savoia; un altro colono dello stesso
centro, Vittorio Migliorini, era morto camminando su una pista minata dalle truppe inglesi;
Giuseppe Capuano e Ignazio Arrabito del centro agricolo Berta; Plinio Rossetto del centro
Battisti; Lino Smaniotto, Costantina Madalozzo, Guido Smaniotto e Florindo Smaniotto del
centro Mameli.
36
Ivi, p. 34.
37
Un documento dattiloscritto (in AECL, cart. 44, fasc. 72/III, s.a., s.d.) enumera le generalità
dei morti, dei feriti e delle donne violentate. Le violenze carnali avevano fatto vittime tra le
donne dei centri Baracca, Battisti e Beda Littoria. Assieme al nome delle vittime sono elencate le ragioni della morte e dei ferimenti, che nella quasi totalità furono causati da colpi di
moschetto; in un caso sono citate sevizie sul cadavere dopo la morte; in tre casi erano stati
assassinati tutti i membri di una stessa famiglia.
101
Federico Cresti
38
U. Marroni, Promemoria per l’Eccellenza il Governatore Generale per la Libia, Tripoli 12 febbraio 1942, in AECL, cart. 44, fasc 72/III (Notizie sulla II occupazione della Cirenaica – Gennaio
1942).
39
Ivi, p. 2.
40
Ivi, p. 3.
41
AECL, VCA2, 2 aprile 1942, pp. 196-197.
42
Ivi, p. 5.
43
Ivi, p. 9.
44
Ad esempio, la censura postale aveva fatto conoscere al MAI, che l’aveva trasmesso all’Ente in
via riservata, il brano di una lettera inviata alla famiglia in Italia da un dipendente dell’ECL, il
geometra Di Biagio, in cui si poteva leggere: «[…] sono tanto stanco della colonia ed un po’ anche dell’Ente per la colonizzazione della Libia che ogni giorno di più si avvia verso una grande
disgregazione e forse ad un fallimento per l’inettitudine e poca scrupolosità dei capi» (AECL,
VCE2, 20 luglio 1942, p. 113). Un altro caso aveva riguardato l’agronomo Chappini, accusato
ingiustamente di essersi allontanato dal villaggio Luigi Razza: era stato dimostrato che il suo
allontanamento era stato autorizzato dal direttore compartimentale «per sottrarlo ad eventuali
rappresaglie da parte degli indigeni» (ivi, p. 113), ma era incorso ugualmente nella censura per
aver scritto in una sua lettera: «Tengo a far rilevare che i miei impegni con l’Ente riguardano
solo prestazione di opera e non il sacrificio della vita. In caso di morte in servizio per la colonizzazione quali impegni ha l’Ente verso la mia famiglia? Nessuno. In caso di invalidità o prigionia
quali impegni ha l’Ente verso il sottoscritto? Nessuno» (ibidem).
45
Anche se in nessun altro documento dell’archivio si trova traccia della richiesta dell’opinione
dei coloni, in una lettera del presidente dell’ECL Cosimo Manni al Commissario per le migrazioni interne Giuseppe Lombrassa si afferma che «i coloni sarebbero del parere di sgombrare»
(AECL, cart. 44: Manni a Lombrassa, 18 febbraio 1942).
46
Il governatore aveva dichiarato a Marroni il 13 febbraio che «per considerazioni di carattere
politico non ritiene opportuno effettuare lo sgombero parziale delle famiglie coloniche della
Cirenaica, pur rendendosi conto della loro triste situazione» (ivi: Marroni a Presidenza, 13
febbraio 1942).
47
Ivi: Marroni a Presidenza ECL Roma, da Tripoli, 26 febbraio 1942.
48
Ivi: Marroni a Presidenza Roma, 20 marzo 1942.
49
AECL, cart. 44: Relazione del Consigliere Duca di Spadafora su missione compiuta in Libia
nell’Ottobre 1942/XX° (in una cartella con questo nome), all. n. 14: Famiglie coloniche della
Cirenaica.
50
Ivi: Appunti consegnati al sig. Duca Gutierrez di Spadafora per trattazione pratiche durante sua
missione in Libia nell’ottobre-novembre 1941.
51
Ivi: Relazione del Consigliere Duca di Spadafora cit.
52
AECL, cart. 44: Marroni a Presidenza ECL, 8 novembre 1942.
53
Ivi: Id., 11 e 14 novembre 1942.
54
AECL, cart. 44, fasc. s.n.: Situazione creatasi in Cirenaica nel novembre 1942, Manni a MAI,
27 novembre 1942.
55
Ivi, Bastico a ECL, 30 novembre 1942, n. 224615, cit. in Manni a MAI, 16 gennaio 1943,
n. 293.
102
la politica coloniale
Le colonie italiane nel carteggio
del ministro Colosimo (1916-1919)
di Vanni Clodomiro
Gaspare Colosimo1 nacque a Colosimi, al confine tra la provincia di
Catanzaro e quella di Cosenza, l’8 aprile 1859 da Pietro Paolo e da Artemisia Colosimo, appartenenti entrambi ad una ricca famiglia. Alla morte
del padre, fu chiamato a Napoli all’età di sei anni dallo zio paterno Domenico, consigliere della Corte di Cassazione. Morto anche lo zio, sua
moglie si prese cura di Colosimo e, nel 1869, lo fece entrare nel collegio
Vittorio Emanuele II, dove ebbe come maestri Pasquale Turiello, Vincenzo
Padula e l’abate Giuseppe Petroni, ottimo latinista e grecista. In collegio
Colosimo rimase per nove anni, cioè fino alla licenza liceale. Compì gli
studi nell’Università di Napoli, laureandosi nel 1882 in giurisprudenza. In
seguito, prese parte a molti processi, difendendo personaggi importanti e
mettendosi in luce come brillante avvocato, nonostante la giovane età.
Fu consigliere e assessore del Comune di Napoli. Egli aveva una tradizione familiare professionale e patriottica da rispettare e mantenere e,
trovandosi solo in quella grande città, si lanciò nella lotta, dividendosi tra
politica e professione, ma dedicandosi in sostanza più alla prima. Come
forza di penetrazione nei due campi usò il giornalismo, interpretandolo in
verità più come una battaglia da combattere che come una professione da
svolgere.
Fu anche un celebre avvocato. Sinteticamente, elenchiamo adesso gli
incarichi politici che Colosimo ricoprì nella sua lunga carriera.
Dopo l’accennata elezione a consigliere comunale di Napoli e al Consiglio Provinciale, venne eletto deputato del collegio di Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Fu sottosegretario di Stato all’agricoltura nel 1898, col
ministro Fortis; sottosegretario di Stato al ministero di Grazia e Giustizia
nel 1906 col ministro Gallo e sottosegretario di Stato alle Colonie nel
1912 col ministro Bertoloni. Fu quindi per breve tempo ministro delle
Poste, e, finalmente ministro delle Colonie col Boselli nel giugno 1916.
103
Vanni Clodomiro
Tale ministero mantenne anche durante il ministero Orlando, ricoprendo
così la carica di ministro delle Colonie per tre importantissimi anni durante e subito dopo il conflitto mondiale. Nel corso delle trattative di pace a
Versailles, Colosimo fu anche vice presidente del Consiglio dei ministri.
Fu proprio allora che, per incarico di Orlando, preparò il futuro accordo
con la Santa Sede, al fine di risolvere il problema del rapporto tra Stato e
Chiesa2. Nel 1919 cadde il ministero Orlando e Colosimo lasciò il suo incarico ministeriale. Fu ancora eletto deputato nel 1921, per l’ultima volta,
nelle file dell’Unione Nazionale Democratica, ma nel 1924, non essendo
stato inserito nel «listone», si ritirò a vita privata. Quella decisione apparve
a taluni come un fatto di prudenza, ad altri come un atto di protesta. Ad
ogni modo, quale che ne sia stata la ragione, sta di fatto che, nel 1924 fu
nominato senatore del Regno.
Morì il 7 settembre 1944, nella sua diletta Napoli.
***
All’atto del suo insediamento al dicastero delle Colonie, il 16 giugno
1916, Gaspare Colosimo si trovò di fronte a tre importanti questioni: le
trattative con Sajed el Idriss per la pacificazione della Cirenaica; l’accordo
italo-inglese circa la Senussia; le pratiche con il Governo inglese per una
cooperazione italiana al confine cirenaico-egiziano.
Per quanto riguarda Sajed el Idriss, il ministero delle Colonie intendeva
condurre le trattative, tenendo fermo, come base, che nulla dovesse essere
concesso, che potesse in un modo qualsiasi intaccare la sovranità dell’Italia sulla Libia; sovranità proclamata con legge dello Stato e con impegni
internazionali.
Inoltre, altro punto fermo delle trattative sarebbe stato lo scioglimento
dei campi e il disarmo, provvedendosi, ovviamente, anche alla liberazione
dei prigionieri. Fermi restando, dunque, tali punti, l’Italia avrebbe riconosciuto la confraternita senussita, con a capo Sajed el Idriss, che avrebbe così
assunto quel potere che gli spettava per eredità, in quanto figlio del fondatore della confraternita stessa. Su quelle basi d’accordo, Italia e Inghilterra
concordavano. Su altre cose, come, ad esempio, facilitazioni commerciali,
doganali, autonomia amministrativa nell’oasi di Cufra, la delegazione italiana aveva libertà di fare concessioni, purché l’Italia mantenesse, ovviamente, la sovranità.
104
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
Alcuni colloqui erano già avvenuti, al momento dell’assunzione del ministero da parte di Colosimo, e altri se ne stavano preparando. Dunque,
spettava ormai al nuovo ministro condurre avanti le trattative e sistemare
la questione della Cirenaica.
Circa la Senussia, era in ogni caso necessario un accordo con l’Inghilterra (questa la seconda questione sul tavolo) e il ministero delle Colonie
aveva già da tempo prospettato al ministro degli Esteri la necessità di un
tale accordo. Ma le difficoltà erano notevoli, in quanto l’Inghilterra rispondeva alle proposte italiane che non poteva entrare in quell’ordine di
idee. Tuttavia, dopo la sconfitta subita dal Senussi in carica Sajed Scerif nel
dicembre 1915 ad opera delle forze anglo-egiziane, e dopo l’occupazione
italiana di Bardia e i contatti dell’Italia con Idriss, primo cugino di Sajed
Scerif, il Governo inglese, che prima non aveva voluto trattare assieme
all’Italia col Senussi, chiese all’Italia stessa di accettare un ufficiale inglese
nella sua delegazione.
Terza questione, infine, era quella accennata della cooperazione italoinglese al confine cirenaico-egiziano. L’Italia, tramite il suo addetto militare
al Cairo, capitano Caccia, ricevette comunicazione che il generale Murray
aveva proposto un’azione comune con gli italiani contro le forze senussite
di Nury Bey, che si trovava in Cirenaica, a 160 miglia ad ovest di Sollum.
Sullo stesso argomento, un promemoria dell’ambasciatore d’Inghilterra
fu presentato al ministro degli Esteri italiano, che ne dette comunicazione
al ministro delle Colonie appena qualche giorno prima dell’insediamento
di Colosimo.
Per quanto riguarda l’accordo italo-inglese per la Senussia, il ministro
degli Esteri Sonnino acconsentì che il ministro delle Colonie trattasse direttamente con l’Ambasciatore d’Inghilterra, sir Rennel Rodd. Tutto ciò
fu preceduto da un incontro tra Colosimo e Sonnino, scopo del quale
era un’intesa sul modus procedendi per iniziare le trattative di accordo e
l’acquisizione, da parte di Sonnino, di uno schema dei punti fondamentali
del negoziato.
L’Inghilterra, intanto, faceva sapere all’Italia che a Sajed el Idriss si chiedevano due cose: che non tenesse truppe al confine egiziano e che liberasse
i prigionieri inglesi. Da parte sua, il governo inglese era disposto a riconoscere Idriss come capo della confraternita e a consentirgli la riscossione
delle decime fra i Senussiti d’Egitto, purché senza costrizione. L’Inghilterra
non aveva alcuna intenzione di fare annessioni, anzi, pur di giungere ad
105
Vanni Clodomiro
un accordo, faceva capire di essere anche disposta a lasciare al Senussi l’oasi
di Giarabub in amministrazione, fatti salvi comunque i diritti territoriali
dell’Egitto. In ogni caso, l’Inghilterra voleva preventivamente concordare
tutto con l’Italia.
Colosimo era convinto che solo un saldo accordo dell’Italia con l’Inghilterra potesse creare con Idriss un’intesa, che avesse una solida base e che
gli consentisse di ottenere concessioni separate dall’una o dall’altra.
Iniziarono così i negoziati tra le due rappresentanze diplomatiche, al
fine di giungere alla stipula di un accordo per un’azione comune nei confronti di Idriss. Ciò, di fronte ai Senussi, avrebbe mutato una situazione di
costante debolezza, sia dell’Italia che dell’Inghilterra, in una situazione di
forza derivante dall’avvenuta intesa, pure se si fosse trattato di un accordo
puramente difensivo.
Tale accordo fu firmato il 31 luglio 1916. Poco dopo, Colosimo, nel
corso di un colloquio con Rennel Rodd, gli disse che sarebbe stato opportuno anche un accordo tra Italia e Inghilterra sulla questione arabica,
accordo che si sarebbe potuto fondare sulla garanzia, da parte delle due
Potenze, delle economie locali, in analogia a quanto avvenuto nel 1888
tra Francia e Inghilterra per Harrar. Ma Rodd rispose che, al momento,
c’erano difficoltà per un accordo del genere. Non se ne parlò più.
Intanto Colosimo premeva presso il ministro degli Esteri circa l’opportunità di ottenere l’adesione della Francia all’accordo italo-inglese del 31
luglio 1916. Infatti, nel corso di un altro incontro con Rodd, fu affrontata
la questione del Nord Africa e si disse delle doglianze della Francia di non
aver avuto comunicazione dell’accordo italo-britannico del 31 luglio per
la Senussia e dell’opportunità che dell’accordo stesso si fosse data notizia.
Il ministro delle Colonie suggerì che si cogliesse l’occasione per indurre
la Francia ad accedere all’accordo. Era evidente l’interesse inglese a che la
Francia facesse parte dell’accordo, in quanto i Senussi, sapendo chiuso il
confine cirenaico-egiziano ai rifornimenti, avrebbero tentato la via della
Tunisia e del sud della Libia per eludere il blocco.
Rodd chiese anche un accordo a tre (Italia, Francia e Inghilterra) sulla
questione araba, cosa sulla quale Colosimo era d’accordo a livello personale (ma non poteva parlare anche a nome di Sonnino) sulla coincidenza di
interessi tra Italia e Inghilterra; lo era di meno sull’utilità dell’entrata della
Francia nell’accordo, poiché essa, dopo la pace, avrebbe certo avanzato
pretese sull’Arabia. Egli proponeva quindi di fare un accordo tra Italia e
106
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
Inghilterra: in un momento successivo, quando cioè la Francia avesse chiesto di conoscerlo, allora avrebbe potuto accedere alle condizioni preventivamente concordate fra Italia e Inghilterra. Rodd si riservò di prendere
in considerazione la proposta. Successivamente, Sonnino, informato del
colloquio, pregò Colosimo di trattare direttamente con Rodd la questione
di un accordo italo-inglese per l’Arabia.
Ma in seguito l’Italia ebbe notizia di un accordo segreto per l’Arabia intervenuto tra Francia, Inghilterra e Russia, il che era un fatto, la cui gravità
fu riconosciuta da Sonnino; questi, infatti, pregò Colosimo di affrettarsi a
gettare le basi di un accordo, sempre per l’Arabia, tra Italia e Inghilterra.
Inoltre, in Tripolitania c’era il problema della rioccupazione di Misurata, cosa da Colosimo ritenuta necessaria, in quanto quella città era divenuta una base di sommergibili e un centro di organizzazione dei Turchi:
rappresentava, quindi, un pericolo politico e militare. Sonnino si mostrò
decisamente favorevole alla rioccupazione di Misurata, perché riteneva che
una tale azione avrebbe fatto, in pieno conflitto mondiale, una buona impressione. Bisognava, però, tentare ogni mezzo per avere consenzienti il
capo di Stato Maggiore e il ministro della Guerra, e perciò Colosimo doveva recarsi al Comando Supremo per parlarne con Cadorna, dicendogli che
non si chiedevano truppe, ma solo il consenso del capo di Stato Maggiore. Se poi anche questo tentativo avesse avuto esito negativo, il Consiglio
dei ministri avrebbe sempre potuto decidere la questione. Subito dopo,
Colosimo parlava della cosa con il presidente del Consiglio, informandolo della posizione favorevole di Sonnino. Chiedeva poi al presidente del
Consiglio il permesso di recarsi in zona di guerra per conferire col capo
di Stato Maggiore e ottenere il consenso. Dopo di che avrebbe parlato col
ministro della Guerra, essendo necessario anche il suo consenso, secondo
la prassi vigente. Boselli si mostrò convinto dell’opportunità di rioccupare
Misurata e diede il suo consenso al colloquio del ministro delle Colonie
col generale Cadorna.
Colosimo espose anche al ministro Morrone la necessità della rioccupazione di Misurata, le ragioni del suo abbandono (Morrone si meravigliava dell’abbandono) e le ragioni della rioccupazione: impedire cioè che
la regione diventasse una provincia turca con bandiera, un’organizzazione
politico-militare turca. Aggiunse che l’unico punto occupato verso la Cirenaica era Homs e che dopo la guerra ci si sarebbe trovati di fronte a gravi
difficoltà per la rioccupazione del territorio abbandonato. Il ministro delle
107
Vanni Clodomiro
Colonie concluse che il generale Ameglio chiedeva qualche aiuto, pur intendendo che di non volere truppe dall’Italia, ma battaglioni irredenti.
Il ministro della Guerra disse di poter dare 3.000 uomini irredenti che
avrebbero fatto domanda e sarebbero diventati volontari. Per il 15 ottobre
1916 sarebbero stati in Italia. Si temeva l’opposizione di Bissolati, ma si
sperava nell’azione di Sonnino.
Intanto, il colonnello Talbot scriveva a Rennel Rodd dicendogli che,
secondo lui, Sajed el Idriss era animato da buone intenzioni e del suo sincero interesse nel portare a buon fine le trattative per la pacificazione della
Cirenaica. Colosimo venne informato da Rodd della lettera e se ne mostrò
compiaciuto, in quanto la considerava un atto di equanimità. Colosimo
riprese il discorso sull’Arabia con l’ambasciatore Rennel Rodd, il quale
manifestò la speranza che la diplomazia avesse la meglio sulle armi e la propensione ad un accordo tra Italia-Inghilterra e Francia, mentre il ministro
delle Colonie era favorevole ad un accordo preventivo tra Italia e Inghilterra, cui far accedere in un momento successivo la Francia. Colosimo ripeté
che l’accordo avrebbe dovuto contenere i seguenti punti: a) luoghi santi in
libere mani musulmane; b) garanzia per l’indipendenza dei capi arabi; c)
obbligo di non occupare l’Arabia e diritto reciproco di opporsi a che una
potenza la occupasse; d) libertà di commercio.
Colosimo era preoccupato della tutela degli interessi italiani, in quanto
era giunta all’orecchio suo e di Sonnino notizia di probabili accordi tra
alcune Potenze, tra le quali l’Inghilterra. Rodd diceva che da un paio di
anni era sul tappeto la questione araba nel suo complesso, la quale non
aveva fatto passi spediti per le soverchie pretese della Francia; ma che erano
a buon punto accordi di massima tra Inghilterra, Francia e Russia per la
sistemazione di tutto il mondo arabo. Egli attendeva una carta dimostrativa con l’indicazione grafica degli accordi proposti e un rapporto illustrativo: l’uno e l’altro avrebbe mostrato al barone Sonnino. Ovviamente, dal
punto di vista del ministro delle Colonie sarebbe stato spiacevole che da
ciò l’Italia fosse messa in posizione difficile, anche se Rodd rassicurava che
quella che l’Italia definiva la questione del mar Rosso sarebbe stata certamente trattata senza dànno per gli interessi italiani. Alle insistenze di Colosimo
su eventuali svantaggi italiani, Rennel Rodd disse che, per quanto poteva
saperne, l’accordo Inghilterra, Francia e Russia per i paesi arabi sarebbe
stato fatto in previsione dello sfacelo della Turchia, regolando in singolar
modo il possesso di Costantinopoli.
108
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
Non è dato intendere bene il «singolar modo», in quanto nel Diario non
c’è spiegazione alcuna della questione, se non una generica affermazione di
buona disposizione dell’Inghilterra nei confronti italiani: si diceva infatti
che, in relazione al Golfo Persico, non si contemplavano, al momento,
occupazioni territoriali, tranne che per le due città di El Tor e Lazzaretto,
che l’Inghilterra aveva interesse a non vedere in mano altrui.
Bisogna qui dire che Colosimo, dal canto suo, si sentiva così preoccupato per gli sviluppi della situazione coloniale italiana, che talora sembrava
non rendersi conto neanche di eccedere nelle richieste e di troppo sollecitare risposte rassicuranti e rapide: e questo spesso non costituiva certo un
vantaggio diplomatico, in quanto, come gli fu anche osservato dagli inglesi, alcune questioni erano di tale delicatezza che richiedevano faticose trattative e lunghe riflessioni da parte di aveva la responsabilità di decidere.
Intanto, nell’immediato, Colosimo continuava ad occuparsi della questione da lui ritenuta molto importante della rioccupazione di Misurata,
per la quale chiedeva un qualsiasi contingente di truppe e di mezzi aerei.
Ai primi di ottobre del 1916, nel corso di un colloquio con Sonnino,
Colosimo riprendeva anche il discorso dell’Arabia comunicando l’intenzione dell’Inghilterra di occupare le città Tor, a nord del mar Rosso, e di
Camaran, sulle coste dello Jemen; da parte sua, mentre Sonnino chiedeva
cosa l’Italia potesse a sua volta occupare, suggeriva che si tentasse con le
isole Farsan.
Il giorno dopo, in Consiglio dei ministri, Sonnino suggeriva a Colosimo di parlare con Bissolati, allo scopo di ottenere gli irredenti prigionieri
dei Russi da arruolare per la Libia.
A proposito della questione araba, Colosimo, sapendo che da due anni
Inghilterra, Francia e Russia trattavano per la sistemazione del reciproco
interesse, se pur non vi fossero già intese, riferiva a Sonnino che sembrava
trattarsi della determinazione della sfera di influenza e del regolamento della questione di Costantinopoli, e per l’Inghilterra anche dell’occupazione
di Tor, nella parte occidentale della penisola del Sinai e di un altro punto
che non gli era stato indicato, forse Cameran. In tali condizioni, per Colosimo, l’Italia non avrebbe dovuto lasciare nulla di intentato per forzare
la mano dell’Inghilterra affinché l’Italia, come potenza sovrana dell’Eritrea
e come potenza sovrana della Libia, con interessi non lievi nel mar Rosso
e nel mondo arabo, non fosse lasciata fuori. Intanto, Colosimo desiderava
che, al più presto, un agente italiano potesse essere inviato a Gedda per fare
109
Vanni Clodomiro
atto di omaggio allo Sceriffo e preparare un servizio di informazioni dai
luoghi santi dell’Hegiaz. Inoltre, pensava anche all’eventualità di un’occupazione italiana delle isole Farsan.
Il 18 novembre Colosimo si recò a far visita al barone Sonnino, per
mostrargli il suo programma coloniale, e per spiegargli la sua posizione
politica in relazione alla condotta italiana nell’ambito della diplomazia internazionale.
Il ministro delle Colonie ricordò al ministro degli Esteri, tra gli altri
colloqui, quello del 9 ottobre, nel quale Sonnino lo aveva pregato di formulare proposte concrete sul programma per la sistemazione dei possedimenti coloniali in Africa.
Colosimo, sapendo che il barone Sonnino aveva già avuto sulla questione stessa contatti con l’on. Martini, che gli aveva presentato in proposito
un dossier, riteneva che l’invito del ministro degli Affari Esteri avesse per
scopo di conoscere se il nuovo ministro delle Colonie mantenesse il punto
di vista del predecessore.
Il ministro fornì a Sonnino uno studio completo sulla situazione italiana in Africa. Sonnino dimostrò compiacimento per il lavoro presentatogli, aggiungendo che la documentazione era ottima, poiché rendeva più
comprensibile e facilitava l’intelligenza dello studio. E poi convenne col
ministro delle Colonie che l’Italia sarebbe stata a posto il giorno che avesse
potuto risolvere la questione etiopica, ma mostrò qualche preoccupazione
che l’Italia potesse entrare in conflitto diplomatico con l’Inghilterra.
Ma il ministero della Guerra propendeva ad utilizzare in Grecia alcuni contingenti italiani dislocati in Libia, contrastando così con l’impostazione che Colosimo aveva dato alla questione coloniale, che egli riteneva
di grande importanza dal punto di vista dei rapporti internazionali, sostenendo pertanto la necessità di non sguarnire la Libia della sua difesa:
una valutazione «semplicista» della situazione italiana era dunque alla base
dell’atteggiamento del ministero della Guerra nei confronti della questione
coloniale, che invece premeva molto a Colosimo. Così, il Consiglio dei
ministri deliberò di non richiamare dalla Libia i 22.000 uomini chiesti dal
ministero della Guerra in nome del Comando Supremo.
Il 1916 si avviava così alla sua conclusione e il nuovo anno si apriva con
la sensazione che la guerra sarebbe stata lunga e difficile.
Infatti, già il 2 gennaio Colosimo presentiva la gravità della situazione
e comunque si convinceva sempre più che la questione della Libia sarebbe
110
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
stata al centro dei problemi della guerra in generale, in quanto il Mediterraneo, infestato da sottomarini, avrebbe finito per portare all’Intesa un
colpo fiero e forse decisivo se non vi si fosse posto rimedio. Ma una siffatta
posizione era destinata a rendere tangibile il dissenso di fondo tra Colosimo e Sonnino, in quanto quest’ultimo non riteneva che il problema della
grande guerra si potesse accentrare sulla questione coloniale. Di tale dissenso diremo più avanti e vedremo quanto abbia pesato sull’azione politica
dell’Italia in seno alla Conferenza di Versailles.
Ma l’obiettivo immediato di Colosimo era quello della rioccupazione
di Misurata, da lui ritenuta un punto nevralgico sotto l’aspetto strategico.
Inoltre, qualche tentativo di ribellione nella Tripolitania impensieriva il
Governo italiano, ma le nostre truppe riuscirono per lo più a mantenere
sempre il controllo della situazione, allontanando il pericolo in particolare
intorno alla zona di Zuara. Intanto, dal punto di vista diplomatico, Colosimo prendeva varie iniziative tendenti a rafforzare i rapporti di amicizia
con l’Inghilterra, specie in relazione ai negoziati con Sajed el Idriss per la
questione dei Senussi. Infatti, le trattative ebbero buon esito, ottenendosi
la pace in una buona fascia litoranea della Cirenaica. Le conseguenze furono soddisfacenti: vi fu la restituzione dei prigionieri italiani, l’apertura
dei mercati di Derna, Bengasi e Tobruk che lentamente ripresero l’attività
precedente, e di conseguenza l’approvvigionamento delle zone interne non
destava più preoccupazioni. Dunque il 1917 si concludeva con un sostanziale successo del ministro Colosimo.
Infatti, vi fu una penetrazione verso l’interno e la ripresa di buone relazioni tra la costa e l’interno stesso. Sajed el Idriss, mantenendo fede ai patti,
arrestò gli ufficiali turchi esistenti in Cirenaica e li avviò verso Cufra, per
consegnarli poi agli Inglesi secondo gli accordi stabiliti appunto verso la
fine dell’anno. In effetti, Sajed el Idriss divenne grande amico dell’Italia in
tutte le vicende successive nei decenni a venire fino praticamente ai giorni
nostri e alla sua deposizione, avvenuta nel settembre del 1969.
Ma le vicende degli anni 1918 e 1919 sarebbero state decisive per le
sorti delle colonie italiane, perlomeno in ordine a quanto si attendeva Colosimo da una futura Conferenza per la pace, che si tenne, come è noto, a
Versailles, dove la delegazione italiana incontrò molte difficoltà, nel senso
che, di fronte alle tre vere grandi Potenze, Stati Uniti, Inghilterra e Francia,
l’Italia rappresentava una specie di cenerentola, costretta, per lo più, ad
assistere alle grandi contese, senza possibilità reali di orientare in qualche
111
Vanni Clodomiro
modo le decisioni di Wilson, Lloyd George e Clemenceau.
Il problema coloniale era strettamente connesso con quello delle rivendicazioni di carattere nazionale e ne subiva, in senso opposto, le oscillazioni. Il presidente del Consiglio dei ministri, Vittorio Emanuele Orlando,
ritenne, a un certo punto, di doversi avvalere della collaborazione costante,
e della presenza fisica, del ministro delle Colonie, Gaspare Colosimo (vice
presidente del Consiglio), nella stessa Francia: fu per quello che gli volle
chiedere di recarsi a Parigi, per affiancare la delegazione. Evidentemente Orlando, dovendo discutere anche di questioni coloniali, non voleva
assumersi la responsabilità di negoziare anche a nome del ministro per le
Colonie. Ma, in quell’occasione, Colosimo rifiutò di spostarsi a Parigi, per
evitare che le divergenze tra il suo modo di vedere le cose e quello della delegazione rischiassero di nuocere alla causa italiana, piuttosto che favorirla.
Per lui, infatti, la questione coloniale era da ritenersi «fondamentale»3 nelle
trattative di pace; ma una siffatta posizione avrebbe potuto indebolire la
compattezza della delegazione e quindi il prestigio dell’Italia, il che Colosimo non volle. Solo se avesse voluto, in un momento successivo, sfruttare
errori politici della delegazione italiana, al fine di accrescere il proprio prestigio personale nelle lotta politica interna, avrebbe potuto pensare, recandosi a Parigi, di sostenere le sue convinzioni. Ma il suo interesse dichiarato
era la migliore riuscita delle trattative italiane, a costo di qualsiasi sacrificio.
E Orlando, ricordando quel frangente politico, ebbe modo, tra l’altro, di
dire che non avrebbe saputo concepire un più alto atto di
nobiltà politica. Intanto, l’episodio mi rende orgoglioso come attestazione di quella
disciplina del mio Gabinetto, fatta di lealtà e di solidarietà, in cui si riassume il carattere di quella forma di Governo. Ma si riafferma pure quel grado eroico di tali virtù
cui… pervenne Gaspare Colosimo. Alieno da ogni aria di presunzione e di sussiego,
egli chiama «le mie ragioni» quelle che erano oneste giuste aspirazioni del Paese; ma
nel tempo stesso avverte la necessità della coordinazione fra le ragioni contingenti del
suo mandato ministeriale e quelle immanenti del Paese, ond’egli difende le sue sino a
quel limite oltre il quale sarebbe compromesso l’equilibrio coi problemi generali. Ed è
mirabilmente generosa la disciplina immediata e quella posteriore, con cui quell’uomo
– cui sarebbe stato pur facile costruirsi in materia coloniale un programma politico
personale e farsene sgabello nel momento delicatissimo che si traversava, per farlo
poi valere in seguito, attribuendosi il merito del suo dissenso, quando la presuntuosa
insolenza o l’ipocrita denigrazione sarebbero imperversate contro l’antico suo capo – si
contentò invece di affidare ad esso le sue ragioni, e con diritta semplicità si proclamò
allora e poi solidale con lui, quali che sarebbero stati i risultati di una partita che si
112
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
presentava così disperata ad essere tratti ad usare l’impossibile pur di vincerla. E così la
vincemmo; perciò solo, che allora non cedemmo4.
Più avanti, Orlando dirà che, se il governo aveva superato momenti
difficilissimi come quello delle trattative di Parigi e quello della ricostruzione interna postbellica, «il merito di averli superati è a lui che soprattutto
spetta»5.
È bene ora dare un’indicazione di quelle che Colosimo, all’atto del suo
insediamento al ministero delle Colonie, riteneva fossero le principali necessità dell’Italia riguardo alla questione coloniale6.
Egli si riprometteva di promuovere e di favorire intensamente un migliore sviluppo della vita delle colonie, in modo che potessero contribuire
col maggiore rendimento possibile ai bisogni della madrepatria. E per questo scopo la direttiva era quella di mettere le colonie in condizioni di chiedere il meno possibile e di dare il più possibile. In particolare, l’Eritrea poté
esportare durante la guerra 12 milioni di scatole di carne in conserva per le
forze armate, pelli per 18 milioni e 50.000 quintali di cloruro di potassio
utile per la fabbricazione di esplosivi7. La Somalia fornì pelli, bovini e cereali. Maggiore fu il contributo chiesto, per la guerra, alla Libia: più di 5.000
libici fornirono manodopera in Italia, e, tornati alle loro famiglie, furono strumento di efficace propaganda della potenza e delle civiltà italiane.
Infine, preoccupazione precisa di Colosimo era quella di preparare le
migliori condizioni possibili per le future trattative di pace. Infatti, l’art. 13
del Patto di Londra dell’aprile 1915, pur facendo riferimento alle possibili
rivendicazioni coloniali italiane, di fatto, come è noto, nulla di concreto
garantiva in proposito: Sonnino, al momento della firma del Patto, non
aveva evidentemente dato soverchia importanza alle colonie, anche se da
quel ministero gli erano pervenuti molti elaborati promemoria. Certamente, Sonnino si preoccupava sopra tutto del Trentino, di Trieste e dell’Adriatico, considerando quella dei confini nazionali una questione essenziale
per l’Italia. E Colosimo di questa situazione era evidentemente impensierito: qui si determinava un sostanziale dissidio di fondo tra il ministro
degli Esteri e quello delle Colonie. Per Colosimo, la questione coloniale
era da considerarsi preminente, e quindi egli cercò subito di preparare, in
quella direzione, condizioni da lui ritenute più favorevoli, tali cioè che
consentissero all’Italia di recuperare più tardi quella posizione contrattuale
che certamente risultava indebolita dopo l’inverno 1914-15, nel corso del
113
Vanni Clodomiro
quale si era perduto, a parte le oasi costiere, il controllo della Libia.
Ad ogni modo, per quanto riguarda le rivendicazioni minime che Colosimo riteneva si potessero avanzare, egli consegnò un promemoria al Re
il 15 gennaio 1918, nel corso di un colloquio. Il ministro sosteneva che le
pretese italiane non avrebbero potuto fondarsi su negoziati secondo il principio del do ut des, perché l’Italia non aveva in Africa territori da scambiare,
nè altri compensi da dare, tranne facilitazioni commerciali e risarcimenti
in denaro. Quello che si poteva pretendere era dunque una condizione
generale di equilibrio, in funzione del contributo dell’Italia alla guerra,
dei possedimenti africani di Francia, Inghilterra e Italia, specie in seguito
alla conquista delle colonie tedesche da parte delle prime due: solo così si
poteva pervenire ad un accordo generale fra le tre Potenze alleate e ristabilire su nuove basi le future relazioni di pace e di alleanza con la Francia
e l’Inghilterra, in Africa come in Europa, evitando finalmente le continue
ragioni, od occasioni, di attriti e conflitti. La situazione poteva così essere
sintetizzata: nell’Africa orientale, l’Etiopia avrebbe dovuto trovarsi nella
sfera esclusiva dell’influenza italiana, così come i porti di Gibuti e Chisimaio; le isole Farsan e Zeila (Seyla) avrebbero dovuto costituire oggetto di
accordo con l’Inghilterra, al fine di estromettere la Francia da tutti i porti
di sbocco dell’Etiopia. Si sarebbe in tal modo ritornati alla situazione del
1891 e del 1894, con l’Italia come potenza dominante in una grande zona
contigua, dall’Eritrea alla Somalia. In più, avendo anche Gibuti a nord
della zona e Chisimaio a sud, e impedendo che Zeila divenisse francese,
l’Italia sarebbe rimasta lo Stato arbitro dell’Etiopia e del suo armamento,
visto che Gibuti era l’unica porta di rifornimento delle armi e delle munizioni per l’Etiopia.
Nell’Africa settentrionale, Colosimo chiedeva, per la Tripolitania, alcune importanti vie carovaniere e la facoltà di istituire consolati e agenzie
commerciali nella zona occupata dalla Francia; per la Cirenaica, il possesso
di Giarabub, in cui si trovavano i luoghi santi del senussismo, e che quindi
era in pratica la culla dei Senussi.
Infine, come programma minimo di riserva, Colosimo chiedeva che
l’Italia ottenesse un impegno dell’Inghilterra a non procedere all’annessione dell’Angola, senza però rinunciare al diritto di opporsi a che una
terza potenza acquistasse o si attribuisse una qualsiasi forma di influenza
in quella colonia8.
Questo è, in sintesi, quanto Colosimo chiedeva come programma mi114
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
nimo nella prospettiva delle trattative con le altre Potenze: si tratta, evidentemente, di un programma, la cui realizzazione avrebbe dato un notevole
prestigio all’Italia, e che tuttavia era considerato minimo dal ministro delle
Colonie, il quale ci sembra chiaro che incorresse nell’errore opposto a quello commesso da Sonnino in occasione del Patto di Londra. E Orlando, come presidente del Consiglio, dovette sempre destreggiarsi alla meno peggio
tra le pressioni – dirette o indirette – dell’uno e dell’altro ministro.
Ma qui la questione era molto meno semplice e schematica di quanto
non apparisse a prima vista. Secondo Colosimo, la questione coloniale
assumeva due aspetti: l’uno «particolarista, nei riguardi soltanto italiani»,
e l’altro internazionale, che si rifletteva, ovviamente, sull’aspetto «particolarista». Egli, preoccupato come era delle possibilità di sviluppo del futuro
assetto coloniale, si domandava se avrebbe prevalso la corrente dell’Intesa
o quella degli Imperi centrali. Ma non è tutto. Altri interrogativi erano
presenti nella sua mente: ad esempio, quale valore avrebbero avuto le deliberazioni prese dal Labour Party, il programma delineato dal generale
Smuts9, i provvedimenti recentemente adottati riguardo all’Albania? e il
ministro si rammaricava di ignorare le risposte. Urgeva sapere. Bisognava «non trovarsi impreparati». Una qualche organizzazione di spionaggio,
dall’una e dall’altra parte, non avrebbe dovuto sfuggire all’Italia. La Francia
si agitava per la Siria, l’Inghilterra per la Mesopotamia, e l’America sosteneva il Sionismo politico e quindi nazionale. Le ripercussioni che tutto
ciò avrebbe avuto nel mondo arabo avrebbero toccato gli interessi italiani;
quindi, era necessario seguire un siffatto movimento diplomatico. Il centro
era la Svizzera: colà convergevano «apostoli ed agitatori in buona fede –
emissari e propagandisti a spese di Stati interessati». E a quel punto Colosimo poneva, con buon intuito, l’accento sul sorgente panturanismo, che,
se era sembrato un sogno sotto l’aspetto religioso, si andava concretamente
formando sotto l’aspetto etnico-politico, appoggiato dalla Germania, la
quale tentava così di contrastare gli interessi dell’Intesa, vólti a smembrare
l’impero ottomano. In effetti, di lì ad otto mesi, dopo l’armistizio di Mudros, del 30 ottobre 1918, si sarebbe manifestata la reazione – impersonata
poi da Kemal Atatürk – alle tendenze russo–inglesi.
Colosimo, capo di un ministero che comportava per necessità di cose
una certa attitudine ai rapporti con le Potenze straniere, era, al contrario,
poco incline ad occuparsi di diplomazia: riteneva conveniente, piuttosto,
guardare da vicino agli interessi esclusivi dell’Italia e agli eventuali benefici
115
Vanni Clodomiro
che ad essa sarebbero potuti derivare dall’assetto delle sue colonie, alle sue
aspirazioni e alla «pace coloniale». Egli suggeriva di creare agenti segreti,
informatori in Russia, Svizzera e Inghilterra, specie nella Svizzera, da lui
ritenuta un «campo aperto a tutte le trattative, a tutti gl’intrighi, a tutti i
convegni, a tutte le tendenze»10.
Ma il nostro governo era sostanzialmente impreparato a seguire tutti
quei movimenti. E in seno alla Conferenza, le difficoltà dell’Italia erano
dovute sopra tutto al punto 9 dei «14» di Wilson. Infatti, esso prevedeva
che il problema dell’Adriatico venisse risolto, tenendo conto della «linea
chiaramente riconoscibile tra le nazionalità»: venivano così «annullate le
rivendicazioni italiane»11 sulle regioni di popolazione tedesca, nel Tirolo
meridionale, e di popolazione slava. In più, nell’Istria e nella Dalmazia
quel principio era letteralmente inapplicabile, perché colà le popolazioni
di lingua italiana non costituivano che dei nuclei. Nasceva, in effetti, un
caso esemplare di controversia. E Orlando era svantaggiato, in certo modo,
dal fatto che le decisioni dovevano essere prese soltanto da quattro persone.
Wilson, Lloyd George, Clemenceau e Orlando trattavano solo in presenza
di un segretario e di un interprete. I Paesi veramente grandi erano gli Stati
Uniti, l’Inghilterra e la Francia: l’Italia era una specie di cenerentola, e,
non essendo presenti altre rappresentanze di Stati che avrebbero potuto in
qualche modo esserle di aiuto, l’isolamento di Orlando era un fatto insito
nelle cose stesse. È per questo, crediamo, che il rappresentante italiano
intervenisse poco, nelle questioni che non interessavano direttamente l’Italia, consentendo anche un maggiore spicco alla personalità dei tre grandi.
D’altra parte, Orlando nutriva una certa preocccupazione per la situazione
interna italiana, della quale comunque Colosimo gli comunicava con grande scrupolo e tempestività i problemi. Questi mantenne sempre col suo
presidente un rapporto di grande rispetto e di collaborazione strettissima,
a testimonianza di un concetto altamente etico dello Stato e del compito
dello statista, inteso piuttosto come un preciso dovere e un servizio da
rendere alla nazione.
Alcune lettere e telegrammi inviati da Colosimo ad Orlando provano la
grande preoccupazione del vice presidente per taluni risvolti della politica
coloniale, che, a suo modo di vedere, aveva una vitale importanza «nell’attuale politica di guerra e nella preparazione della pace come origine ed
epilogo del presente conflitto mondiale»12.
Ovviamente le preoccupazioni per le questioni coloniali erano premi116
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
nenti nella mente di Colosimo al punto che, dopo soli quattro giorni,
riscriveva al «carissimo amico», intrattenendolo ancora, «in confidente intimità» su tali problemi, «trattandosi di argomento che rientra nell’azione
organica del capo del Governo»13.
Entrando nel vivo della questione, Colosimo sottolineava la situazione
coloniale, quale si presentava ai suoi occhi: l’Eritrea aveva «contatti», verso
il Sudan, con l’Inghilterra; a sud, verso il protettorato della costa somala
di Obock-Gibuti, con la Francia; ad est, direttamente con l’Arabia. La
Somalia italiana meridionale e settentrionale aveva «contatti» ad ovest, a
nord e a nord ovest, verso il Giubaland, il Somaliland e il possedimento di
Aden, con l’Inghilterra. L’Eritrea e la Somalia italiana si trovavano ad essere
congiunte «in un tutto politico-economico» all’Etiopia. Dunque, le due
colonie italiane erano «legate» alla questione etiopica, che era «di natura
internazionale», essendo regolata dalla convenzione italo-franco-britannica
di Londra del 13 dicembre 1906, che garantiva l’integrità dell’Abissinia e
i reciproci interessi delle tre potenze in quell’impero. La Tripolitania aveva
«virtualmente contatti» a ovest e a sud, verso la Tunisia, le oasi e il Sahara,
con la Francia. La Cirenaica aveva «virtualmente contatti» a sud, verso il
Sahara, con la Francia, e ad est e a sud, verso l’Egitto e il Sudan anglo-egiziano, con l’Inghilterra. Senonché, la Tripolitania e la Cirenaica facevano
parte del «sistema mediterraneo», e l’Italia era «legata» alle due alleate da
convenzioni «generali e speciali». Colosimo concludeva che, in ultima analisi, la questione della Libia rivestiva, per l’Italia, un’importanza di carattere internazionale. Infatti, lo sviluppo economico e la stessa sicurezza delle
colonie erano legati all’azione internazionale «come causa ad effetto».
Una lunga serie di accordi, segreti e non – stabiliti nel 1906, nel 191617, nel 1917 –, legavano, in effetti, le tre potenze ad una comune direttrice
politico-economica, di cui risultato non ultimo era la situazione sostanzialmente positiva creatasi in Cirenaica. L’Italia era firmataria dell’Atto
generale di Berlino del 28 febbraio 1885 e dell’Atto generale di Bruxelles
del 2 luglio 1890; il primo, relativo alla libertà di commercio, alla libera
navigazione del Congo e del Niger, alla tratta degli schiavi e allo sviluppo
della civiltà in Africa; il secondo, relativo alla tratta degli schiavi e al traffico delle armi e delle bevande alcooliche in Africa: tutti e due investivano,
di fatto, la questione coloniale africana. E di questo Colosimo era perfettamente consapevole. Si trattava, è vero, di due atti «ormai decrepiti», ma la
valutazione che ne davano le potenze in conflitto era diversamente orienta117
Vanni Clodomiro
ta (come d’altra parte era ovvio): la Germania avrebbe voluto farli rivivere,
mutatis mutandis, estendendoli a tutta l’Africa, mentre l’Inghilterra e la
Francia avrebbero voluto modificarli limitandone l’efficacia. Per Colosimo, i due atti rivestivano «grande interesse sebbene di diversa natura»: in
senso negativo (per quanto riguardava l’Atto di Berlino), per i vantaggi che
l’Italia avrebbe potuto ottenere, in caso di eventuali sue rinuncie; in senso positivo (per quanto riguardava l’Atto di Bruxelles), perché l’eventuale
proibizione del commercio delle armi avrebbe costituito un vantaggio italiano in Eritrea e in Somalia. E Colosimo pensava ad una modificazione
dei due Atti solo nella prospettiva di un nuovo assetto africano.
A questo punto, Colosimo, forse, non riusciva ad uscire dal suo ruolo
di ministro delle Colonie, e si abbandonava ad un giudizio, che ci sembra
quanto meno affrettato, sostenendo che la Germania aveva
impostato i suoi scopi di guerra e di pace sulla questione coloniale in relazione specialmente sulle sue colonie perdute, facendone una questione di equilibrio africano e
una conditio sine qua non di esistenza economica per la pace, per ottenere, insieme con
la libertà dei mari, la propria indipendenza economica mediante la disponibilità delle
materie prime in territori di suo diretto dominio14.
Senonché, è ormai noto che le potenze europee – e quindi anche la
Germania – si trovarono, a un certo punto, di fronte ad un groviglio di
fatti e di circostanze, da cui era difficile districarsi: quasi una ineluttabilità
storica, cui l’Europa era pervenuta, probabilmente, a seguito del consolidarsi, tra il 1908 e il 1909, della Triplice Intesa come fatto politico concreto. Fu questo, evidentemente, che dette una certa sensazione di sicurezza
agli alleati, i quali, prima di allora, non potevano certamente pensare ad
una guerra contro gli Imperi centrali, generalmente autori, dopo il 1866,
di una politica di reciproca solidarietà. La Germania ebbe una larga parte
di responsabilità nello scoppio della guerra, questo è indubbio (anche se tale problema suscitò non poche polemiche, specie – come è ovvio – di parte
tedesca, tendenti a scagionare la Germania), ma i motivi che la immisero
su quel piano inclinato sono molteplici, e comunque non riconducibili ad
una formula unica e liquidatoria.
Colosimo, forse perché, in fondo, non riuscì mai a «sprovincializzare»
i suoi orizzonti politici, in quell’occasione, ci sembra dimostrasse una non
del tutto chiara visione della complessa situazione politica internazionale,
118
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
credendo di poterla interpretare quasi esclusivamente alla luce, ripetiamo,
della propria specifica esperienza ministeriale. Pertanto, egli credette di
individuare il problema centrale dei rapporti diplomatici internazionali
nella questione coloniale.
Considerando l’interesse internazionale della questione coloniale italiana, e considerando «gli scopi di guerra della Germania in relazione al problema coloniale», Colosimo riteneva che il fronte unico tra Italia e Alleati
nella guerra conferisse all’Italia stessa il diritto di trattare e «regolare» con
essi il futuro assetto coloniale. In conclusione, essendo l’assetto coloniale
italiano dell’Africa orientale (Eritrea e Somalia) e dell’Africa mediterranea
(Tripolitania e Cirenaica) una questione non solo coloniale ma «principalmente internazionale», essa costituiva un problema da preparare durante il
conflitto, e da risolvere, al momento della pace, in simultaneità con tutti
gli altri di carattere e interesse nazionale. Riguardo all’Italia, quindi, il problema dell’assetto coloniale era visto come l’unico punto di partenza, dal
quale svolgere una «proficua azione nelle nuove alleanze senza assistere in
Affrica alla distruzione di ciò che ci sarà edificato in Europa»15.
Se ciò era vero in linea generale e pregiudiziale, secondo Colosimo non
poteva e non doveva non tenersi conto della questione coloniale come causa fondamentale e conclusione della guerra. Ché se poi si volesse considerare sotto tale unico aspetto, il problema dell’assetto coloniale italiano sarebbe rientrato per necessità di cose nella politica di guerra e nelle transazioni
di pace, visto che ai sacrifici comuni avrebbe dovuto corrispondere una
soluzione comune in Europa e in Africa. La posizione italiana nell’Africa
doveva pertanto esser fatta valere nel gioco degli interessi internazionali
dalla diplomazia italiana, se si aveva la reale coscienza del suo valore
come fattore di equilibrio per reciproci vantaggi fra alleati in relazione anche a tutte le
altre questioni europee ed asiatiche allo scopo di ottenere un assetto razionale dei nostri
programmi affricani secondo il ben noto programma, in verità, molto modesto […]16
che Colosimo aveva comunicato ad Orlando e a Sonnino. La fermezza
della posizione di Colosimo nei confronti della questione in generale, della
delegazione italiana alla Conferenza della Pace e del Governo stesso è testimoniata dal tono di queste sue parole conclusive:
Come vedi, la sintesi che precede stringe nella morsa di un sillogismo inesorabile, nella
attuale politica di guerra e nella previsione di negoziati di pace, l’azione di governo
119
Vanni Clodomiro
nella questione coloniale italiana che si compenetra nella organica questione internazionale per la tutela degli interessi dell’Italia17.
Si vede bene, a questo punto, che Colosimo non si stancava di predicare l’assoluta necessità – come sottolinea chiaramente Mario Toscano
– di pervenire ad accordi preliminari con Francia e Inghilterra, prima che
queste dessero il via a trattative autonome bilaterali. Il «grido d’allarme»18
di Colosimo aveva, in effetti, un reale fondamento, come poi i fatti dimostrarono. Queste preoccupazioni egli manifestava ancor prima che le
vicende della guerra prendessero quella piega favorevole agli Alleati che
si ebbe nella seconda metà del luglio 1918. Colosimo seguiva con scrupolosa precisione tutti i movimenti diplomatici e di propaganda che gli
altri Paesi creavano – praticamente ignorando le esigenze e gli interessi
italiani – riguardo alla sistemazione futura delle colonie. Sonnino, di fatto,
sottovalutò tali movimenti, nonostante gli avvertimenti e le pressioni che
gli venivano dal nostro ministro delle Colonie. D’altra parte, non solo il
ministero delle Colonie italiano era preoccupato del destino delle sue colonie africane: ad esempio, anche in Germania, all’inizio di ottobre – cioè
appena un mese prima dell’armistizio di Compiègne, che avrebbe sancito
il crollo definitivo dell’Impero tedesco – il ministro degli Esteri Wilhelm
Solf si preoccupava, quasi a dispetto della difficile sintuazione interna del
suo Paese, di puntualizzare e rivendicare i diritti della Germania in politica
estera, e in particolare delle colonie africane. E Colosimo ne dava tempestiva notizia ad Orlando, che si trovava a Parigi, il 9 ottobre. La «Depêche
Coloniale et Maritime» del 4 ottobre aveva pubblicato una corrispondenza
da Amsterdam, dove Solf aveva appunto tenuto una conferenza sulla guerra e le colonie il primo ottobre, a cui aveva assistito il re di Baviera:
Il Ministro Solf, secondo la «Gazzetta popolare di Colonia», ha detto che recuperare
le colonie è compito d’importanza nazionale per le materie prime che hanno e che
occorrono alle industrie tedesche.
Senza le colonie la Germania si troverebbe in uno stato di dipendenza dagli altri Stati
e alla discrezione dei paesi esteri. I trattati commerciali non offrono garanzie, l’eguaglianza di trattamento nelle colonie francesi non esisteva che sulla carta. Il governo
imperiale mantiene ferma […]19.
Il telegramma, la cui parte finale sembra irreperibile, rimane così interrotto. Tuttavia, crediamo di poterne ugualmente ricostruire la conclusione:
120
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
infatti esso ricalca, in pratica, l’articolo che Colosimo riferiva ad Orlando.
Per comodità di lettura e completezza di documentazione, riportiamo integralmente tale articolo da noi tradotto:
Amsterdam. Solf ha tenuto, martedì, a Monaco, una conferenza sulla guerra e le colonie. Il Re di Baviera assisteva a questa conferenza.
Secondo la «Gazzetta popolare di Colonia», il ministro ha detto: «Recuperare le nostre
colonie è compito di importanza nazionale che non può essere nascosto da nessun altro. Prima della guerra, i paesi tropicali e sotto-tropicali fornivano il 50% delle materie
prime da cui dipendevano le nostre industrie. Gli attuali surrogati non possono essere
sufficienti in tempi di pace. Senza colonie, dovremo rimanere in una condizione di
dipendenza e alla discrezione dei paesi stranieri. Quando scoppiò la guerra, le nostre
colonie facevano buoni progressi: noi eravamo in grado di resistere all’assalto del monopolio degli altri Stati. I trattati commerciali non offrono garanzie; nelle colonie francesi, la parità di trattamento non esisteva che sulla carta.Il governo imperiale mantiene
ferma la sua richiesta: il ritorno delle colonie africane e di quelle dei mari meridionali
esige, inoltre, una nuova ripartizione dell’Africa, tale da consolidare i nostri possedimenti sparsi. Il Belgio, il Portogallo e la Francia possiedono grandi ed eccessive distese
territoriali. Noi non pretendiamo la parte del leone»20.
Ad ogni modo, ci sembra che le indicazioni e le preoccupazioni di Colosimo per l’assetto coloniale, gli intrighi internazionali, le garanzie e la propaganda, che altrove veniva svolta in quella direzione, dovettero sortire un
certo effetto nell’animo di Vittorio Emanuele Orlando, se si considera che il
giorno prima che Colosimo spedisse il telegramma sopra riportato un altro
gliene era giunto dallo stesso Orlando, nel quale, tra le altre cose, si diceva:
siamo […] in attesa delle comunicazioni di Wilson. Durante questa attesa bisogna tenere fermo in quelle direttive e cioè che un armistizio non è la pace ma un avviamento
alla pace a condizione che si abbiano le giuste garanzie .
Una attitudine impulsiva farebbe perdere tutti i vantaggi e comprometterebbe la stessa
pace facendo il gioco del nemico.
Bisogna mobilizzare tutte le forze della propaganda in tutti i sensi per persuadere di ciò
[…]21.
Naturale quindi che Colosimo insistesse e che non si lasciasse sfuggire
l’occasione di sottolineare l’importanza che per lui rivestiva la conferenza di
Solf. Tuttavia, abbiamo motivo di ritenere che le garanzie e la mobilitazione di tutte le forze della propaganda di cui Orlando si preoccupava fossero
riferite piuttosto al generale assetto dell’Italia, relativo alla frontiera orien121
Vanni Clodomiro
tale e alla questione adriatica, e – in quel particolare momento – all’ordine
interno del Paese, che non alla questione coloniale: infatti, a Parigi, gli era
giunta l’eco di varie manifestazioni pacifiste. Si spiega meglio, così, il fatto
che la parola pace compaia più volte nel testo del telegramma, mentre alle
colonie non si fa alcun cenno.
Orlando teneva di più all’amicizia della Jugoslavia che non alla Dalmazia, che era quasi l’ossessione di Sonnino, o alle colonie, che erano la
preoccupazione di Colosimo: infatti, Orlando – come Bissolati e anche
Diaz – potendo, avrebbe forse barattato volentieri la Dalmazia con Fiume,
perché, evidentemente, ben comprendeva i vantaggi di eventuali buoni
rapporti con gli Jugoslavi. Sonnino, invece, rimaneva evidentemente fermo nella convinzione che lo aveva animato al momento della firma del
Patto di Londra, e cioè che la Dalmazia avrebbe, come l’Alto Adige, l’Istria
interna e l’Albania, costituito, per così dire, una garanzia contro il pericolo
di un’eventuale riscossa austriaca nei confronti dell’Italia. Non pensò – o
non volle pensare – : 1) che la monarchia austriaca non sarebbe sopravvissuta ad una sconfitta; 2) che dalle sue rovine sarebbero sorte le varie
nazionalità a reclamare la propria indipendenza; 3) che il pericolo reale
sarebbe stata l’ostilità degli Slavi e degli Albanesi, rispetto ai quali l’Italia
si preparava ad assumere quello stesso ruolo di tiranno che l’Austria aveva
esercitato nei confronti degli italiani; 4) che se, al contrario, l’Italia avesse
puntato risolutamente sulla distruzione dell’Impero asburgico e sulla liberazione dei popoli oppressi, si sarebbe posta come la naturale alleata di
questi ultimi, aggiudicandosi così automaticamente una preziosa influenza politica ed economica oltre Adriatico; 5) che la sua ostinata posizione
avrebbe avuto – come poi ebbe – conseguenze gravissime per l’Italia, vale
a dire l’accendersi di una fortissima opposizione da parte dell’America,
dell’Inghilterra e della Francia, un dannoso contraso con gli Slavi, infine
l’effetto di collocare l’Italia fuori del problema delle colonie ex tedesche,
economicamente molto più importanti del territorio dalmata. Ma la sua
convinzione – e in questo si trovava in pieno accordo con la Marina – rimaneva quella secondo cui il «preminente interesse italiano era quello di
assicurarsi le basi navali dalmate»22.
Intanto, la Turchia, in seguito alle sconfitte militari subíte nel mese
di settembre, si era risolta a chiedere la pace, insieme con la Germania, al
presidente degli Stati Uniti il 30 di quello stesso mese. Ma il fallimento di
tale richiesta, l’aveva evidentemente spinta ad altre azioni diplomatiche,
122
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
concretizzatesi in una nuova richiesta di armistizio ed apertura di negoziati
alla Francia e all’Inghilterra e non all’Italia. Colosimo, avendo raccolto tali
notizie dai giornali, riteneva – nella convinzione che gli Alleati non avrebbero mai acconsentito a trattare con la Turchia se non unitamente all’Italia
– che quella mossa della Turchia avrebbe legittimato la richiesta italiana di
garanzia per l’esecuzione delle «clausole armistizio relative alla Libia» e di
qualche attribuzione territoriale nelle coste dell’Anatolia «in località che
non sia Adalia».
Al momento della stipula del Patto di Londra, «nessuna decisione definitiva avevano adottato le Potenze dell’Intesa circa la sorte della Turchia»23,
anche se, fin dal 4 marzo del 1915, era stata data alla Russia la garanzia del
possesso di Costantinopoli e degli Stretti: tali accordi vennero confermati
fra le tre potenze nell’estate del 1915, nel marzo 1916 e nuovamente il 6
marzo 1917, sempre all’insaputa dell’Italia. E Sonnino, venuto poi a conoscenza di tali accordi, riuscì – in occasione del convegno interalleato di
Saint-Jean-de-Maurienne del 19 aprile 1917 – soltanto ad ottenere, in linea di massima, la regione dell’Adalia, anche se tale accordo «restava subordinato all’approvazione della Russia»24. Ora, a noi sembra che, proprio nel
rifiuto da parte di Colosimo delle aspirazioni su quel particolare territorio
che costituiva l’unico elemento di novità strappato da Sonnino rispetto
al Patto di Londra, si possa scorgere un ulteriore segno del dissidio tra il
ministro delle Colonie e il ministro degli Esteri. D’altra parte, se noi leggiamo l’art. 9 del Patto di Londra, ci rendiamo come Sonnino, nelle varie
trattative con gli Alleati, poco o nulla badasse alle colonie, dal momento
che la vaga promessa dell’Adalia dell’aprile 1917 costituiva, in effetti, un
semplice mutamento rispetto all’art.9; un mutamento che, tra l’altro, non
interessava l’Italia, che aveva – come abbiamo detto più sopra – già altri
interessi nelle terre adiacenti all’Adalia:
Art.9. In una maniera generale, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia riconoscono
che l’Italia è interessata al mantenimento dell’equilibrio nel Mediterraneo e che essa
dovrà, in caso di spartizione totale o parziale della Turchia d’Asia, ottenere una parte
equa nella regione mediterranea finitima alla provincia di Adalia ove l’Italia ha già
acquisito diritti e interessi che hanno formato l’oggetto di una convenzione italo–
britannica.
[…] Gli interessi dell’Italia saranno ugualmente presi in considerazione nel caso che
l’integrità territoriale dell’Impero ottomano fosse mantenuta e delle modifiche venissero fatte alle zone d’interesse delle Potenze […]25.
123
Vanni Clodomiro
Sembra insomma che ci sia una certa fluidità nella posizione di Sonnino circa gli obiettivi coloniali di reale interesse per l’Italia.
E divergenze tra Sonnino e Colosimo emergevano ancora, quando
quest’ultimo suggeriva ad Orlando di inserire, nelle condizioni di armistizio con l’Austria, che il suo esercito fosse ripartito «secondo proprie nazionalità perdendo così essenza di organismo»26: il che avrebbe permesso
all’Italia di aggiudicarsi, come dicevamo più sopra, una certa influenza
politica oltre Adriatico. Per quanto riguarda in particolare la questione
dell’Asia Minore, il progetto preciso di Colosimo era rivolto all’acquisizione del bacino carbonifero di Eraclea, progetto suggeritogli in precedenza
dal comm. Volpi27 come una prospettiva di concreta utilità per le industrie
italiane. Era chiaro, quindi, che l’Adalia non rientrasse nelle mire del ministro28.
In sostanza, crediamo che Sonnino e Colosimo testimoniassero la presenza, in seno al gabinetto Orlando, di due diverse anime, manifestatesi
fin dal novembre 1914, come sottolinea Pastorelli29, e originatesi, a nostro
avviso, nel corso degli anni 1913 e 1914. Infatti, la corrente colonialistica,
che aveva predominato in epoca postrisorgimentale, si indeboliva proprio
in quegli anni, quando invece si affermavano tendenze anticolonialistiche e si dava, conseguentemente, nuovo vigore all’irredentismo30. Sonnino – conservatore saldo e convinto e sostenitore agguerrito dell’istituto
monarchico sabuado – si sentiva evidentemente vicino all’irredentismo,
mentre Colosimo, come ministro delle colonie, non poteva trovarsi sulle
stesse posizioni, anche perché, come abbiamo accennato più sopra, la sua
adesione alla monarchia non era profonda, ma dovuta a ragioni diverse,
che, non rientrando nel campo dell’ideologia politica in senso stretto, appartenevano piuttosto alla sfera delle riflessioni personali sul complesso
delle proprie esperienze.
Delle due anime presenti in seno al Consiglio dei ministri, ci dà un’immagine non diciamo esaustiva, ma comunque abbastanza definita, lo stesso Colosimo, il quale riporta negli appunti del suo Diario, un dettagliato
resoconto delle riunioni del Consiglio dei ministri del 15 e 16 dicembre
1918, che getta luce su taluni particolari.
In effetti, circa la condotta da seguire in seno alla Conferenza della
Pace, le idee del Governo non erano ancora chiare: un programma ben
delineato non era stato ancora concordato, e proprio quelle riunioni avrebbero dovuto stabilire una precisa linea da assumere e mantenere. Il primo
124
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
intervento di rilievo fu quello di Leonida Bissolati, che impegnò in pratica
tutta la seduta del Consiglio del 15 dicembre. Le conclusioni del ministro
per l’Assistenza Militare – il quale dichiarò che all’Italia sarebbe bastato il
possesso di Trieste, di Fiume e delle isole Curzolari, e magari l’autonomia
di centri principali come Zara o Fiume (forse il termine “Fiume” di prima
è stato un lapsus calami e sta per “Pola”), e che si sarebbe dovuto rinunciare
alle aspirazioni sul Tirolo, sulla Dalmazia e sul Dodecanneso – sono ben
note31. Ma a noi interessa aggiungere quelle che Bissolati adduceva come
motivazioni della propria posizione: prima di concludere il suo intervento,
egli aveva detto che il Tirolo tedesco sarebbe stato un elemento «dissolvitore ai nostri fini nazionali»; che la Dalmazia era tutta slava, con appena un
quarto o un quinto di italiani; infine, che il Dodecanneso, «composto da
popolazioni greche» aspirava giustamente a
congiungersi alla madre Patria. […] Siamo dichiarati imperialisti e nel fatto ci si potrebbe accusare di aver pestato i piedi ai tedeschi nel Tirolo, agli slavi nella Dalmazia
ed ai latini nel Dodecanneso.
Bisogna ispirarsi a Wilson […]32.
Un tale pensiero non sembrava invece preoccupare Sonnino, il che testimonia la maggiore sensibilità di Bissolati nel considerare le esigenze di
nazionalità delle altre popolazioni e, in definitiva, la diversità delle loro
rispettive posizioni.
Lo scambio di idee iniziato nella mattinata del 15 proseguì nel pomeriggio del giorno successivo, quando, alle 16, si riunì nuovamente il
Consiglio. E in quell’occasione, le carte dei vari ministri furono messe sul
tavolo e apertamente confrontate. Sugli elementi di novità che emergono
dagli appunti di Colosimo, rimandiamo senz’altro il lettore al citato saggio
di Pastorelli, che illustra con chiarezza e precisione tali elementi: dalla soluzione indicata da Bissolati, al netto dissenso di Nitti – il quale desiderava
chiaramente far parte della delegazione italiana a Parigi – con Sonnino,
alle dimissioni di Bissolati, alla conferma dei forti dubbi sull’attendibilità
di Cadorna «circa la sua totale estraneità all’elaborazione del patto di Londra»33, alle dichiarazioni conclusive del presidente Orlando, che chiarisce
le ragioni dell’isolamento di Bissolati e Nitti in seno al Consiglio:
nella linea di condotta da seguire alla Conferenza della Pace non può adoperarsi che
un processo empirico. Niente di prestabilito. A quanto chiedono Nitti e Bissolati,
125
Vanni Clodomiro
bisogna affermare che presentarsi con un programma aprioristico di rinunzie, sarebbe
delittuoso.
Noi ci troviamo di fronte a 3 scogli: gli alleati, Wilson ed i jugoslavi; la manovra,
quindi, è pericolosa e delicata.
Il patto di Londra fu un compromesso. Di esso dovremo salvare quanto necessita alla
Patria con gli opportuni accomodamenti e le necessarie transazioni34.
Era quindi una questione di metodo nelle trattative. Tuttavia, non possiamo fare a meno di considerare che Orlando si appoggiava, per così dire,
al nazionalismo per timore del bolscevismo, cosa che in seguito Bissolati
avrebbe dovuto rivelare con chiarezza e che invece non fece35.
Alcune rinunzie, dunque, si sarebbero certamente fatte, a patto però
che ciò non avvenisse aprioristicamente. Ma per noi, in questa sede, è importante porre in rilievo lo sforzo di Colosimo di inserire la questione
coloniale nella politica generale del governo. Per questo, rimandiamo direttamente alle pagine del Diario.
Non possiamo fare a meno, a questo punto, di intravvedere, nell’ultima
parte dell’intervento di Colosimo, una sia pure larvata anticipazione concettuale di quella che poi sarà la parte finale della conclusione di Orlando:
infatti, sia le conclusioni di Colosimo, prima, che quelle di Orlando, dopo,
contengono un esplicito richiamo al patto di Londra, così come ambedue
esprimono concetti non del tutto dissimili quando parlano delle necessità
dell’Italia. A nostro avviso, ciò significa che Orlando, in qualche modo,
avrebbe voluto manifestare il proprio accordo con Colosimo e che Colosimo avrebbe, forse, aderito volentieri alle posizioni di Nitti e Bissolati se, sia
Colosimo che Orlando, non si fossero resi conto, alla fine della riunione,
che i due erano ormai isolati e che appoggiare le loro tesi avrebbe potuto
in qualche modo mettere in pericolo la sopravvivenza stessa del governo.
D’altra parte, quando Colosimo, in apertura di Consiglio, affermava la
priorità della questione coloniale nella considerazione degli interessi generali dell’Italia, concedeva certamente spazio alle prevedibili richieste dei
due e si collocava, per così dire, in una posizione strategica di attesa degli
imminenti sviluppi del dibattito, salvo poi a riprendere la parola, o a non
riprenderla, a seconda della piega che le cose avrebbero preso. Inoltre, si
consideri che Nitti, come anche Colosimo, aveva parlato del «…bisogno
di materie prime, di bacini carboniferi etc. che potremmo più facilmente
ottenere liberandoci del fardello imperialistico»36.
126
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
Evidentemente, anche Nitti sapeva che le mire di Colosimo riguardo
all’art. 9 del patto di Londra erano dirette al bacino carbonifero di Eraclea,
e non all’Adalia, che invece Sonnino aveva cercato di garantirsi con gli
accordi di Saint-Jean-de-Maurienne.
Dunque, nella sostanza, neanche in quelle occasioni a Colosimo riuscì
di far concretamente inserire la questione delle colonie nel generale contesto della politica estera italiana. Anzi, Pastorelli sottolinea in proposito
che quell’inserimento, «nonostante gli sforzi di Colosimo, non si è mai
realizzato»37. Tuttavia, ciò non vuol dire che nessuna delle soluzioni coloniali proposte da Colosimo andò mai in porto, anche se questo avvenne
quando lui non era più ministro: tra il dicembre del 1919 e l’estate del
1925, l’Inghilterra condusse trattative e stipulò accordi con l’Italia, che
tennero conto proprio delle nostre richieste all’Inghilterra fatte nel 1919,
e che portarono all’acquisto di taluni dei territori che Colosimo aveva indicato nel suo programma minimo, quali, ad esempio, il Giubaland, che
l’Italia ottenne col trattato del 15 luglio 1924, firmato dall’ambasciatore
italiano marchese Della Torretta e dal primo ministro inglese Mac Donald
e ratificato alla Camera dei Comuni nel febbraio del 192538.
Ad ogni modo, quelle riunioni di Consiglio dei ministri, con le conseguenti dimissioni di Bissolati il 27 dicembre e di Nitti nel gennaio successivo, indebolirono certamente la posizione e, per così dire, il potere
contrattuale della delegazione italiana alla Conferenza di Parigi, perché,
chi aveva interesse di farlo, insinuò che quella delegazione rappresentava
soltanto una parte dell’opinione pubblica italiana, se non addirittura una
minoranza.
Col 1919, nuove speranze – in attesa della «dura lotta del Congresso di
Versailles»39 – si aprivano nell’animo di Colosimo, che però diceva nel contempo di provare soddisfazione nel vedere «l’Italia compiuta, come la sognarono i suoi martiri e i suoi pensatori»40. D’altra parte, anche Orlando,
nei brevi soggiorni romani, dava, ai ministri che gliele domandavano, notizie improntate all’ottimismo sui rapporti con Wilson e con Lloyd George, pur soffrendo per la durezza mostrata proprio da Clemenceau, che rappresentava la nazione alla quale l’Italia si sentiva maggiormente legata da
affinità di sentimenti. Insomma, Orlando – e non solo lui – sembrava
fiducioso circa il buon esito finale delle trattative. Ma un telegramma diretto da Colosimo a Sonnino il 29 gennaio 1919 – e comunicato anche ad
Orlando – mostrava come l’atmosfera fosse ben presto mutata:
127
Vanni Clodomiro
è chiaro che siamo stati sorpresi, e che una intesa era già corsa fra Inghilterra e Francia
per l’assegnazione delle Colonie già tedesche.
La opinione pubblica finora sonnecchiante sulle quistioni coloniali comincia ad appassionarsi e segue con ansia le vicende delle trattative e bisogna tenere in conto lo
spirito da cui è animata. Spedirò a V.E. i voti del Convegno Nazionale Coloniale
tenutosi nei giorni scorsi a Roma con molta solennità in Campidoglio e che ha avuto
molta eco, perché credo possa servire a V.E. ed agli altri delegati come elemento di
forza nei negoziati […]41.
E la risposta di Orlando, dello stesso giorno, confermava che le preoccupazioni erano molto concrete e, come sappiamo, non prive di fondamento: egli aveva espresso alla Conferenza il proprio punto di vista sulla
necessità per l’Italia di ottenere compensi proporzionati alle risoluzioni che
sarebbero state prese per le altre Potenze. Tuttavia, se, in linea di principio,
la richiesta italiana era stata generalmente condivisa, sul terreno pratico gli
accordi erano di fatto impediti dalla teoria di Wilson
che vuole affidare le colonie tedesche alla Società delle Nazioni, con questo particolare:
che non intende neanche scegliere ora i mandatari, ma vuole che tale scelta sia fatta
dalla Società delle Nazioni quando sarà costituita.
Francia si è dichiarata contraria sostenendo principio annessioni.
Inghilterra si mostra indecisa: accetta il principio di Wilson come regola ma domanda
eccezioni a favore delle colonie conquistate dai dominions.
Io sono rimasto in attesa […] 42.
Orlando, visto il delinearsi di un conflitto in seno alla Conferenza,
aveva cercato di manovrare in modo da portare una voce di mediazione,
accettando, in linea di massima, il principio di Wilson. D’altra parte, considerava anche il fatto che la posizione del presidente americano avrebbe
prima o poi finito col prevalere, data la fermezza con cui era sostenuta:
infatti, la resistenza francese cominciava già a venir meno. Inoltre, Orlando
era convinto di non avere la forza nè la convenienza di sostenere l’urto di
Wilson e riteneva di dover attendere gli sviluppi della situazione per vedere
in quale modo far valere gli interessi italiani.
La Conferenza, apertasi il 18 gennaio, manteneva un ritmo serrato, e
Colosimo, ritenendo un suo preciso dovere far pressione sul suo presidente,
al fine di mantenere vivo il problema coloniale, in quei giorni gli telegrafò
spesso insistendo sempre sulla stessa nota: Orlando, pur riconoscendo la
legittimità delle sue pressioni e delle sue preoccupazioni, non poteva fare a
128
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
meno di ricordargli che la situazione, in se stessa, era molto difficile, anzi
«gravissima». Questo, perché Wilson era irremovibile non solo nel voler
affidare le colonnie tedesche alla Società delle Nazioni, ma anche nel riservare la scelta dei mandatari alla stessa Lega delle Nazioni, il che implicava
«un indefinito rinvio». Ma il peggio era che, durante tale periodo, sarebbe
rimasta l’occupazione
[…] delle forze attuali.
In tali condizioni è assai difficile trovare modo di evitare iattura Italia a meno di non
mettersi nettamente contro Presidente Wilson. A parte generale danno politico che ne
seguirebbe si può dubitare che tale opposizione potrebbe riuscire utile visto che tanto
l’Inghilterra quanto la Francia sono venute man mano desistendo dalla loro opposizione iniziale e si rassegnano più o meno volentieri.
Io mi adopero in tutti i modi per cercare qualche via d’uscita ma debbo con rincrescimento dirti che non è facile43.
Come si vede, la situazione peggiorava di ora in ora, se è vero, come
è, che il brano appena riportato è del 30 gennaio. Colosimo ne fu molto
allarmato e, il giorno dopo, manifestò ad Orlando la sua agitazione, sperando comunque che il telegramma del 30 fosse stato spedito prima della
riunione di cui aveva avuto notizia dai comunicati ufficiali pubblicati in
Italia. Si attendeva una qualche nota esplicativa che lo tranquillizzasse:
Io non posso adagiarmi al fatto così inopinatamente compiuto […]. Il rinvio e nel frattempo la permanenza delle forze attuali nei possedimenti coloniali affricani tedeschi
ci danno il diritto lo stesso a chiedere l’applicazione del Patto di Londra nei nostri
rapporti senza ombra di dubbio. È evidente che l’opposizione francese ed inglese alla
teoria wilsoniana era una lustra e perciò facilmente hanno finito con l’accettarla, potendosene anche gravare per tentare di eludere gli impegni che hanno con l’Italia. Se
è vero quanto traspare dalle indiscrezioni di un’intervista del Signor Tardieu44, e cioè
che sarebbe sottoposto alla Società delle Nazioni il quesito se con la Lega delle Nazioni
non debbano intendersi cancellati tutti gli accordi precedenti, allora il giuoco sarebbe
completo e la pace si tramuterebbe in provvedimenti saturi di rancori nazionali45.
Per questo, Colosimo riteneva che la delegazione italiana dovesse tener
d’occhio la Francia e l’Inghilterra e cercare di avere Wilson dalla propria
parte per poter chiedere a quelle, con fermezza, che venisse trattata subito
la questione delle colonie italiane, stralciandola dalla proposta wilsoniana.
Egli era infatti convinto che ormai Francia e Inghilterra non sarebbero
129
Vanni Clodomiro
certo rimaste escluse dalla spartizione delle colonie ex tedesche e che comunque avrebbero avuto ingrandimenti territoriali in Africa – sia pure col
mandato amministrativo – :
in ogni caso, le ragioni delle nostre rivendicazioni indicate nel promemoria del 30
ottobre 1918, bastano per sé sole a rivendicare il nostro diritto alla desiderata sistemazione che dipende unicamente da Francia e da Inghilterra […]46.
Colosimo si riferisce al memoriale da lui trasmesso, su richiesta della
Consulta, ad Orlando e a Sonnino, il quale, a sua volta, lo aveva consegnato al colonnello House, delegato statunitense alla Conferenza, e a lord
Balfour, ministro degli Esteri britannico, il 3 dicembre 1918. Quel memoriale «fondava le rivendicazioni su tre ordini di considerazioni: sui diritti
antecedenti alla guerra e sui diritti storici; sui diritti nati dalla guerra […];
sulle esigenze del dopoguerra». Per una pace durevole, «bisognava evitare
i futuri dissensi tra gli alleati ed eliminare le cause di attrito»47. Come la
Francia e l’Inghilterra possedevano, la prima nell’Africa nord occidentale,
la seconda dal Mediterraneo fino alla Colonia del Capo, una grande zona contigua, così, anche l’Italia avrebbe dovuto ottenere il collegamento
dell’Eritrea con la Somalia. Le conclusioni del documento mettevano in
luce, sostanzialmente, la necessità, per l’Italia, di avere semplicemente una
sistemazione definitiva dei suoi territori coloniali che, lungi dall’essere una
mira imperialistica, doveva piuttosto costituire una giusta condizione di
equilibrio per un tranquillo sviluppo della sua civiltà48.
Secondo Colosimo, tali «intese» non potevano essere rifiutate dalla
Francia e dall’Inghilterra, le quali,
facendo fin d’ora onore al Patto di Londra, toglierebbero un punto tra le alleate fin
dall’inizio dei lavori della Conferenza ed eviterebbero il grave pericolo di perpetuare in
Affrica, dopo il trattato di pace, quella politica di sospetti e di dissidi che ha caratterizzato le relazioni in Etiopia delle tre potenze firmatarie dell’accordo di Londra49.
E la conclusione del ministro delle Colonie sembrava presagire quella
che per lui non sarebbe certamente stata una favorevole soluzione dei problemi italiani: «Pensa che la nostra questione coloniale di importanza vitale
o si risolve ora o non si risolve più»50.
Ma i problemi italiani non erano solo le colonie. L’agitazione nittiana
che non era più un mistero; la «condotta della stampa senza direzione»51;
130
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
voci diffuse sul rinvio della conclusione della conferenza; una crescente
opposizione in Parlamento: erano tutti elementi che concorrevano a determinare un concreto fermento che non poteva lasciare tranquillo Orlando,
che temeva una crisi, nè tanto meno lo stesso Colosimo, il quale si rendeva
ben conto di tale situazione e non nascondeva la sua preoccupazione per
l’atmosfera che regnava in seno alla delegazione italiana a Parigi, come la
meno adatta alla soluzione della questione coloniale. In più, bisogna considerare anche il fatto che i grandi non si risolvevano ad affrontare ufficialmente la questione delle colonie e che la situazione pertanto peggiorava: la
Francia si era mostrata sempre più ostile all’Italia, e l’Inghilterra non aveva
in alcun modo manifestato una reale disponibilità a rinunciare ad alcuna
delle sue posizioni nell’Africa Orientale.
Inoltre, a Roma, confluivano ogni giorno notizie scoraggianti, come,
ad esempio, quella, secondo cui, in previsione di un intervento del ministro francese delle Colonie, Henry Simon, erano state prese decisioni che
rendevano inattuabile la richiesta italiana di stralciare la sua posizione dal
complesso delle trattative e di onorare il Patto di Londra; oppure quella,
sopra accennata, dei mandati che si sarebbero affidati alla Società delle
Nazioni, se non addirittura il conferimento ad essa della sovranità sulle
colonie ex tedesche. A quel punto, la questione, per l’Italia, diventava, come dice giustamente il Toscano, «di sapere se […] avrebbe avuto ancora il
titolo giuridico per invocare l’applicazione dell’art. 13 del Patto di Londra,
qualora la Francia e la Gran Bretagna non avessero acquistato la sovranità sulle antiche colonie tedesche, ma le avessero avute semplicemente
in mandato temporaneo e teoricamente sempre revocabile»52. Inoltre, ove
l’Italia avesse ottenuto un qualche mandato, avrebbe ugualmente potuto
appellarsi al patto di Londra? Specie su quest’ultima questione la delegazione italiana si trovò in grave disagio, visto che la posizione di Colosimo
manteneva le distanze da quella della delegazione stessa.
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile, di quanto cresceva l’ostilità degli
alleati nei nostri confronti, di tanto si profilava a chiare linee il crollo dei
progetti coloniali italiani, e in particolare di quelli del ministero delle Colonie. L’Italia, ripetiamo, non riusciva ad avere autorità nelle trattative e la
delegazione viveva momenti di disagio e incertezza, dovuti anche al suo
ruolo secondario rispetto a quello dei tre grandi. I telegrammi di Colosimo
ai delegati erano praticamente monocordi, e lamentavano, in sostanza, la
pressoché totale mancanza di considerazione delle nostre esigenze da parte
131
Vanni Clodomiro
degli alleati, anche se la delegazione ripresentava, come aveva già fatto il 5
gennaio, nuovi memoriali relativi alle nostre aspirazioni coloniali. Quello
del mese di marzo, in particolare, non fu apprezzato da Colosimo, perché
in esso non era contemplata la possibilità di realizzare anche i nostri vecchi programmi coloniali, nel caso che l’Italia avesse ottenuto un mandato
dalla Società delle Nazioni. Inoltre, non faceva riferimento al protocollo
del 1906, che Colosimo desiderava venisse sostituito, come abbiamo visto
sopra, da quelli del 1891 e del 1894. D’altra parte, non avendo egli voluto
recarsi a Parigi, era chiaro che non potesse intendere molto bene gli oscuri intrighi e le frequenti manovre degli alleati nei confronti dell’Italia: si
consideri, in particolare, solo per citare un esempio, l’atteggiamento della
Francia riguardo alla questione dell’Etiopia, che non voleva, in sostanza,
far cadere interamente sotto il controllo dell’Italia. Tutto ciò non fece, comunque, che accrescere il disagio sofferto dalla delegazione italiana, divisa
tra le esigenze generali da un lato, e le esigenze coloniali dall’altro.
Gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio furono forse tra i più difficili per l’Italia. La questione di Fiume e della Dalmazia aveva dominato la
Conferenza per la maggior parte di aprile: dopo la promessa di uno statuto
di territorio libero (la massima concessione prospettata all’Italia), il 4 aprile
la nostra delegazione aveva deciso di abbandonare la Conferenza ove le sue
richieste minime non fossero state accettate (ma, fin dal 6 di febbraio Orlando aveva minacciato un’azione di quel genere). Il 23 aprile le trattative
erano ancora in corso quando Wilson rese di pubblico dominio il suo noto
Manifesto al popolo italiano, con cui sperava di far capire agli italiani, anche
se non nell’immediato, le ragioni che spingevano gli Stati Uniti a mantenere quella linea ritenuta giusta dal presidente americano. Orlando, dopo
un’energica protesta, lasciò Parigi alla volta di Roma, allo scopo di ottenere
dal Parlamento un rinnovato mandato di fiducia. Non stiamo qui a descrivere le vicende, del resto già note, di quei giorni, il modo compatto con
cui sia la Camera che il Senato tributarono il loro consenso al presidente
del Consiglio e quella sorta di ubriacatura collettiva che diventò Fiume
da allora fino all’impresa dannunziana e al Natale di sangue. Vogliamo
invece sottolineare che Orlando, commettendo un errore non meno grave
di quello commesso da Wilson in occasione del Manifesto, non volle sfruttare immediatamente quella vittoria presentandosi alla Conferenza con un
maggiore potere contrattuale, facendosi scudo delle pressioni esercitate
dall’opinione pubblica: avrebbe così potuto tentare una tattica analoga a
132
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
quella seguita in occasioni simili dagli altri Paesi. Ma egli volle invece attendere in Italia che da Parigi venisse un qualche cenno di conciliazione:
ciò non avvenne, e l’Italia perdette forse l’unica occasione di far sentire con
maggiori probabilità di successo le proprie ragioni. Anzi, le due potenze
alleate fecero sapere che avrebbero trattato la pace con la Germania anche
in assenza della delegazione italiana, intendendo quell’eventuale assenza
come espressione di una volontà di pace separata e dichiarando che sarebbe
stato denunicato anche il patto di Londra.
Ma la mattina del 7 maggio, sebbene accolto da un atteggiamento glaciale – il clamoroso gesto dell’aprile non aveva ottenuto se non il risultato
di infiammare l’opinione pubblica italiana e di eccitare ulteriormente la
fantasia politica di D’Annunzio –, Orlando faceva il suo ingresso nella
Conferenza, appena in tempo per la consegna delle condizioni di pace alla
Germania. Del che avvertiva Colosimo con un tempestivo telegramma,
nel quale si legge:
noi non c’ingannammo nella valutazione della situazione […] certamente la nostra
assenza oggi avrebbe determinata la dichiarazione degli Alleati che il trattato di Londra
era venuto meno per fatto nostro53. Tutti sono d’accordo nel ritenere l’enorme gravità
della situazione che ne sarebbe derivata senza neanche il conforto di poter rimproverare agli Alleati un caso di indiscutibile infedeltà […] Sembra si accentui il dissidio
Clemenceau-Foch, che ieri parlò pubblicamente contro le condizioni di pace proposte
alla Germania54. Nei nostri rapporti risulta in tutti i sensi da parte degli Alleati una
freddezza ostile, che salva appena le forme. Trovai l’invito per la riunione dei quattro
delle ore 11 e vi intervenni. Non si fece alcuna allusione a noi. Lloyd George relativamente il più amichevole; Clemenceau sereno nella sua ostilità; Wilson mostrava
un certo turbamento. Anche io tenni una attitudine fredda e seccata. La situazione
dunque è molto tesa, anche nei rapporti personali, il che mi fa pensare che sarebbe
stato forse utile un mutamento degli uomini rappresentativi, pur lasciando inalterato
l’indirizzo. Disgraziatamente le complesse condizioni della situazione e del Paese lo
impedirono e sembra che lo impediscano ancora, determinando una pregiudiziale che
non è certamente benefica alle cose55.
Proprio nella seduta del 7 maggio, il Consiglio Supremo della Conferenza si risolveva ad affrontare ufficialmente la questione coloniale. Francia
e Inghilterra avevano preso accordi tra loro per la tutela dei rispettivi interessi coloniali. Riguardo alle decisioni prese per le colonie ex tedesche, Colosimo proponeva subito ad Orlando56 l’invio a Parigi di Salvago Raggi, in
qualità di esperto di questioni coloniali, per le riunioni che interessavano
133
Vanni Clodomiro
l’Italia; e la risposta immediata del presidente conveniva sull’opportunità
di una tale risoluzione57.
Successivamente al 7 maggio, l’Italia cercava di creare un piano di rivendicazioni da sottoporre alle due potenze. Tale piano fu elaborato, sulla
base di considerazioni abbastanza realistiche, dal nostro delegato De Martino: esso riguardava, in particolare, la cessione di Gibuti, di Chisimaio e
del Somaliland britannico. A tale scopo, De Martino aveva approntato una
serie di azioni diplomatiche – per la verità, congegnate con concretezza di
prospettive – in previsione anche di eventuali difficoltà di vario genere nel
corso delle trattative. Senonché, bisogna dire che l’Italia avrebbe dovuto
pensare prima a tale piano, e non quando i giochi erano in pratica già fatti
tra Francia e Inghilterra, senza la minima considerazione degli interessi – e
diremmo quasi dell’esistenza – dell’Italia. Tuttavia, ripetiamo, se Orlando,
invece di attendere a Roma un segno di conciliazione da Parigi, in occasione delle vicende relative al Manifesto di Wilson, si fosse risolto a recarvisi
tempestivamente, non appena ottenuto il consenso dal Parlamento, le cose, forse, sarebbero potute andare diversamente. Quindi ci sembra che la
diplomazia italiana, a parte la scarsa considerazione da parte degli alleati
e addirittura l’ostilità mostrata da alcuni di essi, debba in parte anche alle
proprie incertezze gli insuccessi e il complessivo fallimento che, dal punto
di vista della questione coloniale, caratterizzarono in genere l’andamento
dei lavori della Conferenza di Versailles.
Intanto, correva l’ultimo mese di vita del governo di Orlando, e le preoccupazioni di quest’ultimo erano rivolte, ovviamente, più alle sorti della
politica italiana in generale, che non alla questione coloniale in particolare.
Infatti, la corrispondenza inviata dal presidente del Consiglio a Colosimo
era rivolta sopra tutto al vice presidente, non al ministro delle Colonie. L’8
maggio gli scriveva sui criteri «metodici per la pace con l’Austria»58; due
giorni dopo, riprendendo lo stesso argomento diceva che le
determinazioni relative alle frontiere dovranno essere fatte dalle stesse grandi potenze
alleate ed associate […] nella Conferenza. Questa decisione, per quanto puramente
metodica, ha per noi il vantaggio di consentirci la possibilità di un rinvio delle nostre
questioni, mantenendo il possesso. […] Nella seduta pomeridiana fu votata una massima secondo cui la contribuzione per le riparazioni deve gravare su tutti i nuovi Stati
derivanti dall’ex Impero austro-ungarico, comprese quindi Jugoslavia, Boemia ecc. Tale soluzione corrisponde alle nostre proposte e ai nostri interessi. Le nostre principali
questioni territoriali rimangono in sospeso, evidentemente perché tutti avvertiamo non
134
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
essere ancora matura nessuna possibilità 59.
L’11 maggio, in un altro telegramma, gli scriveva che, «se l’ipotesi di un
semplice mutamento di ministero» avesse potuto sortire l’effetto di portare
la calma e l’unione nel paese, egli ne sarebbe stato felicissimo; e poi gli
chiedeva di «suggerirgli quelle decisioni» che avesse ritenuto «le più utili
al paese, intesa Sua Maestà». La situazione, a Parigi, era certamente grave,
ma Orlando confidava che, in Italia, tutti coloro che avevano «senso di
responsabilità e di patriottismo» si convincessero che una «disunione interna» avrebbe determinato un «irreparabile disastro». Il telegramma – dopo
aver fatto un cenno, purtroppo fugace, al dissidio tra lo stesso Orlando e il
ministro della Guerra, generale Enrico Caviglia, quanto allo scioglimento
del corpo degli arditi o della sua utilizzazione in funzione antisocialista,
dissidio che s’innestava sulla vecchia rivalità tra il Caviglia ed il generale
Giardino, ex ministro della Guerra, anch’egli citato nel documento – si
concludeva con la preghiera a Colosimo di tenere informato il suo presidente su eventuali ulteriori sviluppi della situazione. Successivamente,
Orlando spiegava al suo vice presidente che il ritardo delle decisioni riguardanti l’Italia era dovuto alla resistenza passiva60 della delegazione, la quale
persisteva in quel particolare atteggiamento, non riuscendosi a trovare una
«transazione accettabile». In sostanza, si doveva sapere se il Paese accettava
quel ritardo oppure no:
Tu sai bene come io non dia nessun’importanza alla mia persona quando si tratta di
interessi del Paese. Valuta tu stesso, d’accordo coi colleghi, se la situazione del Paese sia
tale da apparire, nell’interesse delle cose, necessario un cambiamento degli uomini che
sono al Governo. In tal caso, sarà sempre possibile trovarsi il modo, essendo io disposto, anzi lieto, di qualunque sacrificio personale che possa giovare al Paese. Sarà bene
che tu ti rechi a conferire con Sua Maestà, a cui darai notizie di questo […] attenderò
le vostre impressioni61.
Orlando era ormai in condizioni morali di prostrazione e si attendeva,
forse, un incoraggiamento da Colosimo e dal re a rassegnare le dimissioni.
Ma il re non ne volle sapere62.
Intanto, in seno alla Conferenza, si proponeva la questione del tonnellaggio adriatico – che, come abbiamo già accennato, stava molto a cuore
a Sonnino e alla Marina – e la commissione degli esperti, comprendendo
anche inglesi, francesi ed americani, era decisamente contraria a soddisfare
135
Vanni Clodomiro
gli interessi italiani. Le argomentazioni di Lloyd George erano queste:
se l’Italia può avere ragione di preferenza per ciò che concerne i rapporti patrimoniali
con l’Austria-Ungheria, bisogna allora che dia a noi la preferenza nei rapporti con la
Germania. Ma poiché l’Italia è stata ammessa a piena parità di trattamento verso la
Germania, non negare (sic!) eguale trattamento a noi verso l’Austria-Ungheria63.
Data questa posizione di Lloyd George, Orlando si sentiva autorizzato
a credere al vantaggio che fosse ormai definitivamente confermata
l’assoluta parità di trattamento dell’Italia nei rapporti con le riparazioni tedesche, cioé
verso il creditore solvibile. Il danno di Trieste sarà evitato, perché fu ammesso che
l’Italia imputerà nella quota di tonnellaggio che le spetta le navi adriatiche. Totale di
tonnellaggio che ci dovrà essere attribuito a titolo di riparazioni è di circa 100.000 tonnellate, tonnellaggio complessivo di Trieste e Fiume è di 600.000. Noi dunque siamo
sicuri di salvarne i quattro quinti mentre speriamo di fare assegnare l’altro quinto in
conto delle nostre riparazioni. Ti prego di dare comunicazione di ciò tanto a Ciuffelli
quanto a De Nava64, invitandoli a fare in modo che si eviti a Trieste l’impressione di
un danno sofferto dalla città […]65.
Nel pomeriggio di quel 12 maggio sembrava delinearsi la tendenza
degli alleati e degli stessi americani a cercare una qualche soluzione per
le questioni territoriali italiane. Pareva ci fosse un attivo movimento di
intermediari e, comunque, sta di fatto che Lloyd George fece sapere che
avrebbe voluto vedere Orlando e Sonnino alle 10,30 del giorno successivo
e che dopo, alle 11, avrebbe incontrato Clemenceau e Wilson, evidentemente per discutere con loro degli stessi problemi. Orlando riteneva questo un buon segno, dovuto, a suo modo di vedere, alla nota tattica di attesa
mantenuta in precedenza. Ma, francamente, a noi sembra che l’impegno
di mezz’ora di tempo per affrontare problemi di tanta e delicata complessità non avrebbero dovuto consentire previsioni ottimistiche. Infatti, le
cose non sarebbero poi andate come prevedeva Orlando, ispirato forse da
una certa dose di ingenuità politica, o piuttosto di disperazione. Proprio
in questo senso, non bisogna dimenticare che la situazione interna del
nostro Paese impegnava non poco la mente del presidente del Consiglio.
La notte dello stesso 12 maggio, alle 24, indirizzava a Colosimo un nuovo
telegramma con cui lo informava che, nella sostanza, di notizie concrete circa la sistemazione territoriale dell’Italia non poteva darne. Dopo di
che, riprendeva l’argomento delle sue dimissioni, che, se finalizzate alla
136
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
sicurezza di un miglioramento delle capacità degli eventuali uomini nuovi
di trattare con gli alleati, egli non avrebbe esitato a rassegnare. Ma questo
discorso ci sembra in verità un po’ strano, nel senso che, quando un capo
di governo si rende conto di non riuscire più a controllare certe situazioni,
non chiede ripetuti consigli al suo vice e al suo sovrano: passa la mano e
basta. Con questo, non vogliamo dire che Vittorio Emanuele Orlando non
intendesse rinunciare in alcun modo alla sua posizione, ma soltanto che
avrebbe comunque inteso un tale gesto come un vero e proprio sacrificio
personale, sia pure per il bene della patria. Tuttavia, il sacrificio di cui egli
parlava sarebbe stato quello di «restare nell’attuale posizione irta di amarezze e di difficoltà». Infatti, più avanti scriveva:
Per quanto riguarda nostri negoziati, io non potrei affermare con uguale sicurezza il
cambiamento degli uomini abbia ad avere effetto favorevole, poiché le nostre difficoltà sono ormai diventate tali da potersi ritenere indipendenti dagli uomini […]. Un
esempio notevole di ciò si ha nella questione del tonnellaggio adriatico di cui nel mio
precedente telegramma. La questione era già stata talmente pregiudicata nella commissione tecnica che nessuna seria speranza si poteva di aver ragione (sic!) nel Comitato
dei Quattro […]66.
Pertanto, Orlando si diceva «assolutamente certo» che nessun altro negoziatore avrebbe potuto ottenere soluzioni diverse (era evidente, e forse
anche giusto, che difendesse il proprio operato e la propria posizione).
Comunque, egli non si nascondeva le difficoltà derivanti dal fatto che,
nell’ambiente dell’«Edoardo VII», tali notizie suscitassero cori di recriminazioni e che da molte parti si dicesse che tali scacchi erano dovuti all’ormai
scarsa autorità di lui e di Sonnino nelle trattative. Inoltre, l’assenza dall’Italia gli impediva, in certo modo, di percepire con esattezza le ripercussioni
di eventuali decisioni che si dovessero prendere in seno alla Conferenza.
Anche per questo, Orlando preferiva astenersi dal manifestare propositi
precisi. Era comunque «pronto» ad ogni evenienza. Lasciava a Colosimo
ed al re il compito di valutare il da farsi, nell’interesse del Paese.
A questo punto, bisogna francamente riconoscere che Colosimo avrebbe potuto, manifestando al re il suo punto di vista, ottenere da lui l’autorizzazione ad aprire la crisi di governo e, magari, approfittare delle vecchie
divergenze con la linea seguita dalla delegazione per conquistare posizioni
di maggiore prestigio, tentando così un’ottima carta personale. Ma non lo
fece. Inoltre, Nitti era quello che, dopo le riunioni di Consiglio del 15 e
137
Vanni Clodomiro
16 dicembre 1918, aveva seguito, a pochi giorni di distanza, il sacrificio di
Bissolati e che aveva manifestato chiaramente le sue intenzioni di rappresentare l’Italia a Parigi per portarvi esigenze e rivendicazioni diversamente
ispirate, specie in riferimento alla questione dalmata; il che – a parte, naturalmente, il suo prestigio personale – gli conferiva maggiori chances di
Colosimo, il quale, dopo tutto, non aveva fatto altro se non preoccuparsi
esclusivamente delle colonie, evitando di proporre, all’occorrenza, qualsiasi questione di politica generale che non fosse strettamente correlata, appunto, alle colonie. Tuttavia, non si può non considerare come Colosimo,
nonostante la sua visione esclusiva dei rapporti internazionali, riuscisse a
percepire quello che Sonnino si rifiutava di comprendere, e cioè che una
maggiore preoccupazione e un maggiore impegno per le colonie avrebbero
forse posto l’Italia nella condizione di non urtare la Jugoslavia; e ciò, come
abbbiamo detto, avrebbe costituito un innegabile vantaggio. Se a Wilson
si fosse dato il modo di intravvedere una qualche disponibilità dell’Italia
a cedere nei confronti della Jugoslavia, forse la questione coloniale italiana
si sarebbe risolta meglio. Colosimo – forse anche inconsapevolmente – si
trovava su tale posizione. Ma agli Esteri c’era Sonnino.
Come è noto, dopo breve tempo, Nitti, che impersonava la corrente
dell’opposizione alle direttive del governo, avrebbe ottenuto l’incarico di
presiedere il nuovo gabinetto.
Ad ogni modo, l’ultimo periodo del governo di Orlando andava configurandosi come uno dei più tormentati, per effetto dell’alternarsi di notizie, di ora in ora, contrastanti. La mattina del 13 maggio, in seno alla Conferenza, si era trattata, soltanto con Lloyd George, la questione dell’Asia
Minore, prospettandosi per l’Italia due diverse possibilità, e cioè la concessione di una fascia di territorio nell’Anatolia meridionale che andava
dal golfo di Scalanova a Mersin, oppure un mandato generale per tutta
l’Anatolia. Ma ciò era subordinato all’accettazione da parte dell’America
del mandato per la vicina Armenia. Il rappresentante britannico, mentre
si dichiarava fiducioso circa la possibilità di trovare una via di conciliazione, si riservava comunque di «preparare» adeguatamente Wilson. Inoltre,
sembrava che il Consiglio dei ministri francese avesse deliberato di mantenere una linea di condotta più favorevole all’Italia. Per Orlando, tutto
ciò lasciava ben sperare, anche se, reso ormai «edotto dall’esperienza», non
riteneva di poter affermare che tutto si sarebbe subito risolto secondo le
aspirazioni italiane: forse, qualche nuovo fatto, che Orlando ignorava, era
138
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
intervenuto, rendendo più perplessi gli alleati circa una soluzione che lasciasse il malcontento nella delegazione italiana. A quel punto, si poneva la
questione se forzare la mano in quel momento, o se convenisse attendere
una ulteriore maturazione degli eventi: si trattava cioè di stabilire una tattica. La delegazione era compatta nel ritenere di dover insistere sul patto di
Londra come mezzo per esercitare pressioni anche relativamente al problema di Fiume. Quindi, comunicava Orlando a Colosimo,
in ciò si distinguono due tattiche. L’una consisterebbe nel fare un’azione immediata
e risoluta che tenda a fare pressione sugli alleati per una decisione immediata. L’altra
consisterebbe nel mantenere un’attitudine passiva lasciando che gli alleati cerchino
loro il compromesso in guisa che se non lo trovano, la questione rimarrebbe insoluta,
ma noi continueremo nel possesso dei territori, in attesa di tempi migliori […]67.
Dell’opinione di Orlando sulla resistenza passiva abbiamo già detto. Aggiungiamo ora che, in quella particolare occasione, Sonnino, come era ovvio, sosteneva apertamente quella tesi e che lo stesso Orlando si mostrava
sostanzialmente favorevole, ritenendo che esercitare immediate pressioni
potesse equivalere ad una rottura radicale con gli alleati, mentre una politica temporeggiatrice avrebbe evitato quel rischio. D’altra parte, però,
Orlando non si nascondeva che il Paese non gli sembrava affatto disposto
ad ulteriori attese indefinite. Il Paese è stanco e su questa stanchezza speculano tutti i
mestatori politici […]68.
L’attesa avrebbe potuto prolungarsi fino alla firma della pace con la
Germania, ma, ove le cose non si fossero risolte dopo quella pace, nel Paese
avrebbe potuto verificarsi un’«esplosione di collera». Orlando chiedeva a
Colosimo di informare il Consiglio dei ministri senza dare comunicazione
del telegramma, ma, semplicemente, limitandosi a dire che egli stesso poneva la questione in quei termini, dopo aver ricevuto precise informazioni
dal presidente:
ma poiché la data della firma si avvicina (22 maggio) la gravità della decisione da prendere rende necessario che su di ciò si abbiano in tempo tutti gli elementi per risolversi.
Valuta se sia il caso di conferire con Sua Maestà69.
Ma Colosimo dovette dare comunicazione del telegramma e il Consi139
Vanni Clodomiro
glio dei ministri si mostrò orientato verso la prosecuzione delle trattative70.
Il 15 maggio, un colloquio preliminare tra Orlando e Lord Milner71,
alla presenza di De Martino, rivelò con chiarezza la difficile posizione italiana. Il colloquio durò più di un’ora e Milner si mostrò molto cordiale72.
Orlando premetteva una considerazione generale sul diritto di «vedere
riconosciuti» gli interessi in Africa, visto che l’Italia aveva afffrontato notevoli sacrifici e aveva offerto il suo importante contributo militare proprio
nella Libia. Dopo di che, rivendicava un’interpretazione non riduttiva del
patto di Londra, nel qual caso vi avrebbe rinunziato del tutto:
Quello che domando ed esigo è un trattamento di eguaglianza di fronte agli Alleati […]73.
Passati poi ad un esame complessivo delle richieste italiane, Milner –
che, istituita quel giorno stesso la Commissione incaricata di esaminare
le questioni coloniali italiane dal ministro delle Colonie Simon, ne era
il presidente , su proposta unanimemente accettata dello stesso Simon74
– non sollevava obiezioni particolari sulla rettifica di confine tra Egitto e
Cirenaica. Riguardo alla richiesta italiana di costituire un triangolo tra Cirenaica, Egitto e Darfur, rilevava l’importanza di quest’ultimo per le future
comunicazioni, nonché di Giarabub relativamente alla Senussia. Quanto
al Somaliland britannico, Milner dichiarava di non poter fare concessioni,
essendo Aden strategicamente essenziale dal punto di vista militare. Tuttavia, nel prosieguo della discussione, conveniva che una parte avrebbe
potuto essere ceduta all’Italia. Altra concessione di evidente importanza,
dato il prospero futuro della regione, sarebbe stata quella di Chisimaio e
del Giuba. Comunque, a quel punto, Milner faceva osservare come solo
l’Inghilterra si trovasse «a far concessioni all’Italia di qualche valore». Per
Gibuti, disse invece che la Francia non avrebbe mai acconsentito a cederlo.
Orlando scrisse a Colosimo:
A questo punto De Martino autorizzato da me ha prospettata in via di semplice ipotesi, osservando che manca il consenso del Ministero Colonie, il modus procedendi di
cui la relazione De Martino del 9 corrente e la nota del Ministero degli Affari Esteri
del 7 febbraio 1917 N.5 75.
Ho potuto notare il grande interesse di Lord Milner a tale proposta, per cui ritengo
che, qualora tu consenta, il negoziato possa procedere su tale base76.
Vista la disponibilità dell’interlocutore, Orlando affrontò il problema
140
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
dei mandati, cui anche l’Italia aspirava. Fu allora che le cose si complicarono:
Di fronte alla reale difficoltà di una favorevole soluzione, si è accennato in via di ipotesi
ad una soluzione parallela nel senso della nota del tuo Ministero a quello degli Esteri
in data 4 gennaio 1917 n.80 77.
C’è qui da osservare che, nel Diario di Colosimo non si trova la nota
citata da Orlando: si trova invece notizia di una risposta, negativa, a Colosimo, del ministro degli Esteri, in cui questi, mostrandosi seccato di essere
stato «tempestato tutta la mattinata per telefono» dal suo collega delle Colonie, dichiarava che, secondo lui, non «si sarebbe posta occasione di parlare di cose coloniali»78. Sonnino confermava così la sua scarsa sensibilità al
problema coloniale in genere.
Orlando, comunque, aveva rispolverato quella proposta di Colosimo,
ricevendo da Milner un’impressione di minore contrarietà per quell’ipotesi. Sonnino però faceva sapere che la propria partecipazione ai lavori della
Commissione non sarebbe stata opportuna per «varie ragioni». Quindi il
presidente comunicava a Colosimo di aver deciso di sostituire il ministro
degli Esteri col collega Crespi, assistito da De Martino.
Ad ogni modo, dal punto di vista dei risultati, nessuna novità concreta
aveva caratterizzato la giornata del 15 maggio, anche se si era intensificato il ritmo delle conversazioni sulla nostra questione. L’andamento di tali
conversazioni sembrava indicare una effettiva buona volontà da parte degli
alleati, così come degli americani. Comunque, è chiaro che non si potessero fare, e Orlando se ne guardava bene, pronostici precisi. Le intenzioni
erano orientate verso la concessione all’Italia di tutta l’Istria e di tutte le
isole del patto di Londra – tranne Pago – nonché Zara e Sebenico, mentre,
per Fiume, si voleva adottare una formula media, come quella della città
libera. Orlando lavorava nel tentativo di ottenere quanto più fosse possibile relativamente a Fiume. Nel pomeriggio aveva avuto un nuovo colloquio
con Milner sulla questione coloniale. E, malgrado talune resistenze, riceveva l’impressione che il programma minimo di Colosimo sarebbe stato
in gran parte accolto dall’Inghilterra. Per il giorno dopo, alle 11.30, era
fissata una riunione della Commissione, ma Sonnino rifiutava di parteciparvi: ci sarebbe andato Crespi. In ordine alla preoccupazione italiana
per Fiume, gli americani, pur mostrandosi più inclini e cordiali verso la
nostra delegazione, si erano risolti soltanto a consigliare un accordo diretto
141
Vanni Clodomiro
con la Jugoslavia. Orlando aveva avvertito che pretendeva una risoluzione
entro quarantotto ore e che avrebbe interrotto la trattativa se ciò non fosse
avvenuto. L’Italia chiedeva che «un piano di riduzione di armamenti fosse
anche esteso agli altri Stati sorti dall’Austria Ungheria (Boemia, Jugoslavia,
ecc.)»79, tesi che fu accolta per il favore degli inglesi e degli americani,
nonostante la violenta reazione di Clemenceau80. Ma, anche se qualcosa
riusciva ad ottenere, Orlando era ugualmente animato da scetticismo circa
il buon esito complessivo delle trattative. Colosimo intanto lo informava
sull’andamento del Consiglio dei ministri e lui, pur ringraziandolo, accennava alla possibilità che la questione italiana a Parigi potesse «servire come
spunto a quel possibile evento»81.
Ma Fiume costituiva un grosso problema, dal momento che anche i
negoziati con la Jugoslavia per quella città fallivano totalmente. Le conversazioni continuavano con gli americani, nel tentativo di ottenere la concessione che la città fosse, almeno, rappresentata diplomaticamente dall’Italia:
ma Wilson avanzava molte riserve. Per Orlando, il prolungarsi di quelle
conversazioni rappresentava, in sé, un fatto negativo. E tutti i torti, in
effetti, non si può dire che li avesse. In conclusione, non v’era ragione di
disperare, ma neppure di concretamente sperare.
In seno alla Commissione per l’applicazione dell’art.13 del patto di
Londra, riunitasi presso il ministero francese per le Colonie il 16 maggio,
l’Italia era rappresentata da Crespi e da De Martino, vista la defezione di
Sonnino. Crespi, dopo aver sottolineato la mancata attribuzione di mandati all’Italia, enunciò le nostre aspirazioni coloniali: le vie carovaniere
Ghadames-Ghat-Tumno, la frontiera della Cirenaica, la cessione della costa francese della Somalia, del Somaliland britannico, di Chisimaio e del
Giubaland. Inglesi e francesi giudicarono eccessive tali richieste e di gran
lunga superiori agli accordi del patto di Londra, e si riservarono quindi di esaminare con attenzione la proposta. Il ministro francese Simon
giudicò eccessiva anche la richiesta relativa alla Libia, per non parlare di
Gibuti, la cui richiesta significava l’allontanamento totale della Francia dal
Mar Rosso. La Francia era dunque la più ostile all’Italia, ed era quella che
mostrava più apertamente – in pratica – di non voler onorare il dispositivo dell’art.13. Neanche una conversazione pomeridiana con Milner dette
nuovi frutti, data la consapevolezza del ministro inglese di non poter fare
in modo che la Francia recedesse dalla sua ferma posizione di intransigenza. Così, Orlando, scrivendo a Colosimo, gli proponeva la sostituzione dei
142
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
delegati – anche aprendo, eventualmente, una crisi ministeriale «pilotata»
– in modo che la situazione eccezionale potesse essere, sia pure di poco,
modificata. Ma, anche se ciò non era costituzionalmente regolare, avrebbe
dovuto evvenire in tutta fretta:
Dovete ben considerare che nessun disastro sarebbe peggiore di quello che al momento
della eventuale firma con la Germania non vi sia alcuno che abbia il potere per decidere […]82.
Qualche barlume di speranza sembrava accendersi dopo la seduta antimeridiana del 17 maggio. Clemenceau interpellava Orlando sullo stato
della nostra questione. Dopo la sua risposta, Clemenceau disse che intendeva parlarne con Wilson e Lloyd George, e lo fece mentre Orlando si
allontanava: quest’ultimo pensava che ormai si fosse alle strette. Ma poi
gli americani non si fecero vivi, il che lo indusse nuovamente a ritenere
peggiorata la situazione: infatti, gli americani mantenevano un evidente
atteggiamento di resistenza, anche se Lloyd George – impegnadosi personalmente ad agire in quel senso – continuava a ripetere che il piano delle
rivendicazioni italiane avrebbe potuto essere accolto da Wilson.
Riguardo alla situazione interna dell’Italia, strettamente connessa, come era naturale, con quello che accadeva – o ci si aspettava accadesse – a
Parigi, Orlando intratteneva Colosimo sul fatto che la particolare ostinazione di Wilson di quei giorni (e non solo) avrebbe dovuto
convincere i più restii della immensa difficoltà della situazione in cui ci mette la lotta
contro Wilson, in questo momento onnipotente. Tale esatta valutazione della situazione manca spesso in tutti coloro i quali si sorprendono di eventi i quali non sono che la
conseguenza inesorabile di questo stato di cose, come ad esempio, l’insuccesso nel tonnellaggio adriatico, la questione di Smirne83, ecc. È certo difficile porre la questione in
tali termini presso i giornalisti e l’opinione pubblica; ma, pur riconoscendo tale difficoltà, io non saprei consigliare altre direttive in proposito, se non di fare comprendere
sempre più al pubblico italiano tutta l’asprezza della lotta in cui ci siamo impegnati, in
guisa da attribuire a ciò tutti i guai che ci capitano […]84.
Nell’animo di Orlando si era ormai fatta strada la convinzione che bisognasse prendere decisioni talmente importanti e gravi, che egli non se
ne voleva assumere in prima persona la responsabilità: riteneva urgente un
incontro con almeno un gruppo ristretto di ministri, magari tra Modane e
143
Vanni Clodomiro
Torino, allo scopo di non allontanarsi per molto tempo da Parigi, dove la
sua presenza avrebbe potuto rendersi, da un momento all’altro, indispensabile. Si rendeva conto del disagio provocato ai ministri facendoli spostare
da Roma, ma non trovava altra soluzione al problema. Il gruppo ristretto
avrebbe dovuto «portare e riportare il pensiero collettivo». Si trattava di
decidere sui seguenti punti, nel caso che la questione italiana non fosse
stata definita prima della firma della pace con la Germania: 1) ove non si
fosse preventivamente pervenuti all’accordo, bisognava ugualmente firmare la pace con la Germania? 2) in caso affermativo, quale atteggiamento
mantenere in seguito? bisognava persistere in un’attitudine di resistenza
passiva sulla base del patto di Londra, oppure passare al «contrattacco» con
un colpo di mano, come quello, ad esempio, di dichiarare l’annessione dei
territori previsti dal patto del 26 aprile 1915?
è impossibile che una decisione di tanta gravità sia presa senza preventivo scambio di
idee. Rispondi con grande sollecitudine85.
Ma Vittorio Emanuele III si mostrò contrario all’iniziativa di Orlando,
nella convinzione che le trattative dovessero essere condotte, dall’inizio alla
fine, dagli stessi uomini.
Il 20 maggio, nel corso della seconda seduta della Commissione, De
Martino riuscì a far inserire nel verbale della prima seduta la riserva del diritto dell’Italia a partecipare alla distribuzione dei mandati. In apertura di
discussione, Simon accettava di concedere i territori compresi tra Ghadames, Ghat e Tumno, ma era fermissimo nel rifiutare qualsiasi concessione
relativa alla costa francese della Somalia e a Gibuti. L’Inghilterra aderì alla
richiesta italiana di Giarabub, della rettifica di confine tra la Cirenaica e
l’Egitto da Sollum fino al 16° parallelo e di Chisimaio, oltre ad offrire altri
«83.000 kmq. nella zona dell’Oltregiuba»86. Riguardo poi al Somaliland
britannico, Milner si mostrò disponibile ad offrirne una parte (che non
comprendesse però Berbera e Zeila), tentando tuttavia di farlo in subordinazione alla cessione francese di Gibuti. Ribadiva, in sostanza, il concetto,
già in altra occasione espresso, che l’Inghilterra non avrebbe dovuto essere
la sola a fare concessioni di rilievo. Ma Simon era irremovibile, adducendo
nuovamente, a giustificazione dell’ intransigenza francese, il fatto che l’Italia avrebbe praticamente voluto allontanare totalmente la Francia dal mar
Rosso. Inoltre, nel tentativo di far scoprire la pretestuosità della posizione
144
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
inglese – circa la subordinazione della cessione di parte del Somaliland alla
cessione francese di Gibuti – affermò che l’Inghilterra non avrebbe aderito
in ogni caso alla richiesta italiana: il che Milner si affrettò a smentire, dichiarando perfino la disponilità inglese a concessioni maggiori, ove l’Italia
avesse ottenuto Gibuti. A quel punto, non trovandosi un accordo, su proposta di Crespi, si decise di aggiornare la riunione della Commissione al 22
maggio. Ma le cose stavano, ormai, nel modo appena descritto: la Francia
era decisissima87 e l’Inghilterra non lo era altrettanto nel fare concessioni.
Dal carteggio di Colosimo – nel quale, stranamente, per il 1919, non si
trovano i telegrammi da lui spediti ad Orlando, ma solo quelli di quest’ultimo a lui stesso88 – si deduce che il 22 maggio si tenne una riunione dei
Quattro: la mattinata era stata dedicata alle risposte ai delegati tedeschi;
il pomeriggio invece dalla questione delle riparazioni da includere nella
pace con l’Austria. Nel complesso, comunicava Orlando a Colosimo, le
soluzioni adottate erano molto favorevoli, se si eccettuava la questione del
tonnellaggio adriatico. Tuttavia, anche per quest’ultimo era stato accettato
che un accordo interalleato studiasse ogni strada possibile per attenuare il
danno italiano relativamente ai porti dell’Adriatico. Vi era quindi ragione
di sperare che un qualche rimedio si sarebbe trovato.
[…] Wilson cercò di risollevare la questione di esoneri nuovi Stati della Austria Ungheria di concorrere nelle riparazioni, ma questo principio non prevalse e si mantenne
il principio opposto. In complesso dunque per questa parte economica la soluzione
deve apparire soddisfacente 89.
Il giorno dopo, nulla di nuovo accadeva, sostanzialmente, nella nuova riunione dei Quattro. A parte una proposta di transazione in favore
dell’Italia fatta dal colonnello House90 (che poi naufragò per la fermezza di
Wilson), e le solite assicurazioni sulla rapidità della soluzione delle questioni italiane da parte di Lloyd George – alle quali ormai il nostro presidente
non credeva più per effetto di una generale sfiducia nell’andamento dei
lavori –, la sostanza era che Orlando intendeva persistere nella linea difensiva del patto di Londra, perché riteneva che solo un siffatto atteggiamento
avrebbe portato frutti concreti all’Italia. L’unico suo dubbio consisteva nel
fatto di non sapere se si sarebbe potuta «serbare la calma che occorreva per
la attuazione di quel programma»91.
La mattina del 26 maggio, fu trattata dai Quattro la maniera di co145
Vanni Clodomiro
municare agli austriaci le condizioni di pace; dopo di che, Clemenceau
affermò energicamente la necessità di risolvere la questione italiana. Orlando dichiarò che non domandava di meglio e che non era certo colpa
sua se ancora non si era giunti ad alcuna soluzione. Sospesa la discussione, fu ripresa più ampiamente nel pomeriggio, per iniziativa dello stesso
Clemenceau, e durò più di due ore. Orlando disse di aver sempre tentato
di trovare una soluzione conciliativa tra le opposte esigenze, ma che, non
essendovi riuscito, era costretto ad attenersi al dispositivo del patto di Londra. Wilson fece un lungo discorso per dire che egli non poteva consentire
l’applicazione, sic et simpliciter, del patto. Al che, Orlando replicò soltanto
per non perdere terreno «nel campo dialettico». La proposta di Wilson,
fatta in quell’occasione, era che l’Italia accettasse di sottoporre a plebiscito i territori contestati (cioè quelli non compresi nel suo memorandum).
Non avendo Orlando accettato, Wilson gli propose di conferire con la sua
delegazione, al fine di cercare altre vie di conciliazione. Anche Clemenceau
sostenne quella proposta. Ma il rappresentante italiano si dichiarò ancora
fermo sulla proposta House.
Le ultime parole di Wilson lascerebbero sperare, ma il fatto che egli non ha consentito
con House nella sua proposta, mi fa credere che non si piegherà. Ad ogni modo, è bene
che la questione sia stata nuovamente rimesa all’ordine del giorno92.
Il giorno dopo vennero definite le clausole finanziarie con l’Austria e
l’Italia riusciva a salvare un interesse «di circa un miliardo». Successsivamente, fu discussa la questione del confine tra Austria e Jugoslavia in prossimità del territorio italiano.
[…] Per Klagenfurt fu deciso che confine segua linea dei monti, lasciando quindi Klagenfurt agli austriaci. Quanto al triangolo Assling, noi sostenemmo che fosse dato agli
italiani perché la linea di comunicazione Trieste-Vienna non fosse interrotta da territorio jugoslavo. Wilson dichiarò di non dare importanza a questo genere di ragioni e
di voler attribuire quel territorio ai jugoslavi perché abitato da sloveni. Lloyd George
rilevò che data la connessione intima tra (tali ?) questioni ed il generale regolamento
delle questioni italiane, convenisse rinviarla93.
E così avvenne. Lloyd George ebbe un lungo colloquio confidenziale
con Wilson, evidentemente sulla nostra questione, e invitò poi Orlando
a recarsi il mattino successivo da lui, per conferire in proposito. Il nostro
146
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
rappresentante ebbe la netta sensazione che le cose si andassero mettendo
male: le previsioni non potevano essere favorevoli, data l’ostinazione di
Wilson, in particolare sulla questione del confine istriano. Ma Orlando
non intendeva cedere su quel punto: in primo luogo, perché ciò avrebbe significato la creazione di una linea strategica «pessima», e poi, perché l’Italia
avrebbe perduto l’immediato confine con Fiume e poco le avrebbe giovato
l’eventuale dichiarazione di indipendenza della città.
Intanto, per quanto riguardava in particolare il problema coloniale, tale questione era riservata esclusivamente alla Commissione istituita il 15
maggio. Questa si riunì nuovamente il 28 maggio, e Crespi ripetè la richiesta italiana di Gibuti, che era, in pratica, il fulcro del programma coloniale
di Colosimo. Simon rifiutò ancora la proposta e, all’obiezione secondo
cui la Francia avrebbe pur dovuto dare adeguati compensi all’Italia, offrì
una parte di territorio comprendente il massiccio del Tibesti, seguendone
la cresta e collegandosi con la frontiera anglo-francese. Crespi si riservò di
consultare la sua delegazione e la riunione fu rinviata al giorno dopo.
Nel frattempo, Sonnino, convinto di non poter ottenere Gibuti, avanzò
la proposta di chiedere per l’Italia il mandato sul Togo, cosa sulla quale Colosimo non era assolutamente d’accordo per due ordini di motivi: anzitutto, perché sapeva bene che, fallito il piano su Gibuti, sarebbe praticamente
fallito tutto il nostro programma coloniale, e poi, perché, in ogni caso, al
Togo, sarebbe stato comunque preferibile il Camerun. Il giorno successivo,
neanche il rilievo dato da De Martino al grosso sforzo militare dell’Italia
in favore della causa comune, dopo il ritiro dalla guerra della Russia, valse,
sostanzialmente, a mutare la situazione, e così la Commissione non risolse
il problema in alcun modo, per cui si decise di rimandare ogni sistemazione definitiva al Consiglio dei Quattro94.
L’argomento trattato da Orlando nei suoi telegrammi a Colosimo riguardava pertanto solo la questione adriatica. Il 28 maggio scriveva al vice
Presidente, comunicandogli che Lloyd George lo aveva informato di un
piano per l’Italia, dichiarando che anche Wilson era d’accordo. La questione dell’Istria veniva risolta attribuendo a noi tutto il territorio del Patto di
Londra, fatta eccezione di un territorio fusiforme, che avrebbe costituito
uno Stato neutro sotto la garanzia della lega delle Nazioni, governato da
una Commissione di cinque membri, di cui due italiani, uno jugoslavo,
uno del luogo, e il quinto eletto dalle grandi potenze. Fiume avrebbe conservato la sua autonomia di corpus separatum. Dopo quindici anni, era
147
Vanni Clodomiro
previsto un plebiscito anche per zone. Orlando e gli altri colleghi della
delegazione, compreso il generale Diaz, trovarono tale soluzione, se non
proprio ottimale, comunque accettabile, data l’estrema difficoltà della
situazione e dato che, militarmente, la garanzia sarebbe consistita nella
neutralità dei territori. Era da considerarsi anche il fatto che la buona partecipazione dell’Italia al governo effettivo dei territori e il plebiscito finale
avrebbero potuto in parte attenuare i danni. Al contrario, forti difficoltà
si incontravano per Zara e Sebenico, che si voleva dichiarare città libere,
senza attribuirle alla sovranità italiana. Difficoltà sussistevano anche circa
l’attribuzione integrale all’Italia delle isole del patto di Londra:
Noi lottiamo vivamente per le più larghe concessioni su questi ultimi due punti; ma
non sembra che prevalgano idee di assoluta pregiudiziale. Ciò soprattutto per riguardo
alle immense difficoltà della situazione. Ti prego di chiedere subito udienza a Sua Maestà e di comunicargli quanto ti telegrafo per il di lui giudizio. Gradirò pure assai le tue
impressioni. Credo per ora premature comunicazioni ad altri, essendo sommamente
necessario che per ora queste trattative siano tenute segretissime95.
Nella riunione del 29 maggio, Orlando dichiarò che il progetto presentato poteva essere accettato come base di discussione, «sia pur con un senso
di grande sacrificio»96, a condizione però che Zara e Sebenico restassero
all’Italia, così come anche la maggior parte delle isole del patto di Londra,
tranne qualcuna di quelle che potevano avere una minore importanza per
l’Italia. Con sorpresa di Orlando, Wilson dichiarò subito che anch’egli accettava quel progetto come base di discussione. Tale dichiarazione apparve
ad Orlando in netto contrasto con quanto gli aveva detto quella stessa
mattina Lloyd George, il quale lo aveva informato che Wilson era intransigente sulla questione della Dalmazia e delle isole. Il nostro delegato Barzilai, anch’egli preoccupato della questione dalmata, telegrafava a Colosimo
parlandogli della questione di Fiume, delle isole dalmate, e anche delle
colonie97. Ma Colosimo nulla poteva fare dalla posizione in cui si trovava,
tempestato, come era, di ora in ora, dai telegrammi di Orlando, e costretto
quindi ad impegnare la maggior parte del suo tempo nel pesante ruolo di
presidente effettivo del Consiglio dei ministri.
Riguardo alle impressioni che Colosimo gli aveva comunicato – suffragato anche dal parere del re – circa una certa preoccupazione per il confine
strategico, il generale Diaz aveva preparato una bozza, che avrebbe potuto
soddisfare le esigenze di difesa del confine italiano, anche prescindendo
148
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
dalla garanzia derivante dalla neutralità dell’area antistante. Le previsioni
sul modo di applicazione del piano potevano, secondo Orlando, essere
buone, per effetto del miglioramento dei rapporti con Wilson. Lo stesso
giorno fu definito il confine italo-austriaco, con l’attribuzione all’Italia del
Brennero, nonché delle valli di Sexten e di Tarvis, compresa Tarvis. La
questione del triangolo di Assling fu fatta rinviare da Orlando, lieto per
l’attribuzione della due vallate, che andavano al di là del patto di Londra.
Circa le notizie da dare ai colleghi, Orlando scriveva a Colosimo che,
dai telegrammi ricevuti avrebbe potuto desumere la situazione. Riassumendo, il presidente del Consiglio diceva che, in sostanza, le condizioni
fin lì ottenute non comportavano poi «rinunzie dolorose od effettivamente
dannose»: l’unico punctum dolens rimaneva Fiume, anche se l’Italia sarebbe
entrata, unico Stato, con due membri su cinque in quel Governo. Ad ogni
modo, per chi fosse scontento o contento della soluzione, Orlando precisava: 1) che non era ancora detto che quella fosse definitivamente accettata
come tale, perché Wilson aveva avvertito che avrebbe voluto accordarsi
con gli slavi, e non era certo che questi accettassero; 2) che dalla determinazione dei particolari era probabile che nascessero grosse questioni capaci
di determinare la rottura. La situazione quindi non era pregiudicata ancora
nè in senso positivo, nè in senso negativo, ed era compito dell’abilità della
delegazione favorirne il buon esito finale. Ma quello che ad Orlando premeva di sottolineare era che la soluzione di Fiume poteva, tutto sommato,
essere accettata anche senza soverchia rassegnazione se si arriva ad una effettiva autonomia di Fiume […]98.
Chiese poi il conforto dei colleghi del governo e, avutolo, ne fu molto soddisfatto per la forza d’animo che un’apprezzabile manifestazione di
consenso gli dava, per fronteggiare i pericoli e le insidie di una situazione
complessivamente molto pesante. Prese poi a trattare, sia pure brevemente,
di una questione che stava molto a cuore a Colosimo: il bacino carbonifero
di Eraclea. Al riguardo, Wilson gli aveva promesso che avrebbe interposto
i suoi buoni uffici con Clemenceau per consentire che l’occupazione temporanea fosse lasciata all’Italia. Orlando avrebbe insistito. Ma, in effetti, la
sua vera preoccupazione era quella di definire le altre questioni, lasciando
in secondo piano le rivendicazioni coloniali, come d’altra parte dimostra il
carteggio fin qui esaminato, il quale poco o nulla dedica alle colonie: è vero
149
Vanni Clodomiro
che della soluzione di quel problema era incaricata la Commissione presieduta da Milner, ma, annche della relazione finale di quella Commissione
al Consiglio dei Quattro non si trova cenno nelle comunicazioni fatte al
vice presidente del Consiglio.
Quanto, infine, alla questione economica, Orlando riteneva evidente
che l’Italia avrebbe ottenuto una «quota proporzionata»99 ai suoi sacrifici.
Il 2 giugno la Jugoslavia dava a Wilson una risposta sostanzialmente
negativa al memorandum propostole. Questi glielo restituì «osservando
che essi dovevano dichiarare puramente e semplicemente se accettavano
su quelle basi»100. Il mattino successivo Orlando avrebbe dovuto vedere
Wilson per stringerlo e indurlo a procedere oltre nelle deliberazioni, anche
in caso di definitivo rifiuto degli slavi. Di quella stessa occasione, avrebbe approfittato per consegnare anche la bozza di Diaz, relativa a Fiume.
Si trattava, in sostanza, di cercare una via di conciliazione che Orlando
avrebbe comunque dovuto tentare, per evitare il salto nel buio di una lotta
ad oltranza contro tutti. La sera del 3 giugno, nel corso di un colloquio tra
lui e Wilson, cercò di ottenere ulteriori concessioni e garanzie relative alla
linea di frontiera col nuovo Stato, nonché altre garanzie ferroviarie relative
a Trieste. Wilson gli disse che stava ancora trattando con la Jugoslavia, la
quale faceva controproposte per l’Italia inaccettabili. Era dunque possibile
che la questione venisse totalmente riaperta e Orlando intendeva approfittare di ciò per chiedere miglioramenti delle condizioni già previste.
A noi, per la verità, tutto questo sembra un gioco di parole di Orlando,
il quale, mentre si sentiva dire che la Jugoslavia non accettava in pratica alcuna transazione, affermava di voler chiedere di più, fidando su una disponibilità – quella di Wilson – che era, alla resa dei conti, tutta da provare:
forse, s’illudeva di dimostrare ai colleghi del governo che qualcosa avrebbe
ottenuto, pur sapendo che la Jugoslavia sarebbe sempre rimasta rigida sulle
proprie posizioni. Comunque, si rendeva ben conto che la situazione si andava facendo tutt’altro che allegra e che una eventuale rottura non avrebbe
certamente giovato «agli interessi del Paese»101. In effetti, Wilson assumeva
il tipico atteggiamento dell’arbitro, pur nutrendo simpatia verso la Jugoslavia, alla quale, in risposta alle sue pretese su Klagenfurt, confermò di essere
sempre favorevole ai plebisciti.
Il pomeriggio del 4 giugno, Orlando ebbe un colloquio con Lloyd George,
al quale fece presente la necessità che la questione italiana fosse risolta – in
linea di massima – entro il 10 giugno: all’inizio della seconda metà del
150
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
mese, egli avrebbe dovuto infatti convocare il Parlamento per la questione del bilancio, e, in quell’occasione, ove le cose per l’Italia non fossero
ancora state definite, sarebbe stata certa la crisi ministeriale. Ciò avrebbe
comportato la conseguenza di rimettere tutto in questione, prolungando
in maniera indefinita e pericolosa lo svolgimento ulteriore dei lavori della
Conferenza:
Lloyd George mi parve sinceramente impressionato e mi disse che ne avrebbe parlato
personalmente a Wilson. Oggi vedrò Clemenceau sullo stesso argomento […]102.
Anche l’incontro del giorno dopo con Clemenceau sembrò sortire lo
stesso effetto. Orlando lo riferì a Lloyd George, dopo di che, sia quest’ultimo che Clemenceau decisero di parlarne con Wilson per esercitare pressione nel senso desiderato da Orlando. Infatti, il 6 giugno la questione fu
effettivamente trattata – ma in assenza del nostro rappresentante – e Wilson riconobbe la necessità che fosse risolta al più presto. Aggiunse anche
che stava formulando una specie di progetto che si riservava di far vedere
nel pomeriggio ai suoi esperti, e di cui avrebbe in seguito dato comunicazione allo stesso Orlando. Questi cercò di sapere da Lloyd George se tale
progetto prevedesse nuove rinunce da parte dell’Italia, e ne ricevette una
risposta «negativa, ma affatto generica»103.
Colosimo si recò subito dal re, il quale era inquieto, evidentemente
perché i giornali – per indiscrezioni da Parigi – pubblicavano, la mattina
del 9 giugno, la notizia che Wilson avrebbe negato Sebenico all’Italia. Colosimo espose al Re la situazione e questi gli rispose che, per le questioni
militari, avrebbe interpellato il ministro della Guerra. Ma, nel complesso,
Colosimo aveva ricevuto l’impressione di un turbamento di Vittorio Emanuele III, sia per le proposte Wilson in se stesse, sia per la ripercussione
che avrebbero potuto avere nel Paese, sia anche per «la difficoltà ad uscirne
convenientemente». Comunque, anche se non intendeva dare consigli, era
però dell’idea che, pur non rompendo, occorresse «dire francamente che le
proposte non erano soddisfacenti».
Colosimo aveva anche ricevuto da Parigi, quello stesso giorno, un telegramma di Barzilai, nel quale questi metteva in dubbio la scarsa energia
e sincerità con cui Wilson era disposto ad imporsi agli slavi, «che senza imposizione non accetteranno mai nulla», e che quindi era necessario
«mettere al muro l’americano». Inoltre, gli parlava di un progetto milita151
Vanni Clodomiro
re di Wilson sulla Georgia104. Infine, lo avvertiva che sarebbe partito da
Parigi Sinigaglia105, il quale era stato «lungamente coltivato ai fini della
maggiore moderazione»106. Il telegramma si concludeva con l’invito a Colosimo di intercedere presso Orlando, al fine di accelerare la definizione
della questione dalmata con un compromesso o col trattato. E pure a quel
telegramma, evidentemente, faceva riferimento la lettera di Colosimo a
Orlando, quando accennava alla questione della Georgia, sulla quale il
re si era mostrato contrario, dal momento che avrebbe impegnato circa
100.000 uomini
con pericolo interno nostro; con possibilità d’inquinamento dell’animo dei nostri soldati; con quasi certezza che non potremmo ricavarne benefici apprezzabili […]107.
Alle 23,30 dello stesso giorno, Colosimo riceveva da Orlando un telegramma, con cui veniva informato che nuovi passi erano stati fatti dal
nostro presidente nei confronti di Wilson, al quale aveva consegnato un
memorandum contenente un po’ la storia di tutte le trattative. Si metteva
in rilievo lo spirito di conciliazione da cui l’Italia era animata;
ma appunto tale allusione deve servire a persuadere che siamo arrivati ad un limite
estremo di concessioni, al di là del quale non possiamo andare. È mia impressione che
questa risposta (alla richiesta di Wilson di presentare il memorandum, n.d.r.) determinerà l’inizio di un nuovo periodo di asprezze da parte di Wilson108.
Nell’arco di un giorno, Orlando si attendeva una risposta dai tre grandi, e faceva tre ipotesi: 1) che volessero conversare in direzione di una
soluzione conciliativa; 2) che lasciassero cadere la cosa in via dilatoria; 3)
che assumessero un atteggiamento combattivo nei nostri confronti. E già
la sera stessa del 10 si andava delineando la prima ipotesi. Infatti, Clemenceau aveva accennato ad un’ulteriore transazione, in base alla quale si
sarebbero riesaminate le frontiere del nuovo Stato, e si sarebbe data Zara in
piena sovranità all’Italia. Orlando lasciò cadere quel discorso, mantenendo
ferma la pregiudiziale di non poter accettare riduzioni di sorta.
[…] La mia impressione è che le concessioni siano tutte verbali […]109.
Rimaneva così l’amarezza, nell’animo del nostro presidente , di non essere riuscito, di fatto, a concludere gran che su tutta la linea delle trattative.
152
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
La questione dei confini era tutta da stabilire, e il programma coloniale era
praticamente fallito. Intanto il tempo incalzava, e si rendeva urgente un suo
ritorno a Roma per verificare la posizione del Governo in Parlamento.
Orlando era ormai esaurito dallo sforzo mentale di «lottare in un manicomio»110 e, nella capitale francese, in effetti, non riusciva più ad esercitare
alcuna influenza. Un cambio della guardia al governo si rendeva a quel
punto inevitabile. Già il 21 maggio, a Oulx, in uno scompartimento ferroviario, si era tenuta una tempestosa riunione del Consiglio dei ministri
durante la quale Crespi aveva proposto le dimissioni del gabinetto: poi fu
messo in minoranza e fu ristabilita una «precaria unità»111. Ma, dopo gli
ultimi avvenimenti, andato alla Camera, il governo fu sconfitto il 19 giugno con 259 voti contrari e 78 favorevoli. Si concludevano così anche l’ultima esperienza ministeriale di Gaspare Colosimo e il suo sogno coloniale.
L’opinione pubblica italiana, conseguente all’andamento delle trattative, era in gran fermento. L’originario disaccordo sull’ingresso in guerra testimoniato dalla battaglia per l’intervento; la gravità della situazione
economica; il deprezzamento della lira; la crisi finanziaria che obbligava
a contrarre debiti: erano tutti elementi che concorrevano a determinare
quella nota «tensione rivoluzionaria manifestatasi con una serie di scioperi
in tutto il Paese, a partire dall’aprile del ’19»112.
In una siffatta atmosfera sociale ed economica, era chiaro che non
si manifestasse immediatamente la delusione per la soluzione coloniale.
Inoltre, di quanto si illuminava la stella del nazionalismo – quello, sì, era
indignato per l’andamento delle trattative – di tanto si oscurava quella del
colonialismo. Ma ciò non giustifica del tutto Orlando, non giustifica del
tutto la delegazione italiana a Parigi, non giustifica del tutto gli errori di
Sonnino, la cui presenza, in seno alla Commissione interalleata creata il 15
maggio, avrebbe potuto, forse, influire in maniera diversa sulle posizioni
dei rappresentanti dei grandi Paesi. Non giustifica, sopra tutto, la totale
mancanza di «tempestività» di tutta l’azione diplomatica italiana nella prospettiva della Conferenza di Versailles.
Orlando, ad esempio, nei momenti di sospensione delle riunioni, se
ne andava da solo a passeggio per le strade di Parigi, quasi sdegnando la
compagnia di qualsiasi statista degli altri Paesi: se si fosse comportato diversamente da questo punto di vista, avrebbe anche potuto, in qualche
occasione, prendere accordi personali con gli altri rappresentanti, o comunque, stabilire rapporti di autentica cordialità che gli avrebbero potuto
153
Vanni Clodomiro
rendere meno arduo il già difficile compito di ottenere parità di trattamenti, considerato anche che, in sostanza, all’Italia nessuno aveva «fatto la
corte», allo scopo di farsene un’alleata in guerra. Gli ondeggiamenti tra lo
schieramento della Triplice Alleanza e quello della Triplice Intesa ebbero
certamente il loro peso nella considerazione di cui poi godette la delegazione italiana a Parigi. Era stata l’Italia a chiedere le alleanze, a negoziare
prima con l’Austria, e poi – fallite su quel versante le speranze dei famosi
«compensi» – con l’Intesa. Questo, già in sé, doveva essere, per noi, un
motivo di ostilità diplomatica da parte degli Alleati: insomma, una certa
inferiorità dell’Italia – a parte i sacrifici di guerra – nei confronti delle tre
potenze alleate era insita nelle cose stesse. Ma se, a tale inconveniente, qualcuno dei nostri rappresentanti avesse cercato di ovviare, magari cercando le
simpatie personali di qualcuno dei grandi , le cose sarebbero andate meglio
(diciamo meglio, perché, dopo tutto, veramente male non andarono). Fu
anche l’attività di corridoio (dai nostri sempre sdegnata) quella che mancò
alla rappresentanza italiana. Si sa bene come siano importanti certe prassi
nelle trattative di qualsiasi genere.
Gli Alleati, comunque, non vollero realmente associare l’Italia alla vittoria; e al fascismo, dopo, fu ancora più facile avvicinarsi alla Germania
(d’altra parte un timore che ciò avvenisse si era fatto strada nell’animo di
qualcuno dei tre anche durante la stessa Conferenza di Parigi, e precisamente, come abbiamo accennato113, nel mese di maggio).
Ad ogni modo, come andavamo appena accennando, non si può dire
che le cose siano davvero andate male per l’Italia: su questo punto, concorda ormai quasi tutta la letteratura storiografica in proposito. Male andò
veramente la questione delle Colonie. Ma per il resto, in effetti, l’Italia
ebbe molto di più di quanto – specie i nazionalisti – non si fosse disposti
ad ammettere: una quota delle riparazioni tedesche; un seggio permanente
nella Società delle Nazioni; la frontiera del Brennero; una zona slovena
intorno a Tardisio (al di là delle previsioni del patto di Londra); l’assegnazione della maggior parte della flotta mercantile austriaca; infine, e sopra
tutto, la frantumazione dell’Austria-Ungheria: erano conquiste che dovevano essere ritenute di piena soddisfazione. Anzi, più delle altre nazioni,
l’Italia riusciva vincitrice dalla lotta bellica: al posto di una potenza grande
e tradizionalmente ostile, si trovò vicini piccoli o medi Stati, alla testa dei
quali si sarebbe potuta anche mettere, ove si fosse data minore retta alle
pressioni antislave sempre esercitate da Sonnino114.
154
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
Note al testo
1
Per una biografia di Gaspare Colosimo (1859-1944), cfr. G. Masi, Colosimo Gaspare, in
Dizionario biografico degli italiani , vol. XXVII, pp. 472-474. Sul Ministro Colosimo, si
veda anche: C. Gasbarri, La politica africana dell’Italia nelle carte di Colosimo, in «Africa», settembre 1973, pp. 439-460. Nella nota del Gasbarri, data la cura della descrizione
dei fascicoli delle 12 buste di cui si compone il Fondo, è possibile rinvenire il processo
degli avvenimenti dal 1916 alla fine del 1918, specie per quanto riguarda la Cirenaica e
la Tripolitania, che erano l’oggetto specifico della ricerca del Gasbarri. Ma anche per il
rimanente periodo la descrizione è abbastanza puntuale. Si veda poi: a. GarCea, La corrispondenza Orlando-Colosimo (1919 maggio 7-giugno 12), in «Rivista Storica Calabrese»,
a. XIV, 1993, pp. 317-334; dello stesso a. GarCea, Le fonti per la storia della politica
coloniale italiana nell’Archivio Colosimo, in Fonti e problemi della politica coloniale italiana», Atti del Convegno, Taormina (ME), 23-29 ottobre 1989, Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, Roma 1996, pp. 149-155. Per quanto riguarda il testo del Diario, avvertiamo
che ogni documento è rigorosamente conforme all’originale e che pertanto ogni incon gruenza stilistica, sintattica o grammaticale appartiene al documento stesso.
2
Colosimo sostiene, negli appunti autobiograficimessi in appendice al suo Diario, che la sua
bozza di accordo costituì la base sulla quale poi si mosse Mussolini nel 1929.
3
Il 16 dicembre 1918, nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri, sottolineava ancora la propria tesi. Cfr., in proposito, s. sonnino, Diario (1916-1922), a cura di P. Pastorelli,
Bari 1972, vol. III, p. 319.
4
V. E. Orlando, dal discorso in memoria di Gaspare Colosimo, tenuto al teatro Bellini di
Napoli il 18 marzo 1945.
5
Ibidem.
6
Si veda, in proposito, G. ColosiMo, Relazione sulla situazione politica economica ed amministrativa delle Colonie italiane, presentata al Parlamento nella tornata del 23 febbraio
1918, Tipografia del Senato, Roma 1918, pp. 514, oltre a 22 allegati, 8 carte e 1 tavola.
7
Opera tratta dagli scritti di Gaspare Colosimo, p. 6. Il libro (peccato che sia praticamente
privo di riferimenti bibliografici), curato dal figlio Maurizio, fu stampato a Pompei, presso
la Tipografia Pontificia Bartolo Longo nel maggio 1959. Il secondo volume, Articoli giovanili di Gaspare Colosimo, è una semplice raccolta – sempre curata dal figlio – di articoli
giornalistici, tratti dalle varie riviste con cui Colosimo collaborò. Fu stampato a Napoli,
nella Tipografia di Amitrano nel 1960. Inoltre, alcuni scritti critici di Gaspare Colosimo
sono inseriti in Affrica Italiana. Programma massimo e programma minimo di sistemazione dei possedimenti italiani nell’Affrica orientale e settentrionale, voll. I, II (in 3 tomi), III,
Tipografia del Senato, Roma 1917, 1919, 1920; nel volume Misurata, Tipografia del Senato, Roma 1918; nel volume Trattati, convenzioni, accordi e protocolli ed altri documenti
relativi all’Africa, Tipografia del Senato, Roma 1917; infine, nel volume Arabia, voll. I,
II, III, IV, Tipografia del Senato, Roma 1919. Si tratta di una raccolta molto preziosa di documenti, predisposta dal ministro allo scopo di preparare tutti i dati necessari per le future
trattative e le discussioni in seno alla conferenza della pace. Quello scopo di Colosimo non
fu raggiunto, ma la raccolta rimane comunque un utilissimo mezzo di indagine sull’Africa
e sull’Asia, oltre che su molti aspetti della politica nazionale dell’Italia.
8
Archivio di Stato di Catanzaro (d’ora in poi ASC), Fondo Colosimo (d’ora in avanti F.C.),
b. 8,f. IV, anno1918. Programma minimo.
9
Jan Christaan Smuts (1870-1950), militare e uomo politico sudafricano, di origine olande-
155
Vanni Clodomiro
se. Durante il primo conflitto mondiale, partecipò col generale Botha alla conquista delle
colonie tedesche e rappresentò l’Unione Sudafricana nel consiglio di guerra dell’impero
britannico. Fu lui a far adottare il termine Commonwealt per designare l’insieme formato
dall’Impero e dai dominions.
10
ASC, F.C. , b. 8, f. IV, a. 1918. Lettera dell’8 febbraio 1918.
11
Cfr. P. renouvin, Histoires des relations internationales, Paris 1953; trad. it. Roma 1975,
p. 144.
12
ASC, F.C., b. 8, f. IV, a. 1918. Lettera del 3 giugno 1918.
13
Ibidem. Lettera del 7 giugno.
14
Ibidem.
15
ASC, F.C. , b. 8, f. IV, a. 1918. Lettera del 7 giugno.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
M. TosCano, Pagine di storia diplomatica contemporanea, vol. I, Milano 1963, p. 219.
19
ASC, F.C. , b. 8, f. IV, a. 1918.
20
«La Depeche Coloniale et Maritime», 4 ottobre 1918; l’articolo era partito da Amsterdam
il 3 ottobre.
21
ASC, F.C., b. 8, f. IV, a. 1918. Telegramma dell’8 ottobre.
22
r. De FeliCe, D’Annunzio politico, Roma-Bari 1978, p. 5.
23
G. MonDaini, Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d’Italia, parte I, Storia
coloniale, Roma 1927, p. 397.
24
J. L. MièGe, L’imperialismo coloniale italiano dal 1870 ai giorni nostri, Milano 1976, p.
110.
25
Da e. anChieri, Antologia storico-diplomatica, Milano 1941, pp. 359-361.
26
ASC, F.C., b. 8, f. IV, a. 1918. Telegramma del 30 ottobre.
27
Giuseppe Volpi, conte di Misurata (1877-1947), finanziere, industriale e uomo politico, nel
1912 ebbe parte nei negoziati che portarono alla pace di Ouchy.Nel 1919 fu anche delegato
alla Conferenza della pace di Parigi.
28
ASC, F.C., Frammenti del Diario (d’ora in poi Diario). Colloquio tra Orlando a Colosimo
del 15 ottobre 1918.
29
P. PasTorelli, Le carte Colosimo, in «Storia e Politica», aprile 1976, p. 368.
30
Vedi anche J. L. MièGe, L’imperialismo coloniale italiano cit. , p. 103.
31
Vedi P. PasTorelli, Le carte Colosimo cit. , p. 370.
32
ASC, F. C., Diario. Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1918.
33
P. PasTorelli, Le carte Colosimo cit. , p. 376.
34
ASC, F. C., Diario. Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1918.
Cfr., in proposito, r. De FeliCe, Mussolini il rivoluzionario (1883-1920), Torino 1965, p.
455.
36
Ibidem.
35
37
P. PasTorelli, Le carte Colosimo cit. , p. 377.
156
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
38
Cfr. a. Gaibi, Manuale di storia politico-militare delle colonie italiane, Roma 1928, pp.
545 ss.
39
ASC, F.C., Diario. Introduzione agli appunti relativi al 1919.
40
Ibidem. Telegramma augurale dell’1 gennaio 1919 al generale Garioni, governatore della
Tripolitania e reggente della Cirenaica.
41
ASC, F.C., b. 10, f. X, a. 1919. Il Convegno cui si riferisce Colosimo era stato organizzato dall’Istituto Coloniale già dall’ottobre 1918 e si tenne dal 15 al 21 gennaio 1919. Il
Convegno si svolse in tre sessioni: una economica, una per l’emigrazione, e una politica.
Quest’ultima aveva trattato il tema delle questioni della Somalia, dell’Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica nei rapporti internazionali. Vedi: Atti del Convegno nazionale coloniale, Roma 1920; l. Ferraris, A proposito del congresso nazionale di Roma, in «Nuova
Antologia», febbraio 1919, p. 342.
42
ASC, F.C., b. 7, f. IV, a. 1916-1919. Telegramma del 29 gennaio 1919.
43
Ibidem. Telegramma del 30 gennaio.
44
André Tardieu (1876-1945), ministro delle terre liberate e rappresentante francese alla
Conferenza della pace, vi portava una sfumatura intransigente anche rispetto all’estremismo di Clemenceau.
45
ASC, F.C. , b. 7, f. IV, a. 1916-1919. Telegramma del 31 gennaio.
46
Ibidem.
47
J. L. MièGe, L’imperialismo coloniale italiano cit. , p. 111.
48
Cfr. M. TosCano, Pagine di storia diplomatica cit. , pp. 220-21.
49
ASC, F.C., b. 7, f. IV, a. 1916-1919. Telegramma del 31 gennaio.
50
Ibidem.
51
ASC, F. C. , b. 8, f. V, a. 1919. Telegramma di Colosimo ad Orlando del 12 febbraio.
52
M. TosCano, Pagine di storia diplomatica cit. , p. 223.
53
Questa era la sostanza del telegramma collettivo del 3 maggio (Bonin, Crespi, De Martino,
Imperiali), che il giorno successivo aveva indotto Sonnino ad annunziare la partenza.
54
Sull’intervento di Foch alla Conferenza della Pace, si veda S.CresPi, Alla difesa d’Italia in
guerra ed a Versailles, Milano 1941, p. 529.
55
ASC, F.C., b. 8, f. V, a. 1919. Telegramma del 7 maggio. Sulla riunione dei Quattro di quel
giorno e sul profondo abbattimento di Orlando a causa della spartizione delle colonie ex
tedesche (di cui il documento non parla), si veda S.CresPi, Alla difesa d’Italia in guerra
cit., pp. 539-40. In a. salanDra, I retroscena di Versailles, Milano 1971, p. 131, si trova il
resoconto di un colloquio del 6 maggio con Colosimo, molto duro e intransigente riguardo
al comportamento troppo remissivo e comunque sterile di Orlando e Sonnino.
56
Archivio di Stato di Napoli, Carte Colosimo, b. 3. Telegramma n. 4 dell’8 maggio.
57
Ibidem. Telegramma n. 5 dell’8 maggio.
58
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma dell’8 maggio.
59
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 10 maggio.
Orlando intendeva adottare tale tattica, nella speranza che l’Italia riuscisse a resistere per
altri diciotto mesi: così Wilson non sarebbe stato più presidente e la situazione sarebbe
60
157
Vanni Clodomiro
migliorata di molto. Cfr. in proposito o. MalaGoDi, Conversazioni di guerra (1914-1919),
a cura di B. Vigezzi, Milano-Napoli 1960, II, pp. 670-72, 687.
61
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma dell’11 maggio.
62
Sullo scoramento di Orlando di quel giorno, si veda S.CresPi, Alla difesa d’Italia cit. , pp.
248-49.
63
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 12 maggio.
64
Il reatino Augusto Ciuffelli all’Industria e il reggino Giuseppe De Nava ai Trasporti rappresentavano nel gabinetto la nuance giolittiana più favorevole al presidente Orlando.
65
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 12 maggio, ore 21,40.
66
Ibidem. Telegramma del 12 maggio, ore 24.
67
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 14 maggio.
68
Ibidem. Su questa sfasatura tra governo e Paese si veda anche S.CresPi, Alla difesa d’Italia
cit. , p. 561.
69
Ibidem.
70
Cfr., in proposito, a. salanDra, I retroscena di Versailles cit., circa il colloquio di Salandra
con Vincenzo Riccio, ministro dell’Agricoltura.
71
Il visconte Alfredo Milner (1854-1925) era il principale collaboratore di Lloyd George nel
gabinetto di guerra inglese, così come Giacomo De Martino influenzava da lungo tempo
la politica della Consulta.
72
Su questo colloquio, vedi anche M. TosCano, Pagine di storia diplomatica cit. , p. 227.
73
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 15 maggio.
74
Agenzia Stefani. Roma, comunicato del 15 maggio.
75
La proposta si riferiva alla possibilità di un compenso per l’Inghilterra nella regione del
lago Tana.
76
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 15 maggio.
77
Ibidem. La nota accennata da Orlando si riferisce, evidentemente, all’idea espressa da
Colosimo sullo sfruttamento economico dell’Angola. Milner , in proposito, si mostrò più
disponibile circa la possibilità, per l’Italia, di svolgere trattative dirette col Portogallo.
78
ASC, F.C., Diario. Resoconto del 5 gennaio 1917.
79
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 15 maggio, ore 23,50.
80
Non riteniamo del tutto inspiegabile l’ostilità di Clemenceau verso l’Italia, se consideriamo le voci che gli continuavano a pervenire, proprio durante il mese di maggio, di un’alleanza italo-tedesca, oltre che di manifestazioni antifrancesi a Milano e in altre città italiane.
Sul colloquio «tempestoso» tra Clemenceau e Orlando, c’è un telegramma di quest’ultimo
a Colosimo del 25 maggio. Le notizie dall’Italia erano state fornite a Clemenceau da Barrère.
81
Si riferisce, con tutta probabilità, all’ipotesi di scioglimento della Camera ventilato come
mezzo di pressione su un opinione pubblica eccitatissima per Fiume.
82
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 16 maggio.
83
Si riferisce all’occupazione di Smirne da parte della Grecia, avvenuta il 16 maggio. Ciò costituì per l’Italia uno smacco, sia pure mitigato dalla decisione alleata di far sbarcare, insie-
158
Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo
me con le truppe greche, alcuni contin genti francesi, inglesi e italiani. Secondo l’Agenzia
Stefani (comunicato da Parigi del 16 maggio) quello sbarco aveva lo «scopo di proteggere
la popolazione di Smirne contro disordini o massacri». Intanto Sonnino, senza informare
nè gli Alleati, nè Colosimo, nè lo stesso Orlando, faceva occupare altri punti della costa
anatolica, ad ovest di Adalia. Data la situazione, sembrava imminente, verso la fine del
mese, uno scontro italo-greco. Come è noto, Smirne sarebbe poi rimasta alla Grecia.
84
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 19 maggio, ore 0,45.
85
Ibidem. Telegramma del 19 maggio, ore 10,20.
Cfr. M. TosCano, Pagine di storia diplomatica cit., p.230; J. L . MièGe, L’imperialismo
coloniale italiano cit., p. 120.
87
Cfr. r. serToli salis, Storia e politica coloniale italiana, Messina-Milano 19386, p. 197.
86
88
L’unica spiegazione potrebbe consistere nel fatto che Colosimo, nel suo Diario, proprio
ri guardo all’anno 1919, avverte che la documentazione è più scarsa, dati i suoi impegni
maggiori, derivanti dal fatto di essere lui a svolgere le ef fettive funzioni di presidente del
Consiglio. Mancano comunque anche i telegrammi cui Orlando fa cenno nei suoi.
89
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 22 maggio, ore 22,50.
90
Il famoso ed influentissimo colonnello Edward House era il rappresentante personale e
molto più che sempice consigliere del Presidente Wilson.
91
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 24 maggio.
92
Ibidem. Telegramma del 26 maggio, ore 23,50.
93
Ibidem. Telegramma del 27 maggio.
94
Per un resoconto dettagliato di quelle riunioni e della relazione finale da sottoporre ai
Quattro, vedi M. TosCano, Pagine di storia diplomatica cit., pp. 232-40.
95
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 28 maggio.
96
Ibidem. Telegramma del 29 maggio.
97
Archivio di Stato di Napoli, Carte Colosimo, b. 3, telegramma n. 67 del 31 maggio.
98
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 30 maggio.
99
Ibidem. Telegramma del 1 giugno.
100
Ibidem. Telegramma del 2 giugno, ore 23,50.
101
Ibidem. Telegramma del 4 giugno.
102
Ibidem. Telegramma del 5 giugno.
103
Ibidem. Telegramma del 6 giugno.
104
Regione meridionale del Caucaso.
L’ingegnere Sinigaglia costituiva in quei mesi, grazie ai suoi stretti rapporti sia con Nitti
che col socialismo riformista, uno dei maggiori ed influenti punti di mediazione nell’area
politica nazionale.
105
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 9 giugno. Si tenga presente che
Barzilai si sentiva personalmente coinvolto nella questione, in quanto era triestino.
106
Archivio Centrale dello Stato, Carte Orlando, b. 3, f. Colosimo Gaspare. Lettera di Colosimo a Orlando del 9 giugno.
107
159
Vanni Clodomiro
108
ASC, F.C., b. 12, f. XXVI, a. 1916-1919. Telegramma del 9 giugno.
109
Ibidem. Telegramma del 10 giugno.
110
o. MalaGoDi, Conversazioni di guerra cit., p. 696.
C. seTon–WaTson, Italy from Liberalism to fascism: 1870-1925, trad. it. L. Trevisani, Bari
1967, p. 614. Si veda anche S.CresPi, Alla difesa d’Italia cit., p. 584.
111
v. CloDoMiro, I moti per il carovita e il processo di Catanzaro, in «Rivista Abruzzese di
Studi Storici dal fascismo alla Resistenza», luglio 1982, p. 274.
112
113
Cfr. la nota n. 93.
Cfr., in proposito, anche C. seTon–WaTson, Italy from liberalism to fascism cit., pp. 61213; P. Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale, Torino 19686, p. 205; P. renouvin,
Histoires des relations internationales cit., pp.178 ss.
114
160
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana
italiana. Un primo sondaggio
di Marco Lenci e Sergio Baccelli
A tutti è capitato, passeggiando per città e paesi d’Italia, di imbattersi
in aree di circolazione – termine tecnico indicante le diverse articolazioni
del reticolo urbano rappresentate da vie, viali, corsi, piazze, piazzali, ecc...
– la cui denominazione indiscutibilmente evoca località, fatti e personaggi
connessi con l’epopea coloniale. Che la pagina coloniale della nostra storia
nazionale abbia lasciato tracce ben riconoscibili anche nella toponomastica
urbana non è del resto sfuggito agli studiosi1. Nel quadro della progressiva
ed inarrestabile ideologizzazione che, a partire dal ciclone rivoluzionario
francese, ha caratterizzato il modellamento del sistema odonomastico italiano (in sintonia con quanto avveniva nel resto d’Europa) era pressoché
inevitabile che su di esso si riflettessero anche le esigenze celebrative volte a
fissare stabilmente nella coscienza nazionale il fatto coloniale.
Avviata nel 1869 con l’acquisizione di Assab da parte della compagnia
Rubattino (quindi ancor prima che l’unità nazionale trovasse il suo pieno
compimento con la presa di Roma e poi con il riscatto delle terre irredente
del Trentino e della Venezia Giulia), la stagione coloniale nella sua fase
liberale, in pratica sino alla guerra di Libia, venne letta (ed esaltata) come
logica estensione della spinta risorgimentale, quasi fosse il necessario esito
della missione storica della nuova Italia chiamata a conquistarsi un posto di
rispetto nell’arena internazionale. Così concepite e vissute «le guerre coloniali furono a tutti gli effetti guerre nazionali, con mobilitazione dell’onore
della bandiera e dispiegamento di mezzi e ideologie e con sforzo pedagogico che investì a pieno anche le istituzioni scolastiche»2. Ciò fu ben recepito
anche in ambito toponomastico e così non è raro scoprire città e paesi in
cui aree di circolazione celebrative di battaglie ed eroi risorgimentali e/o
collegati con l’epopea della Grande Guerra corrono parallele o si intersecano con altre esaltanti fatti bellici e personaggi connessi all’epopea coloniale3. Pare quasi inutile rilevare – tanto il fenomeno è notorio - che il fasci161
Marco Lenci e Sergio Baccelli
smo, con le sue pulsioni imperiali ed autocelebrative, si inserì poi con forza
in tale alveo producendo, se così si può dire, una seconda energica ondata
nel processo di «africanizzazione» del panorama odonomastico italiano.
Quanto sin qui affermato non brilla certo per originalità. E tuttavia,
pur nella sua scontata ovvietà, il fenomeno non pare essere stato ancora
adeguatamente indagato; se ne sono colti di certo i dati salienti, traendone
conclusioni sensate e condivisibili, ma sinora lo si è fatto, per così dire, solo
a livello impressionistico. Per oltrepassare tale limite era necessario procedere ad una ricerca mirante a fornire in primo luogo alcuni dati precisi e
inequivocabili circa le sue reali dimensioni. Si trattava di rispondere alla
seguente domanda: quante strade, piazze, viali, vie... di valenza coloniale
esistono in Italia? Quesito elementare che sinora è rimasto sostanzialmente
inevaso; ciò è accaduto certamente «perché, tranne pochi singoli casi, e
nonostante il grande fiorire di collane sulla storia delle regioni e delle città
d’Italia, lo studio della toponomastica come indice della storia politica e
della mentalità a livello locale è stato in genere trascurato»4. Ma ancor più
– riteniamo - per l’oggettiva difficoltà che sino a poco tempo fa incontrava
il ricercatore intenzionato ad avviare un’indagine toponomastica su vasta
scala. Se non era eccessivamente difficile infatti reperire dati per singole
grandi realtà urbane - segnatamente Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo - per le quali erano disponibili stradari di una buona affidabilità5, ben
più arduo sarebbe stato spingere l’indagine più in là, estendendola o all’insieme dei capoluoghi di provincia o ai centri più significativi per dimensione demografica oppure – in un encomiabile sforzo di completezza – indistintamente a tutti gli oltre ottomila comuni disseminati nella Penisola. In
ogni caso si sarebbe trattato di operazioni se non impossibili, certamente
assai gravose in termini di tempo e di impegno al punto tale da scoraggiare
anche lo studioso più caparbio. Oggi grazie ad internet la realtà è radicalmente diversa. Attraverso la rete infatti è non solo possibile accedere con
estrema facilità agli stradari di tutti i comuni italiani6, ma si può, partendo da quelli stessi stradari, impostare ogni tipo di indagine. Considerata
una denominazione (ad esempio quella pressoché onnipresente celebrante
Giuseppe Garibaldi) è possibile scoprirne la diffusione (comunale, provinciale, regionale e nazionale) nonché la tipologia dell’area di circolazione ad
essa assegnata nelle singole località (via, corso, piazzale...).
Proprio sfruttando tali nuovi e fondamentali ausili disponibili in rete
abbiamo intrapreso in maniera sistematica una ricerca a largo spettro sui
162
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
toponimi urbani d’afferenza coloniale. Prima di fornire gli esiti di tale sondaggio ed avanzare qualche commento al loro riguardo ci corre l’obbligo
di illustrare i criteri e le modalità a cui ci siamo attenuti nel corso dell’indagine.
Al momento di iniziare il nostro studio avevamo ben presente che per
giungere a risultati davvero conclusivi avremmo dovuto condurre una ricerca che considerasse al tempo stesso l’intero universo dei possibili toponimi d’origine coloniale e l’insieme complessivo dei comuni italiani. Non
avendo – almeno al presente - la grandissima disponibilità di tempo che
una simile ricerca, sia pure condotta con l’ausilio delle più recenti disponibilità telematiche, avrebbe richiesto, ci siamo trovati nella necessità di
dover restringere il campo d’indagine. Precisiamo subito che ciò abbiamo
fatto non tanto sul versante onomastico; anzi sotto quest’ultimo aspetto il
sondaggio si presenta (pur con alcune puntualizzazioni che illustreremo di
qui a poco) assai vicino alla completezza; vi possono certo essere delle mancanze, ma l’aver operato sulla base di una griglia di denominazioni composta da ben 128 elementi ci rende sicuri di non aver compiuto omissioni
troppo gravi (omissioni che altri studiosi potranno comunque sempre colmare). Là dove abbiamo operato un consistente restringimento di campo
è stato invece sul piano dell’area geografica di riferimento. Abbiamo condotto infatti la ricerca limitandola ai soli capoluoghi di provincia7, sicché
il totale delle città considerate ammonta a 112; si tratta di un insieme di
centri grandi e piccoli che da soli coprono (sulla base del censimento del
2001) il 29,91 per cento della popolazione italiana.
I nomi coloniali considerati sono stati – lo ripetiamo – 128. Essi possono dividersi in tre grandi classi concernenti rispettivamente entità geografiche variamente intese (colonie, regioni, città, centri minori, oasi, fiumi
ecc.), fatti d’arme e personaggi. Va da sé che tale distinzione in merito alle
prime due categorie (entità geografiche e fatti d’arme) non deve essere
considerata in maniera rigida: ad esempio un’area di circolazione intitolata
ad Adua può ben rientrare con eguale validità nei due ambiti potendo rievocare al contempo sia la sanguinosa battaglia del 1896 che il capoluogo
del commissariato del Tigrè occidentale compreso territorialmente entro i
confini del governo dell’Eritrea sulla base della legge con cui, il 1° giugno
1936, venne istituita l’Africa Orientale Italiana.
Sul piano più propriamente territoriale le denominazioni scelte si situano nei due grandi insiemi in cui si articolò il dominio coloniale italiano:
163
Marco Lenci e Sergio Baccelli
quello afferente ai possedimenti localizzati nel Corno d’Africa, per un totale di 45 denominazioni (di cui 23 concernenti l’Etiopia, 12 la Somalia,
10 l’Eritrea) e l’altro relativo alla Libia (38 denominazioni). I toponimi
afferenti al primo insieme sono i seguenti: Abba Garima, Addis Abeba,
Adigrat, Adua, Agordat, Amba Alagi, Amba Aradam, Ascianghi, Asmara,
Assab, Axum, Benadir, Brava, Cassala8, Cheren, Chisimaio, Coatit, Dancalia, Daua Parma, Dessiè, Dire Daua, Dogali, Endertà, Eritrea, Etiopia,
Galla e Sidamo, Ganale Doria, Gimma, Giuba, Giumbo, Gondar, Harar,
Lago Tana, Macallè, Massaua, Merca, Migiurtinia, Mogadiscio, Neghelli,
Obbia, Ogaden, Sciré, Somalia, Tembien, Tigrè.
Al contesto libico si riferiscono invece le seguenti denominazioni: Ain
Zara , Azizia, Barce, Bardia, Bengasi, Bir Acheim, Bu Meliana, Cirenaica,
Cirene, Cufra, Cunfida9, Derna, Fezzan, Gadames, Garian, Gebel, Ghirza,
Giarabub, Homs, Leptis Magna, Libia, Marada, Marmarica, Misurata, Sabrata, Sciara Sciat, Sirte, Sirtica, Sollum, Tagiura, Tibesti, Tobruk, Tocra,
Tolmetta, Tripoli, Tripolitania, Zanzur, Zuara.
Possibile, ancorché intuitiva, una distinzione d’ordine cronologico
tra intitolazioni celebranti località e fatti (nonché personaggi) ascrivibili
all’epoca della prima guerra d’Africa (quella compresa, in maniera estesa,
tra l’acquisizione di Assab nel 1869 e la fine del XIX secolo) ed i toponimi
riferibili all’epopea libica. Altre intitolazioni celebrano località, episodi ed
uomini connessi con la fase fascista del colonialismo ed in primo luogo
con la guerra d’Etiopia. Ci si riferisce – sia ben chiaro – al contenuto delle
denominazioni, non già alla data di effettiva intitolazione delle singole aree
di circolazione. A quest’ultimo riguardo merita ricordare che il fascismo
non si limitò a celebrare solo i propri fasti coloniali, ma favorì pure un
rilancio delle denominazioni più antiche connesse alla prima esperienza
eritrea, all’impresa di Libia ed all’esaltazione di quei personaggi (militari,
ma anche esploratori, missionari, amministratori) ai quali fu dal regime
assegnato l’appellativo di «pionieri»dell’impero coloniale italiano10.
Precisiamo infine che nel nostro computo non sono stati considerati quei toponimi collegati inequivocabilmente alle vicende della seconda
guerra mondiale che interessarono lo scacchiere africano sotto controllo
italiano giacché essi evocano fatti che in realtà appartengono ad un contesto storico affatto diverso e che quindi possono essere coloniali solo in
senso lato. Ciò vale, ad esempio, per il caso della battaglia di el-Alamein,
episodio che pure risulta discretamente celebrato un po’ in tutta Italia11.
164
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Analogamente abbiamo proceduto per quelle personalità che, sempre
nel corso del secondo conflitto mondiale e sempre sullo scenario africano,
pur riuscirono a conquistarsi una fama tale da poter avere poi una qualche
ricaduta toponomastica12.
Pur ammettendo tutte le eventuali omissioni e le possibili dimenticanze
compiute, circa le denominazioni geografiche (sia intese in senso stretto
che come località inerenti a particolari fatti d’arme), non pare necessario
fornire ulteriori delucidazioni in merito al criterio sulla base del quale esse
sono state selezionate. Qualche supplementare precisazione invece la dobbiamo al lettore per illustrare i criteri con cui abbiamo scelto i toponimi
concernenti singole personalità. In quest’ultimo settore sapevamo in partenza che, anche volendolo, non avremmo mai potuto nemmeno sperare
di riuscire a censire «tutti» coloro che, a vario titolo, avendo legato la loro
esistenza alla pagina africana della storia italiana, hanno poi visto celebrato
il proprio nome in ambito toponomastico. Di certo, per quanto grande
fosse stato il nostro scrupolo, non saremmo mai riusciti ad intercettare
quanti ebbero a godere di una gloria eminentemente localistica13. Abbiamo così optato per considerare nel nostro novero solo coloro le cui gesta
furono ampiamente illuminate dalla retorica nazionale e che, di conseguenza, trovano ancora oggi ampia ospitalità nei testi storici di argomento
coloniale. Insomma abbiamo scelto personaggi di sicuro spessore nazionale, il cui nome evoca tuttora scenari africani e/o coloniali per lo meno alla
persona di media cultura (un esempio per tutti: chi non ha mai incontrato
nelle proprie letture l’esploratore Vittorio Bottego o l’eroe di Macallè Giuseppe Galliano?) oppure elementi (ed i più appartengono di sicuro a tale
categoria), magari oggi del tutto dimenticati o quasi, ma che ebbero un
loro indiscutibile peso nella vicenda coloniale e nell’immaginario collettivo
che da essa trasse spunto. Con tutta l’arbitrarietà e le sovrapposizioni che
una simile catalogazione comporta, possiamo suddividere le 45 personalità
censite nelle seguenti categorie: esploratori, geografi, viaggiatori (Orazio
Antinori, Odoardo Beccari, Giovanni Beltrame, Gustavo Bianchi, Vittorio
Bottego, Manfredo Camperio, Gaetano Casati, Antonio Cecchi, Giovanni
Chiarini, Ugo Ferrandi, Raimondo Franchetti, Augusto Franzoi, Romolo
Gessi, Giuseppe Maria Giulietti, Pellegrino Matteucci, Giovanni Miani,
Cesare Nerazzini, Carlo Piaggia, Gian Pietro Porro, Luigi Robecchi Bricchetti, Eugenio Ruspoli; Maurizio Sacchi, Augusto Salimbeni, Giuseppe
Sapeto, Leopoldo Traversi); politici, amministratori civili, diplomatici
165
Marco Lenci e Sergio Baccelli
(Pietro Antonelli, Ferdinando Martini); militari caduti in combattimento
(Giuseppe Arimondi, Lionello Bettini, Dalmazio Birago, Francesco Carchidio, Vittorio Dabormida, Tommaso De Cristoforis, Giuseppe Galliano,
Antonio Locatelli, Tito Minniti, Pietro Toselli); militari comandanti e amministratori (Antonio Baldissera, Umberto Cagni, Enrico Millo, Marcello
Prestinari); missionari (Daniele Comboni, Giustino De Jacobis, Reginaldo
Giuliani, Guglielmo Massaia).
Diamo per scontato di aver compiuto esclusioni più o meno gravi o inclusioni, che possono apparire arbitrarie anche alla luce dei criteri selettivi
da noi predisposti. In altri termini siamo consapevoli di aver compiuto un
lavoro parziale che comunque crediamo possa suscitare un qualche interesse e risultare utile come primo approccio oggettivo ad una materia sinora
– lo ribadiamo - trattata unicamente in maniera approssimativa sulla base
di pochi e flebili riscontri quantitativi. Il nostro altro non ha voluto essere
che un lavoro iniziale. Quanti vorranno correggerlo, integrarlo, arricchirlo
dovranno – a nostro parere – impegnarsi in prima battuta in un più vasto
lavoro di acquisizione dei dati estendendo l’indagine a tutto l’insieme dei
comuni italiani. Solo in tal modo si potrà – ad esempio – valutare a pieno
quanto l’ideologia coloniale sia penetrata nel tessuto profondo della nazione, costituito oggi, ma ancor più negli anni in cui il miraggio africano
fu presente al massimo nella mente degli italiani, da varie città di medie e
piccole e da minuscoli paesi. Non mancheranno di certo interessanti risultati, almeno questo sembra indicare l’esito di alcuni nostri primi e parziali
sondaggi, basati per altro su una griglia di denominazioni decisamente più
contenuta (20 voci14 contro 128 di quella da noi impiegata per i capoluoghi di provincia). A puro scopo esemplificativo ricordiamo che la siciliana
Licata (37.976 ab. nel 2001) possiede ben 13 denominazioni coloniali;
la piemontese Castellazzo Bormida (4.268 ab.) 5; le pugliesi Altamura e
Andria (rispettivamente 64.167 e 95.653 ab.) ne contano l’una 10 e l’altra 14; la bergamasca Gazzaniga (4.968 ab.) 5 e l’altra lombarda Legnano
(53.797 ab.) 6; la toscana Pietrasanta (24.409 ab.) 6; la veneta Valdagno
(27.193 ab.) 7.
Un caso del tutto speciale è rappresento dal piccolo comune sardo di
Quartucciu (10.766 ab.), che registra – sempre sulla base della lista ridotta
sopra ricordata - ben 12 denominazioni coloniali, ma che vanta un patrimonio toponomastico coloniale assai più esteso comprendente altre intitolazioni odonomastiche ad Assab, Cirene, Gadames, Misurata, Sirte nonché
166
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
all’oasi libica di Giofra, località quest’ultima non compresa neppure nella
griglia più estesa impiegata in questa ricerca. La cosa ha comunque una
spiegazione. Quartucciu, già comune a sé sino al 1928, fu in quell’anno
inglobato in quello di Cagliari, per poi ritornare autonomo a partire dal
1983. È evidente quindi che il dato relativo a Cagliari registrato nel nostro
studio (solo tre denominazioni coloniali, per la precisione: Bottego, Casati
e Galliano) in una valutazione più propriamente storica dovrebbe essere
corretto con l’aggiunta delle intitolazioni afferenti oggi a Quartucciu giacché queste ultime furono tutte o per lo meno in grandissima parte, presumibilmente, dovute alla volontà degli amministratori cagliaritani.
Per rimanere sul piano della curiosità merita segnalare la forte copertura coloniale di un minuscolo comune vercellese, Rosazza che, con solo
89 abitanti, vanta ben tre strade denominate rispettivamente Adua, Amba
Alagi e Macallé. Ovviamente sarà compito dello storico locale rivelare il
perché di tale eccentricità e di altre similari che di sicuro un sondaggio
condotto sull’intero campione nazionale non mancherà di fare emergere.
Va da sé altresì che solo attraverso una simile indagine si potrà cogliere il
vero peso quantitativo delle singole denominazioni. Un solo esempio: a
Reginaldo Giuliani la nostra indagine assegna 12 presenze su 112 capoluoghi (Bergamo, Bolzano, Firenze, La Spezia, Latina, Milano, Padova, Prato,
Roma Udine, Varese, Venezia), mentre un’indagine condotta sull’insieme
degli 8.101 comuni italiani ci fornisce invece la cifra di 34 citazioni15. Si
passa da un significativo valore del 10,71 per cento sul totale dei capoluoghi ad un insignificante 0,41 per cento sull’insieme dei comuni italiani;
se da una parte ciò ci autorizza a ritenere la ricaduta toponomastica del
celebrato come un fenomeno eminentemente urbano, dall’altra dovrebbe
stimolare ancora di più, almeno a livello locale, un’indagine per cogliere le
motivazioni che hanno spinto vari piccoli centri a quella specifica scelta.
Così pure da un sondaggio a tutto campo potranno emergere particolari coloriture locali di denominazioni che pure hanno uno loro spessore
nazionale. Ad esempio l’asso dell’aeronautica Antonio Locatelli, perito nel
giugno 1936 in Etiopia a Lechemti nell’eccidio della missione guidata dal
generale Vincenzo Magliocco, che nel nostro sondaggio raccoglie 11 citazioni, risulta massicciamente celebrato nella sua provincia di appartenenza
(Bergamo) dove ben 101 comuni su un totale di 244 gli hanno intitolato
aree di circolazione.
Ma altri impegni attendono chi vorrà approfondire questo nostro la167
Marco Lenci e Sergio Baccelli
voro. Si dovrà, ad esempio, oltrepassando il dato puramente quantitativo,
cercare di comprendere la cadenza cronologica con cui le varie amministrazioni locali hanno proceduto all’africanizzazione del loro panorama toponomastico. Si ovvierà, in tal modo, ad un altro limite evidente del presente
sondaggio e già sopra evidenziato per il caso di Cagliari; ci riferiamo al
fatto che questo nostro studio non è stato concepito come una ricerca storica, ma solo ed esclusivamente come una pura indagine toponomastica.
In altri termini si è mirato a fornire una fotografia della situazione presente
senza considerare che i toponimi, coloniali e non, hanno avuto una loro
evoluzione nel corso degli anni di cui meriterebbe dare conto. Un lavoro
simile è già stato condotto da Laura Ricci per quello che è conosciuto
come il «quartiere africano» di Roma, corrispondente ad una zona urbanistica della capitale risalente in buona parte al ventennio fascista. Attraverso
la consultazione dello schedario contenente i testi delle delibere comunali
conservato presso l’archivio toponomastico comunale, la studiosa ha così
appurato che quasi tutti gli toponimi africani di tale quartiere sono stati
decisi effettivamente nell’arco temporale compreso tra il 1920 ed il 1937.
Non solo, ma si è potuto anche accertare come tutti i toponimi coloniali – per quanto riguarda Roma – siano stati soggetti ad una continua
opera di revisione/soppressione. Così è stato per via degli Amara (popolazione etiopica) che nel 1965 ha assunto la denominazione di Santa Maria
Goretti. Similmente è accaduto per i seguenti toponimi: Leptis Magna,
Misurata, Tobruk, Tripolitania (la piazza, mentre sussiste l’omonima via)16.
Ancora in tema di soppressioni di denominazioni coloniali, sempre restando allo scenario romano, è noto il caso di via Dogali che «diventò,
con deliberazione del 18 febbraio 1916, via Romagna»17. Ma il fenomeno
della revisione/soppressione dei toponimi coloniali ha avuto un’estensione
nazionale e – cosa ancora più rilevante – pare essere tuttora in atto come
attesta il caso della recente rinominazione di via Adua in via XXV Aprile
avvenuta nel piccolo comune (solo 259 abitanti) di Rocchetta Nervina in
provincia di Imperia18.
In concreto l’esito del nostro lavoro è raccolto nelle due tabelle qui allegate che, concepite in maniera molto analitica, permettono da sole un’immediata valutazione del riflesso che il fatto coloniale ha avuto nell’odonomastica dei principali centri urbani italiani.
La tabella 1 (Capoluoghi) si articola in tre campi: il primo indica il
nome del capoluogo; il secondo il numero delle ricorrenze coloniali in
168
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Tabella 1 – Capoluoghi
Capoluogo
Onomastico
Roma
87
Addis Abeba (piazza) - Adigrat - Adua - Agordat - Ain Zara - Amba Alagi
(piazza) - Amba Aradam 2 (largo) - Antinori - Arimondi - Ascianghi (largo) - Asmara - Assab - Baldissera - Barce - Beccari - Beltrame - Benadir Bengasi - Bottego (piazza) - Bu Meliana - Cagni - Camperio - Casati - Cecchi - Cheren - Chiarini (largo) - Chisimaio - Cirenaica - Cirene - Comboni
- Cunfida - Dabormida (piazza) - Dancalia - De Cristoforis (piazza) - De
Jacobis - Derna - Dessié - Dire Daua - Endertà - Eritrea (viale) - Ferrandi
- Fezzan - Franchetti - Franzoi - Gadames - Galla e Sidama - Galliano Gessi - Ghirza - Giarabub - Gimma (piazza) - Giuba - Giuliani - Giulietti
- Gondar (piazza) - Homs - Lago Tana - Libia (viale) - Locatelli - Macallè
- Martini - Massaia (viale) - Massaua - Matteucci - Miani - Migiurtinia Millo - Mogadiscio - Nerazzini - Ogaden - Piaggia - Prestinari - Robecchi
Bricchetti - Sabrata - Sapeto (piazza) - Scirè - Sirte - Somalia 2 (viale, largo)
- Tembien - Tigré - Tocra - Traversi - Tripoli - Tripolitania - Zanzur
69
Ain Zara - Amba Alagi (viale) - Antinori - Antonelli - Arimondi - Asmara
- Azizia (viale) - Barce (viale) - Bardia (viale) - Beccari - Beltrame - Bengasi
(viale) - Bottego - Brava (viale) - Cagni - Casati - Cassala (viale) - Cecchi
- Cheren (viale) - Chiarini - Chisimaio (viale) - Cirenaica (viale) - Cirene
(viale) - Coatit - Cufra - Dabormida - Derna (viale) - Dire Daua 2 (viale)
- Dogali (viale) - Eritrea (viale) - Fezzan - Gadames - Galliano - Garian
(viale) - Gebel (viale) - Gessi - Giarabub - Giuba (viale) - Giumbo (viale)
- Gondar (piazzale) - Harar (viale) - Homs (viale) - Lago Tana - Leptis
Magna - Libia (viale) - Locatelli - Macallè - Marada (viale) - Marmarica Martini - Massaia - Massaua - Merca (viale) - Misurata (viale) - Mogadisco
(viale) - Obbia (viale) - Ruspoli - Sirte (viale) - Sollum (viale) - Somalia
(viale) - Tibesti (viale) - Tobruk (viale) - Tolmetta (viale) - Toselli - Tripoli
2 (piazza, viale) - Zanzur (viale) - Zuara (viale)
55
Adigrat (piazza) - Agordat - Arimondi - Asmara - Assab - Axum (piazza) Baldissera - Barce - Benadir - Bengasi - Bettini - Bir Acheim - Birago - Bottego - Cagni - Camperio - Carchidio - Cassala - Cecchi - Cheren - Cirene
(viale) - Comboni - Cufra - Derna - Dessié - Eritrea - Etiopia (viale) - Fezzan - Franchetti - Gadames - Galliano - Garian - Gessi - Giuba - Giuliani
- Giulietti - Harar - Libia (piazzale) - Locatelli - Martini (piazzale) - Massaia (piazza) - Massaua - Minniti (piazza) - Misurata (viale) - Mogadiscio
- Prestinari - Sapeto (piazza) - Sirte - Somalia - Tagiura - Tobruk - Toselli
- Tripoli (piazzale) - Zanzur - Zuara
43
Adua - Amba Alagi - Antinori - Arimondi (piazza) - Asmara - Assab Beccari - Bengasi 2 (calata) - Bottego - Cagni (molo) - Cassala - Cecchi
- Cirenaica - De Cristoforis - Derna 2 (calata) - Dogali (corso) - Eritrea 3
(via al ponte, ponte) - Etiopia 2 (ponte, varco) - Galliano - Gessi - Libia
(ponte) - Massaia - Massaua (viale) - Matteucci - Miani - Millo (salita) Mogadiscio 2 (calata) - Prestinari - Ruspoli - Sacchi - Sapeto - Somalia 2
(ponte) - Toselli - Tripoli 2 (calata)
Rimini
Milano
Genova
169
Marco Lenci e Sergio Baccelli
38
Adua - Agordat - Amba Alagi - Amba Aradam - Antinori - Arimondi Ascianghi - Asmara - Baldissera - Benadir - Bengasi - Bottego - Cagni Camperio - Casati - Cassala - Cecchi - Cirenaica - Coatit - Comboni - Dabormida - De Cristoforis - Eritrea - Ferrandi - Galliano - Gessi - Giuliani
- Libia - Locatelli - Macallè - Miani - Prestinari - Ruspoli -Sacchi - Somalia
- Tembien - Toselli - Tripoli
33
Adua - Agordat - Amba Alagi - Antinori - Arimondi - Asmara - Baldissera
- Bengasi - Birago - Bottego (piazza) - Cagni - Cheren - Cirene (largo) Comboni (vicolo) - De Cristoforis - Derna - Dogali - Franchetti - Galliano
- Gondar - Macallè (Forte di) - Massaia - Massaua - Millo - Misurata Mogadiscio - Ogaden - Sabrata - Sciara Sciat - Tembien - Tobruk - Toselli
- Tripoli
31
Adua (piazzale) - Antinori - Antonelli - Arimondi (corso) - Asmara (piazza) - Baldissera (piazza) - Bengasi (piazza) - Bottego - Cagni (viale) - Casati
- Cecchi - Cirenaica - Cirene (piazza) - De Cristoforis - Derna (piazza)
- Dogali (viale) - Eritrea - Franzoi - Galliano - Gessi - Giulietti - Macallè
(viale) - Massaia 2 (largo) - Massaua (piazza) - Millo (viale) - Piaggia (corso) - Prestinari - Sapeto - Somalia - Tripoli
Vercelli
29
Adua - Agordat - Asmara - Assab - Benadir - Bengasi - Birago - Chisimaio
- Cirenaica - Cirene - Cufra - Derna - Eritrea - Fezzan - Franzoi - Giuba
- Libia - Marmarica - Massaua - Misurata - Neghelli - Obbia - Prestinari Sirtica - Somalia - Tigrè - Tobruk - Tripoli - Zuara
Catania
25
Adua - Amba Alagi - Antinori - Antonelli - Arimondi - Asmara - Baldissera
- Bengasi - Bottego - Cagni - Cecchi - Cufra - Derna - Dogali - Franchetti
- Galliano - Locatelli - Macallè - Massaua - Millo - Misurata - Mogadiscio
- Toselli - Tripoli - Tripolitania
Bari
22
Abba Garima - Addis Abeba - Adua - Ascianghi (largo) - Assab - Bengasi
- Bottego - Cassala - Cheren - Chiarini (vico) - De Cristoforis - Dogali
- Dogali (Eroi di) - Eritrea - Libia - Macallè - Massaua - Mogadiscio - Somalia - Toselli - Tripoli 2 (vico)
Lecce
20
Adua - Amba Alagi - Antinori - Birago - Bottego - Camperio - Casati Cecchi - Comboni - De Cristoforis (piazzetta) - De Jacobis - Dogali - Galliano - Gessi - Matteucci - Miani - Minniti - Piaggia - Sapeto - Toselli
Arezzo
19
Adigrat - Adua - Arimondi - Asmara - Assab - Benadir (largo) - Bengasi
- Bottego - Cecchi - Cheren - Da Bormida - Eritrea - Galliano - Libia Macallè - Massaia - Mogadiscio - Toselli - Tripoli
Reggio
nell’Emilia
19
Adua - Axum - Benadir - Bengasi - Bottego - Cagni - Cassala - Cecchi Eritrea - Franchetti - Galliano - Gessi - Gondar - Macallè - Mogadiscio
- Piaggia - Prestinari - Toselli - Tripoli
Cosenza
15
Adua - Asmara - Bengasi - Bottego - Cirene - Daua Parma - Galliano - Macallè - Massaua - Neghelli - Ogaden (piazza) - Somalia - Tembien - Tigrè
- Tripoli (via lungo Busento)
Firenze
13
Adua (piazza) - Beccari - Bottego - Dogali - Galliano - Giuliani - Locatelli
- Martini - Massaia - Piaggia - Toselli - Traversi - Tripoli
Livorno
12
Addis Abeba (calata) - Adua - Assab (calata) - Bengasi 2 (calata) - Derna Gondar (calata) - Massaua - Mogadiscio (viale) - Neghelli (viale) - Tripoli
2 (calata)
Padova
Palermo
Torino
170
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Siracusa
12
Bengasi - Bianchi - Bottego - Cagni - Eritrea - Gessi - Homs (vicolo) - Massaia - Misurata (vicolo) - Somalia - Tripoli - Zuara (vicolo)
Udine
12
Asmara - Baldissera - Bengasi - Birago - Chisimaio - Derna - Eritrea - Giuliani - Libia (piazza) - Massaua - Mogadiscio - Tripoli
Foggia
10
Bengasi - Dogali 2 (cortile) - Eritrea - Homs - Massaua - Mogadiscio Sciara Sciat - Somalia - Tripoli
Vicenza
10
Antinori - Bottego - Cagni - Cecchi - Chiarini - Gessi - Giulietti - Matteucci - Miani - Prestinari
Parma
9
Bengasi - Bottego 2 (ponte, viale) - Cecchi - Cufra - Derna - Ganale Doria
- Giuba - Tripoli
Verona
9
Adua - Beltrame - Bengasi - Bottego - Comboni - Franchetti - Galliano Locatelli - Massaua
Brindisi
8
Addis Abeba - Asmara - Cagni - De Jacobis - Locatelli - Millo - Minniti
- Mogadiscio
Ferrara
8
Adua - Bianchi - Bottego - Dogali - Gessi - Gondar - Macallè - Matteucci
Grosseto
8
Ascianghi (podere) - Bengasi - Derna - Eritrea - Etiopia - Somalia - Tripoli
2 (piazza)
Sassari
8
Adua (viale) - Bianchi - Bottego 2 (piazza) - Cecchi - Chiarini - Gessi Massaia
Biella
7
Addis Abeba - Adua (piazza) - Asmara - Bengasi - Macallè (viale) - Massaua - Tripoli
Brescia
7
Bottego - Cassala - Comboni - Eritrea - Gessi - Massaia - Somalia
Modena
7
Bottego - Cagni - Dogali - Galliano - Massaua - Salimbeni - Somalia
Pistoia
7
Adua (viale) - Bengasi - Galliano - Macallè - Martini - Toselli - Tripoli
Venezia
7
Amba Alagi - Amba Aradam - Baldissera - Comboni - Galliano - Giuliani
- Massaia
Messina
6
Antinori - Bottego - Cecchi (vicolo) - Comboni - Dogali - Piaggia (vicolo)
Napoli
6
Chiarini - De Jacobis - Eritrea (piazza) - Gessi - Massaia - Neghelli (piazza)
Pesaro
6
Antinori - Cecchi (viale) - Gessi - Martini - Massaia - Tripoli
Treviso
6
Cagni - Cirenaica - Dogali - Eritrea - Libia - Tripolitania
Varese
6
Cirene - Derna - Dogali - Giuliani - Gondar - Toselli
Ascoli Piceno
5
Bengasi - Galliano - Macallè - Massaua - Toselli
Pisa
5
Asmara - Derna - Dogali - Locatelli - Toselli
Asti
4
Adua - Bottego - Cagni (piazza) - Massaia
Bolzano
4
Amba Alagi - Giuliani - Locatelli - Tripoli
Forlì
4
Bengasi - Eritrea - Somalia - Tripoli
Latina
4
Adua - Ascianghi - Giuliani - Neghelli
Olbia
4
Amba Alagi - Bottego - Gessi - Mogadiscio (località)
171
Marco Lenci e Sergio Baccelli
Perugia
4
Antinori 2 (viale) - Birago - Massaia
Ragusa
4
Arimondi - Bengasi - Comboni - Tripoli
Taranto
4
Adua - Cagni - Millo - Minniti
Trapani
4
Adua - Asmara - Neghelli - Tripoli
Trieste
4
Bottego - Cagni (piazzale) - Gessi (viale) - Matteucci
Avellino
3
Asmara - Derna - Tripoli
Bergamo
3
Adua (largo) - Giuliani - Locatelli
Bologna
3
Bottego - Chiarini - Libia
Cagliari
3
Bottego - Casati (piazza) - Galliano
La Spezia
3
Birago - Dogali - Giuliani
Novara
3
Ferrandi - Massaia - Prestinari
Pavia
3
Galliano - Giulietti - Massaua (svincolo)
Pordenone
3
Eritrea - Libia - Somalia
Rovigo
3
Adua (vicolo) - Bottego - Miani
Alessandria
2
Bengasi (vico) - Tripoli
Catanzaro
2
Cagni - Tripoli
Cremona
2
Endertà - Massaia
Iglesias
2
Bottego - Comboni
L’Aquila
2
Asmara - De Jacobis
Lucca
2
Martini - Piaggia
Massa
2
Galliano - Martini
Oristano
2
Adua - Bottego
Ravenna
2
Gessi - Matteucci
Reggio
di Calabria
2
Minniti 2 (aereoporto)
Agrigento
1
Tripoli (cortile)
Benevento
1
Adua
Caltanissetta
1
Arimondi
Carbonia
1
Tripoli
Chieti
1
Chiarini
Como
1
Porro
Crotone
1
Minniti
Nuoro
1
Dogali (piazza)
Pescara
1
Chiarini
172
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Piacenza
1
Millo
Prato
1
Giuliani
Rieti
1
Tripoli
Salerno
1
De Jacobis
Savona
1
Tripoli
Siena
1
Toselli (viale)
Sondrio
1
Adua
Tempio
Pausania
1
Massaua
Trento
1
Comboni
Verbania
1
Adua (piazza)
Viterbo
1
Asmara
Tabella 2 – Toponimi
Onomastico
Capoluogo
Tripoli
39
Agrigento (cortile) - Alessandria - Arezzo - Avellino - Bari 2 (vico) - Biella
- Bolzano - Carbonia - Catania Catanzaro - Cosenza (via lungo Busento) Firenze - Foggia - Forlì - Genova 2 (calata) - Grosseto 2 (piazza) - Livorno
2 (calata) - Milano (piazzale) - Padova - Palermo - Parma - Pesaro - Pistoia
- Ragusa - Reggio nell’Emilia - Rieti - Rimini 2 (piazza, viale) - Roma Savona - Siracusa - Torino - Trapani - Udine - Vercelli
33
Arezzo - Asti - Bari - Bologna - Brescia - Cagliari - Catania - Cosenza Ferrara - Firenze - Genova - Iglesias - Lecce - Messina - Milano - Modena
- Olbia - Oristano - Padova - Palermo (piazza) - Parma 2 (ponte, viale) Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma (piazza) - Rovigo - Sassari 2 (piazza)
- Siracusa - Torino - Trieste - Verona - Vicenza
Adua
29
Arezzo - Asti - Bari - Benevento - Bergamo (largo) - Biella (piazza) Catania
- Cosenza - Ferrara - Firenze (piazza) - Genova - Latina - Lecce - Livorno
- Oristano - Padova - Palermo - Pistoia (viale) - Reggio nell’Emilia - Roma
- Rovigo (vicolo) - Sassari (viale) - Sondrio - Taranto - Torino (piazzale) Trapani - Verbania (piazza) - Vercelli - Verona
Bengasi
28
Alessandria (vico) - Arezzo - Ascoli Piceno - Bari - Biella - Catania - Cosenza
- Foggia - Forlì - Genova 2(calata) - Grosseto - Livorno 2 (calata) - Milano
- Padova - Palermo - Parma - Pistoia - Ragusa - Reggio nell’Emilia - Rimini
(viale) - Roma - Siracusa - Torino (piazza) - Udine - Vercelli - Verona
Eritrea
21
Arezzo - Bari - Brescia - Foggia - Forlì - Genova 3 (ponte, via al ponte)
- Grosseto - Milano - Napoli (piazza) - Padova - Pordenone - Reggio
nell’Emilia - Rimini (viale) - Roma (viale) - Siracusa - Torino - Treviso Udine - Vercelli
Bottego
Vittorio
173
Marco Lenci e Sergio Baccelli
Galliano
Giuseppe
21
Arezzo - Ascoli Piceno - Cagliari - Catania - Cosenza - Firenze - Genova
- Lecce - Massa - Milano - Modena - Padova - Palermo - Pavia - Pistoia
- Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma - Torino - Venezia - Verona
Massaia
Guglielmo
21
Arezzo - Asti - Brescia - Cremona - Firenze - Genova - Milano (piazza) Modena - Napoli - Novara - Palermo - Perugia - Pesaro - Rimini - Roma
(viale) - Sassari - Siracusa - Torino 2 (largo) - Venezia - Verona
Asmara
19
Arezzo - Avellino - Biella - Brindisi - Catania - Cosenza - Genova - L’Aquila
- Milano - Padova - Palermo - Pisa - Rimini - Roma - Torino (piazza) Trapani - Udine - Vercelli - Viterbo
Dogali
19
Bari - Bari (Eroi di) - Catania - Ferrara - Firenze - Foggia 2 (cortile) Genova (corso) - La Spezia - Lecce - Messina - Modena - Nuoro (piazza)
- Palermo - Pisa - Rimini (viale) - Torino (viale) - Treviso - Varese
Cagni
Umberto
18
Asti (piazza) - Brindisi - Catania - Catanzaro - Genova (molo) - Milano Modena - Padova - Palermo - Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma - Siracusa
- Taranto (viale) - Torino (viale) - Treviso - Trieste (piazzale) - Vicenza
Gessi
Romolo
18
Brescia - Ferrara - Genova - Lecce - Milano - Napoli - Olbia - Padova Pesaro - Ravenna - Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma - Sassari - Siracusa
- Torino - Trieste (viale) - Vicenza
Somalia
18
Bari - Brescia - Cosenza - Foggia - Forlì - Genova 2 (ponte) - Grosseto Milano - Modena - Padova - Pordenone - Rimini (viale) - Roma 2 (largo,
viale) - Siracusa - Torino - Vercelli
Massaua
17
Ascoli Piceno - Bari - Biella - Catania - Cosenza - Foggia - Genova (viale)
- Livorno - Milano - Palermo - Pavia (svincolo) - Rimini - Roma - Tempio
Pausania - Torino (piazza) - Udine - Vercelli
Derna
16
Avellino - Catania - Cenova 2 (calata) - Grosseto - Livorno - Milano Palermo - Parma - Pisa - Rimini (viale) - Roma - Torino (piazza) - Udine
- Varese - Vercelli
Toselli
Pietro
15
Arezzo - Ascoli Piceno - Bari - Catania - Firenze - Genova - Lecce - Milano
- Padova - Palermo - Pisa - Pistoia - Reggio nell’Emilia - Rimini - Siena
(viale) - Varese
Cecchi
Antonio
15
Arezzo - Catania - Genova - Lecce - Messina (vicolo) - Milano - Padova
- Parma - Pesaro (viale) - Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma - Sassari Torino - Vicenza
Mogadiscio
15
Arezzo - Bari - Brindisi - Catania - Foggia - Genova 2 (calata) - Livorno
(viale) - Milano - Olbia (località) - Palermo - Reggio nell’Emilia - Rimini
(viale) - Roma - Udine
Macallè
14
Arezzo - Ascoli Piceno - Bari - Biella (viale) - Catania - Cosenza - Ferrara Padova - Palermo (Forte di) - Pistoia - Reggio nell’Emilia - Rimini - Roma
- Torino (viale)
Antinori
Orazio
13
Catania - Genova - Lecce - Messina - Padova - Palermo - Perugia 2 (viale)
- Pesaro - Rimini - Roma - Torino - Vicenza
Comboni
Daniele
12
Brescia - Iglesias - Lecce - Messina - Milano - Padova - Palermo (vicolo) Ragusa - Roma - Trento - Venezia - Verona
Giuliani
Reginaldo
12
Bergamo - Bolzano - Firenze - La Spezia - Latina - Milano - Padova - Prato
- Roma - Udine - Varese - Venezia
174
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Libia
12
Arezzo - Bari - Bologna - Genova (ponte) - Milano (piazzale) - Padova
- Pordenone - Rimini (viale) - Roma (viale) - Treviso - Udine (piazza) Vercelli
Arimondi
Giuseppe
11
Arezzo - Caltanissetta - Catania - Genova (piazza) - Milano - Padova Palermo - Ragusa - Rimini - Roma - Torino (corso)
Locatelli
Antonio
11
Bergamo - Bolzano - Brindisi - Catania - Firenze - Milano - Padova - Pisa
- Rimini (viale) - Roma - Verona
Amba Alagi
10
Bolzano - Catania - Genova - Lecce - Olbia - Padova - Palermo - Rimini
(viale) - Roma (piazza) - Venezia
Chiarini
Giovanni
9
Bari (vico) - Bologna - Chieti - Napoli - Pescara - Rimini - Roma (largo)
-Sassari - Vicenza
Prestinari
Marcello
9
Genova - Milano - Novara - Padova - Reggio nell’Emilia - Roma - Torino
- Vercelli - Vicenza
Baldissera
Antonio
8
Catania - Milano - Padova - Palermo - Roma - Torino (piazza) - Udine Venezia
Cirene
8
Cosenza - Milano (viale) - Palermo (largo) - Rimini (viale) - Roma - Torino
(piazza) - Varese - Vercelli
Martini
Ferdinando
8
Firenze - Lucca - Massa - Milano (piazzale) - Pesaro - Pistoia - Rimini Roma
Millo Enrico
8
Brindici - Catania (largo) - Genova (salita) - Palermo - Piacenza - Roma Taranto - Torino (viale)
Assab
7
Arezzo - Bari - Genova - Livorno (calata) - Milano - Roma - Vercelli
Birago
Dalmazio
7
La Spezia - Lecce - Milano - Palermo - Perugia - Udine - Vercelli
Cassala
7
Bari - Brescia - Genova - Milano (viale) - Padova - Reggio nell’Emilia Rimini (viale)
Cirenaica
7
Genova - Padova - Rimini (viale) - Roma - Torino - Treviso - Vercelli
De
Cristoforis
Tommaso
7
Bari - Genova - Lecce (piazzetta) - Padova - Palermo - Roma (piazza) Torino
Gondar
7
Ferrara - Livorno (calata) - Palermo - Reggio nell’Emilia - Rimini (piazzale)
- Roma (piazza) - Varese
Matteucci
Pellegrino
7
Ferrara - Genova - Lecce - Ravenna - Roma - Trieste - Vicenza
Minniti Tito
7
Brindisi - Crotone - Lecce - Milano (piazza) - Reggio di Calabria 2
(aereoporto) - Taranto
Piaggia
Carlo
7
Firenze - Lecce - Lucca - Messina (vicolo) - Reggio nell’Emilia - Roma Torino (corso)
Benadir
6
Arezzo (largo) - Milano - Padova - Reggio nell’Emilia - Roma - Vercelli
Casati
Gaetano
6
Cagliari (piazza) - Lecce - Padova - Rimini - Roma - Torino
Cheren
6
Arezzo - Bari - Milano - Palermo - Rimini (viale) - Roma
175
Marco Lenci e Sergio Baccelli
De Jacobis
Giustino
6
Brindisi - L’Aquila - Lecce - Napoli - Roma - Salerno
Miani
Giovanni
6
Genova - Lecce - Padova - Roma - Rovigo - Vicenza
Misurata
6
Catania - Milano (viale) - Palermo - Rimini (viale) - Siracusa (vicolo) Vercelli
Neghelli
6
Cosenza - Latina - Livorno (calata) - Napoli (piazza) - Trapani - Vercelli
Addis Abeba
5
Bari - Biella - Brindisi - Livorno (calata) - Roma (piazza)
Agordat
5
Milano - Padova - Palermo - Roma - Vercelli
Ascianghi
5
Bari (largo) - Grosseto (podere) - Latina - Padova - Roma (largo)
Cufra
5
Catania - Milano - Parma - Rimini - Vercelli
Etiopia
5
Genova 3 (ponte, varco) - Grosseto - Milano (viale)
Franchetti
Raimondo
6
Catania - Milano - Palermo - Reggio nell’Emilia - Roma - Verona
Giuba
5
Milano - Parma - Rimini (viale) - Roma - Vercelli
Giulietti
Giuseppe
Maria
5
Milano - Pavia - Roma - Torino - Vicenza
Sapeto
Giuseppe
5
Genova - Lecce - Milano - Roma (piazza) - Torino
Amba
Aradam
4
Padova - Roma 2 (largo) - Venezia
Beccari
Odoardo
4
Firenze - Genova - Rimini - Roma
Camperio
Manfredo
4
Lecce - Milano - Padova - Roma
Chisimaio
4
Rimini (viale) - Roma - Udine - Vercelli
Dabormida
Vittorio
4
Arezzo - Padova - Rimini - Roma
Fezzan
4
Milano - Rimini - Roma - Vercelli
Homs
4
Foggia - Rimini (viale) - Roma - Siracusa (vicolo)
Tembien
4
Cosenza - Padova - Palermo - Roma
Tobruk
4
Milano - Palermo - Rimini (viale) - Vercelli
Zuara
4
Milano - Rimini (viale) - Siracusa (vicolo) - Vercelli
Adigrat
3
Arezzo - Milano (piazza) - Roma
Antonelli
Pietro
3
Catania - Rimini - Torino
Barce
3
Mirano - Rimini (viale) - Roma
176
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
Beltrame
Giovanni
3
Rimini - Roma - Verona
Bianchi
Gustavo
3
Ferrara - Sassari - Siracusa
Dire Daua
3
Rimini 2 (viale) - Roma
Ferrandi
Ugo
3
Novara - Padova - Roma
Franzoi
Augusto
3
Roma - Torino - Vercelli
Gadames
3
Milano - Rimini - Roma
Ogaden
3
Cosenza (piazza) - Palermo - Roma
Ruspoli
Eugenio
3
Genova - Padova - Rimini
Sirte
3
Milano - Rimini (viale) - Roma
Tigrè
3
Cosenza - Roma - Vercelli
Tripolitania
3
Catania - Roma - Treviso
Zanzur
3
Milano - Rimini (viale) - Roma
Ain Zara
2
Rimini - Roma
Axum
2
Milano (piazza) - Reggio nell’Emilia
Coatit
2
Padova - Rimini
Dessiè
2
Milano - Roma
Endertà
2
Cremona - Roma
Garian
2
Milano - Rimini (viale)
Giarabub
2
Rimini - Roma
Harar
2
Milano - Rimini (viale)
Lago Tana
2
Rimini - Roma
Marmarica
2
Rimini - Vercelli
Obbia
2
Rimini (viale) - Vercelli
Sabrata
2
Palermo - Roma
Sacchi
Maurizio
2
Genova - Padova
Sciara Sciat
2
Foggia - Palermo
Traversi
Leopoldo
2
Firenze - Roma
Abba
Garima
1
Bari
Azizia
1
Rimini (viale)
177
Marco Lenci e Sergio Baccelli
Bardia
1
Rimini (viale)
Bettini
Lionello
1
Milano
Bir Acheim
1
Milano
Brava
1
Rimini (viale)
Bu Meliana
1
Roma
Carchidio
Francesco
1
Milano
Cunfida
1
Roma
Dancalia
1
Roma
Daua Parma
1
Cosenza
Galla e
Sidama
1
Roma
Ganale
Doria
1
Parma
Gebel
1
Rimini (viale)
Ghirza
1
Roma
Gimma
1
Roma (piazza)
Giumbo
1
Rimini (viale)
Leptis
Magna
1
Rimini
Marada
1
Rimini (viale)
Merca
1
Rimini (viale)
Migiurtinia
1
Roma
Nerazzini
Cesare
1
Roma
Porro Gian
Pietro
1
Como
Bricchetti
Robecchi
Luigi
1
Roma
Salimbeni
Augusto
1
Modena
Scirè
1
Roma
Sirtica
1
Vercelli
Sollum
1
Rimini (viale)
Tagiura
1
Milano
Tibesti
1
Rimini (viale)
Tocra
1
Roma
Tolmetta
1
Rimini (viale)
178
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
esso rilevate; il terzo consiste nella lista dettagliata dei toponimi coloniali
presenti in quello stesso capoluogo. Avvertiamo il lettore che in questa tabella non compaiono quei capoluoghi in cui i toponimi da noi considerati
non hanno registrato neppure una ricorrenza. Si tratta di ben 25 centri19,
che sul totale di 112 rappresentano un dato non certo trascurabile, tanto
più che tra essi vi sono città importanti. Se ai capoluoghi che non segnano
alcuna ricorrenza aggiungiamo gli altri 20 che ne hanno una sola, v’è da
concludere che un buon 40,17 per cento dei centri amministrativi italiani
più significativi non sono stati neppure sfiorati, almeno a livello toponomastico, dalla retorica celebrativa coloniale o lo sono stati solo in maniera
minima. Alla luce di ciò viene riconfermato quanto sopra già indicato: solo
un sondaggio condotto su scala nazionale potrà fornire il peso reale che
sulla toponomastica urbana ha avuto l’epopea coloniale. La nostra impressione – ma si tratta di una semplice sensazione – è che quel peso sia stato
più ampio di quanto non compaia dal presente studio.
Essendo stata concepita specularmente alla prima anche la tabella 2
(Toponimi) si compone di tre settori: nel primo è riportata la denominazione coloniale considerata; nel secondo è leggibile il numero di capoluoghi
in cui quella denominazione ha valenza toponomastica; il terzo campo
fornisce l’elenco completo di quegli stessi capoluoghi.
Avvertiamo che – nella prima tabella accanto al toponimo e nella seconda di fianco del nome del capoluogo – abbiamo precisato tra parentesi
tutti quei casi in cui l’area di circolazione interessata non sia una semplice
via. In altri termini il lettore può individuare facilmente se un toponimo
indica una via (nel qual caso – in assoluto il più diffuso – non compare
alcuna specificazione), oppure una diversa area di circolazione (largo, piazza, piazzale, ponte, viale, vicolo...). Sempre tra parentesi abbiamo indicato alcune varianti di uno stesso toponimo: ad esempio a Bari, accanto a
Dogali, vengono celebrati pure gli Eroi di Dogali. Quando al fianco di un
capoluogo (tabella 1) o di un odonimo (tabella 2) compare una cifra, essa
sta ad indicare che la denominazione toponomastica considerata titola più
aree di circolazione.
Vogliamo chiudere questa nota ricordando che, nel corso della ricerca,
abbiamo tentato pure di valutare il peso specifico che il fatto coloniale ha
avuto sulla toponomastica italiana in generale. Non essendo al riguardo
possibile reperire un misuratore scientifico adeguato, abbiamo proceduto
per via empirica. Nello stesso campione geografico rappresentato dai 112
179
Marco Lenci e Sergio Baccelli
capoluoghi di provincia, abbiamo valutato per un confronto con quelle
coloniali le ricorrenze toponomastiche concernenti Nino Bixio, Dalmazia,
Goito, Zara. Si è così registrato 72 citazioni per l’eroe garibaldino; 66 per
Zara; 52 per la Dalmazia; 46 per Goito. Ne deriva che Tripoli, il toponimo
coloniale più ricorrente, vanta una diffusione compresa tra poco più della
meta (54,1 per cento) di quella di Bixio e l’84,7 per cento di quella di Goito. Analogamente Adua, che evoca la più importante battaglia coloniale
italiana, con 29 ricorrenze ha un peso toponomastico ben inferiore (-16,2
per cento) di quello di uno dei tanti fatti d’arme del Risorgimento, quale
fu Goito, mentre la colonia più antica – l’Eritrea – vale toponomasticamente meno della metà della Dalmazia, terra che, per tutti i decenni in cui
durò il fatto coloniale, ha attratto le mire dei nazionalisti italiani.
Su tali dati sarebbero possibili varie riflessioni che altri, completando in
tutti i sensi questo nostro primo tentativo, ci auguriamo possano svolgere
quanto prima.
Note al testo
1
Cfr. N. Labanca, L’Africa italiana, in I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, a
cura di M. Isnenghi, Roma-Bari 1996, pp. 257-289 (in specie pp. 280-286); L. Ricci, La lingua dell’impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell’età del colonialismo italiano, Roma
2005, (pp. 189-196). Per un primo contributo alla storia della toponomastica italiana vedi S.
Raffaelli, Il nome delle vie, in I luoghi della memoria cit., pp. 215-242.
2
M. Nani, Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Roma 2006,
pp. 93-94.
3
Tra i tanti emblematico il caso di Pisa dove le vie Derna e Risorgimento corrono parallele.
A Cosenza la parte moderna della città comprende un reticolo di strade coloniali (Neghelli,
Macallè, Tigrai, Bottego, Adua, Galliano, Daua Parma ecc.) intersecanti, prossime o parallele
a vie intitolate: Mazzini, XXIV Maggio, Isonzo, Piave, Brenta. A Reggio Emilia le vie Tripoli
e Bengasi sono prossime alle vie Aurelio Saffi, Quintino Sella, Bettino Ricasoli, Oslavia, Bainsizza mentre, al contempo, le strade celebranti Toselli e Galliano si trovano prossime ai viali
Trento e Trieste ed Isonzo nonché alle vie Fabio Filzi e Nazario Sauro. Va da sé che molteplici
analoghi esempi sono reperibili in tutta la Penisola.
4
N. Labanca, L’Africa italiana cit., p. 281.
5
Per dettagliate referenze bibliografiche di tali stradari ibidem, pp. 282-284.
6
Gli stradari di tutti i comuni italiani sono reperibili ai seguenti siti: World.Maporama.com –
Cartine, piantine e itinerari ovunque nel mondo; TuttoCittà.it; Comuni-italiani.it:Informazioni,
CAP e dati utili. Segnaliamo che i dati reperibili attraverso Maporama e TuttoCittà sono per-
180
Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana
fettamente sovrapponibili; ciò non vale per il sito Comuni-Italiani giacché esso opera fondandosi su un database leggermente diverso. Segnaliamo infine che alcune denominazioni
(verosimilmente pochissime) non sono rintracciabili in nessuno dei tre siti citati; ad esempio
per Olbia abbiamo appurato l’esistenza di una località indicata come Mogadiscio solo per caso,
navigando in rete per altri scopi.
7
Precisiamo che non abbiamo considerato quei centri urbani il cui nome è inserito nella denominazione ufficiale di una provincia senza però che ne vestano istituzionalmente il ruolo di
capoluoghi; è stato questo il caso di Cesena e Carrara giacché le due province di Forlì-Cesena
e Massa-Carrara hanno come unici capoluoghi rispettivamente Forlì e Massa. Per completezza ricordiamo che per le restanti province a nome doppio o complesso i capoluoghi sono
i seguenti: Carbonia e Iglesias (provincia di Carbonia-Iglesias); Sanluri e Villacidro (Medio
Campidano); Lanusei e Tortolì (Ogliastra); Olbia e Tempio Pausania (Olbia-Tempio); Pesaro e
Urbino (Pesaro-Urbino); Verbania (Verbania-Cusio-Ossola).
8
La città di Cassala appartiene al Sudan, già possedimento anglo-egiziano in epoca coloniale, ma
per un breve periodo – tra il 1894 ed il 1897 – fu occupata dalle forze italiane e quindi inserita
nel contesto eritreo.
9
Località costiera della Penisola Arabica bagnata dal mar Rosso di fronte alla quale la flotta italiana, nel gennaio 1912, riuscì ad affondare alcune unità turche. Si trattò di per sé di un evento
assolutamente modesto ma che, al suo compiersi, interrompendo la deprimente stasi che si
registrava sul fronte libico, venne salutato dalla propaganda italiana come un’impresa memorabile; cfr. M. Lenci, La campagna italiana nel Mar Rosso durante la guerra di Libia e la rivolta
antiturca di al-Idrisi dell’Asir in «Storia contemporanea», 1985, 5-6, pp. 971-994.
10
Tale evenienza è già stata ben illustrata limitatamente al caso milanese in N. Labanca, L’Africa
italiana cit., pp. 283-284. Per il recupero fascista dei «precursori» vedi ad esempio P. M. Bardi,
Pionieri e soldati d’A. O. Dall’acquisto di Assab all’impero romano d’Etiopia, Milano 1936.
11
Ben 13 sono i capoluoghi che celebrano toponomasticamente la battaglia di el-Alamein o i
caduti di el-Alamein. Più precisamente hanno aree di circolazioni denominate el-Alamein:
Como, Novara, Parma, Ravenna, Torino, Treviso, Varese, Vercelli; i caduti di el-Alamein sono
celebrati ad Arezzo, Palermo, Pisa, Roma, Torino. Sarebbe interessante comprendere per ogni
caso la motivazione per cui si è proceduto a tale intitolazione tanto più che, da un primo
parziale sondaggio, abbiamo potuto appurare che in almeno quattro casi tale decisione è stata
assunta a decenni di distanza dall’evento: a Parma nel 1990, a Varese nel 1999, a Novara e
Torino nel 2003.
12
Per tale motivo è rimasta esclusa dalla nostra griglia la figura di Orlando Lorenzini, l’eroe della
battaglia di Cheren, che cadde sulla posizione il 17 marzo 1941 ed il cui valore fu riconosciuto
pubblicamente anche dallo stesso comandante delle truppe britanniche William Platt. Simile
il caso del secondo vicerè d’Etiopia, Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, che, dopo aver contrastato fino all’ultimo l’offensiva inglese sull’Amba Alagi, morì prigioniero a Nairobi il 3 marzo
1942.
13
Tale – per fare solo pochi esempi tra gli infiniti possibili – i casi di Aurelio Grue (caduto ad
Abba Garima nel 1896) e di Francesco Crucioli (morto in Etiopia nel 1937), entrambi originari della provincia di Teramo, a cui nel capoluogo abruzzese (che, per altro, non registra alcun
toponimo della nostra griglia) sono intitolate rispettivamente una via ed un viale. Il primo
risulta pure celebrato nel suo comune di origine (Atri) con una via a lui dedicata. Analogo il
caso di Pietro Cella, originario della provincia di Parma e caduto nella battaglia di Adua del
1896, a cui è intitolata una via oltre che a Parma anche a Piacenza.
14
Amba Alagi, Addis Abeba, Adua, Asmara, Bengasi, Bottego, Cirenaica, Derna, Dessiè, Dogali,
Eritrea, Galliano, Gondar, Libia, Macallè, Massaua, Mogadiscio, Somalia, Toselli, Tripoli.
181
Marco Lenci e Sergio Baccelli
15
Dobbiamo questi dati alla cortesia di Giovanni Cavagnini, allievo della Scuola Normale di Pisa, impegnato in una ricerca avente per oggetto, per l’appunto, la vita di Reginaldo Giuliani.
16
Cfr. L. Ricci, La lingua dell’impero cit., pp. 191-194. Viene segnalato inoltre che tre toponimi
coloniali (Coatit, Harar, Sassabanèh), pur regolarmente deliberati, non furono poi concretamente assegnati perchè le aeree di circolazione per cui erano stati concepiti non furono mai
realizzate.
17
S. Raffaelli, Il nome delle vie cit., p. 224. L’Autore, riferendosi alla presenza di Dogali nel panorama odonomastico nazionale, rivela che «le menzioni di quel doloroso fatto d’armi furono
scarse e comunque tardive». Dobbiamo precisare che, alla luce del nostro sondaggio, almeno la
prima delle due affermazioni non pare corretta; il toponimo Dogali registra infatti un ragguardevole numero di ricorrenze (19).
18
L’atto è stato deciso con la delibera della giunta comunale n. 3 del 10 gennaio 2003.
19
Ancona, Aosta, Belluno, Campobasso, Caserta, Cuneo, Enna, Frosinone, Gorizia, Imperia,
Isernia, Lanusei, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Potenza, Sanluri, Urbino, Teramo,
Terni, Tortolì, Vibo Valentia, Villacidro.
182
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
di Cristiana Pipitone
I volti abbronzati, cotti dal sole e dal vento, profili di una virilità più pronunciata, le
fattezze più caratteristiche di taluno, ispide barbe, capellature polverose, occhi lucenti
dal riflesso della fiamma. Il principe col suo bianco bornùs sulle spalle, sovrasta di
tutto il capo gli astanti; Gallina rigira tra le labbra, nella barba brizzolata, l’eterna sigaretta, mentre sembra ammicchi attraverso il monocolo, caccia col frustino il suo «fox»
ischeletrito dalle marce; il ten. colonnello Amato, il comandante dei libici, ben raso
e composto, col suo inalterabile, pacato sorriso; Carrara si arriccia la pubta dannunziana e propone l’istituzione dell’ ordine del «pidocchietto», la più legittima cavalleria
dei partecipanti della colonna; il comandante degli eritrei, maggiore Ossoli, occhi da
saraceno e barbone nero, appare truce come un brigante calabrese. Ed i volti, specialmente, sono illuminati e gli occhi di coloro che il destino ha già eletti, perché meglio
testimonino col sangue e col sacrificio supremo, del proprio e del valore di tutti. Il
generale Graziani avanza con l’alta e magra persona in mezzo al breve cerchio che
ancora più gli si restringe intorno. La sua faccia, dai lineamenti angolosi, che paiono
non comportare altra espressione che quella dell’autorità, della volontà dominatrice
di uomini e di eventi s’imporpora dal riflesso vampante del fuoco che gli scava ombre
profonde e fa risaltare, come modellata nel bronzo d’una medaglia, l’asprezza fiera del
profilo romano1.
Alla vigilia della battaglia di Bir Tagrift2 così apparivano a Mario Bassi,
inviato della «Stampa», gli ufficiali della colonna Graziani. La descrizione
è suggestiva, esotizzante e contiene tutta una serie di stereotipi narrativi: la
quiete in attesa dello scontro, della messa in campo del proprio valore personale e militare. Linee aspre e dure che disegnano i visi e i profili, sorrisi
calmi e pacati, l’«eterna sigaretta in bocca», i capelli impolverati compongono un ritratto di gruppo. Le stesse descrizioni possono adattarsi a molti
degli ufficiali italiani che trascorsero in colonia buona parte della propria
carriera. Alla fine degli anni venti si era affermato un modello ideale che
descriveva gli ufficiali coloniali, e in particolare, coloro che venivano individuati come i «vecchi coloniali»: persone che condividevano stili di vita,
teorie e pratiche.
183
Cristiana Pipitone
Due delle persone citate erano di una certa rilevanza pubblica: uno era
un membro di casa Savoia, Amedeo d’Aosta, l’altro era Rodolfo Graziani.
Entrambi nel giro di poco meno di un decennio si troveranno alla guida
dell’impero fascista3. Su entrambi esiste una vasta letteratura coeva tendente ad esaltarne le gesta4. Graziani era il «soldataccio» congeniale al regime
di cui Mussolini aveva bisogno (al punto che ne venne costruito una sorta
di mito)5. Sul rapporto di Graziani con Mussolini molto è già stato scritto6,
giova qui ricordare come Graziani si presentasse come un nuovo tipo di
soldato, disponibile a sostituire la tradizionale fedeltà al re con il rapporto
diretto con il duce, egli rappresentava insomma «il tipo di ufficiale organico alla politica mussoliniana, cioè l’uomo senza vincoli di lealtà verso il
passato o verso le istituzioni esistenti, senz’altro punto di riferimento che
il duce»7. Alla fine degli anni venti Graziani era un personaggio popolare
che la stampa celebrava evidenziando gli aspetti romantici ed esotici delle
sue imprese8. Anche fisicamente poteva incarnare il mito dell’eroe guerriero che evoca i fasti dell’impero romano: la statura imponente, il «profilo
latino» e il fisico asciutto. Immagine, voce e aspetto fisico sono elementi che non possono mancare nella costruzione di un modello di ufficiale
coloniale. Diverso è invece il duca d’Aosta, che accanto ad una «maschia
fattezza» unisce spiccate caratteristiche di «bontà» e sensibilità coniugando
«le tipiche caratteristiche dell’uomo fascista con le doti di umanità, sensibilità e savoir faire»9 che gli derivano dai natali aristocratici. Se Graziani è
il «generale scipionico» per eccellenza e il duca l’aristocratico, anche altri
impersoneranno, con pochi e marginali slittamenti, il tipo ideale dell’ufficiale coloniale. Scrivendo una biografia di Ruggero Tracchia, Dario Lischi
lo definisce un «prototipo» dell’ufficiale coloniale10. Nel suo ritratto Lischi
si sofferma su una serie di elementi principalmente caratteriali perché:
non bastano né intelligenza né coltura, non conoscenza o bravura militare o volontà.
Occorre innanzitutto “esserci tagliati”, diremo in lingua povera ma espressiva: E occorrono una grande facoltà di conoscenza degli uomini, tatto, penetrazione psicologica,
bontà profonda, sentimento paterno, comunicativa: oltre alla capacità e al coraggio,
oltre ad una estrema freddezza che sappia trasmutarsi improvvisamente in ardore11.
Autorevolezza, atteggiamento «burbero», coraggio, la stessa posizione
assunta nel corso della battaglia diventano elementi connotativi con un’accentuazione su tratti caratteriali piuttosto che su una specifica preparazione professionale e viene operata una semplificazione che diventa vulgata.
184
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
Ma se è semplice cogliere gli aspetti relativi alle rappresentazioni più complesso è definire chi sono in realtà gli ufficiali coloniali italiani. Negli anni
della «riconquista della Libia» si assistette all’autoselezione di un nucleo
di ufficiali superiori che si autodefiniva «coloniale» e che, dotato di ampia
libertà di manovra, padroneggiava e affinava le tecniche di combattimento
nel deserto e di antiguerriglia12. Per gli alti ufficiali la scelta della colonia e
la successiva specializzazione avvenne come opzione individuale: maturò e
si concretizzò nella richiesta di assegnazione ai regi corpi truppe coloniali
fatta di volta in volta.
Ruolo in colonia: dibattiti e frizioni
Il ruolo dei militari nella storia del colonialismo italiano è un ruolo centrale, superiore a quello di qualsiasi altra istituzione statale. In particolar
modo durante il ventennio fascista, il potere italiano nei territori africani,
venne imposto con la forza e l’esercito venne impiegato non soltanto per
funzioni militari ma anche di amministrazione civile. Le vicende militari
della guerra italo-turca del 1911-1912 e del conflitto italo etiopico del
1935-1936 sono abbastanza note, meno conosciute sono invece le operazioni di polizia coloniale che contraddistinsero sia gli anni della riconquista della Libia sia il quinquennio successivo alla guerra italo-etiopica13. Le
storie coloniali coeve sono in gran parte storia della conquista militare14,
allo stesso modo i protagonisti delle operazioni belliche hanno lasciato
voluminose opere di studio e resoconto15. Ciò nonostante uno scarso interesse è stato dedicato all’esercito coloniale come istituzione16 e al personale
impegnato nelle operazioni militari pur non mancando certo biografie,
quantomeno dei più illustri e controversi17.
L’esercito italiano non prevedeva il ruolo coloniale: occupazione e difesa dei territori oltremare dovevano essere garantiti dalle forze armate della
madrepatria integrate dai regi corpi truppe coloniali che, dipendenti dal
ministero delle Colonie (poi Africa italiana), arruolavano su base volontaria
militari autoctoni inquadrati da ufficiali italiani. Esercito metropolitano e
regi corpi truppe coloniali erano considerati entità diverse se non addirittura contrapposte18: tutto ciò influì e non poco soprattutto sull’esercito
coloniale, sottoposto a diverse autorità, e di conseguenza sulla formazione
e la selezione del personale impiegatovi. I corpi regi, quantomeno nella
visione dei diversi comandanti degli stessi, richiedevano una stabilizzazio185
Cristiana Pipitone
ne del corpo ufficiali. I governatori e i comandanti delle truppe avrebbero
desiderato avere a disposizione uomini che scegliessero volontariamente la
colonia, disposti a restarvi per periodi di tempo medio lunghi e che fossero
buoni professionisti. Gli ufficiali prestavano infatti servizio in colonia per
periodi di almeno due anni (tale era la durata della ferma coloniale) rinnovabili per altri due bienni al termine dei quali era previsto il rimpatrio
definitivo. Quello coloniale era un servizio che poteva essere richiesto dagli
ufficiali, che dovevano presentare apposita domanda indicando anche la
colonia di preferenza, qualora le richieste non raggiungessero il numero di
ufficiali da inviare in colonia, si provvedeva destinandone alcuni di autorità19. Accanto agli ufficiali in servizio permanente potevano essere inviati in
colonia anche ufficiali tratti dalle categorie in congedo che ne avessero fatto esplicita richiesta e che fossero fisicamente idonei al servizio coloniale.
Sui tempi di permanenza vi era difformità di vedute tra le autorità militari in Italia e i responsabili in loco. Nel 1923 il comandante del Regio
corpo truppe coloniali della Cirenaica scriveva nella relazione trimestrale
che la decisione del ministero della Guerra di restringere i tempi di permanenza massima in colonia a 5 anni (insieme ad un calo netto delle richieste
per la colonia) aveva messo in crisi il comando truppe e aveva suscitato un
certo disorientamento all’interno del corpo ufficiali, soprattutto tra quelli
che si trovavano proprio al limite della scadenza fissata20. La rigida osservazione della norma e dei regolamenti avrebbe infatti comportato la perdita
proprio di quegli elementi che più avevano esperienza e anche passione per
la vita coloniale, lasciando la colonia ad un turnover di ufficiali, oltretutto
inviativi di autorità, destinati a rimanervi per un breve numero di anni. Tale decisione in realtà non fu applicata e quattro anni dopo, il comandante
del Regio corpo dell’Eritrea poteva dirsi pienamente soddisfatto dell’inquadramento delle proprie truppe in quanto «i 135 ufficiali presenti al 1
settembre erano così ripartiti: 88 a domanda, 47 d’autorità; inoltre 46 si
trovavano nel primo biennio di servizio, 40 nel secondo, 31 nel terzo e 18
nel quarto»21 cioè ben oltre le norme regolamentari. Non altrettanto soddisfatto era il comandate del regio corpo truppe coloniali della Tripolitania,
Giuseppe Malladra, che in una relazione distingueva in due blocchi con
caratteristiche ben distinte gli ufficiali presenti nella colonia: gli ufficiali
superiori erano un «nucleo omogeneo con passato di guerra generalmente
buono e spesso anche brillante, con lunga permanenza in colonia, volontari e appassionati della vita coloniale, di capacità e rendimento sufficiente
186
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
Fotografia scattata dai fotoreporter al seguito delle unità militari dell’esercito italiano. Al centro
un ufficiale al comando del proprio gruppo durante una marcia verso il Tacazzè nel 1935.
Raccolta Angelo Del Boca
od anche assai spiccato»22 mentre il secondo gruppo era assai disomogeneo (alcuni in servizio permanente ed altri di complemento). Tra quelli di
professione la maggior parte non era partita volontariamente e ambiva a
rientrare in Italia il prima possibile mentre per gli ufficiali di complemento, «fra i quali non mancano coloro che hanno un bel passato di guerra»23
la grande maggioranza era spinta dal trovare una collocazione permanente
all’interno dell’esercito e non da una vero interesse per il servizio coloniale.
Esisteva quindi una sostanziale convergenza tra gli interessi dei comandanti dei corpi regi e il ministero delle Colonie nel poter contare su
187
Cristiana Pipitone
personale di carriera, esperto e fortemente motivato. Più volte si pose la
questione della creazione di un ruolo o specialità coloniale. Negli anni
venti essa venne affrontata nel Comitato interministeriale per le questioni
coloniali. Creato alla fine del 1925 su iniziativa del ministero delle Colonie
il Comitato si riunì per circa un anno. Ne facevano parte il ministro delle
Colonie che lo presiedeva, i sottosegretari alle Colonie, Esercito, Marina
e Aeronautica, il capo di stato maggiore generale, Pietro Badoglio, e i capi
di stato maggiore di Marina e Aeronautica24. La seconda riunione affrontò
il tema dei quadri, la discussione fu sollecitata dalla proposta del ministro
delle Colonie, Pietro Lanza di Scalea, di agevolare il passaggio al servizio
permanente di ufficiali di complemento distintisi in colonia. La proposta
venne ripresa da Badoglio che si dichiarava favorevole alla riapertura della
questione – dopo aver sottolineato però che era già stata decisa in senso
negativo – pur con alcune limitazioni e cautele derivanti dalla necessità di
salvaguardare l’esercito nel suo complesso e quindi di evitare che il servizio
in colonia venisse considerato come un modo di aggirare le selezioni delle
accademie militari25. Le Colonie sottolineavano come il problema si fosse
creato dal momento che non era più richiesto che gli ufficiali destinati
in colonia rispondessero a determinati requisiti e chiedevano di ridurre il
numero di ufficiali di complemento e il numero di quelli inviati in colonia
d’autorità, auspicando il passaggio al servizio permanente di quegli ufficiali di complemento in servizio in colonia considerati meritevoli e provvedimenti tali da rendere il servizio coloniale appetibile per un maggior numero di ufficiali di carriera26. D’altro canto lo stato maggiore avrebbe voluto
rendere obbligatorio il servizio coloniale per tutti i giovani ufficiali per un
breve periodo ma si rendeva disponibile ad incentivare con una «maggiore
e più efficace propaganda nelle scuole militari» le domande di assegnazioni
oltremare27. Il punto di vista dei militari di professione andava cioè in senso contrario rispetto a quanto richiesto dalle autorità coloniali. La proposta
di modifica delle turnazioni in colonia prevedeva infatti:
invio degli ufficiali in colonia dopo almeno due anni di servizio in Italia (maggiore
esperienza del servizio presso le truppe); durata del servizio coloniale due anni, poi
rafferme di anno in anno fino ad un massimo di 5 o 6 anni di servizio continuativo
coloniale; nei primi due anni: servizio ai reparti, ed esclusione da qualsiasi servizio sedentario o con carattere civile che non sia accoppiato con servizio ai reparti; possibilità
di ritorno in colonia dopo uno o due anni dal rimpatrio; tutti gli ufficiali subalterni
delle armi combattenti devono partecipare alla rotazione del servizio coloniale, abbia188
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
no o no famiglia. Perciò stabilire la rotazione al più resto possibile dopo i primi due
anni di servizio28.
Lo stato maggiore non si nascondeva le difficoltà che un provvedimento
simile avrebbe comportato sul piano organizzativo ed era profondamente
contrario a concedere incentivi al servizio coloniale che andassero ad incidere sulle carriere. Men che meno vedeva in modo favorevole la proposta
di agevolare il passaggio al servizio permanente per gli ufficiali di complemento impiegati in colonia. Secondo lo stato maggiore per avviare ad una
soluzione le questioni relative all’inquadramento dei corpi regi occorreva:
a) migliorare la qualità della massa degli ufficiali per poter trarne buoni elementi per
le colonie, elementi che ora sono aumentati di numero per le maggiori esigenze delle
colonie mentre la massa degli ufficiali metropolitani è rimasta presso a poco la stessa;
b) attivare una più ampia rotazione degli ufficiali in Sap con tale sistema, si potrà avere
una percentuale maggiore di ufficiali, che stando in colonia, si invogliano a rimanervi;
c) ridurre ed eliminare gli ufficiali di complemento che vengono a complicare la situazione dei quadri in Sap (il loro passaggio in Sap oltre a non esser un vantaggio per la
qualità della massa (poca coltura ecc.) viene a togliere posti agli ufficiali in Sap). Tale
riduzione favorisce la rotazione degli ufficiali in Sap;
d) continuare a comandare d’autorità ufficiali che siano idonei fisicamente, non escludendo quelli che hanno classifiche scadenti, specie se queste dipendono da ragioni che
nel servizio in colonia non possono preoccupare;
e) migliorare le condizioni di vita in colonia, aumentando anche, se del caso, i vantaggi
ora concessi per il computo della pensione29.
Sostanzialmente vi era un rigetto di tutte le richieste fatte dal ministero
delle Colonie derivante dalla necessità per l’esercito di garantire soprattutto i bisogni dell’esercito metropolitano e i diritti di chi era già all’interno.
L’unico aspetto preso in considerazione fu quello relativo alla riduzione
degli ufficiali di complemento nelle nuove assegnazioni: tale richiesta però
andava incontro alle esigenze dello stato maggiore di limitare il più possibile eventuali «aggiramenti» alle norme sul reclutamento. La questione nella
sua globalità in realtà non venne risolta né in un senso né nell’altro.
Occasionalmente si tornò a parlare di ruolo o specialità coloniale nel
corso degli anni mentre per le richieste di personale provenienti dalle
colonie si continuò a provvedere con l’invio di ufficiali che ne facevano
esplicita domanda e coprendo con invii di autorità le eventuali carenze. Il
problema si impose nuovamente con l’impero e i progetti di costruire una
189
Cristiana Pipitone
vera e propria armata coloniale e si arrivò ad una definizione, quantomeno
sulla carta di quello che avrebbe dovuto essere la specialità coloniale. Sulla
carta perché la firma del decreto arrivò praticamente a colonie perse e non
vide mai una applicazione pratica venne infatti presentato alla riunione del
consiglio dei ministri nel marzo del 194230. Il testo però era stato predisposto già nel 193631 e prevedeva la creazione di una specialità coloniale
cui potevano accedere gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al
ruolo comando delle diverse armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).
Tali ufficiali restavano iscritti nel ruolo dell’arma di appartenenza e ad
essi si applicavano le disposizioni dell’esercito regio per quanto concerneva
l’avanzamento32. Per far parte della specialità coloniale era necessario aver
trascorso almeno un anno in colonia ed essere giudicati idonei al servizio
coloniale e l’ammissione alla specialità comportava una ferma di cinque
anni in colonia. Trascorsi questi cinque anni, qualora permanesse l’idoneità al servizio coloniale e il superamento di un esame di «cultura generale
coloniale» l’ufficiale veniva inviato in patria dove avrebbe prestato servizio
per un biennio pur continuando ad appartenere alla specialità coloniale33.
Al biennio di servizio nella metropoli seguiva un altro quinquiennio di servizio in colonia che doveva culminare con un esame di «grado superiore di
cultura coloniale» e superato questo un altro biennio da trascorrere presso
un reparto nazionale. A questo punto si proseguiva con la scansione cinque
anni in colonia e due in Italia fino a che permanesse l’idoneità al servizio
coloniale (i cui requisiti non erano indicati nel testo del decreto legge ma
demandati a una futura determinazione). Il testo era stato elaborato dal
ministero dell’Africa italiana e mirava a creare un corpo di ufficiali, che
pur continuando a dipendere dall’esercito e a mantenervi il proprio ruolo
e la propria posizione in termini di carriera, fosse fisicamente e culturalmente idoneo all’inquadramento delle truppe indigene e che percorresse
praticamente l’intera carriera in colonia. I bienni da trascorrere in Italia
erano una concessione alle esigenze dello stato maggiore di non trovarsi
nei ranghi elementi non più idonei al servizio nei reparti metropolitani.
All’inizio del 1938 il decreto venne bloccato dalla necessità di aspettare
la riforma sulle norme di reclutamento degli ufficiali del regio esercito.
Un anno dopo la situazione era ben lungi dallo sbloccarsi e il ministro
dell’Africa italiana sollecitava quello della Guerra a prevedere una serie di
misure per incentivare la scelta coloniale di un buon numero di ufficiali
«idonei e appassionati»:
190
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
Per assicurare l’afflusso a tale specialità di elementi scelti si riconobbe necessario di
prevedere per gli appartenenti alla specialità stessa alcuni vantaggi e cioè:
– indennità di specialità;
– aumento di indennità di conoscenza lingue;
– corresponsione di metà dell’indennità di equipaggiamento ad ogni rientro in colonia
dai periodi di servizio metropolitano;
– facoltà di conservare la divisa coloniale durate il servizio metropolitano (almeno per
quanto riguarda l’uniforme non di marcia).
Lo schema del decreto legge relativo fu approvato condizionatamente il 12 settembre
1936 dal Consiglio dei Ministri. Senonché attraverso la successiva elaborazione lo
schema in parola sottoposto alla firma sovrana il 3 giugno 1938 risultò spogliato dai
suddetti vantaggi, e principalmente da quello dell’indennità di specialità che, com’è
noto, era stata prevista nell’intento di compensare, sia pure in parte, il maggiore onere
economico che sarebbe derivato agli ufficiali della specialità – specie se ammogliati con
prole – obbligati a percorrere tutta la carriera in colonia34.
Teruzzi proponeva a questo punto di restringere gli organici della specialità al numero di ufficiali effettivamente necessari per l’inquadramento
dei reparti e che erano individuati in 16 colonnelli, 98 ufficiali superiori,
332 ufficiali inferiori e 635 ufficiali subalterni35. La risposta non era stata certo delle più entusiaste e celeri e un mese dopo lo stesso Teruzzi si
trovava a chiedere nuovamente la concessione di vantaggi e incentivi o
quantomeno che agli ufficiali coloniali venissero applicate le stesse agevolazioni previste per coloro che erano impiegati in zone di frontiera, sia in
termini economici che di carriera36. Le resistenze dello stato maggiore non
si limitavano però al tentativo di istituire una specialità coloniale ma coinvolgevano in generale tutte le richieste di stabilizzare il flusso di ufficiali
che raggiungeva la colonia. Era infatti stata richiesta la predisposizione di
percorsi formativi per i militari da inviare nell’Impero e lo stato maggiore
aveva preso in considerazione l’idea di istituire una scuola che organizzasse corsi di tre mesi volti alla preparazione pre-coloniale per ufficiali e
truppa. Secondo il progetto studiato ai corsi avrebbero dovuto partecipare all’incirca 900 ufficiali inferiori, 800 sottufficiali e 3.000 uomini di
truppa ogni anno. In realtà anche la predisposizione di corsi all’interno di
una scuola coloniale venne rapidamente scartata perché considerata troppo
«complessa, abbisognevole di rilevante numero di istruttori, vasti locali in
relazione all’affluenza contemporanea di forti aliquote di personale, ingente quantitativo di materiali d’addestramento, notevoli spese d’impianto e
di gestione (approssimativamente ogni anno il funzionamento della scuola
191
Cristiana Pipitone
assorbirebbe circa 2 milioni di lire), non prontamente realizzabile»37. In
sostituzione veniva data disponibilità a svolgere quattro corsi ogni anno di
40 giorni destinati agli ufficiali inferiori e ai sottufficiali da tenersi «presso
taluni reggimenti del corpo d’armata di Napoli» riservati a 40-50 ufficiali
per corso (aperti sia agli ufficiali in servizio permanente che a ufficiali di
complemento) tratti in larga maggioranza dal corpo d’armata di Napoli.
Gli ufficiali
Dibattiti, proposte e studi non diedero luogo alla creazione di una specialità coloniale. Il servizio in colonia restò quindi una scelta compiuta
singolarmente e individualmente. Alla metà degli anni venti si era già consolidato un gruppo di ufficiali che poteva con buone ragioni autodefinirsi
coloniali, avendo sfruttato tutti gli spiragli lasciati aperti dai regolamenti.
Questo meccanismo di autoselezione è abbastanza evidente prendendo in
considerazione le carriere di alcuni ufficiali che arrivano al grado di generale all’indomani della guerra di Etiopia. A cominciare da Graziani e continuando con Pietro Maletti, Ruggero Tracchia, Luigi Cubeddu. Scorrendo
le carriere dei vari colonnelli e generali a capo dei reparti indigeni risulta
chiaro che per tutti la scelta della destinazione in terra africana non è una
novità indotta dal conflitto. Alcuni - Cubeddu, Belly, Malta, Tracchia hanno partecipato alla conquista della Libia negli anni dieci, e dopo un
periodo in patria in coincidenza con il conflitto mondiale, hanno chiesto
di tornare in Africa.
Scelte individuali dunque che sembrano tracciare però il percorso di
un curriculum, di una carriera particolare all’interno dell’esercito. Questo
è senz’altro verificabile per un vertice, un nucleo di ufficiali che arrivano
all’apice della propria carriera ad assommare cariche ed incarichi di vertice
sia militari che civili. Più complesso il discorso scendendo lungo la piramide gerarchica, anche perché la guerra di Etiopia prima e la perdita delle colonie successivamente danno luogo a due diversi momenti di cesura che è
necessario tenere presente nella valutazione di scelte individuali e di gruppo.
Si trovano indicazioni interessanti esaminando le assegnazioni degli ufficiali ai Regi corpi truppe coloniali nel corso del periodo che va dal 1922
al 193438. La permanenza media degli ufficiali nelle diverse colonie varia
dai due anni e sette mesi degli ufficiali destinati in Cirenaica ai tre anni e
mezzo di quelli destinati in Eritrea. Fin qui il dato coincide abbastanza con
192
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
quella che avrebbe, in via teorica, dovuta essere la permanenza media degli
ufficiali oltremare. Dei quasi cinquemila ufficiali che ruotarono nelle colonie, nel periodo preso in considerazione, poco più del 12 per cento scelse di
restarvi per periodi sensibilmente più lunghi di quanto non fosse previsto
o consentito. E di questo dodici per cento quasi la metà superò abbondantemente il periodo di tempo massimo consentito dai regolamenti vigenti.
L’esame delle permanenze in colonia ci permette però di trovare altre
indicazioni interessanti: l’Eritrea sembra essere quella che attrae maggiormente elementi predisposti ad una lunga permanenza oltremare. Sono
infatti molti meno in termini percentuali e assoluti coloro che scelgono
una permanenza brevissima, meno della ferma minima biennale, mentre è
decisamente alto in valori percentuali, il numero di coloro che decidono e
riescono a fermarsi in colonia per un periodo anche sensibilmente superiore ai sei anni massimi previsti dall’ordinamento in vigore. Particolarmente
alto è il numero di coloro che si fermano per un periodo intermedio, ma
comunque superiore a quello della media. Se consideriamo come indicatore di gradimento della vita militare in colonia una permanenza superiore
ai quattro anni abbiamo un 40 per cento di ufficiali che sceglie la più
tranquilla delle colonie come opzione interessante all’interno della propria
carriera. Percentuale superiore a quella relativa agli ufficiali che restano per
il periodo «medio» di due-quattro anni (38 per cento). Diversi i dati che
riguardano le altre colonie, territori soggetti nel periodo preso in considerazione, ad operazioni di polizia coloniale, che impegnano in situazioni di
guerra e di controguerriglia i militari che vi erano impiegati.
La percentuale di «insabbiati» è infatti compresa tra il 21 per cento della
Cirenaica e il 34 per cento della Tripolitania. Non una differenza particolarmente accentuata considerando che anche la Somalia ha una percentuale di
«insabbiati» che si aggira attorno al 35 per cento. Dall’esame comparativo
delle permanenze nelle diverse colonie emerge inoltre un dato molto netto,
se sono sicuramente di più quelli che vengono assegnati ai regi corpi truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica i picchi maggiori di permanenza sono invece appannaggio di ufficiali che scelgono il Corno d’Africa.
Le gran parte degli ufficiali impiegata in colonia proviene dalla categoria degli ufficiali di carriera. Questa è l’assoluta maggioranza in Eritrea
e Somalia, mentre percentuali lievemente più basse si hanno in Cirenaica
e Tripolitania. Nel periodo considerato gli ufficiali di complemento sono
infatti poco meno del 5 per cento del totale in Eritrea, il 3,5 per cento
193
Cristiana Pipitone
in Somalia mentre per le colonie libiche si hanno cifre attorno al 17 per
cento per la Cirenaica e del 19 per cento in Tripolitania39. Questo dato è
abbastanza in contraddizione con quanto normalmente accreditato in una
sorta di senso comune che vede la colonia come la destinazione scelta per
motivi economici da molti italiani in cerca di un’occupazione e il servizio
coloniale come un modo per ottenere il passaggio in servizio permanente
altrimenti precluso. Accertare l’effettiva composizione dei diversi regi corpi (tra ufficiali in servizio permanente e ufficiali di complemento) risulta
abbastanza complesso, in quanto non si hanno dati precisi, e soprattutto,
verificabili sul lungo periodo. Le relazioni trimestrali non distinguono tra
ufficiali di complemento e quelli in servizio permanente limitandosi a fornire la forza in totale del corpo stesso. Gli ufficiali di complemento vengono abbondantemente nominati però nelle relazioni critiche sullo stato del
regio corpo: a leggerle si sarebbe portati a pensare che la loro percentuale
sul totale del personale fosse molto alta. In realtà, le rare volte che vengono
fornite notizie meno sintetiche si è costretti a concludere che essi, fino al
1935, erano una netta minoranza.
Le analisi sulla permanenza divisi per categorie di ufficiali mostra delle
leggere differenze di comportamento. In Tripolitania sono gli ufficiali di
complemento a mostrare una maggiore tendenza a prolungare la permanenza in colonia il 37 per cento del totale sceglie infatti di restare per periodi superiori ai 4 anni e di questi il 13 per cento vi resta per un periodo
superiore ai 6 anni contro il 28 per cento degli ufficiali in servizio permanente che restano per periodi superiori ai 4 anni (di cui il 13 per cento
resta comunque oltre i 6 anni). In Cirenaica tale tendenza risulta ancora
più marcata: il 37 per cento degli ufficiali di complemento resta infatti per
periodi superiori ai 4 anni (l’11 per cento supera i 6 anni) a fronte del 16
per cento degli ufficiali in servizio permanente (di cui solo il 5 per cento
sceglie l’oltremare per più di 6 anni). Molto diverso è il caso delle colonie
del Corno d’Africa: l’Eritrea è senz’altro la meta preferita dagli ufficiali in
servizio permanente ben il 36 per cento di questi la sceglie come destinazione per periodi lungi (di cui il 16 per cento resta oltre i 6 anni) contro il
16 per cento in totale degli ufficiali di complemento (di cui il 5 per cento
resta più dei canonici 6 anni). La Somalia è invece la colonia che meno
di tutte attira gli ufficiali della riserva: sono solo l’11 per cento quelli che
restano oltre 4 anni e nessuno per periodi superiori a 6 mentre gli ufficiali
in servizio permanente che rimangono oltre i 4 anni sono il 24 per cento
194
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
del totale e di questi un buon 10 per cento si ferma oltre i 6 anni.
È presumibilmente vero che buona parte degli ufficiali di complemento partisse spinto da motivazioni economiche, sia per ottenere un’occupazione transitoria sia per tentare il passaggio nei ranghi. In realtà il passaggio
al servizio permanente avveniva praticamente solo per meriti di guerra e
questo spiega in parte (accanto alla maggiore necessità derivante dalle operazioni di polizia coloniale in corso) la maggiore presenza nelle colonie del
Mediterraneo. Dai dati emerge che i passaggi dalla riserva al servizio permanente riguardò infatti il 37 per cento degli ufficiali destinati in Tripolitania (ma tale percentuale sale al 46 per cento di quelli che restano più a
lungo), il 44 per cento di quelli della Cirenaica (ma se consideriamo quelli
che allungano il periodo la percentuale sale al 58 per cento) mentre solo il
20 per cento (ma la totalità di quelli che scelgono la ferma lunga) di quelli
inviati in Eritrea e nessuno di quelli inviati in Somalia.
L’esame delle permanenze in colonia mette in luce una serie di aspetti
che riguardano l’organizzazione dei regi corpi (almeno per quanto riguarda
i quadri). Si è detto che l’esperienza in colonia, in tempo di pace, veniva
considerata formativa e c’era chi caldeggiava una turnazione che portasse
in Africa una buona parte degli ufficiali italiani. Diverso era invece il punto di vista di chi era impegnato sul campo e che avrebbe preferito poter
contare su un personale preparato e consapevole delle caratteristiche della
vita e della guerra coloniale. L’analisi delle permanenze in colonia mette
in luce la presenza di entrambe le tendenze: da una parte c’è chi sceglie di
allungare la propria ferma coloniale, dall’altro c’è un cospicuo numero di
ufficiali che in colonia si ferma pochissimo (ben al di sotto della ferma di
biennale). Non si tratta di una percentuale irrisoria nella vita dei regi corpi.
Nel periodo preso in considerazione quelli che restano per ferme molto
brevi sono una percentuale che va dal 22 per cento della Somalia e il 32
per cento della Cirenaica. La permanenza media fra questi è attorno ad un
anno, lievemente sopra per Tripolitania, Cirenaica e Somalia e al di sotto
invece per l’Eritrea. Ancora più interessante è però il dato che considera il
numero di quanti sono sotto la permanenza media individuata: all’interno
di questo gruppo infatti si nota come la grande maggioranza degli ufficiali
resta in colonia per un periodo di tempo inferiore alla media. Il dato è
maggiormente accentuato per la Cirenaica e la Tripolitania rispetto alle
due colonie del Corno d’Africa il che si spiega con due ordini di motivi:
da una parte la maggiore distanza dei paesi dell’Africa subsahariana dalla
195
Cristiana Pipitone
madrepatria, dall’altra la situazione di guerra che spingeva i comandanti a
liberarsi più velocemente degli ufficiali meno idonei o motivati. Il turnover
veloce riguardava in termini percentuali e assoluti molto più gli ufficiali
in servizio permanente di quanto non riguardasse quelli di complemento:
in Cirenaica erano il 42 per cento fra gli ufficiali in servizio permanente
mentre il 23 per cento del totale di quelli di complemento; in Somalia il
35 per cento e l’11 per cento; in Tripolitania il 30 per cento e il 13 per
cento e in Eritrea rispettivamente il 31 per cento e il 20 per cento. Questo
è da una parte perfettamente logico e intuibile: gli ufficiali delle categorie
in congedo chiedevano espressamente di essere richiamati e inviati in colonia, mentre per gli ufficiali in servizio permanente la scelta dell’oltremare
poteva essere imposta di autorità, d’altro canto molti rimpatri avvenivano
d’autorità, per inidoneità, mancanze disciplinari etc. e a dar credito alle
relazioni dei vari comandanti dei regi corpi era soprattutto tra gli ufficiali
di complemento che si trovavano gli elementi più problematici.
Per quanto riguarda la volontarietà del servizio coloniale, la fonte utilizzata consente delle conclusioni che vanno lette con una certa cautela: il
«Bollettino ufficiale» registra sempre se l’assegnazione ad un regio corpo
fosse a domanda o d’autorità e sicuramente per molti casi la registrazione è
piuttosto fedele. Si tenga però presente che per taluni che avevano lunghi
trascorsi coloniali la possibilità di essere riassegnato a qualche regio corpo
a propria domanda doveva essere esclusa: in questi casi veniva utilizzato
l’escamotage della chiamata nominativa da parte del governatore o del comandante delle truppe e in quel caso risultava che l’ufficiale fosse partito
su decisione d’autorità. La partenza su libera scelta riguarda, ovviamente,
la quasi totalità degli ufficiali di complemento.
Diversa la situazione per gli ufficiali in servizio permanente: è una scelta per il 53 per cento degli ufficiali assegnati al Regio corpo truppe coloniali della Cirenaica, il 52 per cento per quelli destinati in Eritrea, 51 per
cento per la Tripolitania e del 62 per cento per la Somalia. La Somalia
era sicuramente la colonia in cui le difficoltà ambientali erano maggiori e
questo spiega perché la maggior parte delle assegnazioni veniva fatta prendendo in considerazione la volontà espressa dai singoli. Indicazioni più
interessanti si ottengono esaminando le richieste sul totale delle assegnazioni per ciascuno degli anni considerati. Prendendo in esame le diverse
colonie emergono delle tendenze che differiscono da località a località e in
base alle diverse situazioni militari. La Tripolitania è la colonia in cui – per
196
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
il periodo considerato – le assegnazioni a domanda seguono l’andamento
più costante la percentuale di chi sceglie di andarvi si mantiene sopra il
50 per cento (tranne che per il 1927 che però è anche l’anno in cui vi è
il picco delle nuove assegnazioni e in cui scende di poco sotto il 50 per
cento e il 1934 in cui si tocca il picco negativo) con una buona frequenza
di percentuali superiori che però raramente superano il 70 per cento. Abbastanza simile il dato per la Cirenaica dove gradiscono la destinazione per
ogni anno più della metà degli ufficiali tranne che nel 1927 e nel 1929; si
tenga presente che anche per la Cirenaica il 1927 è l’anno in cui è più alto
il numero delle nuove assegnazioni.
Più altalenanante il dato che riguarda le due colonie del Corno d’Africa:
nei primi anni (tra il 1922 e il 1925) le assegnazioni in Somalia sembrano
essere tutte di ufficiali che scelgono la destinazione volontariamente, nel
1926 nel pieno delle operazioni nell’Oltre Giuba si assiste – come è ovvio
– ad un’impennata degli invii in colonia e in questo caso le assegnazioni
di ufficiali sono a maggioranza di autorità e solo il 40 per cento sceglie di
andarvi; negli anni successivi vi è una crescita percentuale delle assegnazioni a domanda che è parallela ad una diminuzione numerica degli ufficiali
che ogni anno vengono inviati nella. L’Eritrea è la colonia con l’andamento
apparentemente meno lineare: a un grosso picco di assegnazioni nel 1923
corrisponde un basso livello di gradimento (30 per cento) che però in termini assoluti è molto vicino a valore dei due anni successivi (in cui il dato
percentuale è molto alto perché sono sensibilmente di meno gli ufficiali
che partono per la colonia). Per gli anni successivi il livello di gradimento
sembra assestarsi su livelli molto alti in termini percentuali, per crollare poi
nel 1931 (quando scende sotto il 50 per cento), quindi risalire per toccare
un nuovo picco negativo nel 1934.
L’opzione coloniale è scelta dall’89 per cento dei sottotenenti, dal 65
per cento dei tenenti dal 68 per cento dei capitani, 56 per cento dei maggiori, 35 per cento dei tenenti colonnelli e dall’8 per cento dei colonnelli40.
Analizzando i comportamenti di chi sceglie la colonia come luogo per un
cospicuo numero di anni della propria carriera emergono diversi percorsi.
Restringendo il campo di analisi a quanti di fermano più di 4 anni emergono alcune linee di tendenza. In primo luogo c’è chi sceglie di fermarsi oltre
i sei anni previsti dai regolamenti: questo riguarda il 42 per cento degli
ufficiali che si trovano in Eritrea, il 38 per cento di quelli in Somalia, il 29
per cento di quelli in Cirenaica e mentre per la Tripolitania sono il 49 per
197
Cristiana Pipitone
cento. Il dato medio di permanenza, in questo gruppo è di poco inferiore
ai sei anni consecutivi. La scomposizione per grado mostra un andamento
che è molto simile a quello delle assegnazioni: ad essere inviati in colonia
– nel periodo considerato – sono infatti soprattutto tenenti (60 per cento)
seguiti da capitani (25 per cento) poi dai sottotenenti (9 per cento) quindi
a salire lungo la piramide gerarchica. Molto simile la composizione di chi
sceglie di restare in colonia con il 68 per cento di tenenti, il 19 per cento
di capitani e il 7 per cento di sottotenenti mentre praticamente invariata
è la percentuale di ufficiali superiori che parte e che decide di restare (3
per cento i maggiori, 2 per cento i tenenti colonnelli e 1 per cento i colonnelli). Non stupisce che il gradimento della destinazione sia molto alto,
supera in tutte le colonie il 70 per cento a fronte di un dato medio globale
poco superiore al 50 per cento. Così come non stupisce il dato relativo ai
tenenti: si rispetta la proporzione che li vuole in maggior numero sia nelle
assegnazioni che nei scelte di lunga permanenza41. È invece interessante
il dato relativo ai capitani: se un’esperienza in colonia può essere considerata utile all’interno della propria carriera (erano il 68 per cento quelli
che partivano per propria richiesta) il prolungamento della stessa viene
evidentemente percepito come problematico, si tratta di uomini che sono
in una fascia di età più avanzata, con una famiglia in Italia e qualche preoccupazione di carriera. Di altro segno invece il dato che riguarda gli ufficiali
superiori: siamo in questo caso di fronte a persone che l’opzione coloniale
l’hanno già fatta e i cui nomi sono ben noti42; per questi la colonia è una
scelta di vita e di percorso professionale.
Profondamente diversa è la situazione nell’impero. All’inizio dell’estate
del 1936 risultavano presenti circa quattordicimila ufficiali, erano quelli
che avevano partecipato alle operazioni di conquista, e la maggior parte di
loro venne rimpatriata con le grandi unità nazionali. Degli ufficiali inferiori
presenti durante il conflitto circa il 75 per cento apparteneva alle categorie
in congedo e solo una minima parte a quelli in servizio permanente43. Fin
qui nulla di cui stupirsi la campagna per la conquista dell’Etiopia era stata
gestita come quella che Rochat definisce una «guerra nazionale» e con uno
spiegamento di forze che non aveva paragoni con le operazioni militari e
con la forza dei regi corpi truppe coloniali44. Degli oltre quattordicimila
ufficiali presenti in Africa Orientale alla fine del conflitto ne sarebbero dovuti rimanerne, secondo il Nuovo Ordinamento, poco più di duemila di cui
la maggioranza effettivi, coadiuvati da poche centinaia di complemento45.
198
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
La realtà si dimostrò ben diversa. Alla metà di aprile del 1937 si trovavano nell’impero, impiegati nei vari reparti 1.621 ufficiali di carriera e più
di cinquemila appartenenti ad altre categorie. La situazione e la necessità di
quadri per le bande regolari e irregolari, per i battaglioni indigeni costituiti
in soprannumero, per la costituzione dei nuovi enti previsti per la mobilitazione, non consentiva di potersi accontentare di circa duemilacinquecento ufficiali46. Per la fine di giugno Graziani prevedeva di poter smobilitare
circa duemilasettecento ufficiali di complemento e circa quattrocento fra
gli effettivi. La proporzione fra le due categorie vedeva quindi una netta
prevalenza di personale di complemento rispetto ai militari di carriera47.
Nel 1938 erano presenti 5804 ufficiali impiegati nei vari governi e reparti,
di questi solo 1161 in servizio permanente (e di questi solo 987 del ruolo
combattente)48. L’impegno militare nel quinquennio dell’impero, e la vastità del territorio, non consentirono mai di portare la struttura dell’esercito a quella che avrebbe dovuto essere secondo gli organici di pace. Se
a questo si aggiunge la struttura a fungo del corpo ufficiale disegnata da
Badoglio prima e cristallizzata da Baistrocchi49 dopo risulta chiaro che la
proporzione tra ufficiali in servizio permanente e ufficiali di complemento
non potesse che essere inversa rispetto alle esperienze precedenti.
Le carriere
Le prospettive di carriera nel periodo che seguì il primo conflitto mondiale non erano rosee per gli ufficiali italiani, e a maggior ragione apparivano poco rosee per quelli impegnati in modo semi stabile in colonia.
O quanto meno questa era la percezione che ne avevano gli interessati.
L’esperienza in colonia era considerata formativa se essa si concludeva dopo un breve periodo, quando si prolungava veniva considerata dannosa e
potenzialmente perniciosa per la formazione degli ufficiali50. Non stupisce
in questo quadro che le lunghe permanenze in colonia venissero interpretate come elementi in grado si rallentare ancora di più la progressione
delle carriere. È difficile, se non impossibile, verificare se e quanto questa
percezione corrispondesse a un dato reale su tutto il corpo ufficiali. Al di
là delle lamentazioni che nel corso degli anni venti e trenta si alzavano
periodicamente sulle condizioni penalizzanti in cui versava la professione
non esistono studi, né coevi né successivi, che prendano in considerazione
tale aspetto della vita degli ufficiali italiani51.
199
Cristiana Pipitone
Gli unici dati di confronto si trovano nel lavoro di Gian Luca Balestra
sull’Accademia di Modena52. Utilizzando i dati di Balestra come termine
di paragone emerge che l’avanzamento è più o meno allineato per quanto
riguarda il passaggio da tenente a maggiore (in cui gioca il meccanismo
dell’anzianità), arriva più in ritardo per i gradi successivi (quando è in
vigore il meccanismo dell’avanzamento a scelta) mentre l’impiego in conflitti apre prima la strada per l’accesso ai gradi di generalato: Pietro Maletti
e Giuseppe Malta, ad esempio, ottengono la promozione a colonnello un
paio di anni dopo i colleghi metropolitani pari corso, ma raggiungono più
velocemente il grado di generale53; Luigi Cubeddu, che ottiene il grado
di colonnello un anno dopo la maggioranza dei suoi pari corso è però il
primo ad ottenere il grado di generale54. I più giovani Livio Bonelli, Aldo
Princivalle e Orlando Lorenzini devono invece attendere sensibilmente più
dei loro colleghi pari grado prima di ottenere la promozione a maggiore e
a tenente colonnello mentre il passaggio successivo riavvicina gli ufficiali
del campione che conseguono quasi tutti (tranne un caso) la promozione a
colonnello tra il 1936 e il 1939: i tre «coloniali» non sono da meno Princivalle vi arriva nel 1937 per merito di guerra, Lorenzini nel 1938, anche lui
per merito di guerra e Bonelli nel 1939. Il passaggio successivo segna invece una discontinuità e solo sei degli ufficiali del campione raggiungono
il grado di generale mentre tutti e tre i «coloniali» vi arrivano: Princivalle
e Lorenzini nello stesso anno dei due primi ufficiali del campione, Bonelli
nettamente dopo55.
Questi dati, per quanto ben lontani dall’essere conclusivi, suggeriscono
che tra gli «ufficiali coloniali», per lo meno per quelli che raggiungono i
gradi più alti, le progressioni di carriera fossero tutto sommato abbastanza
simili a quelle degli ufficiali «metropolitani». Per quanto si è potuto verificare vi era un rallentamento della carriera che incideva sul passaggio tra
i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello. Mentre non sembra
che vi fosse preclusione rispetto al passaggio ai gradi massimi: anzi rispetto al campione selezionato da Balestra i «coloniali» vi arrivavano prima e
avevano la possibilità di progredire più velocemente. Entrava in gioco, a
questo punto, l’impiego in guerra in modo più continuativo rispetto ai
colleghi «metropolitani» che consentiva il passaggio per merito.
200
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
Note al testo
1
G. Aldo Gatti, Thala… Ya-.Nari, F. Casanova & C, Torino 1933, pp.110-11
2
Nel gennaio 1928 venne deciso da dar corso a una serie di operazioni militari che dovevano
consentire di riunire le due colonie (Cirenaica e Tripolitania) a cavallo del 29° parallelo. Alle
operazioni parteciparono forze sia dalla Tripolitania che dalla Cirenaica. Il 25 febbraio una
colonna comandata da Graziani arrivò nei pressi dei pozzi di Bir Tagrift che si trovano all’interno di una conca. La necessità di reintegrare le scorte d’acqua convinsero il comandante della
colonna ad entrare nella conca, nonostante fosse evidente il rischio che la conformazione del
terreno poneva. Infatti alle 7,45 la colonna venne attaccata da un gruppo di armati di forza più
o meno pari a quella della colonna Graziani. La battaglia durò alcune ore e si concluse con un
successo tattico degli italiani che riuscirono a conquistare i pozzi a costo di alte perdite (da entrambe le parti). Si tratta di uno dei pochi casi in cui le forze in campo si equivalsero in termini
di consistenza numerica. Cfr Angelo Del Boca, Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi,
Laterza, Roma Bari 1986-1988, pp. 96 ss.
3
Secondo Giulietta Stefani, Graziani e Amedeo di Savoia diverranno i poli divergenti entro cui
si collocano i modelli maschili del colonizzatore. Cfr. Giulietta Stefani, Ufficiali coloniali in
Etiopia: una professione maschile, in Militari italiani in Africa. Per una storia sociale e culturale
dell’espansione coloniale, a cura di Nicola Labanca, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2004,
p. 264 e Ead, Colonia per maschi. Italiani in Africa orientale: una storia di genere, Ombre corte,
Verona 2007.
4
Si vedano ad esempio Aldo Caipenta, IL generale Graziani l’africano, Edizioni Aurora, Milano
1936, o Sandro Sandro, Il principe sahariano, L’Azione coloniale, Roma 1933.
5
Alessandro Cova, Graziani, un generale per il regime, Newton Compton, Roma 1987, pp.
83.
6
Cfr. soprattutto Angelo Del Boca, Italiani in Africa orientale, Laterza, Roma - Bari 19761984.
7
Giorgio Rochat, Militari e politici nella preparazione della guerra d’Etiopia, Franco Angeli,
Milano 1971, p. 201.
8
Fabienne Le Houérou, L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie. Les «Ensablés», L’Harmattan, Paris 1994, p. 53.
9
G. Stefani, Ufficiali coloniali in Etiopia: una professione maschile cit., p. 271.
10
Dario Lischi, Il generale Ruggero Tracchia, Nistri Lischi, Pisa 1938.
11
Ivi, p. 25.
12
G. Rochat, Militari e politici nella preparazione della campagna d’Etiopia cit.
13
Bisogna tenere presente che, dopo un netto ritardo la storiografica sul colonialismo conosce
ormai lavori di sintesi e studi particolare. Si vedano in particolare i lavori di Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, Laterza, Roma-Bari 1976-1984; vol. I Dall’Unità alla marcia
su Roma, vol. II La conquista dell’impero, vol. III La caduta dell’impero, vol. IV Nostalgia delle
colonie. Id, Gli italiani in Libia, 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1986-1988; Giorgio Rochat, La
repressione della resistenza araba in Cirenaica nel 1930-31 nei documenti dell’archivio Graziani,
in «Il movimento di liberazione in Italia», n. 110, 1973, pp. 3-39; Id, Il genocidio cirenaico e la
storiografia coloniale, in «Belfagor», n. 4, 1980, pp. 449-456; Id, La repressione della resistenza
in Cirenaica 1927-1931, in Id, Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939,
Pagus, Treviso 1991; Id, L’esercito italiano in pace e in guerra, Rara, Milano 1991; Id, Guerre
201
Cristiana Pipitone
italiane in Libia e in Etiopia, studi militari 1921/1939, Franco Angeli, Milano1992; un bilancio
sullo stato degli studi è in N. Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il
Mulino, Bologna 2002.
14
Si veda ad esempio Raffaele Ciasca, Storia coloniale dell’Italia contemporanea. Da Assab
all’impero, Hoepli, Milano 1938.
15
Si vedano ad esempio Pietro Badoglio, La guerra d’Etiopia, Milano 1936; Rodolfo Graziani, Il fronte sud, Mondadori Milano 1938 solo per citarne due dei più noti.
16
Sui regi corpi truppe coloniale si vedano i lavori di Marco Scardigli, Il braccio indigeno,
Franco Angeli, Milano 1996 e Alessandro Volterra, Sudditi coloniali, Franco Angeli, Milano 2005.
17
Ad esempio Piero Pieri, G.Rochat, Pietro Badoglio, Utet, Torino 1974; Romano Canosa,
Graziani: il maresciallo d’Italia, dalla guerra d’Etiopia alla Repubblica di Salò, Mondadori, Milano 2004.
18
Cfr. Lucio Ceva, Fascismo e militari di professione in Ufficiali e società. Interpretazioni e modelli,
a cura di Piero Del Negro e Giuseppe Caforio, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 400-401.
19
Cfr. Oreste Moricca, Trattato di arte militare coloniale, Roma, Stabilimento tipo-litografico
del genio civile, 1930, pp. 41-42.
20
Archivio dell’Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito (da ora in poi Aussme), L8, 172,
fasc. 2, «Relazioni trimestrali Rctc Cirenaica», agosto 1923.
21
Aussme, L7, 183, fasc. 3, «Relazioni trimestrali Rctc Eritrea», gennaio 1926.
22
Aussme, L8, 173, fasc, 11, «Rapporti trimestrali Rctc Tripolitania», maggio 1926.
23
Ivi
24
Cfr. G. Rochat, La missione Malladra e la responsabilità della preparazione militare in Africa
orientale nel 1926, in «Il Risorgimento», n.3, 1970. I verbali delle riunioni sono in Aussme,
L8, b. 189, fasc. 2.
25
Ivi, verbale del 20 maggio 1925.
26
Ivi, promemoria per le autorità superiori sulla questione «Ufficiali nelle colonie».
27
Ivi.
28
Ivi.
29
Ivi
30
Archivio centrale dello Stato (da ora in poi Acs), Presidenza del Consiglio dei ministri (da ora
in poi Pcm), Atti 1940-1942, Ministero dell’Africa italiana, 81.
31
Aussme, N11, 4104, I-3-5, gennaio 1938.
32
Ivi, art. 2.
33
Ivi, artt. 8 e 9.
34
Aussme, b. 4105, I-3-2, Lettera di Attilio Teruzzi al ministero della Guerra, 17 giugno 1939.
Teruzzi argomentava abbondantemente la necessità di incentivare la scelta coloniale facendo osservare come «chi ha numerosi figli da istruire e per ragioni di servizio si trovi a dover
risiedere – sia pure a quinquienni alternati a bienni in Madrepatria – nelle zone periferiche
dell’Impero, dovrà evidentemente mantenere per gli studi in permanenza i figli ad Addis Abeba
oppure in Italia. Ed ecco che in tal caso la sola indennità coloniale non sarebbe assolutamente
sufficiente a compensare soltanto questa maggiore spesa. Comunque, allo scopo di non gravare
202
Foto di gruppo. Ritratti di ufficiali coloniali
il bilancio dello Stato di nuovi oneri e confidando di poter trovare ufficiali non ammogliati
disposti ad entrare nella specialità, questo Ministero era venuto alla determinazione di dar
corso alla pubblicazione del Rd in parola, senonché è intervenuto nel frattempo il noto provvedimento di carattere demografico (di prossima estensione agli ufficiali) col quale è posta come
condizione di quella ammogliato al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato
che aspiri a successive promozioni».
35
Le cifre indicate da Teruzzi si riferivano all’ordinamento di pace che era ben lungi da quello,
effettivo, vigente al momento in Aoi.
36
Ivi, lettera di Teruzzi al ministero della Guerra, 8 luglio 1939.
37
Aussme, N11, b. 4105, I-3-2A, relazione sul «reclutamento personale nazionale per l’Aoi e la
Libia. Reggimento scuola coloniale», 25 mar. 1939.
38
L’esame è stato condotto sulla base delle assegnazioni ai corpi che risultano sul «Bollettino
ufficiale» del ministero della Guerra: i dati sono stati inseriti in un database da cui sono state
estratte alcune elaborazioni. Sono stati rilevati nome, cognome, grado, appartenenza o meno
al servizio permanente, arma di appartenenza, volontarietà o meno della scelta in colonia, data
di assegnazione e destinazione di assegnazione. Tutte le elaborazioni seguenti si basano sui dati
raccolti in questo modo. Il periodo di osservazione è stato limitato al 1934 in quanto la fonte
scelta per la rilevazione diventa imprecisa e difficilmente attendibile per quanto riguarda il
periodo del conflitto con l’Etiopia: un gran numero di ufficiali viene inviato in Africa orientale
con le divisioni nazionali e di questi è impossibile ottenere la registrazione. I dati successivi
sarebbero quindi stati alterati da una serie di rimpatri cui non corrispondeva notizia di partenza
per la colonia.
39
Sono considerati solo gli ufficiali di complemento partiti dall’Italia con un’assegnazione ai Regi
corpi truppe coloniali. Nelle diverse colonie vivevano cittadini italiani che avevano partecipato
ai corsi per ufficiali di complemento e pertanto erano considerati nella riserva. Ma si trattava
di persone che avevano nelle colonie occupazioni diverse.
40
Il dato soprattutto per gli ufficiali superiori (in particolare per i colonnelli) va ricalibrato.
Quelle esposte sono linee di tendenza ma per i colonnelli è sicuramente falsato dalle assegnazioni d’autorità fatte per aggirare i regolamenti.
41
Ma per la seconda metà degli anni venti non si tratta di un dato omogeneo con la composizione del Regio esercito, vedi infra.
42
Si tratta di Pietro Maletti, Giuseppe Malta, Rodolfo Graziani solo per citarne alcuni.
43
Mario Montanari, “Il progetto AO” e i suoi sviluppi in «Studi storico militari», 1987, pp.
705-731.
44
Una guerra è nazionale quando la mobilitazione coinvolge tutto un paese intero, non solo le
forze armate ma anche l’industria, il capitalismo finanziario e la società nel loro complesso.
Le caratteristiche sono: un esercito numeroso composto da coscritti e richiamati e non da
professionisti, crescita esponenziale delle commesse belliche, massiccia mobilitazione degli attori sociali tramite l’impiego della propaganda dalla carta stampata agli strumenti più evoluti
tecnologicamente. In base a ciò, la guerra italo-etiopica del 1935-36 fu la più tipica delle guerra
nazionali a cui possiamo pensare.
45
Aussme, D1, 184, Promemoria 21754 prot. cit.
46
Aussme, N11, 4130, IV/2/5, Foglio 23834, del 6 maggio 1937. “Esistenza e fabbisogno ufficiali in SPE in AOI”.
47
Ivi.
203
Cristiana Pipitone
48
Aussme, N11, b. 4106, I/3/1.
49
In seguito alla prima guerra mondiale le carriere degli ufficiali italiani erano di fatto bloccate
a causa della forte immissione in ruolo di molti ufficiali di complemento. Gli anni successivi
assistettero ad un progressivo sfoltimento dei ruoli. In termini numerici, nel 1926 si arrivò a un
organico di 194 generali, 4.414 ufficiali superiori, 6.129 capitani e 5.283 ufficiali subalterni.
Nel 1934 con l’ordinamento voluto da Federico Baistrocchi si contrassero ulteriormente le
ammissioni nelle accademie militari e venne istituita la «vacanza obbligatoria» secondo la quale
ogni anno un numero predeterminato di ufficiali doveva abbandonare l’esercito, su questo
problema si veda G. Rochat, Gli ufficiali italiani nella prima guerra mondiale, e L. Ceva,
Fascismo e militari di professione in Ufficiali e società. Interpretazioni e modelli cit.; G. Rochat e
G. Massobrio, Breve storia dell’esercito italiano, Einaudi, Torino.
50
Rimando al mio Cristiana Pipitone, Ufficiali italiani delle guerre coloniali in Militari italiani
in Africa. Per una storia sociale e culturale dell’espansione coloniale. Atti del convegno di Firenze,
12-14 dicembre 2002, cit.
51
Cfr. L. Ceva, Fascismo e militari di professione cit., p. 404.
52
Cfr. Gianluca Balestra, La formazione degli ufficiali nell’Accademia militare di Modena
(1895-1939), Stato maggiore dell’esercito, Roma 2000. L’autore prende in considerazione e
fornisce i dati della progressione nelle carriere dei primi e ultimi classificati all’esame finale
degli allievi di ogni corso dell’Accademia.
53
Per le note biografiche e la carriera di Malta e Maletti cfr Aussme, biografie, b. 41 e 90, per le
carriere degli allievi ufficiali del 51° corso cfr. G. Balestra, La formazione degli ufficiali nell’Accademia militare di Modena cit., p. 432.
54
Per le note biografiche e la carriera di Cubeddu cfr Aussme, biografie, b.91 per le carriere
degli allievi ufficiali del 48° corso cfr. G. Balestra, La formazione degli ufficiali nell’Accademia
militare di Modena cit., p. 428.
55
Per le note biografiche e la carriera di Cubeddu cfr Aussme, biografie, b.93 e b. 94 per le
carriere degli allievi ufficiali del 57° corso cfr. G. Balestra, La formazione degli ufficiali nell’Accademia militare di Modena cit., p. 437.
204
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera
e nelle carte di Giuseppe Brusasca
di Antonio M. Morone
La sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale determinò la perdita delle colonie africane, aprendo una lunga fase di trattative in sede
internazionale per la loro definitiva sistemazione. Dalla caduta dell’Africa
Orientale Italiana nel 1941 e della Libia nel 1943 fino alle due risoluzioni
ONU che nel 1949 e nel 1950 decisero il definito assetto delle ex colonie
italiane trascorse all’incirca un decennio nel quale la nuova Italia accettò
con fatica la conclusione della propria pagina di storia coloniale ed elaborò non senza compromessi una nuova politica indirizzata a perseguire un
rapporto paritario con gli ex sudditi coloniali e più in generale con i popoli
afro-asiatici. Tale percorso fu troppo lento e incerto per essere veramente
genuino e aspirare a conquistare senza riserve la fiducia degli interlocutori africani. Giuseppe Brusasca, ex partigiano, dirigente della Democrazia
Cristiana e parlamentare, fu uno dei maggiori protagonisti della politica
italiana verso le ex colonie, in particolare come membro della delegazione
italiana alla Conferenza della pace di Parigi nel 1947 e poi come sottosegretario agli Esteri e all’Africa Italiana, quasi ininterrottamente, dal 1946
al 19531. Nel passaggio dall’elaborazione all’attuazione della politica della
nuova Italia, l’azione di governo di Brusasca fu decisiva nel testimoniare le
rinnovate intenzioni italiane verso le ex colonie e nel liquidare l’apparato
coloniale in Italia.
Le ex colonie e le rivendicazioni italiane: i messaggi di Brusasca
L’articolo 23 del Trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947
imponeva all’Italia, senza dar spazio a possibili interpretazioni, la rinuncia
alle colonie, affidando il compito di trovare un accordo sulla loro sistemazione alle quattro potenze vincitrici entro un anno dalla ratifica del trattato
medesimo (che risultò essere il 16 settembre 1947) o, in caso contrario,
205
Antonio M. Morone
alle Nazioni Unite2. Nonostante la lettera del Trattato, il governo italiano
chiese da subito e con forza il recupero delle posizioni perse con la sola
eccezione dell’Etiopia e dell’Albania che erano state le vittime più dirette
dell’aggressione fascista. Così facendo si operò peraltro una distinzione tra
colonie fasciste e colonie pre-fasciste che non trovava alcun fondamento
storico, almeno nella misura in cui tutte le colonie, forse con l’eccezione
della sola Eritrea, furono completamente assoggettate all’effettiva potestà
italiana solo durante il periodo fascista. Nel complesso, la politica governativa «non solo eluse i suoi obblighi di trasparenza politica ma attivamente
impedì l’emergere della verità», compromettendo la genuinità della sua
stessa azione politica e ponendo un’ipoteca sul futuro dei rapporti con i
popoli africani3.
Il sostegno alle rivendicazioni verso le ex colonie fu molto ampio e
condiviso dai «programmi elettorali di tutte le forze politiche», anche delle
sinistre che non erano ancora conquistate all’ideologia dell’anticolonialismo4. Le colonie rappresentavano pur sempre un buon argomento elettorale e «nessuno voleva garantire voti agli avversari»5. Il massimalismo
anacronistico e acritico delle prime rivendicazioni italiane subì un progressivo ammorbidimento nel corso delle diverse tornate delle discussioni
internazionali. L’Italia aprì a soluzioni variabili circa i territori richiesti,
solo alcune parti delle colonie, e circa l’intensità della sovranità, facendo
ricorso allo strumento dell’amministrazione fiduciaria o trusteeship system,
ovvero a quell’istituto speciale previsto dalla Carta delle Nazioni Unite
fondato su un principio di responsabilità internazionale verso le colonie
e finalizzato a predisporne nel tempo l’auto-governo o l’indipendenza6.
Tuttavia l’obiettivo ultimo della politica italiana non mutò nella sostanza
almeno fino alla bocciatura del Compromesso Bevin-Sforza il 18 maggio
1949, quando l’Italia compiendo una vera e propria capriola diplomatica
rispetto alle posizioni iniziali sostenne l’indipendenza delle ex colonie.
Le ragioni della linea italiana vanno ricondotte a una precisa volontà
politica, come argomenta convincentemente Nicola Labanca. Furono in
effetti i massimi vertici dello Stato, da De Gasperi a Sforza, a chiedere e
agire affinché l’Italia ritornasse in Africa, in un primo momento nel timore che la perdita delle colonie potesse scatenare dei rigurgiti nazionalisti
a danno delle nuove istituzioni democratiche, un po’ come era successo
alla fine della prima guerra mondiale, ma poi soprattutto in una logica di
continuità dello Stato, nella quale la mancata epurazione dell’apparato am206
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
ministrativo giocò un ruolo importante e le colonie finirono per assumere
un valore intrinseco di patria e di italianità7. Nella più generale prospettiva
della politica estera repubblicana di recuperare il prestigio internazionale
perso a causa del fascismo e della guerra, le colonie valevano tanto quanto i
confini patrii. Fu questa volontà politica di vertice a utilizzare strumentalmente la lobby colonialista per far pressione su un’opinione pubblica che,
al contrario, non percepiva in modo particolarmente lacerante la perdita
delle colonie, come si apprende da uno dei primi sondaggi di opinione della storia italiana realizzato nel 19468. Fu dunque la linea intransigente del
governo italiano ad alimentare aspirazioni sproporzionate nell’opinione
pubblica, piuttosto che il contrario9. Si comprende allora perché le colonie
fossero «il problema fondamentale» della politica estera di quel momento,
come commentò pubblicamente Brusasca, e perciò era auspicabile che su
tale punto non vi fossero «divisioni o incertezze nel popolo italiano»10.
La lobby colonialista operò attraverso una serie di «centrali coloniali»:
il Ministero dell’Africa Italiana (MAI) e i suoi funzionari, i circa 200 mila
profughi d’Africa e infine il complesso di circoli, istituti e gruppi coloniali
sparsi lungo la penisola. L’attività pubblica a vario titolo di tutti questi
soggetti si riassunse in un’opera di propaganda condotta su più livelli, in
Italia, in Africa e nell’ambito della comunità e opinione pubblica internazionale con il fine di creare consenso intorno alle rivendicazioni italiane.
In Italia non si trattò solo di un’ampia attività pubblicistica11, ma anche di
organizzare diversi congressi scientificamente rigorosi che però scontarono
le pregiudiziali politiche e culturali del dibattito sulle ex colonie italiane,
cosicché «molti oratori proclamarono il diritto dell’Italia a essere destinata
per l’amministrazione fiduciaria della Libia, dell’Eritrea e della Somalia»12.
Una simile attività fu messa in moto anche sul versante internazionale
attraverso diversi canali e indirizzata sia verso i referenti più diretti della
politica italiana, Inghilterra e Stati Uniti, sia verso i paesi latino-americani
che, specie nella fase in cui il dossier coloniale fu discusso all’ONU, costituirono un costante riferimento della politica italiana al fine di guadagnare
voti in Assemblea Generale. Fu proprio Giuseppe Brusasca a testimoniare
a seguito di un tour diplomatico in America Latina tra il 1948 e il 1949
che la causa italiana aveva ottenuto «la più larga comprensione» sulla base
del riconoscimento della «capacità della nostra collaborazione per elevare i
popoli di civiltà meno progredita»13.
La propaganda svolta in Italia, oltre a viziare la formazione di una po207
Antonio M. Morone
litica nuova verso le ex colonie, ebbe anche la colpa di contribuire alla
manipolazione del passato coloniale nella coscienza e nella memoria degli
italiani, perseguendo un intento apologetico a oltranza attraverso il conio
di miti quali quelli degli «italiani brava gente» e del colonialismo italiano come colonialismo demografico o di lavoro. Passò per questi canali
quell’opera di mistificazione che proiettò i suoi effetti ben oltre la fine
stessa del colonialismo fino a tempi molto vicino a noi, pretendendo di
scindere la condanna del fascismo da quella del colonialismo, anzi cercando di stigmatizzare quest’ultimo come esperienza intrinsecamente buona o
comunque migliore rispetto agli altri colonialismi europei, dimenticando
però che la realtà dei fatti era invece quella di un sistema di dominio violento, di discriminazioni razziali e sfruttamento economico di un popolo
su popoli altri. Nelle ex colonie la propaganda raggiunse i suoi effetti più
deteriori, ostacolando l’elaborazione da parte italiana di rapporti nuovi
con i popoli africani e con i movimenti nazionalisti, che si erano progressivamente formati nel secondo dopoguerra e che chiedevano prima di
tutto l’indipendenza. Non a caso i messaggi che Brusasca inviò in diverse
occasioni a libici, eritrei, somali e coloni italiani furono respinti da parte
africana e per certi versi fraintesi pure da parte degli italiani d’Africa, che
per storia, interessi economici e ideali politici avevano una posizione conservatrice, se non reazionaria, non fosse altro per essere stati tagliati fuori
da tutti i rivolgimenti culturali e politici che avevano interessato la madrepatria a partire dall’8 settembre 1943.
Al di là delle dichiarazioni ufficiali in chiave nostalgica, l’Italia agì ancor peggio attuando una serie di operazioni più o meno segrete a partire
dal 1946 sotto la guida del MAI e poste in carico al bilancio del Ministero
sotto la denominazione di attività politiche per «la ripresa di contatti con le
popolazioni native»14. La strategia era quella di ammantare le rivendicazioni
italiane del consenso delle popolazioni africane, organizzando movimenti
o partiti politici filo-italiani attraverso il ricorso a quelli che erano stati i
tradizionali collaboratori dell’amministrazione coloniale: ex capi stipendiati ed ex ascari. Dal punto di vista italiano si trattava di perseguire una
politica simile, ma opposta a quella che gli inglesi avevano messo in atto
nelle ex colonie italiane amministrate attraverso la British Military Administration (BMA) e che era finalizzata all’appoggio politico e finanziario di
formazioni politiche locali filo-inglesi. Dal punto di vista dei libici, degli
eritrei e dei somali non si trattava tuttavia della stessa cosa, non fosse altro
208
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
perché la politica italiana faceva perno su gerarchie compromesse con il
vecchio regime coloniale, mentre gli inglesi, pur se in modo interessato e
non senza contraddizioni, accordarono effettivamente maggiori spazi di
libertà politica e si presentarono come liberatori. Nel complesso le azioni
italiane non fecero altro che acuire le incomprensioni, in un clima di reciproche chiusure, e dare sul campo un’idea il più arretrata possibile di ogni
messaggio politico in arrivo da Roma.
Si spiega allora l’incomprensione nella quale cadde il messaggio inviato da Brusasca il 19 settembre 1947, in occasione dell’entrata in vigore
del Trattato di pace, alle popolazioni delle ex colonie. Il testo rivendicava
all’Italia «il mandato […] per guidare ancora quei paesi alle più elevate
forme di struttura politica nel comune interesse di tutte le genti che abitano quei territori» con l’augurio che venisse «ripreso il lavoro comune
per la prosperità e il benessere politico della Libia, Eritrea e Somalia»15.
I libici risposero seccamente che la loro richiesta «legittima e concorde»
era invece «l’indipendenza e l’annessione […] alla Lega araba»16. A circa
un anno di distanza l’evoluzione delle politica italiana tradiva ancora una
visione di stampo coloniale nel nuovo messaggio di Brusasca che invitava i
libici «a scegliere l’Italia come la sola e più qualificata nazione che può […]
condurli rapidamente all’indipendenza»17. In effetti i tentativi italiani di
organizzare gli ex ascari libici in un partito filo-italiano andarono a vuoto:
fatta eccezione per alcune associazioni di ex combattenti e per l’Istiqlal
(indipendenza), partito filo-italiano fondato sul finire del 1948 in Tripolitania, le diverse anime del nazionalismo libico restarono sorde al richiamo
della propaganda italiana.
In Eritrea l’Italia agì in modo simile, investendo i fondi politici del
MAI nel finanziamento dell’Associazione Veterani e del Partito Nuova
Eritrea pro-Italia. La situazione nell’ex colonia degenerò rapidamente a
partire dal 1947 in concomitanza della crescente attività degli shifta, gruppi armanti (letteralmente la parola significa «banditi») che attaccavano gli
italiani e le loro proprietà specialmente nella regione di Keren dove le vittime italiane furono 25 nel periodo che andò fino al 195018. Gli shifta,
oltre ad avere una chiara valenza anti-italiana, rivendicarono l’unione con
l’Etiopia e, perciò, furono collegati all’Unionist Party. Gli etiopici probabilmente appoggiarono gli attacchi, mentre gli inglesi li tollerarono, anche
se la letteratura ha opinioni diverse su questo punto19. A prescindere dalle
responsabilità gli attacchi ottennero parte del risultato perché fu proprio in
209
Antonio M. Morone
questo periodo che molti italiani «gettarono la spugna»20 (nonostante fosse
stato proprio Brusasca a dare la notizia della disponibilità del Banco di Roma ad autorizzare il credito agli agricoltori e industriali danneggiati dagli
attacchi) e che dunque anche le ragioni di un ritorno italiano in colonia a
difesa degli interessi dei suoi coloni andò indebolendosi.
Fu in Somalia che l’azione della propaganda italiana raggiunse le sue
conseguenze più nefaste. Qui l’Italia aveva finanziato e appoggiato la formazione della Conferenza dei partiti verdi (o di Somalia), composta da
ex capi stipendiati ed ex ascari delle truppe coloniali, in opposizione alla
Somali Youth League (SYL) che raggruppava gli elementi più dinamici
della società somala e godeva dell’appoggio della BMA con un programma
politico incentrato sull’indipendenza e sull’opposizione a ogni ipotesi di
ritorno italiano nel paese. A pochi giorni dall’arrivo a Mogadiscio, previsto per il 6 gennaio 1948, della Commissione delle quattro potenze, che
stava visitando gli ex possedimenti italiani con il compito di indagare i
desiderata delle popolazioni africane per poi riferirne in sede internazionale, il sottosegretario Brusasca inviò il 20 dicembre 1947 un messaggio ai
somali, lodando le opere della colonizzazione italiana, definita «un solido
fondamento per la nuova Somalia dell’avvenire», e rivendicando all’Italia,
«in nome del passato, il diritto di guidare i somali sulla via del progresso
e della civiltà verso l’auto-governo»21. In una situazione già di per sé tesa per l’arrivo della Commissione internazionale il messaggio di Brusasca
concorse, pretesto o fatto reale, a eccitare ancor più gli animi e fu collegato
indirettamente agli scontri tra aderenti alla Conferenza e sostenitori della
SYL, che l’11 gennaio 1948 degenerarono in un attacco indiscriminato
agli italiani e alle loro proprietà. Quello che fu ricordato come l’Eccidio
di Mogadiscio contò 52 morti e 48 feriti da parte italiana e 14 morti e 43
feriti da quella somala22.
La SYL, che era l’espressione più genuina del nazionalismo somalo,
contestò il messaggio di Brusasca e quelle formazioni politiche filo-italiane
che ne erano il destinatario indiretto. D’altra parte, nonostante gli inglesi
fossero passibili per lo meno di non essere riusciti a garantire la sicurezza
o secondo altri di aver addirittura preparato e appoggiato il pogrom antiitaliano, a Roma non si poté sfruttare fino in fondo la situazione non solo
per l’imminenza delle elezioni del 18 aprile 1948, che avevano implicazioni da scelta di campo, ma soprattutto perché la propaganda italiana
in effetti c’era stata, anzi aveva raggiunto «proporzioni formidabili»23. Fu
210
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
Vincenzo Calzia, ex funzionario direttivo del MAI e al momento degli
avvenimenti segretario del Municipio di Mogadiscio, a essere accusato in
modo specifico delle manovre italiane e successivamente rimpatriato. In
fondo anche nella altre colonie non si era agito affatto diversamente creando partiti filo-italiani con l’intento di manipolare la scena politica locale;
l’unica differenza fu che non si arrivò al pogrom anti-italiano.
Brusasca verosimilmente non intendeva con il suo messaggio contribuire alla propaganda anti-SYL, ma certo le possibili conseguenze non
dovevano essere ignote a Roma. Sicuramente erano noti i nomi di Calzia
e del barone Pietro Beritelli, magistrato ai conti nel periodo coloniale e,
all’epoca dei fatti, commissario straordinario del Municipio di Mogadiscio, e si conosceva il loro collegamento con i piani propagandistici diretti
dal MAI in Somalia, tanto più che fu proprio Beritelli a fondare (il 30
dicembre 1947) e presiedere il Comitato rappresentativo italiano di Mogadiscio, costituito grazie all’appoggio del MAI con lo scopo di perorare
la causa dei coloni di fronte alla Commissione quadripartita24. L’errore fu
prima di tutto di tattica politica come ebbe a notare non molto tempo dopo Raimondo Manzini, capo dell’Ufficio di collegamento italiano aperto
a Mogadiscio proprio in conseguenza dell’Eccidio al fine di smorzare le
tensioni e avviare un dialogo su più fronti, sia con gli inglesi, sia con i somali. Le dichiarazioni fatte dal governo italiano, oltre a inasprire i rapporti
con la componente locale, risultavano «nebulose» per gli stessi inglesi, con
i quali bisognava ad ogni buon conto trovare un accordo, mentre occorreva
«elaborare le enunciazioni generali dell’on. Brusasca in proposte concrete o
quanto meno far capire che si sta seriamente pensando a quegli argomenti
che maggiormente stanno a cuore all’elemento indigeno più progredito
[educazione, progresso e libertà politica, sviluppo economico]»25.
Giuseppe Brusasca non fu certo l’artefice diretto delle diverse operazioni pianificate dai funzionari direttivi del MAI, verso le quali al contrario
il suo orientamento divenne sempre più scettico. Il problema fu innanzi
tutto quello di aver avuto a disposizione dei cattivi consiglieri. Nel caso
eritreo, per esempio, fu Mario Martino Moreno, direttore generale degli
Affari Politici al MAI, a illustrare la linea d’azione «più appropriata» a un
Brusasca sempre più riluttante nel concedere il proprio consenso a nuovi
fondi per la propaganda:
Abbiamo creato in Eritrea, per riguadagnarla a noi, un partito. Bisogna mantener211
Antonio M. Morone
lo in vita e accrescerlo, imponendo all’erario sacrifici che sono minimi in confronto
all’onere di una sola provincia italiana e di quello che dovremmo spendere domani se
ci fosse restituita un’Eritrea tutta ostile.[…]. Sono spese indispensabili. [Rigetto allora]
la critica sostanziale rivolta alla mia direzione generale: che essa caldeggi, presso Vostra
Eccellenza, un’azione politica locale inutile, dispendiosa e fors’anco dannosa26.
Anni dopo, il 21 agosto 1979, fu proprio Brusasca a ritornare su questo
punto in un’intervista rilasciata ad Angelo Del Boca. Allo storico che gli
chiedeva come mai si fosse circondato soltanto di ex funzionari coloniali,
il politico piemontese rispondeva: «Fu tutto quello che trovai. Ed erano i
soli a saper mettere le mani nei documenti del MAI. Se li avessi estromessi,
il mio compito sarebbe stato anche più gravoso»27.
Semmai la colpa di Brusasca fu quella ascrivibile agli interi vertici politici della Repubblica in quegli anni e dei quali del resto il politico democristiano non poteva che condividerne la linea sia per i suoi incarichi
istituzionali sia per lealtà politica. Brusasca credette di essere almeno in
parte nel giusto, proprio perché come altri vicino a lui non realizzò l’anacronismo di una politica acritica che non considerava quanto la situazione
in colonia fosse ormai un’altra, indirizzata verso l’indipendenza e decisamente ostile a ogni ipotesi di rientro da parte italiana. La linea del governo,
e quella di Brusasca in particolare, fu inadeguata per non aver capito che la
retorica dell’approccio italiano nel sostenere il proprio ritorno in colonia,
fosse anche sotto la forma regolamentata dell’amministrazione fiduciaria,
non trovava consensi sostanziali da parte africana e che anzi il continuo
fare riferimento a un presunto ruolo fattivo, se non proprio buono, del
colonialismo italiano non faceva altro che consolidare l’intendimento contrario delle popolazioni africane che ben sapevano, per averla sperimentata
direttamente, quale era stata la vera faccia del colonialismo italiano, dal
lavoro coatto, ai massacri, alla segregazione. Anche gli appelli di quei pochi
funzionari illuminati che suggerirono linee più moderate e lungimiranti
rimasero di fatto inascoltati.
A riprova di un arretramento generale della politica italiana è il fatto
che il Compromesso Bevin-Sforza, raggiunto alla mezzanotte del 6 maggio
1949 tra i due capi delle diplomazie maggiormente coinvolte nel dossier
coloniale italiano, guardava ancora al passato. Il Compromesso disponeva
la spartizione dell’Eritrea tra Sudan ed Etiopia (pur prevedendo uno status particolare per le città di Massaua e Asmara a garanzia degli italiani e
212
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
dei loro interessi), l’amministrazione fiduciaria su Cirenaica, Tripolitania e
Fezzan da attribuire rispettivamente a Inghilterra, Italia e Francia e, infine,
un’altra amministrazione fiduciaria all’Italia sulla Somalia. Questo schema
si riduceva nella sostanza a un accordo spartitorio tra l’ex potenza coloniale
e la potenza vincitrice che per il fatto di disporre amministrativamente
delle ex colonie era stata di fatto il referente principale di tutta l’azione
diplomatica italiana. I desiderata delle popolazioni non erano considerati
e le Nazioni Unite erano ridotte a un ruolo secondario di ratifica, semmai
erano gli interessi strategici delle potenze occidentali a trovare soddisfazione, non molto diversamente da quanto accadeva in piena epoca coloniale.
Nella parole di Giulio Andreotti «poteva essere valida anche la tesi che
l’epoca dei colonialismi era finita», ma ciò che l’Italia aveva sempre rifiutato ostinatamente di ammettere era che «questo dovesse valere per una
sola nazione, la nostra»28. La bocciatura all’ONU il 18 maggio 1949 del
Compromesso, per lo sbandamento proprio di un membro (Haiti) di quel
blocco latino-americano su cui la politica italiana aveva tanto speculato, realizzò in un senso più generale quella condizione, dimostrando che l’epoca
coloniale era ormai prossima alla fine e che i suoi accordi erano diventati
impraticabili non solo per l’Italia, ma anche per l’Inghilterra.
La nuova politica dell’Italia per l’indipendenza delle ex colonie:
Brusasca va in Africa
La bocciatura del Compromesso Bevin-Sforza dimostrò l’errore da parte italiana nell’aver ritenuto che la chiave della questione coloniale fosse a
Londra, mentre era piuttosto a Washington che l’Italia doveva guardare
se voleva avere qualche soddisfazione, anche in ragione dell’allineamento
atlantico. Proprio però la politica americana nella prospettiva del nascente
assetto bipolare intendeva proteggere i propri interessi strategici attraverso
una logica di influenza indiretta che rendeva l’amministrazione coloniale
ormai superata, anzi controproducente nelle sue velleità più estreme come
avrebbe dimostrato di lì a poco la crisi di Suez del 1956. Fu in questo
quadro che maturò la scelta italiana di rispondere alla bocciatura del Compromesso con una politica decisamente nuova in favore dell’indipendenza
delle ex colonie, pur perseguendo sempre un fondo tattico nelle relazioni
con Londra e nella difesa dei propri interessi residui. La svolta fu ufficializzata dal discorso del ministro Sforza al Comitato politico delle Nazioni
213
Antonio M. Morone
Unite il 1° ottobre 1949: l’Italia si impegnava per l’indipendenza immediata di Libia ed Eritrea e, dopo un’adeguata preparazione, per quella della
Somalia.
La conclusione del dossier coloniale italiano era a portata di mano e
in effetti arrivò non molto tempo dopo attraverso la risoluzione dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 289 del 21 novembre 1949, che
deliberava in favore dell’indipendenza della Libia e del mandato fiduciario
italiano sulla Somalia. Per l’Eritrea la soluzione fu interlocutoria perché la
risoluzione concedeva ancora un anno di tempo per raggiungere una decisione: la colonia primogenita si confermava così il nodo più controverso
dell’intera vicenda. La risoluzione n. 390 del 2 dicembre 1950 dispose
infine che l’Eritrea divenisse, in termini un po’ ambigui, unità autonoma
federata all’Etiopia. Tutte le delibere vennero votate con l’opposizione o
l’astensione dell’URSS, sebbene l’astensione anche della Francia nel voto
finale attutì l’impressione di scelte corrispondenti rigidamente alle logiche
di blocco29. Il trusteeship somalo passò con il consenso dei paesi di nuova
indipendenza, scontando dunque un’ampia convergenza politica sul ritorno italiano nell’ex colonia, anche se il voto contrario dell’Etiopia invitava
l’Italia alla cautela.
Nel complesso le decisioni garantirono le esigenze strategiche occidentali e sfumarono al massimo le aspirazioni italiane. I buoni rapporti degli
inglesi con quello che dopo l’indipendenza della Libia, proclamata il 24
dicembre 1951, diventò re Idris I garantirono agli anglo-americani «il controllo strategico» dell’ex colonia italiana con le sue basi30. L’appoggio occidentale al Senusso ebbe d’altra parte l’effetto, come commentò Brusasca,
«di ridurre al minimo la nostra futura influenza in quella parte del Mediterraneo»31. Nel Corno d’Africa gli Stati Uniti, appoggiando la federazione
etiopico-eritrea, istaurarono nel contempo un’alleanza organica con Haile
Selassie finalizzata a fare dell’Etiopia la potenza regionale di riferimento
della strategia statunitense nella regione. Il patto fu suggellato, in particolare, dall’accordo segreto del maggio 1953 con il quale l’Etiopia concedeva agli Stati Uniti l’utilizzo della postazione per radio-comunicazioni di
Kagnew Station sull’altopiano eritreo (dal nome del battaglione etiopico
impegnato nella guerra di Corea; al tempo degli italiani si chiamava Radio
Marina), che divenne uno degli snodi centrali per il sistema di comunicazione americano di quel tempo. Sull’Eritrea la politica italiana venne
frustrata una volta in più perché dovette rinunciare all’ipotesi dell’indipen214
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
denza separata, che negli intendimenti di Roma doveva meglio garantire
gli interessi residui dell’Italia e degli italiani.
La Somalia fu la pedina più adatta per dare una soddisfazione all’Italia,
soprattutto perché il paese non aveva «un grandissimo interesse strategico»
per gli Stati Uniti32. In effetti il trusteeship system, per la sua stessa disciplina
normativa, non poteva garantire l’utilizzo del territorio per fini militari.
Non fu un caso allora che proprio quella tra le ex colonie italiane meno
interessante dal punto di vista strategico fosse anche la più adatta ad essere
sottoposta all’amministrazione fiduciaria italiana. In Libia, non diversamente dall’Eritrea, dove invece l’interesse anglo-americano era preminente, il trusteeship system venne scartato come possibile soluzione perché «non
sarebbe stato in grado di garantire la difesa del mondo libero»33. Dal punto
di vista italiano la Somalia era il possedimento meno interessante, dove anche i coloni, paradossalmente se si ricorda l’argomento del «lavoro» italiano
da tutelare in colonia, erano pochi rispetto a Libia ed Eritrea34. Tuttavia,
come dichiarò Sforza all’indomani del voto all’ONU, la Somalia «era nulla
come colonia, ma era un’importantissima pedina di politica estera»35. Pur
scontando una logica paternalistica intrinseca nella disciplina del trusteeship system, l’Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia (AFIS) venne
intesa come la prova di riparazione di cui l’Italia disponeva per dimostrare
in concreto la sua nuova politica. Per conseguire tale risultato occorreva
sciogliere però la contraddizione di un mandato chiesto sulla base di una
politica ancora coloniale e ottenuto invece nel quadro di una politica nuova che guardava alla collaborazione e, in prospettiva, alla cooperazione allo
sviluppo, anche se propriamente non si può parlare di cooperazione prima
del 1960. Occorreva dar prova delle rinnovate intenzioni con cui si accettava il mandato e si ritornava in Somalia, prima di tutto verso i somali che
restavano su posizioni caute e anzi, nella componente più forte del movimento nazionale, la SYL, continuavano a opporsi al ritorno degli italiani.
Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi dichiarò, significativamente, l’8 febbraio 1950 durante il dibattito parlamentare sulla ratifica del
mandato fiduciario, che «accettare l’amministrazione vuol dire lavorare per
un mondo nuovo, guadagnarci amicizie fra tutti i popoli che aspirano alla
libertà e al progresso, […] riprendere l’antica politica italiana del Risorgimento»36. Il giorno successivo Brusasca trattò diffusamente il tema firmando l’editoriale Cantiere di qualificazione per il «Corriere della Sera»:
215
Antonio M. Morone
216
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
In queste e alle pagine seguenti
Giuseppe Brusasca
in diversi momenti del suo mandato.
217
Antonio M. Morone
218
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
219
Antonio M. Morone
Noi dovremo svolgere in Somalia una funzione essenzialmente sociale-internazionale
che viene attuata per la prima volta nella storia dei popoli e che se sarà svolta in
corrispondenza delle larghe aspettative dalle quali è già circondata, potrà concorrere
efficacemente per la risoluzione dei più gravi problemi del nostro paese, quello della
disoccupazione.[…] La Somalia deve diventare il banco di prova della democrazia
sociale e delle capacità costruttive internazionali del nostro popolo. […] Quel grande cantiere che sta per diventare ad opera nostra la Somalia deve pertanto servire
per qualificare il popolo italiano come fattore indispensabile per l’opera di solidarietà
tra i popoli che deve caratterizzare la nuova era della civiltà umana che sorge con il
tramonto delle dominazioni coloniali. […] Nessuno tema quindi dal nostro ritorno
in Somalia delle avventure di tipo coloniale, delle innovazioni demagogiche o delle
minacce militari, ma tutti attendano con fiducia la nuova Italia democratica a questa
sua pacifica prova. L’Italia che ha tanto sofferto per la riconquista della sua libertà e
della sua indipendenza e che conosce le durezze della lotta per il pane e per il lavoro
non deluderà nessuno38.
Restava dunque il tema del lavoro che tanta parte aveva avuto nelle
rivendicazioni colonialiste, rivisitato però nella prospettiva della cooperazione e di una nuova stagione nei rapporti con i popoli afro-asiatici.
A fronte delle intenzioni espresse pubblicamente, la situazione in Somalia restava difficile. La Conferenza dei partiti verdi non era riuscita a
costituirsi in un vero e proprio partito politico ed era rimasta vincolata
a un rapporto clientelare con l’Italia e a una tipologia di rappresentanza politica legata a interessi particolari, spesso clanici. La SYL era l’unico
partito che avesse un seguito reale su tutto il territorio e che potesse vantare un’agenda propriamente politica: l’indipendenza, la modernizzazione
socio-economica, l’educazione e la lotta al clanismo. Nonostante i contatti
tra autorità italiane e dirigenza della SYL fossero stati attivati ancor prima
del passaggio di competenze tra amministrazione inglese e italiana39, la Lega durante tutte le prime fasi del mandato rimase su posizioni pregiudiziali
e certo il rapporto dell’Italia con la Conferenza non aiutava alla reciproca
comprensione. Il dubbio di fondo della SYL riguardava proprio le intenzioni italiane e la loro sincerità.
Il primo viaggio in Somalia del sottosegretario Brusasca ebbe un ruolo
determinante nel risolvere questa situazione, favorendo il dialogo tra italiani e somali nel quadro della nuova amministrazione. Il sottosegretario
arrivò a Mogadiscio il 25 maggio 1950 in un clima teso: il giorno precedente la segreteria centrale della SYL in una circolare diretta a tutte le
sezioni periferiche del partito aveva ordinato di prepararsi per una «forte
220
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
protesta contro la politica dell’amministrazione fiduciaria»40. Nell’incontro che Brusasca ebbe con Adaan Cabdulle Cisman, esponente di spicco
della SYL e futuro primo presidente della Repubblica somala, il leader
leghista non risparmiò le critiche all’Italia. Di fronte all’argomentazione,
forse un po’ retorica, di Brusasca che ricordava l’opera di valorizzazione
economica dell’Italia in Somalia, Cisman rispose seccamente che gli inglesi
avevano dato ai somali un bene ben più grande in un tempo molto minore:
la libertà politica41. Nonostante la partenza in salita, l’incontro si concluse
positivamente. Brusasca si impegnò a nome del governo italiano a rispettare i nuovi compiti a cui l’amministrazione fiduciaria era chiamata e non
mancò neppure una esortazione verso la comunità italiana di Somalia a
prendere atto dei nuovi tempi e della nuova missione italiana. Per parte sua
la SYL aprì a una collaborazione condizionata, precisando che essa aveva
«per divisa l’interesse dei somali e della Somalia innanzi tutto. […] Perciò
l’AFIS può pienamente contare sull’appoggio della SYL ovunque e in tutto
ciò che s’intendesse fare nell’interesse del paese»42.
La promessa di collaborazione fu ribadita formalmente il 9 giugno con
apposita delibera del Comitato centrale del partito. Il rapporto tra Lega
e AFIS negli anni a venire fu tutt’altro che semplice, ma di certo questo
passaggio fu determinante nel porre le basi per la futura collaborazione. La
visita di Brusasca in Somalia si concluse l’8 giugno con «un vero successo
personale senza tema di smentita», secondo l’opinione di Francesco Bona,
presidente della sezione somala della Democrazia Cristiana (DC) e discreto informatore di Brusasca43. In effetti il viaggio del sottosegretario aveva
messo in pratica i punti essenziali della nuova politica italiana: il riconoscimento del ruolo delle élite nazionali africane e la revisione del rapporto
con la comunità italiana di Somalia.
Nonostante la collaborazione tra SYL e AFIS fu per tutta la durata del
mandato soggetta a continui avanzamenti e arretramenti e solo dopo le
prime elezioni politiche del 1956 si poté considerare veramente acquisita, l’azione di Brusasca ebbe in effetti un ruolo molto importante specie
in vista della definitiva approvazione dell’Accordo di amministrazione fiduciaria all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1950,
quando da un lato l’Italia tornò a ribadire intenzioni e significato del mandato e dall’altro la SYL realizzò che a ogni buon conto l’Italia avrebbe
amministrato il territorio per i successivi dieci anni. Pochi giorni dopo il
voto all’ONU, Brusasca firmò un secondo editoriale Anno nuovo in Africa
221
Antonio M. Morone
orientale sul «Corriere della Sera» nel quale «al colonialismo [che] vive tra
il sangue e le rivolte degli indigeni» egli contrapponeva la situazione in
Somalia dove «gli italiani, per il loro senso di umanità, per il loro spirito di
fraternità e per la loro capacità di lavoro, sono invitati dai nativi a rimanere
e a ritornare»44. Se in pubblico i toni restavano un po’ retorici, Brusasca
appariva più concreto in privato e, comunicando con la presidenza del
Consiglio dei ministri, il giorno successivo ribadiva che l’Italia grazie al
mandato poteva pensare di «eliminare in tutti gli Stati di recente sorti a vita
indipendente quei preconcetti, quelle diffidenze che oggi spesso precludono il cammino a nostre iniziative», acquisendo nei fatti una «una politica
anti-colonialista»45.
Il significato a più ampio raggio che il mandato assumeva nella dimensione internazionale era in effetti implicito anche se si considera il programma completo del viaggio di Brusasca in Africa. Sulla via di Mogadiscio il
sottosegretario fece tappa in Eritrea mentre durante il viaggio di ritorno si
fermò al Cairo: sia l’Etiopia a cui guardava la tappa all’Asmara, sia l’Egitto
e per estensione i paesi arabi erano già emersi quali referenti privilegiati
dell’Italia durante la discussione del dossier coloniale al di là della rigida
contrapposizione Est-Ovest e la visita di Brusasca si proponeva di approfondire entrambi i versati. L’Egitto era un interlocutore privilegiato non
solo per la sua leadership all’interno del mondo arabo, ma anche per la sua
presenza in Somalia in qualità di membro dell’United Nations Advisory
Council of Somalia, organo di controllo sull’amministrazione italiana con
sede a Mogadiscio. Nella prospettiva della distensione del 1955 tra i due
blocchi, che avrebbe permesso tra l’altro l’ammissione dell’Italia all’ONU,
la politica neo-atlantica dell’Italia acquisì sempre più una specializzazione
mediterranea nella quale l’Egitto era un rerente obbligato46. Il mar Rosso
e la Somalia costituirono un retroterra di tale politica tanto per l’Egitto
quanto per l’Italia. Anche se nella tappa cairota di Brusasca nel giugno
1950 tale politica doveva ancora dischiudersi nella sua pienezza, va tuttavia
ricondotto a questo quadro l’auspicio del sottosegretario a colloquio con
i suoi colleghi egiziani per una sincera collaborazione tra i due paesi in
Somalia e più in generale nell’ambito mediterraneo. Fu inoltre Giovanni
Fornari, primo amministratore in Somalia e futuro ambasciatore d’Italia
al Cairo, a confermare indirettamente tale intendimento, affermando che
il mandato sulla Somalia era prima di tutto «in funzione della politica
mediterranea e dei paesi arabi»47. La carta araba, se aveva rappresentato
222
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
sostanzialmente un’occasione mancata durante la discussione del dossier
coloniale, negli anni seguenti venne ricercata con maggiore convinzione,
anche grazie alla Somalia, ma nel complesso finirono per prevalere le ragioni dell’allineamento a Occidente come dimostrò la crisi di Suez, quando
«Nasser, oggetto di premure fino a poco prima, diventa il “dittatore egiziano”»48.
Sull’altro versante Eritrea ed Etiopia rappresentavano i termini di
un’unica partita dove gli interessi residui italiani in Eritrea dovevano bilanciarsi con l’esigenza di normalizzare le relazioni con l’Etiopia. La questione
aveva evidentemente una portata politica e simbolica molto importante,
perché si trattava di recuperare il rapporto proprio con quel paese che aveva
da sempre incarnato le mire del colonialismo italiano nel Corno d’Africa e
che era stato l’oggetto più diretto dell’aggressione fascista alle popolazioni
africane. Inoltre la normalizzazione delle relazioni con Addis Abeba avrebbe garantito la protezione degli italiani che ancora risiedevano in Etiopia,
anche se va detto che essi furono rispettati prima di tutti dallo stesso imperatore Haile Selassie già al momento del suo ritorno al potere nel 1942,
perché egli intese la presenza italiana come risorsa tecnico-economica per
il paese e come mezzo politico per sottrarsi a una sudditanza troppo stretta
nei confronti dell’Inghilterra.
L’iniziativa italiana in Eritrea che sosteneva l’indipendenza separata del
paese si poneva in contrapposizione diretta con l’interesse di Addis Abeba
a un’incorporazione, piena o limitata, dell’Eritrea giocando sull’appoggio
anglo-americano. Inoltre proprio il trusteeship somalo, un po’ paradossalmente se si considerano le premesse generali della politica italiana a tale
riguardo, rischiava di costituire un freno nel cammino di avvicinamento tra Italia ed Etiopia, perché la presenza italiana al confine meridionale dell’Impero, pur se a termine e nello specialissimo quadro fiduciario,
«inevitabilmente evocava nelle menti del governo etiopico memorie di un
passato penoso»49. Infatti l’Etiopia aveva votato contro il mandato perché
in generale si opponeva al principio della tutela dell’Africa e in particolare
perché obiettava sulla designazione dell’Italia come amministratore (anche
considerato che essa non era membro dell’ONU), tanto più che la mancata
delimitazione del confine somalo-etiopico aumentava la preoccupazione
per il ritorno dell’Italia50.
Nel maggio 1950 durante la tappa all’Asmara del suo viaggio in Africa,
Brusasca aveva dichiarato che «l’Italia era ancora nettamente contraria a
223
Antonio M. Morone
qualsiasi divisione dell’Eritrea e appoggiava il riconoscimento della completa indipendenza del territorio»51. Tuttavia poche settimane dopo, nel
luglio 1950, fu lo stesso Brusasca, questa volta nella qualità di capo della
delegazione italiana a Lake Success, a indicare come la questione eritrea
nella più impellente prospettiva della guerra in Corea era diventata «secondaria» e quindi al fine di non restare isolati e di non dimostrare senso di
scarsa responsabilità occorreva «essere pronti alla conciliazione, pur sostenendo l’indipendenza» dell’ex colonia52. L’interesse etiopico (e americano)
finì per prevalere nella soluzione federale e nonostante l’impegno italiano a
garantire le prerogative eritree di fronte al governo etiopico, la federazione
istituita dall’ONU non resistette alla prova. L’Eritrea fu annessa nel 1962
come provincia all’impero e «l’Italia si dimostrò impotente verso gli abusi
dell’Etiopia»53.
La decisione sulla federazione nello scorcio del 1950 semplificava il
quadro generale, favorendo la ripresa dei normali rapporti italo-etiopici e
ponendo rapidamente fine all’attività degli shifta, a riprova della loro valenza politica e forse dei loro appoggi esterni. Il secondo viaggio di Giuseppe Brusasca in Africa individuò proprio nella normalizzazione dei rapporti
con l’Etiopia il suo obiettivo principale, anche se il quadro d’insieme era
più complesso proponendosi «l’esame dei problemi che concernono gli interessi delle collettività italiane in Eritrea e in Somalia», la ricognizione dei
progressi dell’AFIS e la partecipazione al fianco di Fornari alla Conferenza
internazionale di Nairobi sui problemi della mutua assistenza tra i territori
africani54.
La strategia di avvicinamento ad Addis Abeba fece tappa all’Asmara,
dove Brusasca arrivò il 10 agosto 1951 per ribadire ancora una volta l’impegno del governo a favore degli interessi della comunità italiana, ma questa volta attraverso le buone relazioni con l’Etiopia piuttosto che attraverso
l’indipendenza separata dell’ex colonia. Nella tappa a Mogadiscio, Brusasca tornò a sottolineare gli impegni presi a nome del governo italiano, la
volontà di rispettare le scadenze in vista dell’indipendenza, nella convinzione che «per noi tutti i somali sono uguali […] ma da tutti desideriamo
rispetto e collaborazione sincera»55. L’apertura alla SYL rimaneva l’obiettivo, anche se l’appoggio che l’AFIS non aveva ancora del tutto tolto alla
Conferenza rischiava di renderlo problematico. La Conferenza manteneva
una funzione strumentale, ridotta a pungolo per spingere la SYL verso
una maggiore apertura o a contrappeso in un sistema politico dove i Gio224
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
vani somali stavano acquisendo una posizione di monopolio e gli italiani
non volevano rinunciare completamente ad avere un pur minimo spazio di
manovra. Il rischio era di una reciproca chiusura che l’azione di Brusasca
tentò di allentare56.
Dopo il passaggio in Kenya, Brusasca arrivò il 5 settembre 1951 ad
Addis Abeba. Oltre alla determinazione americana ad appoggiare la missione italiana nella convinzione che una reale distensione a livello regionale non potesse raggiungersi senza gli italiani, una lunga opera di preparazione in loco era stata portata innanzi soprattutto dai due diplomatici
Renato Piacentini e Giuliano Cora. Fu quest’ultimo a giocare un ruolo
essenziale nell’appianare le divergenze esistenti e non a caso fu proprio
Cora a essere trattato di fatto come il primo ambasciatore italiano, ancor
prima dell’arrivo di quello vero, Alfonso Tacoli57. Ciò non toglie che la
scelta di Brusasca fu decisiva, «per il suo passato anti-fascista e la sua predisposizione a concepire una politica africana nuova» che suscitò nei suoi
interlocutori «un’impressione favorevolissima»58. Il bilancio della missione
fu sicuramente positivo, come testimonia il processo verbale dell’incontro, anche se a ridimensionarne la portata entusiastica dei commenti dello
stesso sottosegretario vi fu una certa indeterminatezza sia sulla questione
dei risarcimenti che su quella delle garanzie sul futuro legame federale con
l’Eritrea59. Il secondo in grado della delegazione italiana Smoquina, che dal
Cairo aveva seguito l’evolvere della vicenda e da lì aveva raggiunto Brusasca
in Etiopia, rimproverò al sottosegretario di non essere stato capace di limitare la strategia etiopica di «tener lontana l’Italia pur dando l’impressione
contraria all’opinione pubblica internazionale», anche se l’intento era forse
quello di compiacere gli Stati Uniti (con i quali proprio il 7 settembre 1951
veniva firmato un accordo di amicizia e commercio), piuttosto che quello
di tenere veramente a distanza l’Italia60. Nel complesso il ruolo personale
di Brusasca fu determinante, anche se proprio nell’elogio della sua persona
gli etiopici ottennero di far ricadere sulla parte italiana la responsabilità dei
contenuti degli accordi presi61.
La liquidazione del sistema coloniale italiano: il MAI e l’AFIS alla
prova di Brusasca
La nuova politica dell’Italia verso le ex colonie ebbe un versante tutto
italiano non meno importante di quello esterno e altrettanto decisivo nel
225
Antonio M. Morone
testimoniarne le intenzioni ultime anche in Africa. Si trattava di liquidare o riconvertire quelle «centrali coloniali» che avevano costituito i punti
focali della propaganda colonialista e che la svolta del 1949 aveva di fatto
reso inutili, anzi in prospettiva rischiavano di costituire un vero e proprio
contrappeso nell’applicazione della nuova linea italiana. Forse fu proprio
questo il versante più difficile e, per certi versi, doloroso della politica postcoloniale italiana, nella misura in cui incideva direttamente su quel concetto di «italianità» che tanta parte aveva avuto nelle precedenti rivendicazioni
coloniali, ma al tempo stesso aveva il sapore di una sfida per quella stessa
politica.
Una prima questione fu quella dei profughi d’Africa che affollavano ancora i campi di accoglienza lungo la penisola in attesa di una sistemazione
definitiva. Questa non a caso arrivò molto rapidamente nel 1949, quando
era ormai evidente che i profughi non sarebbero mai ritornati in colonia
e la loro stessa presenza nei campi rischiava di trasformarsi da emergenza
sociale a pericolo per l’ordine pubblico. Dei circa 100 mila profughi (sul
totale di 200 mila) che erano passati per i campi, al 12 novembre 1949 solo
2.400 erano ancora quelli ospitati nelle strutture pubbliche62. La decisione
di chiudere progressivamente i campi fu in effetti politica, a prescindere
dal reale reinserimento dei loro ospiti nel tessuto sociale circostante.
Nonostante la legge n. 137 del 4 marzo 1952 affrontasse organicamente la materia nell’intento di favorire il riassorbimento dei profughi nella
società civile e produttiva attraverso sussidi per le famiglie, quote riservate
nell’edilizia popolare e corsi per la «qualificazione, il perfezionamento e la
rieducazione professionale» (art. 13), finirono per contare di più la capacità e l’imprenditorialità dei singoli e in molti casi ci vollero diversi anni per
sanare le differenti situazioni.
L’altro versante era quello propriamente istituzionale, costituito dalla
pletora di enti, istituti e circoli coloniali. Quelli statali o parastatali furono
per la maggior parte chiusi o riconvertiti durante gli anni cinquanta, anche
se alcuni, specie se privati, resistettero ben più a lungo. Nella vastità di
questo sistema il nodo centrale da sciogliere era quello del MAI, che aveva
svolto la funzione di centro di aggregazione per tutte le «centrali coloniali».
Privo dell’oggetto stesso del suo amministrare nel dopoguerra, il recupero delle colonie per il ministero non era una semplice vicenda di politica
internazionale, ma rappresentava la ragione stessa per la sua sopravvivenza
e per quella dei suoi funzionari. La svolta del 1949 abbracciando l’indipen226
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
denza delle colonie anticipava anche la definitiva liquidazione del ministero. Si trattò di uno dei problemi più spinosi con cui Brusasca si dovette
confrontare, sia per la difficoltà di ricollocare i suoi circa 11 mila funzionari, sia perché l’attività del ministero si intrecciò con la gestione dell’AFIS.
L’amministrazione fiduciaria imponeva una discontinuità politica e
istituzionale verso il passato, anche attraverso la sua struttura amministrativa. La proposta formulata alla presidenza del Consiglio da Brusasca indicava come preferibile una struttura nuova, la più «leggera» possibile, per la
gestione dell’AFIS63:
[Scartando] innanzi tutto e nel modo più deciso l’idea della creazione di un apposito
ministero o anche di un alto commissariato, [perché] costituirebbe un appesantimento
inutile e […] una volta creato, o diverrebbe un doppione e un intralcio inutile per
l’AFIS quando si fosse limitato a far da passacarte, o, qualora avesse voluto impartire
sue direttive specifiche indipendenti e magari in contrasto con quelle dell’amministratore, creerebbe inevitabilmente un conflitto tra Roma e Mogadiscio. [Inoltre] potrebbe
destare dubbi e critiche sulla nostra effettiva volontà di dare autonomia e indipendenza
a quel paese e costituirebbe una doppia spesa.
L’amministrazione italiana in Somalia era destinata a evolversi fino a
distaccarsi completamente dall’ordinamento italiano al momento dell’indipendenza somala; allora la scelta migliore era quella di creare a Roma
una struttura limitata con compiti di collegamento, lasciando all’amministratore e all’amministrazione in Somalia «la più ampia discrezionalità
sulla scelta dei modi e dei tempi dell’attuazione della politica approvata dal
governo», perché in definitiva non si trattava di «governare una provincia
o un territorio italiano, ma un territorio africano destinato a diventare uno
Stato estero».
In concreto Brusasca proponeva la costituzione di due strutture:
Un Comitato di Coordinamento per la Somalia tra tutte le amministrazioni centrali
italiane con il compito di indicare le soluzioni al presidente del Consiglio, lasciando
naturalmente poi a questi di decidere e all’amministrazione di attuare le direttive così
concordate; […] un Ufficio che abbia una certa attrezzatura, modesta sì ma necessaria
per seguire l’amministrazione nei vari settori tecnici: si tratterebbe praticamente di
fare da tramite tra Mogadiscio e Roma per quanto riguarda o l’invio di personale o
l’acquisto di materiale, o l’inoltro di suggerimenti o consigli nei singoli settori. Tale
ufficio dovrebbe fare altresì come segreteria del Comitato di coordinamento per la
Somalia. [Questi due organi sarebbero stati posti in carico] agli Esteri, dato che, attra227
Antonio M. Morone
verso l’amministrazione della Somalia, noi vogliamo raggiungere soprattutto obiettivi
di politica estera.
Il rapporto concludeva ribadendo la motivazione politica che soggiaceva alla proposta istituzionale:
L’amministrazione della Somalia è già un’amministrazione statuale come lo sono i
ministeri o i commissariati, non si vede perché si dovrebbe porle al di sopra un’altra
amministrazione statale per controllarla. Basta affidarne a un ministero la responsabilità di fronte al parlamento. Tale ministero avrà con essa i rapporti che ha con le singole
direzioni generali del proprio ministero, senza l’intermediario di uno speciale e pesante
organo centrale.
La proposta di Brusasca, formulata allo scadere della gestione provvisoria dell’AFIS il 2 dicembre 1950 in concomitanza con l’approvazione definitiva all’ONU dell’Accordo di Tutela, rimase allo studio della presidenza
del Consiglio per circa un anno prima che la soluzione definitiva fosse
presa. Le lungaggini non andarono solo a scapito dell’efficienza della nuova amministrazione, ma favorirono soprattutto un clima di incertezza nel
quale le diverse speculazioni avvantaggiarono l’insinuarsi dell’interesse della
burocrazia del MAI che pensò di potersi riconvertire senza troppi problemi
nella gestione dell’AFIS, cosicché da «sopravvivere» al Ministero stesso al
prezzo di qualche compromesso. Durante i primi due anni di amministrazione fiduciaria si operò in modo pragmatico, attraverso una co-gestione
di fatto tra MAE e MAI. Gli Esteri designarono il primo amministratore,
Giovanni Fornari, e il suo capo di Gabinetto, Pier Pasquale Spinelli, che
erano entrambi di carriera diplomatica64; intrattennero le relazioni con le
Nazioni Unite e furono il responsabile ultimo della gestione fiduciaria di
fronte alla presidenza del Consiglio. Il MAI, attraverso le sue direzioni
generali a Roma, provvide a tutto il resto, garantendo in particolare il collegamento e l’approvvigionamento verso la Somalia e fornendo inoltre la
stragrande maggioranza del personale che ricoprì i ruoli tecnici e amministrativi della costituenda amministrazione in Somalia, circa 750 persone.
La duplicità della gestione AFIS, che poco sapeva di stacco col passato,
venne più volte criticata proprio dalle autorità fiduciarie a Mogadiscio nel
suo collegamento con Roma. Il segretario generale, Pompeo Gorini, che
pur proveniva dal MAI65, ma era anche stato segretario particolare di Brusasca, parlava di «formula dei due ministeri, ibrida e pericolosa»66. Fornari
228
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
era ancora più duro quando affermava che il MAI «non ha più alcuna
autorità né alcuna possibilità di seguire in forma attiva il nostro lavoro.
È diventato un semplice e inutile passacarte, che non può più ricoprire
le funzioni di amministrazione centrale, né si può pretendere altro da un
organismo che sta per morire e ne ha la coscienza»67. Tuttavia l’interferenza
più grave non fu tanto nel collegamento con Roma, ma proprio in Somalia, dove i funzionari provenienti dal MAI costituirono un contrappeso
nella gestione progressista dell’AFIS. Nell’alternativa tra «persone nuove»,
che nulla avevano a che fare con il passato coloniale, ma che pure non
avevano alcuna esperienza africana, e «persone vecchie», che provenivano
direttamente dal passato coloniale, ma che avevano una pregressa esperienza africana, la scelta fu evidentemente per quest’ultima opzione. Sulla
decisione pesò forse una sincera convinzione di fare bene, ma sicuramente
anche il ruolo di camera di compensazione che il servizio presso l’AFIS
giocava nella redistribuzione dei funzionari in esubero del MAI. Si trattò
«forse di un errore» – commentava l’amministratore Fornari ex post – «ma,
onestamente, non credo ci si potesse allora regolare diversamente data l’esistenza di un MAI con tutto il suo personale così sacrificato e provato»68.
Non sempre i vecchi funzionari coloniali si abituarono alla nuova realtà fiduciaria, come si apprende dalla testimonianza inedita di Mohamed
Abdulle Sheikh, leader della SYL, futuro parlamentare e ambasciatore in
Italia:
Vi è una parte dei funzionari dell’AFIS concordi nell’impossibilità o inammissibilità
che la Somalia diventi un paese indipendente; parte di questi criticano l’AFIS per la
sua incapacità amministrativa e per il suo comportamento verso i nativi. […] Questi
funzionari non si oppongono direttamente al programma di governo italiano, ma continuano a presentare una serie di azioni, di proposte, di suggerimenti che paralizzano
o modificano i progetti del governo69.
Nell’AFIS si creò una differenziazione tra funzionari progressisti e conservatori, dove l’indirizzo progressista dei vertici si dovette confrontare
con il corpo centrale dell’amministrazione, che ebbe posizioni più caute,
a volte di segno contrario e «in taluni – come scriveva Fornari – di astio
preconcetto verso le organizzazioni che, come la SYL, ci sono state nemiche e si dimostrano ostili. […] Dobbiamo superare la posizione di parte
per assumere quella di autorità tutoria di tutti i somali, pronti a premiare
o a punire gli uni e gli altri»70. Non mancarono infine le accuse circa una
229
Antonio M. Morone
connotazione eminentemente fascista di alcuni funzionari, che preoccupò
in modo particolare l’ex partigiano Brusasca71. I vertici dell’AFIS ridimensionarono il problema parlando di «preoccupazioni un po’ esagerate» ed
esclusero «preferenze ad appartenenti del MSI nell’assegnazione di incarichi nell’amministrazione»72, ma a Brusasca rimaneva il cruccio (e non
si stancò di sollecitare Fornari su questo punto) che la nostalgia di alcuni
funzionari si saldasse con quella ugualmente diffusa tra la comunità italiana di Somalia che era spesso rimasta ancorata ai suoi «privilegi di razza»73.
Da parte somala il coinvolgimento a più livelli del MAI nella gestione
dell’AFIS non poteva che rimandare direttamente al passato e alimentare
i timori verso la sincerità di quelle rinnovate intenzioni dell’Italia delle
quali proprio Brusasca si era fatto personalmente garante nella sua visita a
Mogadiscio del maggio 1950. La tensione era implicita nel fatto che «molti
fra i militanti della Lega avevano lavorato per l’amministrazione coloniale
italiana alle dirette dipendenze di quegli stessi personaggi che adesso tornavano per preparare l’indipendenza somala»74. La SYL infatti protestò
alle Nazioni Unite, lamentando che «con l’eccezione dell’amministratore
e di pochi altri, i funzionari dell’AFIS, particolarmente quelli più alti in
carica, appartengono al MAI. […] L’assetto dell’amministrazione italiana
in Somalia è identico a quello che esisteva durante il regime fascista»75. I
Giovani somali restavano scettici sul fatto che chi fino a poco tempo prima
era stato in Somalia come dominatore poteva convertirsi prontamente alla
politica della nuova Italia e dell’AFIS. Solo il costante impegno dei vertici
dell’AFIS, di Fornari e di Brusasca in particolare, riuscì a limitare i funzionari più retrivi e ad assicurare una politica nel complesso progressista.
Un punto di svolta, seppur parziale, fu segnato quando il governo pose
termine al regime di contingenza nella gestione dell’AFIS con la circolare
del MAE n. 61/626 del 15 gennaio 195276 che istituiva la Direzione Generale dell’Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (DGAFIS). In
effetti la proposta originaria di Brusasca sull’assetto istituzionale dell’amministrazione italiana fu realizzata solo parzialmente, nella misura in cui si
evitò di creare una struttura ad hoc e il quadro di riferimento fu in effetti il
ministero degli Esteri. Non fu invece accolto il suggerimento sul Comitato
di coordinamento e sull’Ufficio di collegamento, ritenendosi migliore una
soluzione un po’ più pesante con la costituzione di un’apposita Direzione
Generale. La motivazione era espressa da Vittorio Zoppi, segretario generale del MAE:
230
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
Data l’importanza internazionale del compito affidatoci, non si poteva fare a meno di
darvi un certo rilievo […] costituendo, almeno, una direzione generale apposita presso
il MAE. Ogni altra denominazione, come ad esempio, servizio o ufficio, avvilirebbe
l’alta funzione cui è chiamato a presiedere77.
Al di là del prestigio e dell’importanza internazionale, ebbe però rilevanza anche il consolidato argomento della liquidazione del MAI. Infatti
la costituzione della DGAFIS si ridusse «praticamente nel mettere alle dipendenze degli Esteri l’organizzazione già esistente e funzionate al MAI»,
trasferendo da un ministero all’altro una direzione generale e attribuendogli il compito specifico di amministrare l’AFIS78. Inoltre sul versante propriamente somalo i funzionari italiani rimasero in gran parte ex coloniali
fino alla fine del mandato; l’inversione di tendenza si ebbe piuttosto in
ragione della progressione della somalizzazione, ovvero dell’inserimento
nei ruoli amministrativi dei funzionari somali.
Se sul versante dell’amministrazione fiduciaria la costituzione della
DGAFIS fu in effetti un evidente compromesso, d’altra parte l’effetto fu
quello di accelerare la chiusura definitiva del MAI. Il 1° ottobre 1952, il
sottosegretario Brusasca poteva rispondere all’interrogazione parlamentare
dell’onorevole Berti che la situazione al MAI era in via di soluzione nel suo
complesso:
Degli 11 mila dipendenti, molti sono di fatto già sistemati, perché soltanto 590 sono
ancora in servizio presso il ministero: 9 mila sono comandati presso le altre amministrazioni dello Stato, un migliaio è ancora in Eritrea, in Libia e in Somalia, e un
migliaio circa in aspettativa79.
Il MAI venne definitivamente liquidato con la Legge n. 430 del 29
aprile 195380: il personale in carico ad altre amministrazioni venne integrato a titolo definitivo nell’amministrazione assegnataria, mentre per i restanti impiegati ancora dipendenti direttamente dal MAI fu predisposta la
messa in congedo o il trasferimento con ulteriori provvedimenti normativi
ad hoc81. Le competenze residue furono trasferite agli Esteri, a cui andavano l’archivio storico e i compiti di assistenza delle comunità italiane nelle
ex colonie ricondotti all’ambito delle normali prerogative di protezione e
tutela dei cittadini italiani all’estero; all’Istituto italo-africano (ex Istituto
coloniale italiano) andava il museo coloniale; alle Finanze passò la gestione
dell’Azienda monopolio banane della Somalia e alla Difesa spettarono le
231
Antonio M. Morone
competenze relative ai militari ancora dipendenti dal MAI. Si chiudeva
così una vicenda che, apparentemente tutta italiana, finì attraverso l’AFIS
per ripercuotersi sulla più ampia scena della politica della nuova Italia verso le ex colonie. A Brusasca va sicuramente il merito di aver proposto fin
dall’inizio la soluzione più funzionale e politicamente corretta, raccogliendo le sollecitazioni che gli venivano dai vertici italiani a Mogadiscio, anche
se essa trovò applicazione solo parziale e tardiva.
Tra le pieghe del processo di liquidazione del MAI si insinuò un ultimo
elemento di vischiosità che condizionò non solo la politica post-coloniale
italiana, ma soprattutto la memoria del colonialismo. Di fronte al destino
ormai segnato del ministero, si fece strada nella burocrazia coloniale l’idea
di «salvare il centro di aggregazione […] che aveva ruotato attorno all’Ufficio Studi del MAI» e che era stato uno dei protagonisti della propaganda
colonialista82. Il decreto interministeriale n. 140 dell’11 gennaio 1952 diede corpo a tale progetto, costituendo, presso il MAE, il «Comitato per la
documentazione dell’opera dell’Italia in Africa», con il fine di valorizzare la
pagina di storia coloniale appena conclusa, attraverso lo studio e la pubblicazione della documentazione del sopprimendo dicastero. Tale opportunità era stata posta allo studio dal MAE fin dal 194483, ma fu nell’autunno
del 1951 che Brusasca diede l’incarico a quello che era stato l’ultimo governatore della Somalia, Francesco Saverio Caroselli84, di mettere a punto un
progetto operativo, tramutatosi poi nel decreto del 1952.
Il Comitato fu composto, a parte alcuni studiosi come Carlo Giglio,
Carlo Zaghi, Raffaele Ciasca e Giuseppe Vedovato, per gran parte da alti
funzionari del MAI (15 su 24) che si trovarono da un giorno all’altro a
passare dal ruolo di amministratori a quello di biografi della propria attività in Africa. Il risultato fu controverso ma nella sostanza negativo: i circa
quaranta volumi raccolti nella collana L’Italia in Africa «si sono rivelati
opere di semplice compilazione e del tutto sfasati rispetto al disegno di
pura edizione documentaria quale era stato concepito in origine», forse
con la sola eccezione delle serie economico-agraria e scientifico-culturale85.
L’ effetto ultimo fu quello di una storiografia «priva di qualsiasi requisito di
serietà e di scientificità»86, che produsse una conoscenza distorta del colonialismo italiano, «con il solo scopo di porne in evidenza i meriti e anche
la sua diversità o eccezionalità rispetto ai colonialismi coevi»87.
Fu probabilmente sotto la pressione del Comitato che i documenti
dell’ASMAI furono acquisiti dal MAE invece di confluire nell’Archivio
232
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
Centrale dello Stato, che proprio in quegli anni era in fase di allestimento88. Nella sua attività il Comitato perpetrò un vero e proprio scempio
archivistico ai danni dell’intero patrimonio documentario dell’ex MAI attraverso la costituzione del cosiddetto fondo «Africa 3» che ruppe l’ordine
originale delle carte. Infine il Comitato, avocandosi il diritto esclusivo di
accedere alle carte dell’archivio storico del MAI, limitò l’attività degli storici indipendenti fino agli anni ottanta. Le eccezioni furono poche ed è
indicativo come l’americano Robert L. Hess (per sua stessa ammissione
uno dei primi storici indipendenti a poter utilizzare nel 1956 le carte sulla
Somalia) parli di «archivi storici del Comitato» non degli Esteri89.
Dopo la morte di Caroselli nel 1968, la direzione del Comitato fu affidata a Gaspare Ambrosini, costituente e deputato della Democrazia Cristiana, docente universitario e magistrato: una figura parzialmente nuova per
non avere un passato esplicitamente coloniale, ma che a ogni buon conto
condivideva l’impostazione del lavoro svolto. Il Comitato venne soppresso
solo nel 1984 dal decreto ministeriale n. 887 del 13 marzo e fu in effetti
solo a partire dalla fine degli anni settanta che si affermò una nuova leva
di studiosi che inaugurarono finalmente un nuovo dibattito scientifico sul
passato coloniale, rivedendone in termini critici la storiografia. Ciò non
toglie che la distorsione negli studi coloniali e nella memoria del colonialismo, a causa anche dell’opera del Comitato, fu tale che secondo Nicola
Labanca ancora oggi ha senso parlare a tale riguardo di «memorie diversificate» degli italiani90. La partecipazione di Brusasca alle fasi preparatorie
del Comitato e poi alle sue operazioni non gli rende onore. Fu egli stesso
a giustificarsi durante un’intervista rilasciata a Del Boca, affermando di
essere stato «costretto a fare il fuoco con la legna che aveva sottomano, cioè
con i rottami del più vieto colonialismo»91. È pure vero che gli effetti più
nefasti dell’attività del Comitato vanno imputati alla dirigenza scientifica
di Carlo Giglio, storico di formazione e di convinzioni coloniali, piuttosto
che alla presidenza onoraria di Brusasca92.
Nel complesso l’opera di Giuseppe Brusasca fu d’indirizzo politico e
di esecuzione tecnica nel presiedere al complesso ambito della revisione
in termini post-coloniali dei rapporti tra Italia e Africa. Brusasca operò
scelte sicuramente difficili, a volte impopolari, e nelle sue corrispondenze,
direttamente o indirettamente, questo dato traspare. Se alcune leggerezze
erano state compiute nell’avvallare l’opera della propaganda italiana, successivamente Brusasca operò sinceramente in favore della svolta italiana,
233
Antonio M. Morone
per nulla appesantito o compromesso dalle precedenti posizioni. Il nome
del politico piemontese si legò sicuramente più agli sforzi della rinnovata
politica italiana che non a quelli della propaganda vecchio stile. L’attenzione speciale che Brusasca ebbe per l’AFIS, che di quella svolta doveva essere la punta avanzata, e per la normalizzazione dei rapporti con l’Etiopia,
testimonia il suo impegno leale e fattivo per la politica della nuova Italia
verso le ex colonie.
Note al testo
1
Giuseppe Brusasca nacque a Cantavenna, frazione di Gabiano Monferrato, provincia di Alessandria, il 30 agosto 1900. Fu sottotenente di artiglieria nel 1919. Dopo le lauree in Giurisprudenza e in Scienze Economiche e Sociali, fu dal 1920 al 1923 attivista del Partito Popolare di
Alessandria e Casale Monferrato e direttore del settimanale monferrino «Il domani». Dal 1923
al 1925 fu consigliere comunale a Casale. Durante il fascismo fu costretto a trasferirsi a Milano
dove esercitò la professione legale, ma nel contempo partecipò all’organizzazione clandestina
della Democrazia Cristiana (DC), specie nella provincia di Alessandria, con Gronchi, Meda,
Iacini, Malvestiti e Clerici. Durante la Resistenza fu vice-presidente del Comitato nazionale di
liberazione Alta Italia. Membro del Consiglio nazionale della DC, dal 1945 al 1957 fu presidente dell’Amministrazione provinciale di Alessandria. Dopo essere stato eletto alla Costituente nella circoscrizione di Alessandria, fu deputato alla Camera dal 1946 al 1968, svolgendo in
particolare la sua opera presso la commissione Esteri. Sottosegretario di Stato all’Industria e al
Commercio dal 13 luglio 1946 nel secondo governo De Gasperi, il 18 ottobre 1946 venne nominato sottosegretario agli Esteri nel dicastero retto da Nenni. Sottosegretario all’Aeronautica
dal 14 febbraio al 31 maggio 1947 nel terzo governo De Gasperi, ritornò a ricoprire la carica di
sottosegretario agli Esteri dal 1947 al 1951 nel quarto e quinto governo De Gasperi. Dal 1951
fino al 1953 fu sottosegretario all’Africa italiana nel settimo governo De Gasperi. Nel 1951
coordinò la ricostruzione dopo l’alluvione del Polesine. Dal 1955 al 1957 durante il primo
governo Segni fu sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per lo spettacolo, occupandosi della riforma della Biennale di Venezia. Negli anni seguenti Brusasca ricoprì ancora
diversi incarichi governativi: capo della delegazione italiana alla Conferenza mondiale del caffè
nel 1962 e presidente della Commissione interparlamentare per la legge contro le frodi dei vini
nel 1965. Nel 1968 fu eletto senatore e membro della commissione Esteri di palazzo Madama.
Allo scadere della quinta legislatura, nel 1972, Brusasca rinunciò a candidarsi nuovamente e si
dedicò alla difesa dei diritti degli anziani come presidente del Movimento anziani della DC.
Morì a Milano il 1° giugno 1994.
2
Lo studio più completo ed esauriente sull’argomento è quello di Gianluigi Rossi, L’Africa
italiana verso l’indipendenza (1941-1949), Giuffré, Milano, 1980.
3
Angelo Del Boca, Myths, Suppressions, Denials, Defaults of Italian Colonialism, in A Place
in the Sun, Patrizia Palumbo ed., University of California Press, Berkeley e Los Angeles, Ca.
2003, p. 18.
234
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
4
Pietro Pastorelli, La politica estera italiana del dopoguerra, Il Mulino, Bologna 1987, p.
124.
5
Giampaolo Calchi Novati, Il Corno d’Africa nella storia e nella politica, SEI, Torino 1994,
p. 258.
6
Per una ricostruzione critica dell’idea e dell’istituto del trusteeship system si veda William Bain,
Between Anarchy and Society, Trusteeship and the Obligation of Power, Oxford University Press,
Oxford 2003. Per un approfondimento sul caso della tutela italiana in Somalia: Antonio
Morone, L’Onu e l’Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia. Dall’idea all’istituzione del
trusteeship, in «Italia Contemporanea», marzo 2006.
7
Nicola Labanca, Oltremare, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 430-432.
8
Il dolore suscitato per la perdita delle colonie era paragonabile per l’opinione pubblica italiana
a quello per la perdita di Tenda, Briga e del Moncenisio. Il dato è riportato da N. Labanca,
Oltremare cit., p. 348.
9
Alberto Tarchiani, Dieci anni tra Roma e Washington, Mondadori, Milano 1955, p. 192.
10
La citazione si riferisce all’intervento svolto da Brusasca al convegno dei profughi d’Africa
tenutosi a Torino il giorno 8 dicembre 1947, ripreso da «La Stampa» del 9 dicembre 1947 e
riportato infine da A. Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale, IV, Laterza, Roma-Bari 1984,
p. 33.
11
Attraverso il MAI, furono concessi contributi in diversa misura alla Società geografica africana
d’Italia, all’Istituto di studi orientali, all’Istituto per l’oriente, alla Società africana d’Italia, al
Centro di studi coloniali di Firenze, all’Erbario coloniale di Firenze, alle Cliniche per le malattie tropicali e sub-tropicali di Roma e Napoli, all’Ente mostra d’oltremare e del Lavoro italiano
nel mondo (ex Ente mostra triennale delle terre d’oltremare) e all’Istituto italo-africano (ex
Istituto coloniale italiano). Con il patrocinio governativo furono pubblicate quattro relazioni sulla colonizzazione in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, un volume fotografico e
statistico sull’opera dell’Italia, diverse monografie sulle coloni e sul lavoro italiano in Africa, la
«Rassegna settimanale della stampa nazionale ed estera» e il «Bollettino mensile della stampa
estera per l’Africa e il Medio Oriente». Altre iniziative furono la Fiera di Bari del settembre
1947, la nuova Fiera del Levante di Bari del settembre 1948 e la Fiera del mare di Taranto nel
luglio 1948. L’elenco dettagliato dei finanziamenti è contenuto nella «Relazione sull’attività
svolta dal Ministero dell’Africa Italiana al 31 dicembre 1949», pp. 10-12, Archivio Storico di
Casale Monferrato (d’ora in poi ASCM), carte «Brusasca», b. 71, f. «relazioni».
12
G. Calchi Novati, Studi e politica ai convegni coloniali del primo e del secondo dopoguerra in
Atti del Convegno Fonti e problemi della politica coloniale italiana (Taormina-Messina, 23-29
ottobre 1989), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1996, p. 189. Particolare importanza
ebbe l’attività congressuale svolta dal Centro di studi coloniali di Firenze: Aspetti dell’azione
italiana in Africa, Atti del convegno di studi coloniali, 29-31 gennaio 1946, Stet, Firenze 1946;
Amministrazione fiduciaria all’Italia in Africa, Atti del secondo convegno di studi coloniali,
12-15 maggio 1947, Stet, Firenze 1948 (Il testo fu successivamente tradotto e pubblicato in
lingua inglese a cura del Centro con il titolo The question of the Administration of Italian Colonies in Africa under Trusteeship, Stet, Firenze 1949); Atti del terzo convegno di studi africani
3-5 giugno 1948, Stet, Firenze, 1948. Oltre ai convegni fiorentini vanno ricordati i Congressi
dei profughi d’Africa: Siracusa, agosto 1947, Bari, settembre 1947, Padova, ottobre 1947 e
Asti, dicembre 1949.
13
Giuseppe Brusasca, Solidarietà nazionale per i profughi dell’Africa, Tipografia della Camera
dei Deputati, Roma 1949, pp. 5-6.
14
ASCM b. 71, f. «relazioni», relazione sull’attività svolta dal MAI al 31 dicembre 1949.
235
Antonio M. Morone
15
«Bollettino settimanale della stampa coloniale italiane ed estera», n. 2, 8 gennaio 1948.
16
La citazione è tratta dal volantino intitolato Libia e le aspirazioni italiane contenuto tra le carte
dell’ASCM, b. 20, f. 183 e riportato da A. Del Boca, Gli Italiani in Libia, Vol. II, Laterza,
Roma-Bari 1988, p. 369.
17
ASCM, b. 34, messaggio ai libici del 6 marzo 1948, riportato in A. Del Boca, Gli italiani in
Libia, II, cit., p. 371.
18
Oltre all’attività anti-italiana vi furono almeno altri due tipi di shifta, banditismo vero e proprio,
oppure quello legato a ragioni personali o lotte tra clan contrapposti. Cfr. Tekeste Negash,
Eritrea and Ethiopia. The Federal Experience, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1997.
19
La versione riportata nel testo è tratta da G. Calchi Novati e Pierluigi Valsecchi, Africa:
la storia ritrovata, Carocci, Roma 2005, pp. 258-259. Contrario invece a un coinvolgimento
diretto etiopico è Tekeste Negash nell’opera citata, a p. 65: «Lo Stato etiopico fu implicato con
gli shifta agli occhi degli inglesi non tanto per la sua assistenza attiva, ma perché esso incoraggiò
lo stesso obiettivo perseguito dagli shifta, vale a dire, l’unione dell’Eritrea con l’Etiopia». Gli
shifta sarebbero allora una diretta reazione in termini di terrorismo politico da parte dell’Union
Party e dei suoi simpatizzanti contro le ingerenze della propaganda italiana, in un quadro istituzionale nel quale la BMA non fu in grado di controllare e reprimere il fenomeno.
20
A. Del Boca, Gli italiani in Africa orientale cit,. IV, p. 150.
21
«Relazioni Internazionali», n. 4, 1948, p. 54. Il testo integrale del documento è pubblicato
anche dal «Bollettino settimanale della stampa coloniale italiana e estera», n. 1, 1948.
22
La ricostruzione tracciata dalle pubblicazioni di Giampaolo Calchi Novati sintetizza, con dovizia di fonti, il quadro generale della vicenda e i suoi risvolti particolari: Gli incidenti di Mogadiscio del gennaio 1948: rapporti italo-inglesi e nazionalismo somalo, in «Africa», n. 3-4, 1980
si basa su fonti reperite presso l’ASMAE, l’ACS, il PRO e l’Archivio della Croce Rossa; Una
rilettura degli incidenti di Mogadiscio del gennaio 1948 e il difficile rapporto fra somali e italiani,
in «Studi Piacentini», n. 15, 1994 aggiorna lo studio precedente alla luce dell’apertura alla
pubblica consultazione del rapporto della Commissione d’indagine inglese Flaxman.
23
Ioan M. Lewis, A Modern History of Somalia, Longman, London 1980, p. 125.
24
La tesi di fondo sostenuta dal Comitato rimaneva la sostanziale bontà dell’opera di avvaloramento economico compiuto dagli italiani in colonia e la bontà della passata dominazione
coloniale. Cfr. Pietro Beritelli, Relazione del Comitato Rappresentativo Italiano alla Commissione d’investigazione delle Quattro Potenze sul territorio della Somalia, (dattiloscritto inedito),
s.d. (ma presumibilmente gennaio 1948), custodito presso la Biblioteca della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Pavia.
25
Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi ASMAE), carte «AFIS», b. 19,
f. 42, telespr. riservato 1032 del 30 luglio 1948 da Manzini al MAE. Il testo della corrispondenza venne inoltrato al MAI con il telespr. n. 3/831/C del 24 agosto 1948, rintracciabile nella
medesima posizione archivistica.
26
ASCM, b. 2/b, ONU. Eritrea, lettera del 30 giugno 1948 da Moreno a Brusasca, riportata in
A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, IV, cit., p. 136.
27
A. Del Boca, Gli italiani in Africa orientale cit., IV, p. 129.
28
Giulio Andreotti, De Gasperi e il suo tempo, Mondadori, Milano 1964, p. 317.
29
G. Rossi, L’Africa italiana verso l’indipendenza cit., p. 584.
30
Geoff Simons, Libya and the West. From Independence to Lockerbie, Centre for Libyan Studies,
Oxford 2003, p. 30.
236
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
31
ASMAE, «Ambasciata di Londra», b. 1417, f. 1, telespresso 90/1497/C del 4 novembre 1950
da Brusasca all’ambasciata d’Italia a Londra, riportato in A. Del Boca, Gli Italiani in Libia
cit., II, p. 410.
32
«The area is without major strategic importance» (Department of State Bulletin, 17th April
1949, p. 485, riportato in Okbazghi Yohannes, The United States and the Horn of Africa,
Westview Press, Oxford 1997, p. 203).
33
Geoff Simons, Libya and the West cit., p. 29.
34
G. Calchi Novati, Il Corno d’Africa nella storia e nella politica cit, p. 89.
35
ASCM, «Brusasca», b. 32, f. 9, appunto della riunione per la Somalia tenuta il 26 novembre
1949 al MAI.
36
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia e Somalia: dieci anni di collaborazione, Istituto
Poligrafico dello Stato, Roma 1962, p. 28.
37
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 262, lettera del 9 agosto 1950 da Brusasca (New York) a Fornari.
38
«Corriere della Sera», 9 febbraio 1950.
39
Antonio M. Morone, Governo nella Somalia sotto Amministrazione Fiduciaria Italiana. Dal
trapianto istituzionale all’indipendenza, tesi di dottorato, Università di Pavia, marzo 2007, pp.
147-162
40
ASCM, «Brusasca», b. 34, f. 65, circolare n. 1/G/8° del 24 maggio 1950 dalla segreteria della
SYL a tutte le sezioni.
41
A. Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale cit., IV, p. 224.
42
ASCM, «Brusasca», b. 60, f. 56, Indirizzi di saluto ed omaggio a S. E. Brusasca da parte di capi,
notabili e capi partito di Mogadiscio, 26 maggio 1950.
43
ASCM, «Brusasca», b. 33, f. 29, lettera del 15 giugno 1950 da Bona a Brusasca.
44
«Corriere della Sera», 6 gennaio 1951.
45
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 262, lettera del 9 dicembre 1950 da Brusasca alla PCM.
46
G. Calchi Novati, Mediterraneo e questione araba nella politica estera italiana, in Storia dell’Italia repubblicana, a cura di Francesco Barbagallo, vol. II, Einaudi, Torino 1995, pp. 210-213.
47
ASMAE, «AFIS», b. 19, f. 28, verbale della prima riunione dei Commissari, Mogadiscio, 2527 luglio 1950. In letteratura questa tesi è sottolineata da Saadia Touval, Somali Nationalism,
Harvard University Press, Cambridge 1963, pp. 170-171.
48
G. Calchi Novati, Il canale della discordia. Suez e la politica estera italiana, Quattro Venti,
Urbino, 1998, p. 32.
49
ASMAE, «Inventario Rappresentanze diplomatiche», Londra 1861-1950, b. 1397, riportato
in G. Calchi Novati, Italia e Etiopia dopo la guerra: una nuova realtà, i risarcimenti e la stele
rapita, in «Africa», XLVI, 4(1991), p. 481.
50
G. Calchi Novati, Italia e Etiopia dopo la guerra cit., p. 482.
51
ANSA, n. 102 del 25 maggio 1950.
52
ASCM, «Brusasca», b. 1/a, ONU. Eritrea, f. 2, lettera del 16 luglio 1950 da Brusasca a Sforza,
riportata in A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale cit. , IV, p. 67
53
G. Calchi Novati, Come dimenticare il colonialismo, «Nuova Antologia», n. 241, gennaiomarzo 2007, p. 148.
237
Antonio M. Morone
54
Intervista di Brusasca al «Il Popolo Nuovo» del 10 agosto 1951.
55
AFIS, Bollettino mensile, n. 6, agosto-settembre 1951, Stamperia AFIS, Mogadiscio, pp.6-7,
riportato in A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, IV, p. 236.
56
A. M. Morone, Governo nella Somalia cit., pp. 162-176.
57
Piacentini aveva avuto una lunga attività diplomatica in Etiopia, dove si era stabilito dopo il
suo pensionamento e vi era rimasto fino all’estate del 1942 svolgendo attività semi-ufficiali di
collegamento con le autorità inglesi. Una volta rientrato in Italia, stilò vari rapporti per il ministero degli Esteri dal 1944 in avanti. L’ambasciatore Cora, anch’egli con una lunga esperienza
in Africa, arrivò in Etiopia nel maggio del 1951 a titolo privato come presidente di una società
di trasporti la SANE, ma con precise consegne da parte degli Esteri. I dettagli di queste operazioni e un quadro esaustivo circa la normalizzazione delle relazioni italo-etiopiche si trovano in
G. Calchi Novati, Italia e Etiopia dopo la guerra cit., pp. 483-487.
58
Ivi, p. 488.
59
La questione dei risarcimenti fu risolta solo con l’accordo stipulato il 6 marzo 1956 ad Addis
Abeba, dal successore di Tacoli, l’ambasciatore Berio, concludendo così dopo la fase militare
e politica della sistemazione dei rapporti italo-etiopici, anche quella economica. Rimaneva
però ancora in sospeso la vicenda della stele di Axum, trafugata a Roma durante l’occupazione
fascista e che tornò in Etiopia solo nell’aprile 2005.
60
ASMAE, «Inventario rappresentanze diplomatiche», Londra, b. 713, lettera da Smoquina a
Tallarigo del 22 ottobre 1951, riportato in G. Calchi Novati, Italia e Etiopia dopo la guerra
cit., p. 495.
61
Ibidem, p. 492.
62
A. Del Boca, Gli Italiani in Africa orientale cit., IV, p. 34.
63
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 262, lettera del 9 dicembre 1950 da Brusasca alla PCM.
64
Fornari era stato ambasciatore a Santiago del Cile dal 1948 ed ex segretario della Delegazione
italiana alla Società delle Nazioni.
65
Gorini aveva servito in Tripolitania, Oltregiuba, Cirenaica, Harar e nella sede centrale del MAI
a Roma; partecipò alla campagna di Libia, ma non a quella d’Etiopia.
66
ASCM, «Brusasca», b. 34, f. 60, lettera del 9 marzo 1950 da Gorini a Nasi.
67
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 261, lettera n. 1038/s. del 7 aprile 1951 da Fornari a Brusasca.
La citazione è riportata parzialmente anche in A. Del Boca, Gli Italiani in Africa orientale cit.,
IV, p. 233.
68
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 261, lettera del 10 marzo 1951 da Fornari a Brusasca. Un quadro
simile fu espresso a suo tempo anche dagli osservatori inglesi, nei rapporti che seguirono il
trapasso tra amministrazione inglese e italiana: «The Ministry of African Affairs is cluttered up
with ex Italian officials who are mostly career minded and as they have been posted Mogadishu: jobs have to be found for them. The Italian Chief Administrator apparently considers that
it is wrong. [...] Also the Somali remember them and are not convinced that they have changed
their policy». Public Record Office (d’ora in poi PRO), «FO», b. 371, f. 80887, letter no. 48
of 3rd June 1950 from Mogadishu Consulate to FO.
69
Mohamed Abdulle Sheikh, Testimonianza di un protagonista. Storia del rapporto tra la Somalia e l’Italia di 103 anni, dall’accordo commerciale firmato a Zanzibar 28.5.1885 ad oggi,
(dattiloscritto inedito), s. d., p. 73.
70
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 262, lettera del 26 agosto 1950 da Fornari a Brusasca.
238
La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca
71
Le denunce erano arrivate a Brusasca in particolare da Francesco Bona, segretario della DC di
Mogadiscio e da Luigi Massimini, corrispondente per il «Corriere della Somalia». Bona parlava
di un «rigurgito fascista accentuato da molti discorsi dei nuovi funzionari», che mancavano «di
qualsiasi spirito democratico» (ASCM, «Brusasca», b. 33, f. 29, lettera del 15 giugno 1950 da
Bona a Brusasca). Massimini riferiva di uno «sviluppo del neo-fascismo» (ASCM, «Brusasca»,
b. 48, f. 284, lettera del 7 ottobre 1950 da Massimini a Brusasca) che causava «grande intralcio
alla difficile opera del governo centrale» (ASCM, «Brusasca», b. 48, f. 284, lettera del 22 dicembre 1950, da Massimini a Brusasca). «Il Movimento Sociale Italiano ha 260 iscritti, … la DC
una cinquantina» (ASCM, «Brusasca», b. 48, f. 284, lettera del 17 marzo 1951 da Massimini
a Brusasca). Infine le fonti della Polizia segnalavano che, tra gli italiani, «il partito che dà segni
di maggiore attività è il MSI» (ASCM, «Brusasca», b. 37, f. 105, appunto del comandante del
Gruppo territoriale Carabinieri Somalia, Alberto Mennerini, dell’11 giugno 1951). L’esame di
alcune fonti terze sembrano avvalorare questi dati. Una prima testimonianza è quella che i documenti diplomatici inglesi attribuiscono a Ranshofen-Wertheimer, segretario generale dell’U.
N. Advisory Council for Somalia: «The Italian officials who have come to Somalia, with the
exception of the Chief Administrator and possibly a few others, are entirely Fascist minded»
(PRO, «FO», b. 371, f. 80886, letter n. CFa/0111 of 16th May 1950 from B.A.S. Nairobi to
FO). La tesi è ripresa direttamente da un altro rapporto inglese: «The spirit of Fascism has not
been completely exorcised from the Administrative body of this territory. I was amused by one
of the heads of departments at Headquarters, who dined with me the other night, when he
described himself as a «Fascist-without-war-crimes» all in one word» (PRO, «FO», b. 371, f.
80887, Despatch n. 8 of 14th September 1950 from British Consulate Mogadishu to FO.
72
ASCM, «Brusasca», b. 46, f. 261, lettera n. 1038/s. del 7 aprile 1951 da Fornari a Brusasca.
73
A. Del Boca, Gli Italiani in Africa orientale cit., IV, p. 238. L’impegno di Brusasca nell’appoggiare le autorità fiduciarie a discapito di vecchi interessi della comunità italiana emerge
bene da numerosi documenti riportati nel capitolo dedicato all’AFIS nella medesima opera
di Del Boca.
74
Mohamed Aden Sheikh e Piero Petrucci, Arrivederci a Mogadiscio, Edizioni Associate,
Roma 1994, pp. 48-49. Il dato è confermato anche dalle fonti inglesi immediatamente dopo
l’handover tra BMA e AFIS: «Many Italians who come to Somalia to fill posts in the Administration have considerable previous experience of Colonial Government and some have had
previous service in Somalia» (PRO, «FO», 1015/553, Report on the return to Somalia in
amplification of official report on transfer of administration from Gamble to Colonial Office,
15th May 1950).
75
«With the exception of the Administrator and few others, the number of the Italian administration, particularly the top-raking officials, are the staff of the Ministero Africa Italiana. […]
The set-up of the Italian administration in Somaliland is identical to that during the fascist
regime» (ASCM, «Brusasca», 81/ONU, memorandum to the General Assembly of the U.N.
from the Somali Delegation on the Trust Territory of Somalila, Lake Success, N.Y., October,
1950).
76
La DGAFIS venne organizzata in tre uffici: affari politici; affari interni, amministrativi e del
personale; affari economici, finanziari e commerciali.
Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), «PCM», 1955-1958, 17/3-1179, lettera n.
61011086 del 23 gennaio 1952 da Zoppi a Balbucci.
78
Ibidem.
77
79
ASCM, «Brusasca», 71/parlamento, Camera dei Deputati, risposta a interrogazione parlamentare, 1° ottobre 1952.
80
Art. 2, co.1°, n. 1; «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» (d’ora in poi GURI), n. 135,
239
Antonio M. Morone
1953. La norma si trova anche nel «Bollettino Ufficiale dell’AFIS» (d’ora in poi BUAFIS),
suppl. 1 al n. 7.
81
Legge n. 431 del 9 luglio 1954 in GURI n. 159, 1954 (la legge si trova anche nel BUAFIS,
sup. 3 al n. 7, 1954); DPR n. 1090 del 20 ottobre 1954 in GURI, n. 275, 1954 (o BUAFIS
sup 3 al n. 1, 1954); DPR. n. 1451 del 30 novembre 1954 in GURI n. 60, 1955 (o BUAFIS
sup. 3 al n. 4, 1955); DPR. n. 1452 del 30 novembre 1954 in GURI n. 63, 1955 (o BUAFIS,
sup. 3 al n. 4); DPR. n. 1466 del 30 novembre 1954 in GURI, n. 65, 1955 (o BUAFIS, sup. 3
al n. 4, 1955); DPR. n. 1496 del 30 novembre 1954 in BUAFIS, sup. 3 al n. 4, 1955.
82
Vincenzo Pellegrini e Anna Bertinelli, Per la storia dell’amministrazione coloniale italiana,
Quaderni ISAP, Giuffrè, Milano 1994, p. 103.
83
Ivi, p. 104.
84
Caroselli nacque a Roma il 12 marzo 1867. Dopo la laurea in giurisprudenza entrò in magistratura e nel 1912 fu reclutato tra i funzionari coloniali. Compì gran parte della sua carriera
in Somalia, dove divenne governatore il 15 dicembre 1937. Morì a Zagarolo il 30 dicembre
1967.
85
Marco Lenci, Dalla storia coloniale alla storia dell’Africa, in «Africa», n. 2, 2003, p. 209.
86
Giorgio Rochat, Colonialismo, in Storia d’Italia, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1978, p.
109.
87
A. Del Boca, Le conseguenze per l’Italia del mancato dibattito sul colonialismo, in «Studi Piacentini», n. 5, 1989, p. 117.
88
V. Pellegrini e A. Bertinelli, Per la storia dell’amministrazione coloniale cit., p. 105.
89
Robert L. Hess, Italian Colonialism in Somalia, The University of Chicago Press, Chicago
1966, VIII.
90
N.Labanca, Oltremare cit., p. 458.
91
A. Del Boca, L’Africa nella coscienza degli italiani, Oscar Mondadori, Milano 2002, p. 116.
92
Cfr. Il colonialismo e l’Africa. L’opera storiografica di Carlo Giglio, a cura di G. Calchi Novati,
Carocci, Roma 2004.
240
La politica tedesca per l’Africa a servizio
della riunificazione
di Francesca Zilio
A dieci anni dalla nascita della Repubblica federale di Germania e in
seguito all’acquisizione di una certa indipendenza in politica estera, al rapido evolversi della decolonizzazione e all’associazione di buona parte del
continente africano alla CEE, il Governo di Bonn si risolse ad elaborare
una compiuta politica per l’Africa. La riunificazione, obiettivo primario e
imprescindibile di ogni governo federale, e uno dei principali strumenti
predisposti per raggiungerla – la Dottrina Hallstein – ne avrebbero rappresentato il fondamento, ma anche il limite. Nel perseguire una tale politica
estera, Bonn necessitava infatti di ottenere e mantenere sia il sostegno dei
paesi africani di nuova o prossima indipendenza, sia quello dei suoi alleati
occidentali e soprattutto dello storico nemico francese, i cui interessi erano
difficilmente conciliabili con quelli del suo ex impero coloniale.
Il presente saggio - basato prevalentemente su documenti inediti dall’Archivio politico del ministero degli Esteri della Repubblica federale di Germania1 – si propone di analizzare una particolare politica (la cooperazione
allo sviluppo tedesca per l’Africa) in un particolare periodo (1955-1972),
proponendola come caso emblematico di successo della diplomazia economica nel perseguire un obiettivo strategico di politica estera.
Riunificazione, Dottrina Hallstein e cooperazione allo sviluppo
Uno dei cardini della politica estera della Repubblica federale di Germania durante la guerra fredda fu la Dottrina Hallstein. Fondata sull’Alleinvertretungsanspruch, ovvero sul preteso diritto del Governo di Bonn
ad essere l’unico rappresentante legittimo della Germania e dei Tedeschi in
ambito interno ed internazionale, essa prevedeva l’interruzione delle relazioni diplomatiche con i paesi che avessero stretto analoghe relazioni con
la Repubblica democratica tedesca. Queste avrebbero infatti rappresentato
241
Francesca Zilio
una minaccia per la futura riunificazione, obiettivo primario di tutti i governi federali del dopoguerra. Affermava pertanto il ministro degli Esteri
von Brentano nel giugno 1956:
Il riconoscimento della Repubblica democratica tedesca significherebbe riconoscere a
livello internazionale la divisione della Germania in due Stati. La riunificazione allora
non sarebbe più l’eliminazione di un disturbo temporaneo nell’organismo dell’intero
Stato tedesco, ma si trasformerebbe nel compito infinitamente più difficile di riunificare due diversi Stati tedeschi. […] Il riconoscimento della Repubblica democratica
tedesca da parte di Stati terzi dovrebbe essere considerato dal Governo federale come
approvazione dell’illegittimo distacco di una parte del territorio sovrano tedesco e ingerenza negli affari interni tedeschi2.
In quanto tale, il riconoscimento più o meno esplicito del Governo di
Pankow avrebbe rappresentato un «atto non amichevole», cui si sarebbe
reagito con «provvedimenti graduali» a seconda della gravità dell’atto, della
scena politica internazionale del momento, dell’importanza degli interventi del blocco orientale nel Paese in questione, dell’autorità e dell’influenza
del suo capo di Stato, ma anche del peso delle relazioni economiche bilaterali e di eventuali successi o fallimenti della Dottrina appena avvenuti in altri luoghi. Fu così che la rottura ufficiale dei rapporti diplomatici
avvenne in due soli casi (Jugoslavia 1957, Cuba 1963), mentre furono
molto più spesso adottati provvedimenti minori, di altra natura, come la
sospensione degli aiuti allo sviluppo o la minaccia di tale sospensione a
scopo deterrente.
Se nelle sue definizioni «ufficiali» – desumibili dai discorsi di Adenauer,
Von Brentano e Grewe – la Dottrina Hallstein si rivolgeva all’intera comunità internazionale, risulta infatti evidente che nella pratica ne fossero
esclusi sia gli alleati occidentali, che si erano impegnati a sostenere l’Alleinvertretungsanspruch, sia i paesi del blocco socialista, con i quali Bonn
non poteva intrattenere relazioni diplomatiche poiché essi avevano riconosciuto la DDR molto prima dell’enunciazione della Dottrina3. Questa, di
conseguenza, si rivolgeva in sostanza ai cosiddetti non allineati, che erano
in gran parte paesi in via di sviluppo nati dopo il 1955. In tale contesto
era palese lo stretto legame tra la politica di cooperazione allo sviluppo del
Governo federale e la Dottrina che ne plasmava la politica estera.
L’importanza della cooperazione allo sviluppo per la risoluzione della «questione tedesca» e la conseguente necessità di strumentalizzarla non
242
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
mancarono di essere illustrate chiaramente e compiutamente dall’«Auswärtiges Amt»:
Mi baso sul fatto che l’affermazione dell’Alleinvertretungsanspruch non sia un metodo
o una dottrina mutabile della nostra politica estera, ma che si tratti piuttosto di una
posizione centrale sulla strada della riunificazione, che l’identità della Repubblica federale di Germania con lo Stato di tutti i Tedeschi sia indissolubilmente legata a questa
rivendicazione, vale a dire che la Repubblica federale, nel momento in cui abbandonasse tale rivendicazione, decadrebbe ad essere solo uno Stato situato su territorio
tedesco, rinuncerebbe praticamente alla riunificazione e contribuirebbe a provocare la
fine dei Tedeschi come nazione. Dal ruolo dominante che l’Alleinvertretungsanspruch
ricopre consegue che noi dobbiamo porre tutti i mezzi a nostra disposizione a servizio
di questa politica estera, che sola ci permette di essere all’altezza del compito storico
che è stato assegnato alla Repubblica federale di Germania. Il fallimento o addirittura
la rinuncia alla finora fruttuosa politica di isolamento di Pankow sarebbe una catastrofica sconfitta in politica estera. […] Uno dei pochi e il più efficace metodo per rafforzare la nostra politica estera nei confronti dei paesi in via di sviluppo sono gli aiuti allo
sviluppo in tutte le loro manifestazioni. Poiché producono effetti all’estero, gli aiuti
allo sviluppo hanno per ogni governo anche un rilievo di politica estera. Tuttavia essi
non hanno per nessuno Stato un’importanza in politica estera come per la Germania,
poiché nessun altro Stato donatore deve superare la divisione della sua nazione. In questa situazione ogni considerazione dogmatica o pratica che sia atta a sciogliere gli aiuti
allo sviluppo tedeschi dal loro necessario vincolo di politica estera è un passatempo
mentale non solo inutile, ma nocivo per l’interesse tedesco4.
Una tale dichiarazione, sostenuta e condivisa dalla diplomazia federale,
non lascia dubbi in merito alla collocazione della politica tedesca di cooperazione allo sviluppo in rapporto ai principali obiettivi di Bonn: uno
strumento a servizio della riunificazione, del tutto sottomesso ai dettami
della Dottrina Hallstein.
Ne è un’ulteriore dimostrazione il fatto che già nel 1955 il ministero degli Esteri avesse addirittura chiesto che fosse istituito a bilancio un capitolo
destinato ad «aiuti immediati» per obiettivi di politica estera, che avrebbe
permesso di avere a disposizione dei fondi da assegnare ad un qualsiasi
Paese in via di sviluppo non appena questo avesse tentato di avvicinarsi
eccessivamente a Pankow. Tali somme avrebbero dovuto convincerne i Governanti a rifiutare analoghe offerte provenienti dall’Est e non sarebbero
state vincolate ad alcuna precedente valutazione sulla necessità economica o sulla sostenibilità dei progetti che sarebbero andati a finanziare5. Si
trattò di una delle poche occasioni in cui il ministero delle Finanze riuscì
243
Francesca Zilio
ad opporsi. Anche nella verifica dei risultati degli aiuti allo sviluppo che
le missioni diplomatiche tedesche dovevano effettuare periodicamente era
presente, a fianco di quella economica, una sezione politica riguardante il
successo o meno degli aiuti rispetto agli interessi tedeschi in politica estera:
Fino a che punto gli aiuti tedeschi fanno progredire i nostri rapporti politici con il
Paese ricevente (posizione sulla questione tedesca)?
Cosa ottengono – di per sé e insieme agli aiuti degli altri paesi occidentali – nella
resistenza contro gli sforzi del blocco orientale nei confronti del Paese ricevente? In
quale rapporto sono con gli aiuti del blocco orientale, in particolare della zona d’occupazione sovietica, per quanto riguarda la quantità effettiva e l’impressione visiva? Quali
tipi di aiuto si sono rivelati particolarmente efficaci politicamente? Come può essere
migliorata la pubblicità per aumentare i risultati politici?6
È evidente che effetti politici più soddisfacenti e duraturi si sarebbero
ottenuti attraverso misure più attraenti economicamente. La diplomazia
federale affermava quindi che
di questa attrattiva fa parte anche il fatto che coloro che politicamente stanno dalla
nostra parte in maniera più attiva, cioè sostengono la nostra Deutschlandpolitik, abbiano maggiori vantaggi economici, in altre parole che ricevano più aiuti allo sviluppo
rispetto ai sostenitori inaffidabili. Viceversa, la sottrazione di aiuti economici nel caso
di una crisi politica, per esempio il riconoscimento di Pankow, può avere un rilievo
significativo solo se questi aiuti erano essenziali per lo Stato in questione e quindi la
loro sottrazione ha un effetto dannoso7.
La strumentalizzazione degli aiuti allo sviluppo avveniva pertanto in
due direzioni: come premio e ulteriore incentivo per gli alleati alla causa
della riunificazione, come punizione o deterrente per coloro che avevano
violato gli interessi tedeschi o dimostrato di avere intenzioni in questo
senso.
La cooperazione allo sviluppo nei confronti dell’Africa come strumento della Dottrina Hallstein
Lo stretto legame fra la risoluzione della «questione tedesca» come obiettivo primario di politica estera e l’impostazione della politica di cooperazione allo sviluppo si rendeva particolarmente evidente in relazione al continente africano. Esso univa infatti ad un grave sottosviluppo economico
244
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
un altrettanto grave disordine politico, caratterizzato dalla presenza di una
molteplicità di nuovi Stati, nati dal processo di decolonizzazione, che appena affacciatisi sulla scena internazionale avrebbero potuto facilmente subire le influenze orientali e riconoscere in massa la DDR. Si rese pertanto necessaria l’elaborazione di particolari politiche nei confronti dell’Africa, che
tenessero conto delle sue specificità storico-politiche e conseguentemente
sia delle difficoltà che delle opportunità che queste avrebbero presentato.
Ne forniscono un resoconto significativo le trascrizioni della riunione
dei capi missione di tutte le missioni diplomatiche tedesche in Africa, convocata ad Addis Abeba dal 12 al 18 ottobre 1959 allo scopo di approfondire e dibattere l’attuazione della politica che Bonn avrebbe condotto nei
confronti del continente per i successivi dieci anni, fino alla conferenza di
Abidjan8 (28 marzo - 2 aprile 1968), nel corso della quale fu rivendicata
una maggiore indipendenza dell’Afrika-Politik rispetto alla DeutschlandPolitik. A questa sarebbe infatti seguita la dichiarazione del 28 ottobre
1969 nella quale il cancelliere Brandt riconobbe ufficialmente l’esistenza
di «un secondo Stato in Germania», eliminando così il fondamento della
Dottrina Hallstein.
Pochi mesi dopo la conferenza, le conclusioni furono riassunte in modo
esemplare:
La politica africana della Repubblica federale è determinata dalla necessità di aiutare
i giovani Stati africani per fermare un’avanzata dell’Oriente comunista in Africa. […]
A questo proposito bisogna opporsi efficacemente agli sforzi della zona d’occupazione
sovietica per un riconoscimento diplomatico9.
Non a caso, uno dei temi principali della conferenza, illustrato dal consigliere d’ambasciata Herbert Schroeder, capo dell’ufficio 307 (paesi africani) presso il ministero degli Esteri, fu «L’Africa nel conflitto Est-Ovest»:
Il conflitto non è più un duello fra l’Africa e le potenze coloniali europee, bensì
una battaglia a tre fra l’Occidente, il nazionalismo africano e l’offensiva del potere
comunista. Agli Africani si presenta all’improvviso un’alternativa che finora non
avevano conosciuto10.
La reazione a tale situazione fu suggerita da Hasso Von Etzdorf, direttore della direzione generale territoriale III:
245
Francesca Zilio
Compito dell’Occidente è allearsi con il nazionalismo africano, perché se non lo facciamo noi, lo farà l’Est11.
La propaganda socialista era tanto più rischiosa in quanto era diffusa
da URSS e Cina anche attraverso il movimento di solidarietà afro-asiatico.
Gli Stati di nuova o imminente indipendenza avrebbero infatti più facilmente interpretato come gesti amichevoli le offerte del blocco sovietico, estraneo al colonialismo, piuttosto che gli aiuti occidentali, spesso
considerati un risarcimento obbligatorio da parte degli ex colonialisti o al
massimo un tentativo di liberarsi dai sensi di colpa. Attraverso tali aiuti
l’Occidente avrebbe invece dovuto «verificare le opportunità per un legame a lungo termine dei paesi in via di sviluppo con l’Occidente e ricorrere
a misure adeguate»12. Tali misure avevano perciò l’obiettivo di risolvere
una contraddizione: avrebbero dovuto assicurare l’appoggio dei paesi africani all’Occidente (e, di conseguenza, alla posizione di Bonn sulla questione tedesca), ma ciò sarebbe stato possibile solo dimostrando il sostegno
dell’Occidente stesso alle rivendicazioni di neutralità e non allineamento
di tali paesi, le quali impedivano che questi potessero venire legati al blocco
euro-atlantico attraverso la stipulazione di trattati o l’istituzione di alleanze
o patti difensivi. In tale contesto, la politica culturale, la propaganda13 e soprattutto la cooperazione allo sviluppo si sarebbero rivelate di fondamentale importanza nelle relazioni della Germania con il continente africano
(o, per meglio dire, delle Germanie, considerando che i due stati tedeschi
si fronteggiavano sullo stesso piano e con metodi analoghi14). Un’altra relazione presentata alla Conferenza di Addis Abeba era perciò dedicata agli
obiettivi che il Governo federale si prefiggeva appunto attraverso gli aiuti
allo sviluppo destinati a tale continente:
La finalità della politica di cooperazione allo sviluppo è intensificare, mediante lo «sviluppo», le relazioni fra i paesi occidentali e quelli in via di sviluppo e ottenere un’influenza quanto più possibile duratura sul Governo e la popolazione di questi territori,
contenere l’influsso del blocco orientale e stabilizzare le condizioni politiche ed economiche dei paesi in via di sviluppo. Anche la politica commerciale contribuisce allo
sviluppo di questi Stati. Il suo compito è però quello di promuovere il proprio commercio estero. La politica di cooperazione allo sviluppo ha in primo luogo obiettivi di
politica estera, quelli della politica commerciale sono principalmente economici15.
Fra tutte le componenti della politica estera, la cooperazione allo svi246
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
luppo era dunque ritenuta il mezzo più adatto per combattere il comunismo e mantenere legati all’Occidente i paesi africani di nuova indipendenza; altrimenti detto, per impedire che questi riconoscessero la DDR. Nella
politica di contenimento del comunismo in Africa, condivisa dall’intero
blocco occidentale, si inseriva infatti una speciale variante tedesca, che prima di qualsiasi altro regime comunista al mondo doveva combattere quello
che si trovava entro i suoi confini16.
Anche le direttive per l’assegnazione degli aiuti ai singoli Stati furono
oggetto di trattazione durante la conferenza, in quanto avrebbero dovuto
essere funzionali alle necessità che l’applicazione della Dottrina Hallstein
avrebbe di volta in volta suggerito:
Le misure di assistenza devono essere realizzate in modo elastico, prendendo in considerazione aspetti psicologici e adattandosi alle condizioni del momento. […] Una
certa determinazione delle priorità regionali, anche se non rigida e da verificare costantemente alla luce delle evoluzioni, è perciò necessaria. I criteri a questo proposito
sono: a) i particolari rapporti economici e culturali dei paesi in via di sviluppo con
la Repubblica federale; b) la loro importanza politica, economica e culturale in una
particolare regione e nel mondo; c) la minaccia [che tali paesi subiscono] attraverso
l’offensiva economica del blocco orientale; d) l’assistenza da parte di altri Stati del
blocco occidentale17.
Le regole stabilite alla nascita della Dottrina, in occasione della Conferenza degli ambasciatori del dicembre 1955, restavano quindi valide anche
per i paesi africani d’imminente indipendenza: la generosità della Repubblica federale nei loro confronti sarebbe dipesa dal loro atteggiamento verso il blocco comunista e, in particolare, verso la DDR e dalla loro capacità
di influenzare paesi vicini o affini nelle loro rispettive decisioni in proposito. Che tali decisioni fossero cruciali per il destino della nazione tedesca,
era fuori discussione:
La particolare importanza [della politica di cooperazione allo sviluppo] sta per noi nel
fatto che i nostri interessi politici peculiari, come la riunificazione e il non riconoscimento della DDR, dipendono da essa18.
Tanto maggiori erano dunque i rischi che i nuovi stati, appena guadagnata la sovranità in politica estera e desiderosi di distanziarsi dalle potenze
coloniali, riconoscessero la DDR, tanto più duro sarebbe stato il conflitto
fra i due Stati tedeschi in questa parte del mondo, e tanto più intenso
247
Francesca Zilio
l’impegno del Governo federale per guadagnarsi, attraverso gli aiuti economici, degli alleati importanti sulla strada della riunificazione. La politica
estera verso l’Africa diventava così una semplice proiezione verso l’esterno
della Deutschland-Politik, inserita nel quadro globale della concorrenza
fra Est e Ovest19.
Ne è un ulteriore dimostrazione il fatto che il Governo di Bonn approfittasse del primo contatto ufficiale con i neonati paesi africani – il
telegramma che comunicava agli esecutivi appena istituiti l’avvenuto riconoscimento dello Stato – per chiarire l’ obiettivo principale che perseguiva
attraverso tale riconoscimento:
Il Governo federale, quale rappresentante liberamente eletto e legittimo del Popolo
tedesco, ha intenzione di stabilire relazioni diplomatiche con […]20.
L’Alleinvertretungsanspruch era così posto immediatamente come conditio sine qua non per stringere contatti ufficiali con la Repubblica federale.
Considerata l’inesperienza in campo internazionale della maggior parte
dei governanti africani, quella che avrebbe potuto sembrare una semplice
formula di rito diveniva dunque un precedente cui la diplomazia tedesca
avrebbe potuto appellarsi nel caso in cui un Governo avesse dimostrato di
condividere la «teoria dei due Stati». La grande tempestività con cui Bonn
riconobbe i nuovi stati africani, a volte aprendo proprie missioni diplomatiche precedentemente alla data ufficiale dell’indipendenza o invitando
in Germania già prima della loro elezione o nomina i futuri capi di Stato
e di Governo21, si giustificava quindi con la necessità di sottrarli immediatamente, addirittura prima che acquisissero sovranità in politica estera,
all’influenza orientale. Ogni Stato da cui si otteneva il riconoscimento prima che potesse entrare in contatto con l’avversario era una preda sottratta
alla DDR. Ottenuto tale risultato, gli aiuti allo sviluppo sarebbero serviti a
mantenere l’ambita preda sulla retta via22.
La vantaggiosa mancanza di un recente passato coloniale
La semplice attestazione dell’importanza della cooperazione allo sviluppo con l’Africa per la risoluzione della questione tedesca non bastava,
nel concreto, a renderla uno strumento efficace al raggiungimento di tale
obiettivo, poiché
248
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
con il solo libretto degli assegni non ci si fa nessun amico e il comunismo non si lascia
comprare23.
Solo un sottile ma poderoso impegno diplomatico poteva infatti riuscire nella difficile impresa di ottenere, attraverso degli aiuti economici, che
popolazioni e governi impegnati strenuamente a liberarsi dallo sfruttamento occidentale e ad assumere un proprio ruolo nelle relazioni internazionali
sostenessero la lotta di un Paese strettamente alleato ai loro dominatori per
bandire dalla comunità internazionale un altro Stato, che si dimostrava
peraltro molto generoso nei loro confronti.
La Germania orientale e i suoi paesi «fratelli» si trovavano invece in
una situazione molto più favorevole poiché, essendo privi di ogni passato
coloniale e strenui oppositori delle potenze occidentali, si offrivano come
possibili nuovi alleati disinteressati e più vicini alla cultura e alle aspirazioni africane. Essi non avevano perciò mancato l’occasione di ergersi a paladini dei movimenti anti-razzisti e anti-imperialisti e di offrire poi il proprio
sostegno economico ai paesi che, una volta ottenuta l’indipendenza, volevano sottrarsi radicalmente alla tutela, ma quindi anche ai finanziamenti,
della ex madrepatria (ad esempio la Guinea nei confronti della Francia
nel 1958). Esistevano inoltre elementi del sistema politico ed economico
dell’Unione Sovietica e dei suoi satelliti (partito unico, organizzazioni di
massa, economia pianificata) che, in seguito ai fallimenti dei sistemi democratici importati dai colonizzatori, potevano sembrare ai nuovi governanti
particolarmente attraenti. Ancora, l’Unione Sovietica e la Cina, in quanto
paesi agricoli arretrati che si erano trasformati o si stavano trasformando in
moderni Stati industriali senza l’intervento di capitali stranieri, offrivano
insieme ai finanziamenti un modello di successo da seguire24.
In un tale contesto, l’unico punto di forza che la Repubblica federale
poteva far valere per sottrarsi alle critiche portate all’Occidente e usufruire
al contempo di alcuni vantaggi competitivi ostentati dal blocco orientale
era quello di presentarsi anch’essa come estranea al colonialismo e quindi
a qualsiasi politica di potenza in Africa. Non si trattava di un’estraneità
assoluta, ma senza dubbio Bonn era molto meno compromessa di altri
suoi alleati occidentali. L’esperienza coloniale tedesca in Togo, Cameroun,
Africa del Sud-ovest, Tanganica e Ruanda-Urundi era infatti durata solo
trent’anni (1884-1914) e si era definitivamente conclusa con la sconfitta
nella I Guerra mondiale, all’indomani della quale la Società delle Nazioni
249
Francesca Zilio
aveva assegnato gli ex possedimenti tedeschi a diverse potenze mandatarie25.
Il segretario di Stato Van Scharpenberg affermava pertanto:
Il fatto che non siamo più una potenza coloniale è oggi un vantaggio fondamentale
nelle nostre relazioni con gli Stati africani già sovrani o che sollecitano l’indipendenza26.
Nelle relazioni con un continente quasi interamente colonizzato, che
stava facendo della lotta contro la dominazione straniera il proprio obiettivo primario e la propria ragione di unità, l’importanza di tale caratteristica
risultava lampante e divenne di conseguenza la parola d’ordine con cui la
diplomazia tedesca cercava di difendere le proprie posizioni.
A questa si aggiungeva un’altra peculiarità, che avrebbe dovuto facilitare la comprensione reciproca fra gli stati africani e la Repubblica federale,
facendo sì che essa fosse percepita come un partner particolarmente sensibile alle istanze africane rispetto al resto del blocco occidentale: anche
la Repubblica federale aveva sofferto di recente le dure esperienze della
distruzione della guerra, della crisi economica, dell’occupazione straniera,
dell’imposizione di confini artificiali e anch’essa faticava a superarle. Non
poteva perciò non appoggiare fortemente i principi dell’integrità territoriale e dell’autodeterminazione dei popoli, dell’obbligo di non ingerenza
nelle questioni interne africane, del diritto dei paesi africani a praticare una
politica estera e di sviluppo indipendente da entrambi i blocchi. Basandosi
sul principio della reciprocità, pretendeva però che gli Stati africani sostenessero a loro volta le corrispondenti rivendicazioni tedesche:
La cooperazione allo sviluppo assume un particolare accento politico attraverso lo
strisciante conflitto fra Est e Ovest, poiché essa è intenzionalmente impiegata da parte
comunista come mezzo di combattimento. È perciò diventata un fattore fondamentale
nella lotta per il futuro dei giovani popoli ambiziosi, che non hanno intenzione di
barattare la loro indipendenza, spesso conquistata appena di recente, con un nuovo
status coloniale di stampo comunista. Questo è il punto in cui i nostri particolari
obiettivi politici tedeschi vengono più fortemente a contatto con quelli dei paesi in
via di sviluppo. Così come questi paesi hanno rivendicato e ottenuto l’autodeterminazione e ora non vogliono vederla esposta ad una nuova minaccia, anche la Germania
divisa e sottoposta nella sua zona sovietica ad uno status coloniale vuole l’autodeterminazione politica. Poiché il contrasto con l’Oriente comunista è universale, gli aiuti allo
sviluppo che forniamo tornano anche a vantaggio di questo nostro speciale interesse
tedesco, in quanto attraverso la stabilizzazione dei paesi in via di sviluppo si migliorano
anche le prospettive che un giorno l’Est riconosca i limiti delle sue possibilità. Possa
250
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
allora non essere lontano il giorno in cui anche alla Germania non possa più essere
negata l’autodeterminazione27.
Il supporto alle rivendicazioni africane si traduceva quindi nella pretesa
di un’approvazione da parte africana delle analoghe esigenze tedesche: la
persistenza della sovranità del Governo federale su tutti i territori facenti
parte dei confini del 1937; il diritto del popolo tedesco alla «unità nella
libertà», cioè a determinare attraverso libere elezioni il proprio sistema di
governo; il fatto che i contatti con la DDR fossero interpretati a Ovest
come un’illegittima ingerenza negli affari interni tedeschi, atta ad approfondire la divisione della Germania.
Se il sostegno degli Stati africani nella «questione tedesca» era importante, soprattutto perché significava averli sottratti all’influenza comunista, il destino della nazione tedesca restava però comunque nelle mani delle
quattro potenze vincitrici, due delle quali erano le maggiori potenze coloniali mondiali. La diplomazia federale si trovò perciò costretta ad assumere
una posizione che cercasse di accontentare i nuovi alleati africani senza
scontentare quelli occidentali:
In quanto alleati delle potenze coloniali Gran Bretagna, Francia, Belgio e Portogallo
dobbiamo tenere conto dei loro legittimi interessi africani e non possiamo lasciarci
contrapporre a loro dagli Africani. D’altra parte dobbiamo avere riguardo anche delle
altrettanto legittime aspirazioni dei paesi africani che ci dimostrano la loro fiducia.
In questo conflitto d’interessi non possiamo dichiararci semplicemente neutrali, ma
dovremmo anche sforzarci di impiegare il nostro capitale di fiducia verso entrambe le
parti. Altrimenti corriamo il rischio di incorrere in entrambi i campi nella reputazione
di machiavellismo e di inaffidabilità28.
Nella definizione dei propri rapporti con i singoli Stati africani, Bonn
non poteva dunque prescindere dalle relazioni che questi continuavano ad
intrattenere con la loro ex madrepatria o che essa continuava a rivendicare:
La nostra politica per l’Africa è naturalmente influenzata dal conflitto Est-Ovest. […]
La Repubblica federale di Germania dovrebbe avere riguardo per i suoi alleati con
possedimenti coloniali, mentre i sovietici cercano di presentare agli africani il regime
di Pankow come la Germania migliore. La nostra politica in Africa dovrebbe pertanto
concentrarsi innanzitutto su tre compiti:
1. Rafforzare la posizione globale dell’Occidente;
2. Prevenire le infiltrazioni orientali;
3. Impedire il riconoscimento di Pankow29.
251
Francesca Zilio
In tale contesto giocavano inevitabilmente un ruolo determinante le
diverse posizioni che Francia e Regno Unito assunsero nei confronti del
fenomeno della decolonizzazione. La maggiore o minore disponibilità delle singole potenze coloniali a concedere la formale indipendenza ai propri
possedimenti e a permettere un loro più o meno autonomo ingresso nella
comunità internazionale determinava infatti il margine di intervento che
il Governo federale poteva permettersi in tali paesi, ma anche il margine
di rischio che essi, se lasciati liberi di condurre una politica estera quasi
autonoma, potessero avvicinarsi indebitamente alla DDR. Ciò contribuisce a spiegare la diversità delle azioni e dei risultati tedeschi nei confronti
delle ex colonie passate sotto mandati differenti, come dimostrano i casi
emblematici del Togo francese e del Tanganica inglese.
Il Togo: la colonia modello tedesca diventata riserva di caccia francese
Rispetto ai suoi alleati occidentali, la Repubblica federale godeva non
solo del vantaggio di avere un passato coloniale molto circoscritto e non
recente, ma anche di aver lasciato un ricordo non troppo negativo nelle sue
ex colonie. Alcune di esse vedevano anzi nella Germania e poi nella Repubblica federale un alleato fondamentale sulla via dell’indipendenza e l’unica
speranza di sopravvivenza in seguito alla decolonizzazione e si appellarono
pubblicamente al suo sostegno, divenendo così i punti di riferimento della
penetrazione e dell’espansione di Bonn africa, come chiaramente illustrato
dal Cancelliere Brandt nella sua prefazione al primo numero della rivista
«Internationales Afrikaforum»:
La breve epoca coloniale tedesca fortunatamente non si è lasciata dietro conseguenze
dannose, con alcuni paesi africani ha prodotto anzi legami particolarmente stretti.
[…] Gli Africani sanno valutare che noi cooperiamo con loro senza porre condizioni
politiche. Noi capiamo che essi vogliono organizzare il loro ordinamento interno sulla
base delle loro particolarità africane. Capiamo anche il loro desiderio di perseguire una
politica estera indipendente, senza farsi trascinare nei conflitti delle grandi potenze.
Ci aspettiamo però altrettanta comprensione per la questione esistenziale del popolo
tedesco - l’unità nella libertà. Un comportamento che crei degli ostacoli alla riunificazione tedesca dovrebbe essere considerato un’ingerenza nei nostri affari interni e
giudicato dall’opinione pubblica tedesca, dai partiti politici e dal Governo come un
atto non amichevole. Siamo grati agli Stati africani per aver continuato a dimostrare
comprensione per i nostri obiettivi e interessi fondamentali e averci sostenuto attivamente in molte occasioni30.
252
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
L’esempio sicuramente più significativo di tale sostegno è quello
del Togo, l’antica «colonia modello» tedesca, in cui nacque nel 1924 il
«Deutsche-Togo Bund», noto come «patto tedesco-togolese» o «alleanza
tedesco-togolese». Si trattava di un movimento patriottico che proponeva
che il territorio togolese, diviso fra francesi e inglesi, fosse riunito in un
mandato assegnato alla Repubblica federale, che lo avrebbe così accompagnato sulla via dell’indipendenza31. Com’è facilmente immaginabile, il
patto dovette subire le persecuzioni inglesi e francesi e, sopravvissuto in
clandestinità, riprese le proprie attività nel 1945. Nel 1951 una sua delegazione intraprese un lungo viaggio di rappresentanza, nel corso del quale
fu ricevuta dal Cancelliere Adenauer e dal ministro degli Esteri. Il Bund
avrebbe poi ispirato il «Comité de l’Unité Togolaise» e la politica di Sylvanus Olympio, eletto presidente della neonata repubblica alla testa del
comitato stesso, e sarebbe rimasto attivo fino al 1974.
Considerando che esso fu creato appena 5 anni dopo la sconfitta che
privò la Germania di tutte le sue colonie, è legittimo chiedersi quali ragioni abbiano spinto la popolazione coloniale ad avere così tanta fiducia
nei suoi ex dominatori da richiamarli in proprio aiuto e da mantenere tale
convinzione per ben 50 anni. All’indomani di entrambe le guerre mondiali, sicuramente contava anche il fatto che la Germania fosse un Paese
sconfitto e distrutto e che i Togolesi si augurassero quindi che una potenza più debole della Francia e del Regno Unito avrebbe loro concesso più
facilmente l’indipendenza. Têtêvi Godwin, storico togolese e funzionario
delle Nazioni Unite, afferma invece soltanto che «un tale prestigio non si
spiega che attraverso il confronto fra la prassi coloniale tedesca ed altre
prassi coloniali»32.
Tale interpretazione parve confermata dalle celebrazioni per l’avvenuta
indipendenza, in occasione delle quali l’affetto, la gratitudine e la fiducia
della popolazione e del Governo togolesi stupirono i tedeschi intervenuti.
Ospite d’onore della cerimonia organizzata nella sua antica residenza fu
l’ultimo governatore militare del Togo, l’ottantasettenne duca Adolf Friedrich zu Mecklenburg. Il quotidiano «Die Welt» descrisse così l’accoglienza riservatagli:
Gli indigeni venuti da lontano si sono radunati e hanno accolto il duca con applausi
e un’esultanza entusiastica. Il duca è arrivato a Lomè con un ritardo di dodici ore.
Ciononostante, più di cento dignitari della Repubblica del Togo hanno resistito all’ae253
Francesca Zilio
roporto per accoglierlo. Quando il duca ha salutato coloro che lo attendevano nella
loro lingua, l’entusiasmo è esploso33.
I politici non furono da meno:
Il Dottor Olympio, cugino del Primo Ministro, dà a nome dell’associazione culturale
tedesco-togolese il benvenuto al primo ministro tedesco che mai sia stato in Togo e
agli altri ospiti tedeschi. Ma prima che lo faccia […] risuona nell’antica colonia la terza
strofa dell’inno nazionale tedesco: «unità e diritto e libertà». […] Egli conclude con le
parole: «I nostri cuori battono di gratitudine e amore per il Popolo tedesco.» Tutto ciò
cinque ore prima della proclamazione dell’indipendenza34.
Aggiunse un giornalista:
Nella pubblicazione commemorativa ufficiale che il Governo togolese ha pubblicato
per il giorno dell’indipendenza si trovano le immagini di sei uomini particolarmente
benemeriti per lo sviluppo del Paese; cinque di essi portano un nome tedesco. Il forte
accento che il Governo del giovane Stato ha posto sul contributo tedesco alla sua storia
non era certamente inteso solo come un atto di obiettività storica. Esso rappresenta
evidentemente allo stesso tempo un appello a dimostrare la nostra prontezza all’aiuto
anche nella nuova epoca del Togo35.
La presa di posizione ufficiale del giovane Governo sulla questione tedesca fu un’ulteriore dimostrazione della fedeltà togolese agli ex colonizzatori:
Ad un pranzo che il ministro Schwarz diede in onore di eminenti politici togolesi, fra
cui quattro ministri, si alzò in piedi il presidente del Parlamento. Egli porse in un ottimo tedesco i migliori auguri del suo Paese per la nostra riunificazione. Il suo motto:
«Il primo amore non si scorda mai36.
Al di là della retorica, il Governo togolese dimostrò la sua grande stima
verso la Repubblica federale anche nelle questioni più concrete ed essenziali
per la gestione e lo sviluppo del Paese. Il presidente Sylvanus Olympio, ad
esempio, chiese ad un tedesco, il professor von Mann, di analizzare i progetti di trattato che la Francia gli aveva sottoposto per mantenere il Paese
ancora legato a sé dopo l’indipendenza e di modificarli nel segno della parità di diritti37. Ancora, a proposito della totale mancanza di dati e progetti
in molti campi fondamentali - dall’istruzione, alla formazione dei quadri,
254
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
alle strategie di sviluppo – e della conseguente necessità per il suo Paese
di un «master plan» in campo economico e sociale, il presidente affermò:
«Avete il pieno potere di farlo. Avrei piacere che lo facessero i Tedeschi»38.
Offrire ai propri ex colonizzatori un compito a tal punto suscettibile di
estendere la loro influenza in ogni angolo del Paese era senza dubbio indice
della situazione disperata in cui si trovava l’esecutivo togolese (come quelli
degli altri paesi africani all’indomani dell’indipendenza), ma anche della
fiducia che esso aveva nel fatto che i tedeschi avrebbero saputo trattenersi
più di altri da tentazioni neocolonizzatrici.
Oltre a tale benevolenza, il Paese presentava condizioni economiche
migliori rispetto a molti vicini e quindi opportunità d’investimento più
vantaggiose, nonché una posizione geopolitica significativa, anche in
considerazione del suo desiderio di costruire una comunità economica
dell’Africa occidentale con Mali e Nigeria, che avrebbe attirato altri Stati
dalla parte dell’Occidente e di Bonn e costituito un importante fattore
stabilizzante in una regione in cui si temeva particolarmente l’influenza
estremista di Ghana e Guinea.
Tutto ciò rendeva particolarmente allettante un poderoso impegno in
Togo e i giornali non mancarono di sottolinearlo:
Non è un capitale perso ciò che viene investito nell’una o nell’altra forma in Togo. Chi
tende la mano, nello spirito di una collaborazione disinteressata [sic!], al più giovane
Paese di questo continente che lotta con impetuosa energia per le sue nuove forme
di vita politiche, sociali ed economiche, può essere sicuro di conquistarsi un alleato
di ragguardevole rilievo morale su tutta l’immensa scena africana. In questa disputa,
la Germania occidentale – che ancora oggi è considerata dal Togo il solo successore
dell’antico impero tedesco – ha migliori chances rispetto ad altri Stati del mondo libero. La fiducia che ci è dimostrata in Togo è un capitale che altrimenti non ci è messo
a disposizione in nessun’altra parte del mondo. Se lo lasciamo inutilizzato, ne approfitteranno altri e si presenteranno come i legittimi successori. Al di là della cortina di
ferro attendono impazientemente in agguato […]39.
Oltre alla stampa e al grande pubblico, evidentemente anche alla diplomazia non sfuggiva il potenziale racchiuso nelle relazioni con il Togo.
Basti citare le parole dell’ambasciatore Torok in una lettera diretta a Bonn
per accompagnare l’invio della relazione di un ricercatore tedesco sul suo
viaggio in Africa occidentale, in cui questi era arrivato a scrivere:
255
Francesca Zilio
Abbiamo per tre settimane il diritto di prelazione [sic!] su questo Paese e poi mai
più!40
L’ambasciatore, dopo aver fatto presente che l’autore dello scritto era
giovane e inesperto, non contestò le sue affermazioni, ma si limitò ad aggiungere:
La relazione non fornisce nessun elemento nuovo, dà tuttavia l’occasione di richiamare nuovamente e urgentemente l’attenzione sulla necessità di inviare esperti tedeschi.
Quanto più è rimandato l’arrivo di questi tecnici, tanto più a lungo permane un vuoto
che all’occorrenza può essere riempito dall’Est41.
Naturalmente l’importanza delle ex colonie, in particolare Togo e Cameroun, nell’ottica delle relazioni con l’intero continente africano era già
stata evidenziata nel corso della citata conferenza di Addis Abeba42. In tale
occasione, si sottolineò, al di là della propaganda, anche la necessità di
provvedimenti concreti in campo agricolo ed industriale, che incidessero
profondamente sul progresso dei due paesi. Un contributo determinante allo sviluppo dei suoi alleati sarebbe infatti stato il migliore biglietto
da visita con cui la Repubblica federale poteva presentarsi agli altri stati
africani: la fama di un Paese ricco e affidabile, che pretendeva peraltro
dai partner altrettanta affidabilità a sostegno delle proprie rivendicazioni
nazionali. L’importanza della cooperazione con le sue ex colonie, sarebbe
stata riaffermata alcuni mesi dopo in termini ancora più chiari:
Il conflitto fra Est e Ovest rende necessario che ogni Paese occidentale curi specialmente i rapporti con quei paesi di colore con cui è legato da amicizia. Ciò vale nel nostro
caso per il Cameroun e il Togo, dove finora permangono grandi simpatie per noi43.
Fra i suoi antichi possedimenti, Togo e Cameroun erano dunque quelli con cui la Repubblica federale aveva mantenuto legami più stretti, ma
anche quelli che erano passati nelle mani della madrepatria più gelosa delle proprie colonie: la Francia. I suoi obiettivi vitali di politica estera imponevano dunque a Bonn di ingerirsi nella cosiddetta «riserva di caccia»
francese, ma al tempo stesso di astenersi da qualsiasi azione che avrebbe
potuto compromettere il riavvicinamento al proprio nemico storico, assolutamente necessario nell’ottica di una riunificazione possibile solo attraverso l’approvazione delle ex potenze occupanti. Un compromesso che
256
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
si sarebbe rivelato impossibile sia a livello bilaterale - in quanto i francesi,
attraverso il Trattato dell’Eliseo, avevano obbligato i tedeschi ad informarli
di tutte le loro attività nell’Africa francofona – sia nell’ambito della Comunità europea, in cui la cooperazione allo sviluppo, nota come politica
d’associazione, era controllata in modo ferreo da Parigi.
A questo proposito, sarà sufficiente sottolineare che la cooperazione
in favore dei paesi e territori d’oltremare associati alla CEE fu posta dalla
Francia come conditio sine qua non della sua adesione ai Trattati di Roma, che i meccanismi del Fondo europeo di sviluppo (FES-FED) furono
ripresi direttamente dal Fides, il «Fondo d’investimento per lo sviluppo
economico e sociale» attraverso il quale Parigi finanziava le proprie colonie e che la sua gestione fu affidata a Jacques Ferrandi, uno dei maggiori
architetti del Fides nell’Africa occidentale francese, mentre il Commissario
responsabile del settore era Robert Lemaignen, ex presidente della Società
commerciale dei porti africani, ex amministratore dell’Istituto di emissione
dell’Africa occidentale francese e del Togo e presidente onorario del comitato dell’Africa francese della Camera di commercio internazionale44 In
cambio del proprio consenso alla politica d’associazione e dell’ingente contributo al FES (inizialmente pari a quello francese), la Germania ottenne
che la Direzione generale Sviluppo fosse diretta da Helmut Allardt, subito
allontanato per aver criticato il lato un po’ troppo africano della politica di
sviluppo comunitaria e sostituito da Heinrich Hendus, più gradito al ministero degli Esteri francese anche per aver promosso una riorganizzazione
amministrativa che permise a Ferrandi di diventare l’unico responsabile
del FES, gestore di un enorme potere discrezionale nella scelta dei progetti da presentare per l’approvazione al Comitato del FES, e di affermare:
«La DG8 c’était le FED et le FED c’était moi»45. Non contento della sua
influenza grazie ai vari rappresentanti francesi, il governo De Gaulle intervenì peraltro direttamente nella cooperazione comunitaria, arrivando fino
a porre il proprio veto su tutti i progetti che non prevedessero controllori
tecnici francesi e a prevedere il richiamo di Ferrandi - come se fosse stato un
ambasciatore anziché un funzionario comunitario unicamente dipendente
dalla Commissione – quando questi si oppose a un progetto appoggiato da
Parigi, ottenendo poi di far riunire il Comitato del FES per l’approvazione
mentre costui era in ferie.
Ancora, approfittò del fatto che durante i negoziati sul Trattato di Roma
i membri si fossero accordati per dare immediatamente inizio ai finanzia257
Francesca Zilio
menti ai paesi associati attraverso il FES, ma di sviluppare invece progressivamente, senza un termine perentorio, l’apertura dei mercati d’oltremare
e l’elaborazione di una legislazione che garantisse parità di trattamento a
tutti i paesi membri. Prima ancora dell’indipendenza, il Governo francese
stipulò infatti con i singoli paesi africani dei trattati, i cosiddetti «accordi di
cooperazione», che le riservavano particolari diritti in settori fondamentali
come l’economia, la politica interna e la politica estera. Il caso del Togo
ne fu un esempio lampante. Lo scambio di lettere avvenuto il 28 maggio
1960 fra i due governi prevedeva che la Francia rappresentasse gli interessi
togolesi in tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali presso cui il
Togo non aveva una rappresentanza autonoma, che assistesse il Togo nella
costruzione del suo esercito e che nel frattempo le forze armate francesi
ne difendessero i confini46. Come si è visto, il presidente Olympio chiese
ad un esperto tedesco, il professor von Mann, di analizzare le bozze e di
modificarle affinché i trattati finali prevedessero una parità di diritti. Per
quanto riguardava le disposizioni economiche, Von Mann si pronunciò
molto chiaramente:
Di questi trattati c’è da dire che, se il Togo li firmasse nella forma proposta dalla Francia, si troverebbe in una situazione ancora più svantaggiosa di quella precedente l’indipendenza. A titolo di esempio, si noti che secondo l’articolo 18 del Trattato economico
tutti i prodotti francesi potrebbero essere introdotti nel Togo in esenzione da dazio, ciò
che finora non era previsto. Significativo di questa stesura di contratto è inoltre il fatto
che esso fissa esplicitamente il diritto del Togo a concludere trattati commerciali, doganali e finanziari con Stati terzi e non lo prevede come per uno Stato indipendente. Se il
Togo volesse contrarre un prestito straniero, sarebbero necessarie precedenti consultazioni con la Francia. Anche accordi aerei e navali dovrebbero essere sottoposti all’esame
francese. Il Togo dovrebbe concedere alla Francia privilegi nel settore del commercio
e delle tariffe così come nell’organizzazione del mercato. Donazioni straniere non potrebbero essere accettate senza precedenti consultazioni con la Francia47.
L’accordo successivamente stipulato prevedeva che il Togo dovesse acquistare annualmente dalla Francia prodotti per un valore di 2 miliardi e
445 milioni di franchi CFA, corrispondente a circa il 37 per cento delle sue
importazioni totali48. Obblighi ancora più pesanti erano stati imposti da
un analogo accordo di cooperazione al Cameroun, il quale nel 1961 esportava in Francia il 59 per cento dei propri prodotti e doveva acquistarvi il
55 per cento delle sue importazioni49. Simili dati si ritrovano in documenti
258
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
d’archivio tedeschi riguardanti Costa d’Avorio, Gabon, Mali e altre colonie
francesi, evidentemente seguiti dal commento che tali prassi contrastavano
sia con la lettera che con lo spirito del Trattato CEE50.
Accanto alle discriminazioni «ufficiali», costituite dalla legislazione in
vigore e dagli accordi di cooperazione, la diffusa presenza di organismi e
personale francese nelle ex colonie anche dopo l’indipendenza permise a
Parigi di limitare quanto più possibile l’intervento degli altri paesi membri
in quelli che considerava ancora i propri domini attraverso azioni di lobbying che miravano a discriminare pesantemente le imprese straniere, in
particolare quelle tedesche:
Si moltiplicano i reclami degli esportatori tedeschi per l’uso restrittivo della distribuzione di valuta per importazioni dalla Repubblica federale. Si è ripetutamente verificato che, quando in uno Stato dell’Unione africana e malgascia51 un importatore ha
richiesto una licenza d’importazione per prodotti tedeschi, gli è stato innanzitutto
comunicato dai locali uffici di cambio che avrebbe potuto ugualmente ordinare merci
equivalenti dalla Francia. In seguito rappresentanti di imprese francesi, che erano stati
informati dalla Camera di commercio della sua intenzione di ordinare prodotti tedeschi, gli hanno fatto visita e l’hanno espressamente pregato di annullare il suo ordine.
Solo nei casi in cui l’importatore, nonostante la pressione fattagli, ha persistito nel
voler ordinare prodotti tedeschi, gli è stata concessa una licenza d’importazione. A
questo proposito, si deve inoltre notare che la compilazione di numerosi e complicati
formulari scoraggia molti commercianti dall’ordinare altri prodotti rispetto a quelli
francesi, che possono essere importati senza complesse formalità. Si dovrebbe pertanto
aspirare a che la distribuzione di valuta per importazioni dai paesi CEE possa avvenire
nell’ammontare necessario e soprattutto senza una procedura amministrativa troppo
onerosa52.
Nonostante le speranze tedesche, la situazione non sarebbe migliorata
neanche un decennio dopo la stipulazione dei Trattati di Roma: alla fine
del 1969 e a parità di contribuzioni al FES, i partecipanti alle gare d’appalto erano per il 52,34 per cento francesi, per il 2,03 per cento tedeschi.
I vincitori delle gare d’appalto erano per il 55,32 per cento francesi e per l’
1,07 per cento tedeschi53. Anche gli scambi commerciali fra la Repubblica
federale e i paesi associati erano molto ridotti in proporzione al contributo
tedesco al FES. Dal 1958 al 1967 le importazioni tedesche aumentarono
da 76 a 207 milioni di dollari, le esportazioni da 51 a 123. La Francia,
che partecipava al FES in egual misura, importava nel 1958 beni per 618
milioni di dollari, passati nel 1967 a 793 e nello stesso periodo quasi rad259
Francesca Zilio
doppiò le sue esportazioni (da 501 a 929 milioni)54.
A livello bilaterale, la cooperazione franco-tedesca nel settore degli aiuti
allo sviluppo era cominciata dal momento in cui la Germania aveva iniziato ad impegnarsi attivamente nel settore e aveva accettato di contribuire
al FES con una somma equivalente a quella francese, diventando così un
interlocutore fondamentale per Parigi, che necessitava del suo contributo
per ridurre il proprio impegno economico in Africa e della sua acquiescenza per evitare che questo contrastasse gli interessi francesi.
Parigi non avrebbe tardato a chiarire la sua interpretazione di tale cooperazione:
Alla domanda esplicita del deputato Scheel, se una partecipazione economica della
Repubblica federale nell’Africa francofona significasse un diritto ad essere consultati,
rispose l’ex senatore Leon Hamion: Voi Tedeschi potete certo essere i padroni dei vostri
soldi, ma mai del nostro destino politico55.
Il Trattato dell’Eliseo, firmato a Parigi il 22 gennaio 1963, prevedeva
una stretta cooperazione nei settori delle relazioni internazionali, della difesa, dell’educazione e delle politiche giovanili. La cooperazione si sarebbe
realizzata attraverso periodici incontri dei capi di stato e di Governo e dei
ministri delle materie interessate, nonché attraverso una perenne collaborazione fra i ministeri e le rispettive missioni diplomatiche. La caratteristica principale del Trattato era rappresentata dal cosiddetto obbligo di consultazione qualificato, cioè dal fatto che entrambi i governi si impegnassero
non solo a consultarsi prima di ogni decisione su questioni di interesse
comune e, in particolare, di politica estera, ma anche a cercare di pervenire
ad una posizione comune56.
In considerazione dei particolari interessi o, nelle parole del ministro
francese Triboulet, del «ruolo speciale» della Francia in molti paesi africani,
evidentemente riconosciuto anche da Bonn, nel concreto il Trattato avrebbe finito per trasformarsi in un meccanismo istituzionalizzato di controllo
francese su ogni aspetto della cooperazione tedesca nelle sue ex colonie.
Già in occasione del primo incontro con il suo omologo Scheel il 21 marzo
1963, Triboulet affermò infatti che gli aiuti allo sviluppo della Repubblica
federale a favore degli stati africani avrebbero dovuto essere «precedentemente concertati con la Francia» e che tutti gli investimenti tedeschi
avrebbero dovuto essere «intrapresi nel quadro della presente pianificazio260
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
ne»57. Scheel rispose che «la Repubblica federale non [voleva] diventare un
concorrente della Francia in questi paesi per indebolire la posizione della
Francia. […] La Repubblica federale non [voleva] disturbare le buone relazioni della Francia con i paesi africani, ma aiutare ad accelerare il processo
di decolonizzazione»58.
Anche gli aiuti bilaterali agli ex possedimenti francesi facevano quindi
parte della chasse gardée che Parigi aveva già rivendicato a livello comunitario. Nel quadro di un tale rapporto di sottomissione di tutte le decisioni
tedesche alle priorità francesi, come poteva la Repubblica federale presentarsi agli Stati africani in qualità di alternativa ai loro precedenti dominatori? Ancora una volta è significativo illustrare la situazione del Togo. Il
Governo di questo Paese riteneva di estrema importanza la costruzione
di un porto nella capitale Lomè e ne aveva più volte fatto richiesta alla
Francia. Nel 1960 Parigi aveva deciso di rifiutare la domanda togolese e
di finanziare invece la costruzione di un porto nel Dahomey, come premio per il fatto che quest’ultimo, al contrario del Togo, non aveva ancora
rivendicato l’indipendenza. Olympio si rivolse immediatamente a Bonn,
che si assunse la responsabilità del progetto solo dopo aver ottenuto il benestare della Francia, in questo caso interessata ad alleggerirsi da un impegno finanziario notevole59. Questa pretese comunque di essere informata
dettagliatamente sull’evolversi della pianificazione e delle relazioni con il
Governo togolese. Nel marzo 1963, a seguito di uno dei periodici incontri
fra Scheel e Triboulet, il capo di gabinetto del ministro francese elencò
al responsabile economico dell’ambasciata tedesca a Parigi i casi in cui il
ministero non si sentiva sufficientemente al corrente delle attività tedesche: uno di questi era il porto di Lomè60. L’ambasciata parigina ne diede
comunicazione alla missione di Lomè, che rispose affermando che si era
già consultata con l’ambasciata francese in loco e che comunque avrebbe
mandato un’altra istruzione circolare (Runderlaß) a tutte le altre ambasciate tedesche nei paesi africani francofoni per raccomandare loro ancora una
volta di informare i colleghi francesi di tutti i progetti che si intendevano
intraprendere nel Paese61.
Un altro progetto sul quale il ministero francese per la cooperazione
richiedeva più notizie riguardava la costruzione di un istituto tecnico a
Sokode, sempre in Togo. In questo caso si ebbe una dimostrazione evidentissima dei rapporti fra i due alleati, ovvero della vera e propria maniacalità
francese nella preservazione della sua riserva di caccia e della totale sotto261
Francesca Zilio
missione tedesca: Scheel non si scompose quando Triboulet al successivo
incontro lo pregò, riguardo agli aiuti tecnici che la Germania forniva per la
costruzione della scuola, «di prendere contatto con il tecnico francese che
aveva compilato il progetto generale»!62 Nel Paese dell’Africa francofona in
cui la Repubblica federale aveva maggiore influenza e cui concedeva maggiori aiuti,63 essa non era libera nemmeno di costruire una scuola. Risulta
poi quasi incredibile che una questione di questo genere fosse trattata a
livello ministeriale, nell’ambito di un trattato che prevedeva consultazioni
prima di ogni decisione «in tutte le questioni importanti della politica estera»64. Durante il seguente colloquio, fu nuovamente trattato il medesimo
tema dell’istituto tecnico e Scheel dovette rassicurare Triboulet di non avere intenzioni di svolgervi lezioni in tedesco. Lo rassicurò poi che nel finanziare la costruzione di una tipografia in Camerun intendeva inviare solo
personale tecnico e non redattori per la formazione di giornalisti locali,
essendo consapevole che esisteva già una scuola di giornalismo francese65.
Come si è visto, Bonn contava di poter sfruttare la sua fama di potenza non (recentemente) coloniale per conquistare all’Occidente – e alla
sua causa nella «questione tedesca» – quei paesi che, volendosi liberare
dall’influenza dell’ex madrepatria, rischiavano di rivolgersi al mondo comunista. Tuttavia, se già era difficile presentarsi come l’alternativa ad un
proprio alleato, ciò diventava pressoché impossibile nel momento in cui
ci si obbligava esplicitamente e formalmente ad agire secondo gli interessi
di quest’ultimo, fino ad impegnarsi a fornirgli una lista completa di tutti
i progetti e gli accordi stipulati con gli Stati dell’Africa subsahariana66. La
diplomazia tedesca ne era evidentemente consapevole:
L’ufficio 410 ha convocato una riunione per discutere di determinate proteste francesi
su un’attività economica tedesca troppo forte negli ex territori francesi. L’ufficio 307 si
rende conto che il nostro rapporto con la Francia deve avere priorità assoluta rispetto
alle nostre relazioni con i paesi dell’Africa subsahariana67.
La Tanzania: la colonia tedesca diventata vetrina della DDR
Si è già notato come i fondi destinati dalla Repubblica federale alla
cooperazione allo sviluppo fossero dispersi fra una miriade di destinatari,
poiché sarebbe bastato un solo riconoscimento della DDR da parte di uno
Stato importante per minare la Dottrina Hallstein e far fallire il principio
262
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
dell’Alleinvertretungsanspruch su cui il Governo federale basava le sue speranze di riunificazione. Mentre la DDR poteva concentrare i propri seppur
scarsi mezzi solo su alcuni Stati ad essa ideologicamente più vicini, la Repubblica federale era pertanto costretta a distribuire i propri aiuti secondo
il cosiddetto «principio dell’annaffiatoio». Ciononostante, si rendeva necessaria la scelta di alcuni «destinatari privilegiati», sia per non rischiare di
disseminare somme minime in una miriade di paesi – rendendo gli aiuti
vani sia politicamente che economicamente – sia perché la forza economica e demografica, il peso politico dei leader, la posizione geopolitica e la
storia dei diversi paesi in via di sviluppo li rendevano singolarmente più o
meno importanti e utili alla causa tedesca:
In Africa, dopo che inizialmente abbiamo attraversato tutto il continente con l’annaffiatoio, dobbiamo in una seconda fase trattare i nostri amici e i nostri antichi protettorati meglio degli altri68.
Tali affermazioni dell’ambasciatore tedesco a Dar-es-Salaam indicano
come il Tanganica fosse fra gli interlocutori più importanti di Bonn, nonostante il ministero degli Esteri fosse consapevole che
in Tanganica [esistesse] una posizione verso l’epoca coloniale tedesca essenzialmente
più critica che, ad esempio, in Togo o in Camerun69.
D’altra parte, lo stesso ministero aveva posto quali discriminanti fondamentali per la scelta dei destinatari dei maggiori contributi tedeschi delle
caratteristiche che ben corrispondevano alle condizioni di questo Paese,
poiché riguardavano
1. I particolari rapporti politici, economici e culturali del singolo Stato con la Repubblica federale e le prospettive di ricevere da esso sostegno per la politica di riunificazione tedesca;
2. Il peso politico, economico e culturale dello Stato, considerato in una particolare
area e complessivamente nel mondo;
3. Le priorità dell’Unione sovietica nei suoi tentativi di influenzare politicamente ed
economicamente i paesi sottosviluppati;
4. La «divisione del lavoro» del mondo occidentale riguardo alle misure di sostegno ai
paesi sottosviluppati70.
Si aggiungeva inoltre che, data la limitatezza dei fondi a disposizione,
263
Francesca Zilio
gli aiuti bilaterali avrebbero dovuto essere concessi «solo nei casi in cui
ci si [potesse] aspettare come conseguenza una particolare influenza della
Repubblica federale sul Paese considerato», mentre «riguardo quegli Stati
che non [ricadevano] nelle categorie sopra elencate, la Repubblica federale [avrebbe dovuto] generalmente limitarsi a convogliare i propri aiuti
attraverso le organizzazioni internazionali esistenti o ancora da crearsi»71.
Rispetto al continente africano, si stabilivano in particolare i seguenti punti di riferimento:
Gran parte dei territori africani – in particolare il Congo, l’Africa occidentale ed equatoriale francese ed il Madagascar – è già legata agli Stati del Mercato comune in una
nuova forma di associazione economica. Anche gli Stati nordafricani del Maghreb,
Marocco e Tunisia, hanno l’opportunità di entrare in stretto rapporto con i Sei Paesi.
Altrettanto importante risulta il consolidamento delle relazioni con una serie di paesi
africani indipendenti. […] [Ciò] dovrebbe darci motivo di guadagnare influenza su
quegli Stati che non appartengono ancora ad alcuno dei sistemi regionali politici o
economici esistenti, che perciò necessitano e cercano sostegno e proprio per questo
motivo sono visti dall’Unione sovietica come un promettente campo di prova per i
propri obiettivi politici ed economici72.
Come si vede, tali considerazioni potevano prestarsi sia ad essere in
parte valide per quasi tutti i paesi africani, finendo così per ritornare alla
politica dell’annaffiatoio, sia a rivelarsi contraddittorie73.
Tuttavia esse si adattavano in modo particolare alla situazione del Tanganica, sia considerato da solo che nella successiva federazione con Zanzibar, a formare la Tanzania.
Innanzitutto, essendone stato colonia fino al 1919, il Paese aveva evidentemente particolari legami storici, politici e culturali con la Germania. Molti uomini politici e personalità di rilievo parlavano fluentemente
tedesco e alcuni avevano studiato in Germania. Ciò ne faceva un centro
d’attenzione sia per la politica che per l’opinione pubblica tedesca:
Il Tanganica era il più grande degli antichi protettorati tedeschi e per questo motivo
gode tuttora di un vivo interesse dell’opinione pubblica tedesca. Lo sviluppo politico
del Tanganica è seguito con grande attenzione. L’ambasciatore tedesco a Dar-es-Salaam
è perciò più sottoposto alle luci della ribalta dell’interesse pubblico della Repubblica
federale di altri capi missione nel continente africano74.
Così come sollecitava l’impegno dei propri diplomatici in Tanganica,
264
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
il ministero degli Esteri si impegnava quindi anche ad attirare l’attenzione
della popolazione sul proprio impegno nella ex colonia, diffondendo pubblicazioni che raccoglievano le testimonianze di coloro che oggi chiameremmo i cooperanti tedeschi:
Personalmente considero la Tanzania come un paese di fiaba. […] I contributi tedeschi per lo sviluppo tecnico del Paese sono accolti con grande gioia e riconoscenza. La
popolazione è sempre amichevole e servizievole. Spesso si incontrano ancora africani
che hanno vissuto e servito sotto l’amministrazione tedesca, parlano ancora tedesco e
si ricordano di quei tempi volentieri e con approvazione75.
Il Tanganica era stato inoltre il primo Stato dell’Africa orientale britannica a divenire indipendente. Tale maggiore maturità politica, unita al
prestigio del suo presidente – successivamente a capo anche della Tanzania – gli garantivano una certa influenza sui paesi vicini, soprattutto dal
momento in cui Nyerere si impegnò in prima persona per creare la Federazione dell’Africa orientale e istituì nella capitale il Pan African Freedom
Movement for East, Central and South Africa (Pafmecsa) e il comitato
di coordinamento stabilito alla conferenza panafricana di Addis Abeba
per sostenere gli Stati ancora sottoposti al dominio coloniale portoghese. Nelle intenzioni iniziali, la Federazione dell’Africa orientale avrebbe
dovuto comprendere Tanganica, Zanzibar, Kenya e Uganda, che sotto la
dominazione inglese avevano fatto parte della Common Services Organisation e godevano pertanto di una certa interdipendenza economica e
finanziaria. La creazione di federazioni regionali era, secondo Nyerere, la
strada migliore per giungere all’unità africana, obiettivo al quale era volto il previsto progressivo ampliamento dei membri della federazione con
l’ingresso di Somalia, Ruanda, Burundi, Rhodesia del Nord, Nyassaland e
Congo-Leopoldville76.
Anche se era prevedibile che molti dei progetti di Nyerere per l’integrazione politica del continente non si sarebbero poi realizzati, il fatto
che fosse a capo di uno degli Stati più significativi dell’Africa nera (sia per
numero di abitanti, circa. 9 milioni, che per superficie, 940.000 chilometri
quadrati), il suo forte impegno per l’unità africana e la particolare forma
di non allineamento che proponeva gli conferivano senza dubbio un certo
prestigio internazionale, reso evidente anche dal suo ruolo di mediatore
in svariati conflitti interafricani. Di conseguenza, egli si rivelava essere un
265
Francesca Zilio
interlocutore di primo piano per il Governo federale, che avrebbe dovuto
dosare abilmente i propri finanziamenti e l’offensiva diplomatica contro la
DDR per mantenere la sua concreta posizione favorevole sulla questione
tedesca (il Tanganica aveva riconosciuto solo la Germania Ovest), ma al
tempo stesso rispettare ufficialmente la sua forma di socialismo africano e
di non allineamento.
Dati tali presupposti, i Governi di entrambi i paesi erano consapevoli
del grande potenziale delle loro relazioni amichevoli, ma anche del sottile
filo lungo il quale queste relazioni si mantenevano e dei conseguenti rischi.
Bonn sosteneva infatti che
Sarebbe troppo definire la politica estera del Tanganica come filo-occidentale. Nyerere
non vuole farsi coinvolgere né nel conflitto Est-Ovest, né nei contrasti fra il mondo
arabo e Israele. Ne è tipica la sua pretesa: «non mi lascio imporre i miei nemici dai miei
amici.» Ciononostante non si può ignorare che il Tanganica ha legami notevolmente
più forti con l’Occidente che con L’Oriente. Ad ogni modo, fu un errore dell’Occidente mettere troppo in evidenza Nyerere come suo amico77.
Allo stesso modo, a Nyerere non era estranea la Realpolitik, per cui
ai suoi proclami sull’indipendenza del Tanganica e dell’intero continente
africano non dimenticava di unire la consapevolezza dei margini entro cui
tali rivendicazioni potevano muoversi:
Quando si ha bisogno di aiuti esterni, è impossibile evitare che decisioni a contenuto
politico vengano prese fuori dal proprio Paese. […] Ma a volte il tipo o le condizioni
degli aiuti hanno un contenuto più ideologico e allora dobbiamo decidere se accettare
le condizioni o rallentare il nostro sviluppo economico78.
Opportunità e rischi nelle relazioni reciproche erano dati anche dalla
condizione post-coloniale del Paese. Al contrario del Togo, il TanganicaTanzania presentava il doppio vantaggio di essere un ex mandato del Regno Unito – il quale aveva dimostrato un approccio molto meno rigido nei
confronti della decolonizzazione e aveva quindi concesso più facilmente
l’indipendenza e una maggiore autonomia in politica estera – e di non
essere pertanto associato alla CEE, il che escludeva la necessità di dover
rendere perennemente partecipi gli altri Stati membri delle proprie azioni e
accettarne il controllo. D’altra parte, se l’associazione alla CEE restringeva
fortemente il campo d’azione tedesco a causa delle posizioni francesi, essa
266
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
costituiva anche una buona garanzia di ancoraggio dei paesi associati al
blocco occidentale. La maggiore indipendenza in politica estera del Tanganica lo rendeva quindi più facilmente avvicinabile dal blocco sovietico già
prima della federazione con un Paese dichiaratamente filo-orientale come
Zanzibar, unico in Africa ad aver riconosciuto la DDR79. Come si vede,
tornavano valide ancora una volta le suddette previsioni per la distribuzione dei finanziamenti.
Per quanto riguardava la «divisione del lavoro» con gli occidentali e
quindi anche le relazioni con l’ex potenza coloniale, l’attenzione di Bonn
era sempre desta:
Gruppi nazionalisti cercheranno di servirsi della Repubblica federale contro gli inglesi.
Eviti di farsi coinvolgere in tali conversazioni. I nostri obblighi di alleanza ci impongono, in tali situazioni, di tutelare i nostri alleati80.
La «riservatezza» da avere nei confronti del Regno Unito non era tuttavia paragonabile a quella pretesa dai francesi. Nonostante appartenesse al
Commonwealth, il Paese era infatti in rapporti tesi con la madrepatria, con
cui sarebbe addirittura arrivato ad interrompere le relazioni diplomatiche
(1965-68, a causa della politica inglese verso la Rhodesia). Come testimoniano gli incontri bilaterali anglo-tedeschi sull’Africa, più che difendere la
propria «riserva di caccia», Londra era quindi interessata a che fosse un suo
alleato ad «occuparsi» dei suoi ex territori e a cercare di proteggerne l’immagine di fronte ai pesanti interventi di DDR, Unione sovietica e Cina81.
Tali interventi si sarebbero mostrati molto più invasivi e pericolosi dal
momento in cui il Tanganica si federò con Zanzibar. Pur non volendo
entrare nei dettagli degli avvenimenti susseguitisi sin dalla dichiarazione
d’indipendenza di Zanzibar, su cui esiste una valida bibliografia82, risulta evidente che l’unione fra uno Stato filo-occidentale – considerato da
Bonn, nonostante tutto, un proprio baluardo e pertanto generosamente
finanziato – e lo Stato più filo-orientale di tutta l’Africa – l’unico ad aver
riconosciuto la DDR, diventandone una vetrina nel continente e un destinatario di ingenti contributi – creò una situazione alquanto particolare.
Nel momento in cui fu annunciata la federazione, ma anche successivamente (era previsto che entrasse in vigore dopo un anno), le dichiarazioni
di Nyerere – capo di Stato del Tanganica e della Tanzania – e di Karume
– presidente di Zanzibar e vicepresidente della federazione – risultavano
267
Francesca Zilio
inconciliabili. Nel corso del suo primo incontro con l’ambasciatore della
DDR Fritsch dopo l’annuncio della federazione, Karume affermò infatti che
Zanzibar avrebbe assunto un ruolo guida nell’unione e che le sue relazioni
internazionali non avrebbero subito alcun cambiamento. Aggiunse infine:
Se il Tanganica non è pronto a riconoscere la DDR, allora preferiamo rompere l’Unione83.
Cinque giorni dopo (il 28 aprile 1964), Nyerere confermava all’ambasciatore federale Schroeder che, come si era correttamente commentato all’estero, la federazione era diretta «contro l’influsso comunista a Zanzibar»84.
Allo stesso tempo, egli sosteneva che
i principi alla base della politica estera della Repubblica unita [di Tanzania] saranno
gli stessi attualmente operanti negli Stati separati di Tanganica e Zanzibar. Dobbiamo
lavorare per l’unità africana e la libertà africana e dobbiamo rimanere non allineati
rispetto agli scontri fra potenze mondiali che non ci riguardano. Ogni questione internazionale sarà valutata sulla base del suo valore e la nostra amicizia verso tutte le
nazioni dipenderà solo dalla loro condotta verso di noi. Non dobbiamo permettere ai
nostri amici di scegliere per noi i nostri nemici85.
Da tali promesse si deduceva che nell’Unione entrambi i paesi avrebbero mantenuto la loro precedente politica estera - che sulla questione
tedesca era assolutamente opposta – e che non avrebbero accettato ingerenze altrui nella determinazione delle proprie relazioni internazionali - riferimento non troppo velato alla consueta offensiva diplomatica di Bonn
contro la DDR – ma che comunque si intendeva limitare l’influenza di
quest’ultima a Zanzibar!
Ciò non poteva che allarmare la Repubblica federale, la quale si dimostrava però molto fiduciosa sul sostegno di Nyerere, in sostanza perché
fino ad allora le era sempre riuscito di far pendere l’ago della bilancia a
proprio favore, poichè anche i governanti africani più lusingati dalle proposte orientali avevano finito per stare dalla parte di chi poteva loro offrire
di più. Nel caso particolare, Bonn sapeva che avrebbe potuto sostituirsi
alla DDR negli aiuti a Zanzibar, mentre quest’ultima non aveva la forza
economica per impegnarsi altrettanto in Tanganica. Più che un rischio,
la formazione della Tanzania era quindi ritenuta un’ottima opportunità
per scalzare la DDR dal suo unico appoggio in Africa. Non si erano però
268
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
considerati a sufficienza alcuni elementi fondamentali: la convinzione del
Governo di Zanzibar, che era stato l’unico a non cedere all’ultimo momento alle pressioni occidentali e a riconoscere ufficialmente la DDR, il
cui ambasciatore era il decano del corpo diplomatico presente sull’isola;
il fatto che a tale convinzione si aggiungesse una questione di principio:
uniformarsi in tutto e per tutto alle scelte di politica estera del Tanganica
avrebbe significato assumere una posizione subalterna nella Federazione;
la personalità e il prestigio di Nyerere, che, per quanto realista sui suoi
margini di manovra, non poteva permettersi di dimostrarsi sottomesso ad
ogni capriccio tedesco. Tali furono alcuni dei fattori che avrebbero portato
al clamoroso fallimento della Dottrina Hallstein nell’Africa orientale.
L’atteggiamento iniziale di Nyerere era sembrato tuttavia confermare
le aspettative ottimistiche di Bonn. Alla richiesta dell’ambasciatore Fritsch
di intraprendere negoziati per estendere il riconoscimento diplomatico a
tutta la federazione, egli aveva infatti risposto che l’ambasciata tedescoorientale a Zanzibar sarebbe stata trasformata in una semplice rappresentanza commerciale (massimo grado ottenuto da una rappresentanza della
RDT in Africa, se si esclude l’Egitto). E quando Fritsch gli aveva opposto
le garanzie in senso contrario che gli erano state confermate dai principali
politici di Zanzibar, Nyerere si era limitato a dichiarare che se la DDR
avesse insistito per intrattenere rapporti diplomatici con l’intero Stato, si
sarebbe resa responsabile della rottura dell’Unione: l’esatto contrario di
ciò che aveva affermato Karume. Nyerere informò subito l’ambasciatore Schroeder dell’accaduto e il Governo federale si dimostrò favorevole
all’ipotesi della rappresentanza commerciale, intendendola però solo come
una tappa del percorso che avrebbe dovuto portare all’eliminazione totale
della presenza orientale a Zanzibar.
Il Governo di Berlino Ovest, evidentemente contrario a perdere la propria unica ambasciata in Africa, finì invece per accettare la prospettiva della rappresentanza commerciale, consapevole che il diritto internazionale
non obbligava l’Unione ad «acquisire» i rapporti diplomatici di Zanzibar
(avrebbe dovuto decidere ex novo) e che avrebbe potuto comunque mantenere la sua forte influenza sull’isola accreditando il proprio personale con
altri titoli.
Karume e i suoi ministri si dimostravano invece assolutamente intransigenti nel non voler rinunciare ai rapporti diplomatici dell’intera Tanzania
con la DDR.
269
Francesca Zilio
Dopo un susseguirsi di contrasti fra Karume e Nyerere, di incomprensioni con entrambi gli ambasciatori tedeschi, di smentite e di prese
di tempo varie di cui non daremo conto, all’inizio del 1965 il presidente
della Tanzania si risolse a seguire il cosiddetto «modello del Cairo», cioè a
concedere alla DDR un consolato generale, che riteneva un compromesso
ideale: meno di un’ambasciata, più di una rappresentanza commerciale.
Ciò era però inaccettabile per il Governo federale, che si era reso conto
di aver commesso un errore dimostrandosi tanto tollerante con l’Egitto e
che dopo la costruzione del muro di Berlino aveva irrigidito maggiormente
le proprie posizioni, non intendendo accettare più alcuna concessione a
Pankow (ammesso che un consolato generale in Tanzania rappresentasse
una concessione rispetto ad un’ambasciata a Zanzibar).
Da questo momento in poi, la cooperazione allo sviluppo fu nuovamente sfoderata come puro strumento della Deutschlandpolitik: a patto
che la DDR fosse privata di ogni rappresentanza in Tanzania, Bonn ribadì
la sua offerta di subentrare in tutte le attività e i finanziamenti di Pankow
a Zanzibar e di concederne ulteriori a condizioni ancora più favorevoli e
inviò il ministro Scheel a Dar-es-Salaam per i relativi negoziati. Tale atteggiamento del Governo federale induce a due ordini di considerazioni. In
primo luogo, la scelta di Scheel, ministro per la cooperazione allo sviluppo,
per un negoziato che riguardava una questione eminentemente diplomatica come il non riconoscimento della Germania orientale da parte della
Tanzania, dimostra ancora una volta inequivocabilmente il carattere puramente strumentale assegnato alla politica di cooperazione allo sviluppo
rispetto ai prioritari obiettivi di politica estera del Governo federale. In
secondo luogo, la possibilità concessa a Bonn di inviare direttamente sul
posto un ministro per difendere i propri peculiari interessi evidenzia la
prospettiva completamente diversa con cui il Regno Unito si poneva nei
confronti del suo ex impero coloniale e degli alleati che intrattenevano rapporti con questo. Certamente si deve considerare che la limitazione della
sfera d’influenza del blocco comunista era anche negli interessi di Londra,
così come di tutto il blocco occidentale, e che la Repubblica federale si
mostrò sempre leale nell’informare gli alleati, ma sarebbe molto difficile
immaginare una simile libertà di manovra per Bonn in un qualsiasi Stato
dell’Africa francese.
Tale «fiducia» nei Tedeschi non si dimostrò però molto ben riposta,
poiché il loro atteggiamento intransigente – tradottosi nella minaccia di
270
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
taglio degli aiuti allo sviluppo per la Tanzania – condusse non solo al secondo grave fallimento dell’Alleinvertretungsanspruch, subito successivo
al caso egiziano86, ma anche ad un duplice smacco per tutta l’alleanza occidentale proprio in due zone in cui l’influenza del blocco orientale era molto forte. Tale atteggiamento era incomprensibile per Nyerere, che credeva
di non meritare una punizione da Bonn, ma gratitudine per aver scacciato
da Zanzibar il pericolo comunista chiudendo l’unica ambasciata che la
RDT era riuscita ad ottenere in un Paese non allineato. Anche vari ministri federali vi si opponevano, principalmente per la preoccupazione che
una tale scelta spingesse ulteriormente la Tanzania nelle braccia dell’Est.
Ciononostante, quando Dar-es-Salaam comunicò l’apertura del consolato
generale, unita peraltro all’esplicita dichiarazione di non riconoscimento
della DDR, il ministero degli Esteri riuscì ancora una volta ad imporsi,
tagliando gli aiuti militari e rimpatriando tutti gli addetti.
La reazione di Nyerere fu orgogliosa quanto inaspettata: affermando
di non volersi lasciare né comprare, né tiranneggiare, egli rinunciò anche
a tutti gli aiuti allo sviluppo che il Governo federale non aveva bloccato. I
progetti di aiuti tecnici sarebbero dunque continuati fino al termine previsto, poi non ne sarebbero stati iniziati di nuovi, così come non sarebbero
stati concessi nuovi crediti.
Dal momento che la Tanzania era in rapporti tesi sia con Londra (sarà di
poco successiva la rottura delle relazioni diplomatiche), che con Washington (due diplomatici statunitensi erano appena stati accusati di aver sostenuto un presunto tentativo di colpo di stato a Zanzibar e immediatamente
rimpatriati) e che Parigi si occupava pressoché esclusivamente dell’Africa
francofona, Bonn avrebbe dovuto giocare in Tanzania, secondo l’opinione
americana, «un ruolo maggiore di qualsiasi altro Stato» e invece vi aveva
lasciato, nelle parole dei francesi, «uno spazio libero per i Cinesi»87.
Anche rispetto alle conseguenze negative che il Governo federale, in
nome dell’Alleinvertretungsanspruch, aveva provocato a tutti gli alleati
non proteggendo le aree di influenza occidentale dalle infiltrazioni comuniste – obiettivo ufficialmente prioritario della cooperazione allo sviluppo
federale – il Regno Unito fu la potenza che reagì meno pesantemente, nonostante fosse proprio quella più interessata. Nei diversi negoziati bilaterali
successivi all’interruzione delle relazioni diplomatiche con gli inglesi e degli aiuti dei tedeschi, in un periodo in cui l’offensiva orientale continuava
ad aumentare, Londra si mostrò anzi comprensiva verso le istanze di Bonn,
271
Francesca Zilio
per il quale «un cambiamento della posizione ufficiale tedesca non [era]
previsto». Il Governo federale affermava infatti:
Se riprendessimo nuovamente gli aiuti statali su larga scala, gli altri paesi ne dovrebbero dedurre che noi a lungo andare non solo tollereremmo atti non amichevoli verso la
Germania, ma addirittura li ricompenseremmo88.
Nella realtà, nonostante il taglio ufficiale, la Tanzania aveva praticamente mantenuto tutti gli aiuti, poiché i 12 progetti di aiuti tecnici già
iniziati al momento della ritorsione tedesca furono tutti portati avanti e in
campo militare gli esperti tedeschi furono sostituiti da canadesi. Non solo,
questa situazione permetteva a Nyerere di continuare a sfruttare entrambe
le Germanie attraverso la cosiddetta «politica dell’altalena». Fu così che nel
1966 la RDT approfittò del taglio degli aiuti occidentali per fare una vantaggiosissima offerta costituita da un prestito senza interessi e da un contributo a fondo perduto per motivi umanitari. La Tanzania rifiutò sperando
nella ripresa imminente degli aiuti federali, ma non mancò di far notare a
Bonn quanto le fosse stato difficile rifiutare una proposta così vantaggiosa
e ciò le valse la promessa di 2,5 milioni di marchi (anche la ripresa ufficiale
degli aiuti sarebbe avvenuta solo nel 1970 con la große Koalition). Di conseguenza, anche dopo la punizione di Nyerere, «il contributo globale per
la Tanzania, compresi gli aiuti delle Chiese e dei privati, [era] ancora il più
ingente che [Bonn accordava] ad un singolo Paese africano»89.
Ciononostante, il Governo federale fu accusato da ogni parte di aver
ingiustamente punito la Tanzania per mostrare un gesto di forza dopo che
la sua debolezza si era manifestata in modo evidente con l’Egitto, fu rimproverato dagli occidentali (soprattutto da Stati Uniti e Francia) di aver
lasciato campo libero al nemico, danneggiando così tutta l’alleanza, e fu
bersaglio delle critiche di Nyerere, che non mancò di far presente ai colleghi dell’Organizzazione per l’unità africana come Bonn fosse incoerente
criticando l’occupazione sovietica nella Germania orientale, ma intrattenendo buoni rapporti con Portogallo e Sudafrica, che negavano l’autodeterminazione agli ultimi popoli africani sottomessi. Tali accuse, portate
avanti da un leader dell’Africa anglofona, erano tanto più gravi se si considera che Bonn era già biasimata in tutti i paesi dell’Africa francofona per
il suo appoggio, sia a livello bilaterale che attraverso la CEE, alla politica
neocolonialista di Parigi. L’atteggiamento assunto nei confronti della Tan272
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
zania si era dunque rivelato fallimentare su tutti i fronti.
Date tali premesse, potrebbe sorprendere come Bonn fosse ancora ottimista sul successo dell’Alleinvertretungsanspruch in tutta l’Africa e addirittura sulla propria situazione in Tanzania:
Il veloce impegno a Zanzibar non ha potuto impedire che, con la creazione dell’Unione Tanzania, il successo d’immagine dato dallo stabilimento di un’ambasciata ufficiale
della zona d’occupazione sovietica a Zanzibar sia andato perso, cosa che è potuta essere
solo in parte compensata dall’accettazione del consolato generale a Dar-es-Salaam.
[…] Il Console generale della zona d’occupazione sovietica in Tanzania, Lessing, ha
provocato molto velocemente la diffidenza di Nyerere ed è sorvegliato e fortemente
limitato nelle sue attività90.
Conclusioni
È innegabile che l’applicazione della Dottrina Hallstein non sia sempre stata coerente e che la maniacale lotta quotidiana della diplomazia di
Bonn contro la DDR raggiunse a volte degli eccessi tali da perdere credibilità come principio di politica estera, ma è altrettanto vero che essa
riuscì comunque nel proprio obiettivo di evitare per più di 15 anni che la
DDR fosse riconosciuta dalla gran parte della comunità internazionale. Se
la Dottrina Hallstein fu in seguito abbandonata, ciò non fu infatti dovuto
ai suoi fallimenti – anche se clamorosi - ma piuttosto alla sopravvenuta
consapevolezza che l’isolamento internazionale della DDR non fosse più
la via giusta da percorrere per ottenere la riunificazione.
Al contrario di quanto auspicava la diplomazia federale, fu molto difficile convincere gli Africani della totale estraneità tedesca ad ogni politica
di potenza o della bontà del sistema occidentale per il loro sviluppo economico-sociale, ma fortunatamente per Bonn era altrettanto difficile che
i governanti africani fossero disposti, al di là delle critiche e delle accuse,
a rinunciare in massa al sostegno finanziario e tecnico di una delle prime
potenze economiche mondiali, la cui rivale non era certamente in grado di
offrire altrettanto su larga scala. La ragione del successo della politica del
Governo federale in Africa fu dunque quella enunciata in modo esemplare
da Jomo Kenyatta: «Nel caso di Stati divisi, cerchiamo l’amicizia del più
potente».
273
Francesca Zilio
Note al testo
1
Si riferiscono pertanto a tale archivio (Politisches Archiv des Auswärtiges Amts, abbreviato PA/
AA) i diversi documenti citati nelle note successive.
2
Peter Bender, Die «Neue Ostpolitik» und ihre Folgen. Vom Mauerbau bis zur Vereinigung,
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996, p. 280; Ying-Feng Yang, Der Alleinvertretungsanspruch der geteilten Länder: Deutschland, Korea und China im politischen Vergleich, Peter
Lang, Frankfurt am Main 1997, pp. 29-30.
3
Nel momento in cui il governo federale tentò un primo approccio di Ostpolitik, ritenne possibile stringere rapporti con i paesi satelliti in virtù della teoria del «difetto congenito», secondo
la quale era possibile «perdonare» loro il riconoscimento della DDR appunto perché ne erano
stati costretti fin dalla nascita. Il tentativo fallì quando, una settimana dopo lo scambio di ambasciate tra la Germania occidentale e la Romania, i ministri degli Esteri del Patto di Varsavia
stabilirono che nessun membro del Patto avrebbe potuto normalizzare i propri rapporti con la
Repubblica federale prima che lo avesse fatto la DDR.
4
Verhältnis von Außen- und Entwicklungspolitik. Vortrag Dr. Pauls am 16.12.64, PA/AA: B
58–III B1, 651.
5
Ibidem. Cfr. anche Hans-Joachim Spanger, Lothar Brock, Die beiden deutschen Staaten in
der dritten Welt. Die Entwicklungspolitik der DDR: Eine Herausforderung für die Bundesrepublik
Deutschland?, Westdeutsche Verlag, Opladen 1987; Klaus Bodemer, Entwicklungshilfe – Politik für wen? Ideologie und Vergabepraxis der deutschen Entwicklungshilfe in der ersten Dekade,
Weltforum-Verlag, München 1974, p. 122.
6
Überprüfung der Ergebnisse unserer Entwicklungshilfe, PA/AA: B 58–III B1, 866.
7
Verhältnis von Außen- und Entwicklungspolitik cit.
8
Cfr. PA/AA: B 2, 213.
9
Ref. 307: Niederschrift der Abteilungsleiterkonferenz über Afrika vom 16. Juli 1960, 25 luglio
1960, PA/AA: B 34, 205.
10
Legationsrat I. Kl. Schroeder, Afrika im Ost-West-Konflikt in Protokoll der Afrikakonferenz des Auswärtigen Amts vom 12. bis 18. Oktober 1959 in Addis Abeba, PA/AA: B 2, 96, pp.
50-63.
11
Ministerialdirektor von Etzdorf, Afrika in der Weltpolitik, ibidem, pp. 39-49. Della stessa
opinione, cfr. anche Vermerk Dg III B an Herrn D III, 23 aprile 1963, PA/AA: B 68, 232.
12
Vortragender Legationsrat Dumke, Entwicklungspolitik und Förderungsmassnahmen in
Afrika in Protokoll der Afrikakonferenz des Auswärtigen Amts vom 12. bis 18. Oktober 1959 in
Addis Abeba cit., pp. 306-323
13
In questo settore, particolarmente efficaci furono le due esposizioni itineranti che l’Auswärtiges Amt promosse nel 1961 nell’Africa occidentale e nel 1963 nelle regioni centro-orientali.
Agli abitanti di centinaia di città e villaggi in circa 20 Stati furono illustrati il miracolo economico e il sistema scolastico tedeschi, nonché la drammatica situazione creata dalla costruzione
del muro di Berlino, con tanto di immagini dei tentativi di fuga verso l’Ovest. Cfr. Rainer
Tetzlaff, Grundzüge und Hintergründe Bonner Afrika-Politik. Eine Einführung, in Afrika
und Bonn. Versäumnisse und Zwänge deutscher Afrika-Politik, a cura di Helmut Bley e Rainer
Tetzlaff, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1978, pp. 28-38.
14
Sulla lotta fra Bonn e Pankow per la conquista dell’Africa, tema volutamente escluso dalla presente trattazione, l’opera di riferimento è quella di Sara Lorenzini, Due Germanie in
274
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
Africa. La cooperazione allo sviluppo e la competizione per i mercati di materie prime e tecnologia,
Polistampa, Firenze 2003.
15
Vortragender Legationsrat Dumke, Entwicklungspolitik und Förderungsmassnahmen in
Afrika cit.
16
Cfr. Volker Matthies, Wird Afrika rot? Kommunismus als Bedrohungsvorstellung deutscher
Afrika-Politik, in Afrika und Bonn cit., pp. 160-187. Per una chiara descrizione del ruolo degli
Stati Uniti, della Repubblica federale e degli altri alleati nella cooperazione allo sviluppo occidentale, cfr. anche Sara Lorenzini, Due Germanie in Africa cit., pp. 15 ss.
17
Vortragender Legationsrat Dumke, Entwicklungspolitik und Förderungsmassnahmen in
Afrika cit.
18
Ivi.
19
Rainer Tetzlaff, Grundzüge und Hintergründe Bonner Afrika-Politik cit., p. 28.
20
Anerkennungstelegramme an die Regierungen der Republik Madagascar, der Föderation Mali und
der Republik Togo, PA/AA: B 34, 205.
21
Fino al 1959 esistevano 5 ambasciate federali in Africa (Sudafrica, Liberia, Etiopia, Ghana,
Guinea, Sudan), fra il 960 e il 1964 ne furono aperte 26 nella sola Africa subsahariana. Cfr.
Ulf Engel e Hans-Georg Schleicher, Die beiden deutschen Staaten in Afrika: zwischen Konkurrenz und Koexistenz 1949-1990, Institut für Afrika-Kunde, Hamburg 1998, p. 37; Christian Uhlig, Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und die Nord-Süd-Beziehungen in
Deutschland, Frankreich, Europa: Bilanz einer schwierigen Partnerschaft, a cura di Robert Picht,
Piper & Co. Verlag, München 1978.
22
L’unica eccezione al riconoscimento immediato delle ex colonie divenute indipendenti è Zanzibar, ed è un’eccezione che conferma la bontà della regola: in assenza di azioni occidentali,
Zanzibar riconobbe la Germania orientale e, a seguito dell’unione fra i due paesi, rischiò di
trascinare su questa via anche il Tanganica. Ad eccezione dell’Egitto, nessuno Stato africano si
sarebbe mai tanto avvicinato alla DDR.
23
Ministerialdirektor von Etzdorf, Afrika in der Weltpolitik cit. Sull’opinione concorde di
Kennedy in proposito, cfr. Sara Lorenzini, Due Germanie in Africa cit., p. 18.
24
Legationsrat I Kl. Schroeder, Afrika im Ost-West-Konflikt cit.; Afrika und Bonn, a cura di
Helmut Bley e Rainer Tetzlaff cit., pp. 177-180. Cfr. anche Sara Lorenzini, Due Germanie
in Africa cit., pp. 18 ss.
25
Il Cameroun fu spartito tra Regno Unito (ad ovest) e Francia (ad est), esattamente come il
Togo, l’Africa del Sud-ovest fu assegnata all’Unione sudafricana, il Tanganica al Regno Unito
e il Ruanda-Urundi al Belgio. Nel 1946 l’Organizzazione delle Nazioni Unite avrebbe trasformato tutti i mandati in amministrazioni fiduciarie, ad eccezione dell’Africa del Sud-ovest, che
fu praticamente annessa dall’Unione sudafricana e con il nome di Namibia sarebbe divenuta
indipendente solo nel 1990, ultimo fra gli Stati africani. La regione orientale del Cameroun
si sarebbe trasformata in uno Stato sovrano nel 1960, mentre quella occidentale sarebbe stata inizialmente accorpata alla Nigeria, per poi riunirsi all’altra nella Repubblica federale del
Cameroun. Il Togo francese avrebbe ottenuto l’indipendenza nel 1960, mentre la regione amministrata dal Regno Unito sarebbe divenuta parte della Repubblica del Ghana, creata nello
stesso anno. Il Tanganica raggiunse l’indipendenza nel 1961 e si unì dopo tre anni a Zanzibar,
formando l’attuale Tanzania. Il Ruanda-Urundi fu diviso nel 1962 fra la Repubblica del Ruanda a nord e il Regno (poi Repubblica) di Burundi a sud.
26
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes an Herrn Bundesminister a. D. Dr. Thomas Dehler,
Betr., Veröffentlichung eines Buches über «Kamerun als deutsches Schutzgebiet», PA/AA: B 34,
275
Francesca Zilio
39. Della stessa opinione, cfr. anche Vermerk Ref. III A 1, Betr.: Deutsch-französischer Vertrag,
ibidem; Deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der EH, 11 luglio 1963, PA/AA: B
58–IIIB1, 297; Ministerialdirektor von Etzdorf, Afrika in der Weltpolitik cit.
27
Ministerialdirektor Dr. Sachs, Die Entwicklungshilfe – ein wesentlicher Bestandteil der
deutschen Außenpolitik, 15 settembre 1961, PA/AA: B 58–IIIB1, 116. Cfr. anche Verhältnis von
Auβen- und Entwicklungspolitik, Vortrag Dr. Pauls am 16.12.64, PA/AA: B 58–III B1, 651.
28
Ministerialdirektor von Etzdorf, Afrika in der Weltpolitik cit.
29
Brief des Bundesministers des Auswärtigen an den Botschafter der BRD Herrn Dr. Herbert
Schroeder, Dar-es-Salaam, 5 febbraio 1963, PA/AA: B 34, 438.
30
Willy Brandt, Deutschland und Afrika (Vorwort für die Zeitschrift «Internationales Afrikaforum»), marzo 1967, PA/AA: B 34, 730.
31
Têtêvi Godwin Tété-Adjalogo, De la colonisation allemande au Deutsche-Togo Bund, Editions L’Harmattan, Paris 1998, pp. 176-93.
32
«Un tel prestige ne s’explique que par la comparaison de la praxis coloniale allemande avec
d’autres praxis coloniales», ibidem, p. 192.
33
Freiheit! dröhnten die Trommeln. Die ehemalige deutsche Kolonie Togo würde der jüngste unabhängige Staat im Schwarzen Erdteil, «Die Welt», 19 maggio 1960, PA/AA: B 34, 39.
34
Die Nacht ist lang, aber der Tag kommt. Togo feiert seine Unabhängigkeit. Bundesminister Schwarz
überbringt Grüße aus Deutschland, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», n. 106, 6 maggio 1960,
ibidem.
35
Ein eiches Erbe zu erschließen. Lebendige deutsche Vergangenheit in Togo – Zukunftschancen einer
Hilfe zur Selbsthilfe, «Kasseler Post», 11 maggio 1960, ibidem.
36
Guten Tag, wie geht’s? Ein Besuch bei Mlapa IV, Häuptling von Togoville, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», n. 114, 16 maggio 1960, ibidem.
37
Botschaft der BRD Lomè, betr.: Togoländisch-französische Beziehungen, 25 giugno 1960, PA/
AA: B 34, 40.
38
Wolfgang Teuscher, Bericht über die gegenwärtige Situation in Togo und Vorschläge für dringend notwendige Schritte der BRD, PA/AA: B 34, 38.
39
Ein eiches Erbe zu erschließen. Lebendige deutsche Vergangenheit in Togo – Zukunftschancen einer
Hilfe zur Selbsthilfe cit.
40
Wolfgang Teuscher, Bericht über die gegenwärtige Situation in Togo und Vorschläge für dringend notwendige Schritte der BRD cit.
41
Botschaft der BRD Lomè, betr.: Bericht des Herrn Teuscher über die gegenwärtige Situation in
Togo, 12 maggio 1960, PA/AA: B 34, 38
42
Cfr. Legationsrat I. Kl. Schroeder, Afrika im Ost-West-Konflikt, PA/AA: B 2, 96, pp.
50-63; Konsul I. Kl. Reichhold, Länderbericht Communauté Francaise, ibidem, pp.119-127;
Generalkonsul Soehring, Länderbericht Französisch-Äquatorial-Afrika und Kamerun, ibidem, pp.137-144.
43
Ref. 307: Aufzeichnung betr.: Deutsche Wirtschaftspolitik in den ehemals französischen Gebieten
Afrikas, 30 maggio 1960, PA/AA: B 34, 38.
44
Notice biographique de M. R. Lemaignen, Archivi storici dell’Unione europea: CM2/1958 –
191; Véronique Dimier, De la dictature des drapeaux au sein de la Commission Européenne?
Loyautés multiples et constitution d’une identité commune au sein d’une administration multinationale, VIIe congrès de l’Association française de science politique, Lille, 18, 19, 20 et 21
276
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
septembre 2002.
45
Da un’intervista a J. Ferrandi, 26 agosto 1999, in Véronique Dimier, De la dictature des
drapeaux au sein de la Commission Européenne? cit., p. 11.
46
Botschaft Lomè betr.: Französisch-togoländische Beziehungen, 2 giugno 1960, PA/AA: B 34,
40
47
Botschaft Lomè betr.: Togoländisch-französische Beziehungen, 25 giugno 1960, ibidem.
48
Ref. III B5 betr.: Besondere Beziehungen Frankreichs zu den UAM-Staaten; hier: vertragliche
Festlegung des Außenhandelsvolumens, 23 ottobre 1963, PA/AA: B 58–IIIB1, 298.
49
Sui vantaggi ottenuti dalla Francia in Cameroun e altri Paesi attraverso gli «accordi di cooperazione» v. Augustin Dibengue, Zur Vormachtstellung Frankreichs im frankophonen Afrika: Die
Beziehungen Kameruns zu Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland von 1960 bis Anfang
der achtziger Jahre im Vergleich, Alano Verlag / Edition Herodot, Aachen 1994, pp. 260-293.
50
PA/AA: B 34, 40; Vermerk Ref. III B5 betr.: Deutsch-französische Besprechungen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, 2 ottobre 1963, PA/AA: B 58–IIIB1, 298.
51
Ne facevano parte, oltre alle ex colonie tedesche Cameroun e Togo, Dahomey (attuale Benin),
Costa d’Avorio, Gabon, Congo Brazzaville, Mauritania, Niger, Alto Volta (attuale Burkina
Faso), Ruanda, Senegal, Chad e Repubblica centrafricana .
52
Ref. III B 5 betr.: Besondere Beziehungen Frankreichs zu den UAM-Staaten; hier: Devisen Bewirtschaftung, 23 ottobre 1963, PA/AA: B 58 –IIIB1, 298. Cfr. anche Volker Alberts, Die
Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft 1957
– 1983, Lit, Münster 1986, passim; Klaus Billerbeck, Europäisierung der Entwicklungshilfe
III – Gemeinschaftliche Entwicklungshilfe für die afrikanischen Assoziierten, Schriften des Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, Berlin 1972, passim.
53
Telex Nr. 227 aus Brüssel an das Referat I A 2, 19 febbraio 1964, PA/AA: B 58–III B1, 363. Cfr.
anche Dr. Feilner (Ref. III B 3) an das Referat I A 2, Betr.: Deutscher Beitrag zum EWG-Fonds
und deutsche Beteiligung an der Durchführung der daraus finanzierten Projekte, Bezug: Telex Nr.
227 vom 19. Februar 1964 aus Brüssel, 25 febbraio 1964, ibidem.
54
Volker Alberts, Die Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungspolitik der Europäischen
Gemeinschaft 1957–1983 cit., pp. 36-7.
55
Dr. Frank: Aufzeichnung betr.: Teilnahme an der Studientagung des Centre d’études de politique
etrangère in Paris, 15 dicembre 1958, PA/AA: B 34, 38.
56
Norbert Lang, Die Bemühungen um die politische Einigung Europas seit dem Scheitern der
europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in Zur Integration Europas – Festschrift für Carl Friedrich Ophüls aus Anlass seines siebzigsten Geburtstages, a cura di Walter Hallstein e Hans-Jürgen
Schlochauer, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1965, pp. 136-9; Referat 200: Aufzeichnung betr.: Deutsch-französische Zusammenarbeit, 14 gennaio 1963, in Akten zur Auswärtigen Politik
der Bundesrepublik Deutschland, volume 1/1963, a cura di Hans-Peter Schwarz, Oldenbourg,
München, pp. 82-5.
57
Protokoll über die ersten deutsch-französischen Besprechungen über die Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungshilfe am 22.7.63 in Paris, PA/AA: B 58-IIIB1, 298.
58
Niederschrift über die Besprechung des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit
dem französischen Minister für Zusammenarbeit, M. Triboulet, am 21.3.1963 in Paris, ibidem.
59
PA/AA: B 34, 39: vari testi. Sul problema del coordinamento fra gli aiuti bilaterali dei singoli Paesi membri e quelli finanziati dal FES, v. a proposito del porto di Lomé: Vermerk für
Herrn Generaldirektor H. Hendus, betr.: Informationsaustausch über die Aktionen des Europäi-
277
Francesca Zilio
schen Entwicklungsfonds einerseits und die bilaterale deutsche Hilfe andererseits, in Archivi storici
dell’Unione europea: BAC 25/1980 – 474, pp. 3-6
60
Botschaft der BRD Paris, betr.: Zusammenarbeit der Wirtschaftsreferenten der EWG-Staaten in
Entwicklungsländern; hier: Frankenzone, 26 aprile 1963, PA/AA: B 68, 232
61
Botschaft BRD Lomé an Botschaft BRD Paris, betr.: Zusammenarbeit der Wirtschaftsreferenten
der EWG-Staaten in Entwicklungsländern; hier: Frankenzone, 15 agosto 1963, ibidem.
62
Niederschrift über die Besprechungen des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Walter Scheel mit dem französischen Kooperationsminister Raymond Triboulet am 4./5. November
1963 in Bonn, 6 novembre 1963, PA/AA: B 58-IIIB1, 298.
63
Insieme degli aiuti bilaterali tedeschi ai Paesi dell’Unione africana e malgascia nel 1963: Togo
(quasi 130 milioni di marchi), Camerun (93), Dahomey (25), Costa d’avorio (60), Gabon
(21), Congo Brazzaville (9), Mauritania (2), Niger (15), Alto Volta (25), Ruanda (11), Senegal
(56), Chad (16), Repubblica centrafricana (16). Der Bundesminister für Wirtschaft an das
AA, Betr.: Deutsch-französische Konsultationen über Entwicklungshilfefragen nach Artikel II,3
des deutsch-französischen Vertrages vom Januar d. J. am 24.10.1963, 9 ottobre 1963, PA/AA: B
58-IIIB1, 298.
64
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die
deutsch-französische Zusammenarbeit, in Dokumente zu Deutschland 1944 – 1994, a cura di
Peter März, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2000, p. 117.
65
Cfr. Protokoll der deutsch-französischen Besprechungen über die Zusammenarbeit im Bereich der
Entwicklungshilfe am 30.1.64 in Paris, PA/AA: B 58-IIIB1, 299.
66
Cfr. Protokoll über die ersten deutsch-französischen Besprechungen über die Zusammenarbeit im
Bereich der Entwicklungshilfe am 22.7.63 in Paris cit. Il successivo incontro prevedeva all’ordine
del giorno il punto «problemi africani», in cui i tedeschi illustrarono tutte le loro attività nella
chasse gardée. Cfr. Protokoll der deutsch-französischen Besprechungen über die Zusammenarbeit im
Bereich der Entwicklungshilfe am 24.10.63 in Bonn cit.
67
Ref. 307: Aufzeichnung betr. Deutsche Wirtschaftspolitik in den ehemals französischen Gebieten
Afrikas, 30 maggio 1960, PA/AA: B 34, 38.
68
Brief Dr. Herbert Schroeder an Herrn VLR I. Klasse Hans-Georg Steltzer, 16 ottobre 1963,
PA/AA: B 34, 438
69
Brief des Bundesministers des Auswärtigen an den Botschafter der BRD Herrn Dr. Herbert
Schroeder, Dar-es-Salaam, 5 febbraio 1963, ibidem.
70
Regionale Schwerpunktbildung der deutschen Förderungsmassnahmen für unterentwickelte Länder
unter politischen Gesichtspunkten, 1 dicembre 1958, PA/AA: B 58 – III B1, 117. Come si è
visto, alla Conferenza di Addis Abeba, svoltasi 10 mesi dopo, tali punti furono integralmente
ripresi.
71
Ibidem.
72
Ibidem.
73
Cfr. Vermerk Dg III B an Herrn D III, 23 aprile 1963, PA/AA: B 68, 232.
74
Brief des Bundesministers des Auswärtigen an den Botschafter der BRD Herrn Dr. Herbert
Schroeder, Dar-es-Salaam, 5 febbraio 1963 cit.
75
Aus Briefen deutscher Fachkräfte, in Deutsche in Entwicklungsländern. Erfahrungen deutscher
Fachkräfte in Afrika, Asien, Lateinamerika, a cura di Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, Druckerei Karl Metzmaier, Baden-Baden 1965.
278
La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione
76
Cfr. Botschaft der BRD Dar-es-Salaam an das Auswärtige Amt, betr.: Ostafrikanische Föderation, giugno 1963, PA/AA: B 34, 438.
77
Tanganjika – Länderaufzeichnung, Stand: Dezember 1962, PA/AA: B 34, 438. Cfr. anche
Brief des Bundesministers des Auswärtigen an den Botschafter der BRD Herrn Dr. Herbert
Schroeder, Dar-es-Salaam, 5 febbraio 1963 cit.
78
Dal discorso di apertura della 12esima sessione della conferenza della FAO, 18 novembre
1963, in Julius Nyerere, Freedom and Unity. A selection from writings and speeches 1952-65,
Oxford University Press, Dar es Salaam 1967, pp. 231-251.
79
Aufzeichnung über die Aktivität der SBZ in Afrika (ohne VAR), Stand Juni 1967, PA/AA: B
34, 730.
80
Brief des Bundesministers des Auswärtigen an den Botschafter der BRD Herrn Dr. Herbert
Schroeder cit.
81
Cfr., a titolo d’esempio, Aufzeichnung über die deutsch-britischen Konsultationen über Afrika
südlich der Sahara am 27.6.66, PA/AA: B 34, 730; Ergebnisniederschrift über deutsch-britische
Konsultationen vom 25.7.67 in London betreffend Afrika, ibidem, in cui Londra dimostra un
atteggiamento completamente diverso da Parigi riguardo il ruolo degli interventi tedeschi nei
suoi antichi domini coloniali.
82
Sia per gli eventi di seguito citati che per una più completa descrizione delle relazioni fra Tanganica, Zanzibar, Germania Ovest e Germania Est negli anni sessanta-settanta, cfr. fra gli altri
Ulf Engel: Afrikapolitik im Schatten der Hallstein-Doktrin. Die beiden deutschen Staaten und
Tanzania, 1964-1965, «University of Leipzig Papers on Africa – Politics and Economics Series»
No. 19/1998; Ulf Engel e Hans-Georg Schleicher, Die beiden deutschen Staaten in Afrika:
zwischen Konkurrenz und Koexistenz 1949-1990 cit.; Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin:
der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955-1973. Aus den Akten der beiden
deutschen Außenministerien, Duncker & Humblot, Berlin 2001; Heinz Schneppen, Eine Insel und zwei deutsche Staaten. Sansibar und die Hallstein-Doktrin 1964-1966, «DeutschlandArchiv» 1999, Verlag Leske+Budrich, Opladen, pp. 409-419; Sara Lorenzini, Due Germanie
in Africa cit.
83
Cit. in Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin: der diplomatische Krieg zwischen der BRD und
der DDR 1955-1973 cit., p.187.
84
Ibidem, p. 194.
85
Cit. in Julius Nyerere, Freedom and Unity. A selection from writings and speeches 1952-65
cit.
86
A seguito dell’invito di Ulbricht al Cairo, evento la cui gravità meritava una punizione maggiore rispetto al taglio degli aiuti allo sviluppo decretato il 17 febbraio 1965, ma che, dato il rilievo
internazionale di Nasser, non si poteva tradurre nell’interruzione dei rapporti diplomatici, nel
maggio successivo Erhard decise di riconoscere Israele, provocando così la rottura delle relazioni diplomatiche con tutti i Paesi della Lega araba.
87
Cit. in Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin: der diplomatische Krieg zwischen der BRD und
der DDR 1955-1973 cit., pp. 206-7
88
Ergebnisniederschrift über deutsch-britische Konsultationen vom 25.7.67 in London betreffend
Afrika cit.
89
Ergebnisprotokoll der deutsch-französischen Konsultationen auf Dirigentenebene über Schwarzafrika am 30.6.67 in Paris, PA/AA: B 34, 730
90
Aufzeichnung über die Aktivität der SBZ in Afrika (ohne VAR) cit.
279
il razzismo
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi
alla radio e sulla stampa (1935 -36)*
di Mirco Dondi
Dalle immagini al significato: tratti di un percorso
L’essenza ultima della comunicazione è quella di essere una fabbrica di
significati e di valori che, in un regime dittatoriale, è favorita dall’omologazione del messaggio degli emittenti. Nei regimi autoritari l’informazione
trascende facilmente nella comunicazione, (lemma che contiene nel suo
significato una finalità di promozione che il termine informazione non ha)
e nella formazione, laddove si attua un meccanismo volto a fissare un’opinione in chi accede al messaggio.
Promozione e formazione si rivelano decisivi per creare l’immagine di
un’Africa che, a seconda delle finalità, appare affascinante o feroce (succosa
preda da conquistare, ma con abitanti da isolare) in una altalena di paradossi. La messe di immagini della quale è investita l’Italia (con fotografie,
stampe, cartoline, sequenze cinematografiche, ma anche fumetti e vignette
o articoli di giornali in quanto creatori di immagini attraverso opinioni) è
funzionale alla persuasione collettiva. L’immagine dell’Africa che il fascismo riesce a creare va oltre la durata del regime e si inserisce anche all’interno della costruzione dell’identità nazionale, chiamata a superare l’alterità
delle due Italie (il Nord e il Sud), attraverso la rappresentazione della radicale diversità antropologica dell’Africa, chiusa nella sua arretratezza1.
Il messaggio razzista diventa parte di questo percorso. In coincidenza
con la guerra di Etiopia, in Italia si verifica una campagna razzista, dettata
da più finalità, contro i neri africani. Il messaggio razzista richiama vecchi
stereotipi o ne crea di nuovi delineando l’altro in contorni semplici, sommari, ma netti. La stereotipizzazione razzista agisce attraverso la creazione di immagini (o l’interpretazione decontestualizzata di quelle esistenti)
281
Mirco Dondi
che il regime si preoccupa di infondere nell’opinione pubblica. La radio
e la stampa, in quanto mezzi di comunicazione di massa, sono strumenti potenti (pur con i limiti che si vedranno) per diffondere l’immagine
dell’altro2. La radio si impone per lo sforzo immaginativo ed evocativo nei
confronti dell’ascoltatore; la stampa allinea tutte le possibili argomentazioni persuasive che cartoline e vignette satiriche sintetizzano proprio con
un’immagine, nell’umore del momento, lasciando però indelebili tracce
del loro passaggio nella formazione degli italiani. Nei programmi radiofonici di evasione e nella stampa umoristica, il messaggio razzista passa
in maniera più efficace, grazie all’apparente innocenza della modalità che
parrebbe volta a suscitare il riso o a distrarre piuttosto che a convincere.
Per comprendere la costruzione del messaggio dei media, occorre partire dal contesto storico-ideologico verificando quanto e come il messaggio
razzista si riversa sui mezzi di comunicazione di massa. In particolare si
cercherà di dimostrare un percorso, evidente nel caso italiano, dove nazionalismo, colonialismo e razzismo sono elementi correlati, ciascuno a
sostegno dell’altro.
Razzismo, nazionalismo, colonialismo
Nella storia del fascismo italiano, come nella storia dei totalitarismi
e dei regimi autoritari del XX secolo, il razzismo si pone come uno strumento adattato a rafforzare un sistema di potere attraverso la codificazione
gerarchica dei governati3. La gerarchia che mira ad imporre l’ideologia razzista si annuncia come perpetua e insovvertibile e guarda all’altro – come
avviene nel caso dei fascisti verso gli etiopi – in qualità di figure stereotipate, prive di evoluzione, la cui condizione si profila come una condanna
definitiva all’inferiorità. Solo l’intervento dell’uomo bianco può produrre
un miglioramento delle condizioni di vita4. La pratica razzista è soggetta a
graduazioni diverse, nello stesso periodo e all’interno dello stesso regime,
come dimostra la vicenda del razzismo fascista nei confronti degli etiopi. Le
linee di pensiero che portano al razzismo sono diverse, così come differenti
sono le esecuzioni delle pratiche razziste, poiché non tutto l’antisemitismo
sfocia nell’inferno dei lager e non tutto il razzismo produce l’apartheid5.
Il caso italiano, diversamente da quello tedesco, presenta contenuti diversi intorno alle dottrine razziste. Le teorie del razzismo fascista possono
essere inquadrate in tre tipologie:
282
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
- il razzismo biologico, incentrato sull’elemento fisico e genetico;
- il nazional-razzismo che sottolinea il primato spirituale dell’Italia e il
suo legame psichico e biologico con l’antica Roma (parole chiave di questa
linea sono i termini civiltà e stirpe, quest’ultimo preferito a razza);
- il razzismo esoterico tradizionalista, di tutti il più intransigente, dove
per tradizione si intende «un corpus di conoscenze esoteriche di epoca
primordiale» basato sul rifiuto della modernità e costruito su una società
divisa in caste6.
Naturalmente queste teorie si affermano e si ampliano durante il fascismo, ma si basano su sedimenti preesistenti (la lunga tradizione dell’antisemitismo, il disprezzo verso i neri africani a partire dal XVI secolo). Tra
le dottrine razziste del fascismo matura sia un’interazione che uno scontro
benché, in questo periodo (1935-1936), all’avvio di una pratica razzista
non corrisponda l’adozione di una teoria né, negli anni successivi, ci sarà
spazio per una sola dottrina razzista7.
Lo sfondo dell’ideologia razzista è il nazionalismo8. I processi di nazionalizzazione maturano per contrasto e originano «una società unita da un
errore comune riguardo alle proprie origini e da una comune avversione
nei confronti dei vicini»9. Nell’Europa occidentale accanto all’orgoglioso
sentimento di appartenenza a una società nazionale – che si definisce con
il termine di patriottismo – si evidenzia anche un sentimento nazionalista che, nelle versioni più estreme, confligge con la democrazia. Il nazionalismo, come il razzismo, è un ordinatore gerarchico della società e per
questa funzione è richiamato da una parte delle classi dirigenti e delle élite
economiche e culturali europee; per contro la capacità del nazionalismo
di evocare un’immagine di grandezza e di superiorità nei confronti degli
altri stati riesce ad attecchire, in misura non trascurabile, anche fra i ceti
popolari. In Italia il fascismo si impossessa del messaggio nazionalista, divulgandolo fra le masse con una capacità che i nazionalisti non avevano
avuto. Ogni nazionalismo implica presupposti razzisti nel momento in
cui postula l’immutabile superiorità politica, culturale e morale della propria nazione sulle altre nazioni. Tra il patriottismo e il nazionalismo c’è un
confine labile10. Gli aspetti più evidenti nel passaggio dal patriottismo al
nazionalismo, si riscontrano nella volontà di aggressione e nella xenofobia,
ovvero nell’avversione a tutto ciò che è straniero, elemento sempre più ricorrente nell’ideologia fascista. Il regime autoritario (e ancora di più quello
totalitario) si caratterizza per la chiusura culturale di fronte all’esterno.
283
Mirco Dondi
Il passaggio dal nazionalismo a forme più nette di razzismo si ha con
la crescente attenzione sul sangue, sull’illusoria esclusività degli elementi
genetici che si vorrebbe caratterizzassero un popolo. In Italia i concetti razzisti passano, da argomento trattato da élite ristrette, a tema per masse più
vaste dopo la prima guerra mondiale, nel 1919. Un fascista dei primordi
come Filippo Tommaso Marinetti sostiene tesi razziste di marca biologica e
gerarchica che trovano nel primo Mussolini un ascoltatore attento11.
Con l’affermazione di regimi totalitari come il nazismo e il fascismo, il
razzismo giunge ad essere codificato da disposizioni di legge. (Le democrazie europee, anche se attuano pratiche razziste, si guardano dal codificarle).
Nelle dittature è più facile instillare politiche razziste perché il sistema di
governo si basa sulla contrapposizione manichea tra amico e nemico.
Nei regimi totalitari non basta diffondere l’idea di grandezza (tipica del
nazionalismo) e l’idea di purezza (tipica del razzismo), ma occorre spingere
l’opinione pubblica ad assumere atteggiamenti aggressivi di tipo bellico e
di tipo discriminatorio che non sono sempre immediati perchè possono
provocare gravi conseguenze per sé (la morte in guerra) e per gli altri (la
privazione della cittadinanza o la morte). L’obiettivo della propaganda è
quello di trasformare il razzismo da stereotipo culturale a comportamento
imposto. Condizionamento e coercizione spingono a uniformare i comportamenti e a presentarli come socialmente virtuosi. La società fascista é
totalmente investita dal messaggio nazionalista e razzista, in una mobilitazione che arriva a coinvolgere scienziati e intellettuali ed entra, in forma
invasiva, all’interno dei programmi scolastici12.
Il colonialismo rappresenta una forma di attuazione della politica
nazionalista, all’interno del perseguimento della politica di potenza. Alla base del colonialismo esiste una discriminazione razziale che ha come
presupposto di partenza una visione del mondo che divide i popoli in
due categorie: conquistatori e conquistati. L’idea di missione civilizzatrice
è un’illusoria sublimazione, un pregiudizio eurocentrico che strumentalmente ricorre in occasione della campagna di Etiopia. Il fardello dell’uomo
bianco – titolo della nota poesia di Rudyard Kipling13 – ovvero la missione
dei ricchi bianchi volta a civilizzare i selvaggi, è un fragile paravento per
celare relazioni internazionali basate sulla forza. La presenza di colonie riordina profondamente lo Stato nelle sue scelte politiche, culturali e anche
nell’orientamento religioso. Il messaggio razzista induce a rendere accettabile o trascurabile l’impiego della violenza, anche indiscriminata, nelle
284
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
colonie. Ciascuno stato ha attuato proprie politiche di gestione delle colonie differenziando il proprio atteggiamento, in particolare nel rapporto
instaurato con la popolazione indigena. Gli italiani si rivelano incapaci a
instaurare rapporti culturali e di scambio con le popolazioni locali, aspetto
invece riuscito a britannici e francesi, capaci di creare un corpo di funzionari locali collaborazionisti. L’occupazione coloniale riflette gli aspetti della
società colonizzatrice.
La visione coloniale del regime fascista risponde al disegno classico sostenuto da una parte delle élite liberali di fine Ottocento (Francesco Crispi
e Sidney Sonnino). Le colonie sono considerate un elemento di prestigio,
un luogo nel quale indirizzare i flussi migratori, la valvola di sfogo per
decongestionare il conflitto sociale promettendo oltremare quella terra che
ai contadini non si può dare in patria14; sono obiettivi però che né l’Italia liberale né l’Italia fascista riescono a conseguire. Negli anni trenta la
conquista coloniale è fuori dal tempo. Gli ampi investimenti militari e il
costante impiego della forza militare sono aspetti che non si conciliano con
la politica coloniale e che, nel caso italiano, ne spiegano il fallimento15.
La questione non si esaurisce dentro all’ambito coloniale perché il regime sta adottando una prospettiva diversa, che guarda all’ordine mondiale,
investendo gli equilibri europei. L’ormai imminente confluenza tattica e
ideologica con la Germania nazista è volta a creare una gerarchia di nazioni
che non riguarda soltanto europei e colonizzatori, ma investe sull’obiettivo
di creare un ordine nuovo, interno alla stessa Europa, sulla base di principi
storici, culturali e razziali. La campagna razzista contro i neri africani e i
mulatti prelude alla più ampia e intensa campagna antisemita che trova la
sua formulazione giuridica nell’autunno del 1938.
Creare una cultura per il destino imperiale
Nella narrazione ideologica cara ai nazionalisti, la nazione si rivela per
avere una storia lunga dai confini originari lontani e sfumati che, naturalmente, sono preesistenti allo Stato. L’ambizione di ogni nazionalismo è
quella di richiamare – con l’intento di farli rivivere – i momenti più fulgidi
della storia nazionale. La visione romana del fascismo non poteva prescindere dall’impero. A partire dal maggio 1936 e per il resto dell’anno (i mesi
della retorica imperiale), l’apparato propagandistico utilizza l’immagine
dell’impero a più fini:
285
Mirco Dondi
- mostrare che il fascismo coincide con il momento più alto della storia
passata divenendo vindice degli smacchi dell’Italia liberale (la sconfitta di
Adua e la «vittoria mutilata» della prima guerra mondiale);
- giustificare l’adozione delle leggi razziali in nome della purezza di
sangue dell’impero;
- competere (quanto meno nominalmente) con gli imperi coloniali britannici e francesi;
- porsi in un piano di parità con il nuovo alleato nazista.
Dalla vittoria nella guerra italo etiopica esce la proclamazione dell’impero (9 maggio 1936) che è concepita da Mussolini per imprimere, anche
nominalmente, una svolta al regime. Alessandro Lessona che nel 1936 diventa ministro delle Colonie, tre anni prima, quando la questione etiope non è ancora all’ordine del giorno, rammenta, in una manifestazione
dell’Istituto coloniale fascista, che per attuare una politica coloniale bisogna creare una coscienza coloniale nella popolazione che deve sostenere
questa scelta16. Nel momento in cui si avviano le operazioni contro l’Etiopia, non mancano le perplessità anche tra i seguaci del fascismo; i documenti della polizia, in quanto a scetticismo, mostrano una realtà distante
dall’unanimismo (in alcuni momenti si teme una possibile guerra contro
la Gran Bretagna), ragione per cui la propaganda si rivela uno strumento
indispensabile17. Su questo piano il ruolo dei media si rivela decisivo per
orientare ed entusiasmare gli italiani più scettici. Gli italiani sono stati più
avvinti che convinti dall’idea dell’impero, ma in ogni caso ne sono stati
temporaneamente trascinati. La conquista dell’Etiopia appare come una
risorsa di benessere, in grado di allontanare le difficoltà economiche e per
questa ragione anche i ceti proletari ne rimangono attratti18. La propaganda è altrettanto fondamentale nel momento in cui la conquista dell’Etiopia
resta una soluzione sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato: non è
l’Etiopia e la proclamazione dell’impero che può dare maggiore peso internazionale all’Italia; in politica interna, la conquista è presentata come una
missione rivelatrice di un destino – quello imperiale – che deve imporre
agli italiani nuovi comportamenti19. Dal 1935 in avanti il regime si impone di educare gli italiani attraverso la guerra. È in questo modo che la
missione diventa il salto in avanti nella costruzione dello Stato totalitario.
L’impronta razzista che caratterizza la campagna di Etiopia, appare
predeterminata da almeno due rilevanti elementi: il primo si riferisce alle disposizioni amministrative coloniali già vigenti (anche se non ancora
286
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
organiche), il secondo all’orientamento razzista di Mussolini e della classe
dirigente del regime. Su quest’ultimo elemento non mancano affermazioni e disposizioni che lo possono confermare. Con la campagna di Etiopia, il razzismo diventa un elemento di controllo dell’opinione pubblica
nell’ambito di un piano già elaborato nel gennaio 193320. A distanza di
quattordici mesi, nell’aprile del 1934, Mussolini nel suo discorso romano
al Teatro dell’opera, dopo avere ricordato la compattezza etnica, linguistica
e morale degli italiani annuncia che occorre battersi per la «difesa della
razza», proposito che, non a caso, dà il nome nel 1938 a una delle più compiute riviste razziste del regime volute da Mussolini21. Pochi giorni prima,
all’inizio del mese di aprile del 1934, Mussolini si adira per la pubblicazione del romanzo della scrittrice Maria Volpi, nota con lo pseudonimo
di Mura. L’opera, intitolata Sambadù, Amore negro, esce con l’importante
casa editrice Rizzoli e racconta la relazione amorosa tra un nero africano,
laureato in ingegneria a Firenze, con una donna italiana, relazione dalla
quale nasce un figlio. Il romanzo è posto sotto sequestro perché «offende la
dignità della razza». Il sottosegretario agli Esteri, Pompeo Aloisi, che aveva
travisato la trama pensando a una relazione di un italiano con una donna
africana, commenta nel suo diario: «Inammissibile da parte di una nazione
che vuole creare in Africa un impero»22.
La vicenda è legata al varo di un nuovo regime di censura – proprio
nell’aprile 1934 – che pur abolendo formalmente la censura preventiva,
sottopone i testi – ma l’ambito finisce per estendersi anche ai giornali – al
più efficiente controllo dell’Ufficio stampa di Mussolini che, oltre a valutare il carattere ideologico, ne sorveglia i contenuti razziali. Per Giorgio
Fabre questo provvedimento segna in anticipo una «svolta totalitaria e razzista»23. Si tratta di una intuizione che trova un’altra conferma. Alcuni mesi
dopo il varo del nuovo regime di censura, precisamente il 25 settembre,
Benito Mussolini scrive sul suo quotidiano, «Il Popolo d’Italia», un articolo
di impronta razzista dai toni apocalittici (la razza bianca rischia l’estinzione
dinanzi al progredire di quella nera e gialla). L’Africa diventa la soluzione
ai problemi nazionali e razziali. La virulenza dei toni mussoliniani non è
figlia di episodici livori, ma punta all’obiettivo della conquista dell’Etiopia
anticipandone i temi propagandistici e lo spirito razzista24.
All’interno di questo contesto si può comprendere il diverso peso politico che hanno le tre tipologie di messaggio razzista che investono gli italiani durante la guerra di Etiopia. Non avrà nessuna attuazione il razzismo
287
Mirco Dondi
assimilazionista, anche se serve per creare consenso all’interno; sarà altrettanto strumentale il tema della colonizzazione civilizzatrice che, agendo su
un pregiudizio eurocentrico, serve a legittimare l’azione di forza sul fronte
interno, ma soprattutto sul fronte esterno della politica internazionale; sarà
invece il razzismo segregazionista, in definitiva la forma meno propagandata
fino alla metà del 1936, a divenire la misura di una pratica di governo.
Il razzismo nelle colonie per l’impero, lo Stato totalitario, la gerarchia
Lo sforzo propagandistico del regime, maggiormente pianificato e risolto in forme di vasta mobilitazione collettiva, si ha in coincidenza con
la guerra di Etiopia (ufficialmente dall’ottobre 1935 al maggio 1936)25,
mai chiamata come tale dal regime. Uno dei massimi registi del battage
pubblicitario legato alla campagna di Etiopia è Dino Alfieri, un avvocato,
giornalista nazionalista divenuto fascista, protetto nella seconda metà degli
anni trenta da Galeazzo Ciano che ne favorisce l’ascesa a ministro della
Stampa e propaganda26. L’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa
permette al regime totalitario di aumentare il dispiegamento della sua pressione persuasiva. Attraverso la guerra di Etiopia il regime fascista intende
orientare l’opinione pubblica su più questioni (militari, razziali, di politica
interna, di politica estera) e richiede un’attenzione e una partecipazione
crescenti. Ha colpito l’opinione pubblica internazionale il raduno congiunto nelle piazze, tra le 18,45 e le 19,10, del popolo italiano il 2 ottobre
1935 per ascoltare la voce di Mussolini che, nell’occasione, dichiara l’Italia
pronta a seguire la sua politica di potenza. Il giorno dopo l’Italia dà inizio
alla guerra contro l’Etiopia, ma lo Stato africano nel discorso, nonostante
sia la ragione della contesa, è accennato soltanto in un passaggio, a dimostrazione dei diversi interessi che il regime intende attivare27.
L’investimento del regime nella campagna di Etiopia è cospicuo. Gli
ingenti mezzi militari impiegati sono finalizzati ad ottenere una rapida
vittoria attraverso la quale si vuole migliorare il controllo sull’opinione
pubblica – cercando di passare da un consenso passivo a un consenso attivo – e avanzare nella costruzione dello Stato totalitario. L’avvio di una più
esplicita politica razzista, a partire dalla campagna di Etiopia e dai successivi provvedimenti di stabilizzazione dell’area conquistata, porta progressivamente a un cambio di orientamento del regime che passa dalla linea
di integrazione – definibile come fascistizzazione della società (anche con
288
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
mezzi coatti) – a una linea di fascistizzazione differenzialista nella quale la
cittadinanza – fascistizzazione non sarà acquisibile da determinate categorie, come per la popolazione africana e, dal 1938, per gli ebrei.
Nella storia coloniale italiana le tentazioni segregazioniste non sono
mancate e sono precedenti al fascismo. Nella prima colonia, l’Eritrea, le
forme di discriminazione verso la popolazione locale risalgono al momento dell’insediamento, nel 1890, e proseguono nel 1909 con la distinzione delle scuole per italiani e per indigeni mentre nel 1916, nella capitale
Asmara, sono varate le linee di insediamento segregazionista, nonostante
rimanga operante il costume del madamato (una convivenza con caratteri
di servaggio tra il bianco e l’indigena, dove quest’ultima si deve occupare
dell’abitazione e del soddisfacimento sessuale dell’uomo, istituto che è un
eloquente paradigma della conquista del bianco)28. La divisione tra italiani
ed eritrei è applicata anche ai trasporti pubblici: ai bianchi è destinata la
parte anteriore del mezzo, ai neri quella posteriore. Quest’ultimo provvedimento si segnala come un’operante discriminazione di fatto che ottiene
una sistemazione giuridica, nell’ambito di una linea più radicale, il 31 luglio 193729.
La legislazione coloniale, anche in tema di razzismo, non è sempre stata
coerente, ma alla luce delle precedenti disposizioni per l’Eritrea, la gestione
del territorio etiope – marcata da un più consapevole razzismo – non spezza la continuità con il passato, all’interno di uno schema inevitabilmente
distante dal razzismo assimilazionista.
Il governo delle colonie, specie quelle dell’Africa orientale, diventa un
laboratorio che anticipa la leggi razziali del 1938. Il quadro legislativo del
regime nelle colonie punta al costante rafforzamento del bianco a scapito
dell’indigeno e, proprio nell’Africa orientale, è varata una compiuta legislazione segregazionista30.
A nemmeno un mese dalla conquista ufficiale dell’Etiopia e dalla proclamazione dell’impero, il 1° giugno 1936 è emanato il regio decreto legge 1019 Ordinamento e amministrazione dell’Africa orientale italiana che
adegua, con notevoli restringimenti, le precedenti disposizioni del 6 luglio
1933 riguardanti l’Eritrea e la Somalia. Dal precedente ordinamento sono
espunti quegli articoli che disciplinavano l’acquisizione della cittadinanza
metropolitana per i meticci (così al tempo erano definiti, nel linguaggio
giuridico, i figli di padre italiano e madre africana). Per i meticci figli di
ignoti è abrogata la possibilità del genitore italiano di riconoscere il figlio
289
Mirco Dondi
nato da una relazione con una donna africana. La legge precedente, pur
contemplando la possibilità di acquisizione della cittadinanza metropolitana da parte dei meticci, restava restrittiva. Al compimento del diciottesimo
anno, il meticcio sarebbe stato sottoposto all’accertamento dei requisiti
antropologici e culturali di italianità, necessari per ottenere la cittadinanza,
ma indiscutibilmente ispirati a un criterio razzista31.
La questione del meticciato è il riflesso di un costume diffuso nelle colonie italiane. La promiscuità tra italiani e popolazione locale è soprattutto
sfruttata per il soddisfacimento sessuale del colonizzatore. I lavoratori e i
soldati avevano rapporti con le prostitute, definite sciarmutte. Viceversa,
sin dall’inizio dell’esperienza coloniale, i funzionari civili e gli ufficiali potevano avere una donna-serva in affitto. Una parte di queste donne conviveva con il colonizzatore, altre, pur non convivendo, avevano relazioni stabili. Questo costume ha prodotto numerosi figli che spesso l’uomo italiano
non ha riconosciuto. Il destino dei figli era l’abbandono e l’isolamento
anche dalla comunità indigena e, per scongiurare questo tipo di vita, diversi missionari si erano battuti perché la legge offrisse la possibilità a questi
ragazzi di acquisire la cittadinanza italiana. Il provvedimento del 6 luglio
1933 recepisce, pur con i suoi evidenti limiti, questa richiesta. (Nell’ottica
razziale fascista il meticcio è una non razza).
Dopo la conquista di Addis Abeba, nel maggio del 1936, i rapporti
sessuali tra italiani e donne locali sono banditi. Il diffuso costume del madamato è abolito. Il comportamento dell’uomo nuovo fascista deve essere
volto al dominio, viceversa un’eccessiva familiarità rischia di confondere
le gerarchie (preoccupazione tema di veline del ministero della Stampa e
propaganda), ma dietro a questa ragione ufficiale, si rinviene l’esigenza di
evitare la procreazioni e la difficile gestione dei meticci.32 La legislazione
penale razzista, volta a tutelare la purezza della stirpe, compie l’inevitabile
passaggio, dal divieto alla punizione, contemplando il delitto di madamato
nel decreto legge n. 880 del 19 aprile 1937 che punisce con la reclusione
da 1 a 5 anni l’italiano che convive con una donna africana. Il reato è
quello di gettare discredito sulla razza italiana convivendo con una persona
di razza inferiore33. Il fascismo non vuole ripetere in Etiopia l’esperienza
della colonizzazione eritrea dove, secondo i dati riferiti al 1921 e al 1926,
i meticci sono un terzo della popolazione bianca residente34. Il decreto
dell’aprile 1937 mostra che non si tratta soltanto di un problema coloniale, ma di una visione globale razzista, dal momento che sono proibite le
290
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
relazioni coniugali anche «con uno straniero appartenente ad un popolo
con tradizioni, costumi e norme giuridiche analoghe a quelle dei sudditi
dell’Africa orientale italiana»35.
L’obiettivo del regime è quello di dividere le abitazioni degli italiani da
quelle degli indigeni, evitare ogni forma di familiarità tra italiani ed etiopi,
in un quadro di separazione che investe i luoghi pubblici come, ad esempio, i cinema e i bar36. Militarmente, la fase di conquista o di riconquista
dei territori si accompagna alla pratica degli stermini di massa che hanno
l’intento di annientare intere comunità37.
I provvedimenti legislativi separazionisti sono sostenuti dai quotidiani,
dalle riviste di tema coloniale («Rivista delle colonie», «Annali dell’Africa
italiana»), nella pubblicistica e nei convegni, ma la campagna contro gli
africani ha un’intensità decisamente minore rispetto alla campagna antisemita del 1938. Nell’opinione pubblica italiana, anche a causa di una tradizione culturale precedente al fascismo, esisteva una visione consolidata
circa «l’inferiorità» dei neri africani, al punto che «presentare i negri come
esseri inferiori non significava essere razzisti»38. Il maggiore martellamento
sull’opinione pubblica, in occasione della campagna antisemita del 1938,
si giustificherebbe allora in conseguenza dell’integrazione della comunità
ebraica in Italia e della difficoltà a individuare l’ebreo.
Diversi storici fanno risalire alla proclamazione dell’impero e all’estensione dei territori coloniali, l’origine delle legislazione razziale fascista39. In
realtà, anche se la consequenzialità degli eventi è corretta, la commistione
razziale non è la principale preoccupazione del regime. La politica razziale
è lo strumento impiegato dal regime per scandire le sue gerarchie ed imporre comportamenti.
In questa direzione l’ideologia ruralista è stata uno specchio delle gerarchie sociali, con le campagne che sono state assunte a metafora di una scala
sociale alla quale la Chiesa ha conferito la sua benedizione40. Lo schema
ruralista, come elemento ideologico, è però in declino nella seconda metà
degli anni trenta perché il progetto statale di Mussolini non è quello di
costruire un regime autoritario clericale ma, al contrario, è quello di affermare la progressiva autonomia del fascismo (quindi di Mussolini) dalla
Chiesa e dal re, il che significa rafforzare e completare lo Stato totalitario.
La politica razzista è funzionale a questo progetto, così come è altrettanto
adatta la virulenta campagna antiborghese che segue l’emanazione delle
leggi razziali, campagna volta a imporre nuovi comportamenti, più cinici
291
Mirco Dondi
e bellicosi, che l’»italiano nuovo» dovrebbe adottare nella società e verso i
nemici stranieri41.
Con la politica razziale, alla forza evocativa delle immagini delle quali
si nutre la campagna razzista, si abbina un corpo di leggi che fissano i
rapporti gerarchici. Benito Mussolini, in un celebre discorso a Trieste il 18
settembre 1938, nel pieno di una crescente campagna razzista, fa risalire
esplicitamente la politica razziale alla «conquista dell’impero» affermando
che «gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio»,
laddove con il termine prestigio si allude alla necessità di evitare commistioni di popolazioni diverse42. In altri termini: senza purezza di sangue e senza
gerarchia non può esserci impero.
Il razzismo fascista alla radio
Gli archivi dei programmi radiofonici dell’Eiar (Ente italiano audizioni
radio) sono, per gli anni trenta, incompleti ed estemporanei, conseguentemente non è possibile rintracciare tutti i testi trasmessi e analizzare la
strategia di comunicazione (il modo di costruzione del messaggio, ma anche la sua frequenza) circoscrivendo un periodo cruciale43. Per ricostruire
il discorso razzista alla radio, non resta che affidarsi ai materiali sparsi,
alle volte pubblicati dalle principali case editrici, calandoli all’interno della
specificità del mezzo. Quanto all’elaborazione dei contenuti, si parta dal
presupposto che il discorso razzista riduce la complessità a banali e mistificanti semplificazioni (si esorcizza in questo modo la complessità di una
modernizzazione tendenzialmente ingovernabile).
Gli aspetti razzistici della politica fascista sono riconducibili a più campi di intervento che il regime non manca di diffondere via radio. L’interesse verso lo sport sia nelle più alte espressioni agonistiche (nei programmi
«Cronache dello sport» e Radiosport»), sia nella sua pratica quotidiana
(con programmi didattici che invitano a praticare la ginnastica a casa) si
inserisce nel quadro di «esaltare la forza e la vitalità della razza italiana»44.
Analogamente, la politica di accrescimento demografica e le iniziative a
tutela dei neonati, rimandano a una finalità che è soprattutto di tutela
della razza45.
Il discorso razzista si inserisce nei differenti modelli di trasmissione di
ciascun medium. Ovviamente la modulazione del messaggio razzista si
adatta, per la radio, a seconda del tipo di programma trasmesso (intratte292
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
nimento o informazione) e così accade per la stampa che varia i suoi toni
(asseverativo, irato, faceto, ecc.) a seconda della natura della pubblicazione
(quotidiano, settimanale di cronaca, foglio satirico). All’analisi semiotica
del discorso razzista, occorre abbinare il potenziale pubblico di riferimento
che ovviamente non è mai un pubblico indistinto, ma sono segmenti individuabili di opinione pubblica.
L’impiego della radio a fine propagandistico è uno strumento nuovo
le cui potenzialità, controllate dal regime ma riconosciute in ritardo, non
sono pienamente sviluppate. La diffusione del mezzo in Italia non è ancora ampia e il ritardo degli abbonati alla radiofonia – rispetto alla Gran
Bretagna, agli Stati Uniti e alla Germania – riflette lo sviluppo inferiore
del Paese.
L’abbonamento radiofonico, i costi dell’apparecchio e della sua gestione sono altri ostacoli per un’ampia diffusione. La radio è un elettrodomestico diffuso prevalentemente fra la borghesia, media e piccola, e negli anni
trenta i ceti proletari ne sono ancora esclusi. Nella distribuzione geografica
ci sono più apparecchi in città che non in campagna e al Nord più che al
Sud. Il clima di mobilitazione, e di costruita euforia che accompagna la
guerra all’Etiopia, vorrebbe rendere la penetrazione degli invasori italiani
nel territorio africano alla stregua di una avventura. Per l’Italia è la prima
guerra che ha copertura radiofonica e questo aumenta l’interesse verso le
notizie, unitamente all’interesse di quanti hanno i familiari arruolati in
Africa (circa 330.000 soldati e quasi 100.000 operai militarizzati)46. È proprio a partire da questo momento che il regime dedica particolare attenzione alla radio47.
Il 1936 è un anno prodigo di eventi: la vittoria ufficiale della guerra,
proclamata a maggio, le polemiche contro la Società della nazioni (a causa
delle sanzioni inflitte all’Italia per avere attaccato lo stato etiope che della
Società delle nazioni è membro), ma anche le olimpiadi di Berlino – come
occasione di svago – contribuiscono a un’impennata degli abbonamenti
radiofonici che raggiungono in quell’anno la cifra di 697.062 unità, con
una crescita di oltre 140.000 abbonamenti nell’anno successivo quando
si raggiunge la quota di 839.582. Soltanto quattro anni prima, nel 1933,
gli abbonati erano meno della metà, 372.807. La cifra degli abbonati è
inferiore agli apparecchi in circolazione essendo presente una porzione di
pubblico che riesce ad evadere l’obbligo dell’abbonamento48.
La vicenda etiope segna una tappa importante anche per l’espansione
293
Mirco Dondi
della radio, con notevoli investimenti in nuovi impianti che raggiungono
le località dell’Africa Orientale nelle stazioni di Asmara e Addis Abeba
destinate a diffondere le trasmissioni di radio Roma. (Anche la Francia e
la Gran Bretagna producevano trasmissioni radiofoniche nei territori coloniali)49. Dinanzi ai crescenti obiettivi del regime (la guerra di Etiopia, il
consolidamento dello stato totalitario) oltre ad aumentare l’interesse verso
il mezzo di trasmissione, si incrementano i programmi di informazione a
discapito dell’intrattenimento. La pressione degli eventi spinge verso una
trasformazione del mezzo di comunicazione.
La forza di persuasione dei nuovi mezzi di comunicazione come la radio, il cinema e i suoi cinegiornali risiede nella novità e in quell’alone di
mistero che ne accompagna, per i più, l’inconoscibilità tecnica. Negli anni
trenta i media non sono ancora usurati, sono recepiti ingenuamente e non
ne è ancora colta da chi ne usufruisce, se non in minima misura, l’enorme capacità di manipolazione e infingimento. Questo aspetto illustra il
fascino che può esercitare il medium, ma l’attrazione e la curiosità non
implicano che il mezzo, in questo caso la radio, si riveli efficace nel rimodellare l’identità, e le opinioni. La radio ha influito solo in minima misura
sul costume, soprattutto in rapporto all’effetto che nei decenni successivi
ha prodotto la televisione. Questo discorso acquista ulteriore pertinenza al
cospetto delle alte aspettative del regime durante la campagna di Etiopia.
Tanto più sono elevate le attese del persuasore, tanto più ampia può essere
la distanza tra l’obiettivo e il risultato ottenuto. Incide, sulla stampa come
sulla radio, non solo la possibilità materiale di raggiungere il pubblico, ma
anche il tasso di analfabetismo (che nel 1931 è segnalato al 17,4 per cento
per gli uomini e al 24,2 per cento per le donne) senza contare le più alte
percentuali di semianalfabetismo, l’incompleta uniformità linguistica del
Paese, tutti elementi che staccano porzioni consistenti di opinione pubblica dalla lettura dei giornali e da una piena comprensione del messaggio
radiofonico50.
La pubblicazione dei testi dei programmi di maggiore successo o ai
quali è attribuita rilevanza politica, il ruolo di traino all’ascolto radiofonico esercitato dal settimanale ufficiale dell’Eiar – «Radiocorriere»51 – e la
partecipazione, nelle vesti di commentatore politico, di alcuni dei più noti
giornalisti del regime, rendono la radio un’impresa editoriale all’interno di
un’industria culturale ancora ristretta.
Per la radio, se si parla di ascolto individuale e familiare, si può indivi294
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
duare un pubblico mediamente istruito (il pubblico colto tende a rimanere
scettico verso il mezzo), specialmente gli elementi più giovani dei ceti medi
piccolo-borghesi delle zone urbane52. Il pubblico privilegiato dei media
(cinema, radio, giornali) si può identificare nelle commesse e nei commessi
dei grandi magazzini, negli impiegati di aziende private, nei piccoli commercianti, negli artigiani, nei dipendenti statali e parastatali dei gradi medi
e bassi53. Ciò non toglie che, nell’ottica del regime, il pubblico radiofonico
sia da permeare perché può fungere da cinghia di trasmissione del messaggio fascista anche verso coloro che, con fatica, accedono all’informazione
benché il gusto e l’ideologia del regime riesca a penetrare con più efficacia
nelle trasmissioni di intrattenimento che non in quelle di formazione/informazione.
Rispetto agli studiosi della stampa, quelli della radio, più influenzati
dalla sociologia e dalla metodologia delle comunicazioni di massa, si sono
posti il problema di valutare non solo il messaggio, ma il grado di ricezione del messaggio attraverso lo studio del pubblico radiofonico54. Nel caso
dell’ascolto della radio, al mutamento della modalità di ascolto (personale
e nell’ambito familiare oppure collettivo e coatto nei punti pubblici di
diffusione) cambia il livello di ricezione.
Le trasmissioni ad ascolto collettivo e coatto (ad esempio la radio rurale, i programmi per le scuole elementari e medie, ma anche i discorsi di
Mussolini) si caratterizzano per la semplicità del messaggio. Si evince, dai
documenti dell’Ufficio stampa e propaganda, che le trasmissioni ad ascolto
collettivo servono per orientare quelli che sono considerati gli strati più
bassi della popolazione e, tale modalità di ricezione delle trasmissioni, è
ritenuta particolarmente adatta per l’indottrinamento degli etiopi, magari facendo ricorso allo «stile immaginario che sa colpire l’indigeno». Un
documento del 7 giugno 1937, sulla radiodiffusione nell’Africa orientale
italiana, contiene tutte le espressioni più tipiche del razzismo nei confronti
del popolo conquistato. Si va dal tono paternalistico, di chi apparentemente concede, «la nostra opera di propaganda e di assistenza spirituale e
culturale non deve limitarsi soltanto alla popolazione metropolitana [italiana]» al tono sprezzante di chi, rifiutandosi di capire la cultura del luogo,
preferisce rifugiarsi nello stereotipo: «Data la mentalità degli indigeni, naturalmente portati alla bugia e a dar credito alle più iperboliche menzogne,
non vi è chi non veda l’utilità di un servizio di propaganda che possa far
giungere a essi […] la voce vera e autorizzata del governo»55.
295
Mirco Dondi
Si coglie da queste note sull’ascolto collettivo come lo «stile immaginario» non sia deputato soltanto a colpire l’indigeno, ma gli stessi italiani.
Dentro a questo tipo di programmi l’aspetto argomentativo degrada
in quello emozionale, favorito dalla ricezione collettiva che più facilmente
genera un’interazione fra i soggetti in ascolto. Nella propaganda all’interno
della Penisola, tra una presa di posizione ideologica (la campagna antinglese) e un messaggio più marcatamente razzista (contro gli africani prima
o contro gli ebrei dopo) la ricezione del pubblico, specialmente quello a
più basso livello di istruzione, assorbe più facilmente ciò che è più vicino
ai propri stereotipi. Alla visione non sempre univoca nel messaggio razzista
verso gli africani, e non sempre omogeneamente instillata, si pone come
contraltare un marcato messaggio antinglese i cui effetti sull’opinione pubblica appaiono evidenti al punto che, per gli osservatori stranieri, Mussolini appare meno antibritannico di quanto non lo sia la popolazione56. Sulla
questione antinglese, ma questo vale per ogni massiccia campagna contro
qualcuno e qualcosa, ai segnali di distensione internazionale che si manifestano con il Gentlemen’s agreement del 1937, non corrisponde un analogo
allentamento della tensione nell’opinione pubblica. I messaggi introiettati
non sono diffusi soltanto dalla propaganda attraverso i media, ma sono
parte di una trama di relazioni sociali che investe l’educazione. Il regime
sedimenta atteggiamenti che, non di rado anche inconsapevolmente, vanno oltre la sua durata57. Si pensi al caso del più popolare radiocronista sportivo del regime, Niccolò Carosio, il quale continua a caratterizzare le sue
cronache negli anni della repubblica per la puntigliosa assenza di anglicismi, ma mostra anche di non avere abbandonato l’indole razzista quando,
durante i campionati del mondo di calcio di Messico ’70, apostrofa con il
termine «negraccio» un guardalinee etiope «colpevole» di avere segnalato
un fuorigioco all’Italia58.
Uno dei programmi di cui esiste un’ampia raccolta di testi pubblicati, fino al maggio 1936, è Cronache del regime, una rubrica popolare di
commento politico ai fatti del giorno favorita dall’orario di messa in onda
– dopo il giornale radio delle 20 – per una durata di 15 minuti. È chiaro
l’intento di avere concentrato all’ascolto, in quell’ora, la maggior parte del
pubblico adulto. Il commentatore quasi esclusivo della trasmissione nella
sua prima fase è Roberto Forges Davanzati, un nazionalista convertito al
fascismo, un giornalista di primo piano, senatore, membro dal 1923 del
Gran Consiglio del fascismo, direttore del quotidiano romano «La Tribu296
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
na» e con interessi anche nel mondo della cinematografia, sul quale ricade la piena fiducia di Mussolini. Forges Davanzati scompare il 1° giugno
1936, creando qualche problema all’Eiar per la sua sostituzione, tant’è che
la rubrica Cronache del regime torna soltanto il 23 settembre.
Il programma rappresenta una svolta per l’intento formativo che si prefigge sul pubblico («l’espressione forse più smaccata della propaganda fascista alla radio» oppure «una delle realizzazioni più strumentali ed efficaci
dell’informazione59) ed è la prima iniziativa importante di Galeazzo Ciano
in qualità di responsabile per la Stampa e la propaganda60. Di fronte alle
alte aspettative del regime, il commentatore incontra l’elogio dei critici radiofonici e la piena fiducia dei dirigenti dell’Eiar che definiscono la rubrica
una «cattedra radiofonica di politica e di sociologia»61. Non è rilevante soltanto il contenuto della trasmissione, ma è altrettanto importante, ai fini
dell’obiettivo di formazione del pubblico, che sia conferita autorevolezza
al suo conduttore.
Sono ricorrenti gli interventi di Forges Davanzati che puntano a sminuire lo stato etiope di Hailè Selassiè agli occhi dell’opinione pubblica. Nel
1935 Forges Davanzati ribadisce in due commenti dell’8 e del 15 maggio
che l’Etiopia non è una nazione e questo appare, dallo sguardo del colonizzatore, una ragione in più per acquisirne i territori62. È vero che l’Etiopia
deve ancora avviare il suo processo di nazionalizzazione, e deve affrontare
una situazione dove 12 milioni di abitanti sono divisi da appartenenze tribali e 70 lingue diverse. Intrigo, omicidio e guerra civile rappresentano la
norma63. In Etiopia, il potere dei grandi latifondisti (ras) è in concorrenza
con quello centrale ed assume ancora connotazioni di tipo feudale, ma la
riforma avviata da Hailè Sellassié, nel 1931, punta a ridimensionare il potere dei ras locali a vantaggio del potere centrale. Nel 1930 Hailè Selassiè
(il suo nome di battesimo è Lij Tafari Makonnen) diventa imperatore e nel
1931 disegna un sistema bicamerale. Nonostante il cammino sia ancora
lunghissimo, la riforma di Hailè Selassiè guarda lontano ed è animata da
un’ottica modernizzatrice pur all’interno di contraddizioni, tra innovazione e arcaicità, presenti nella stessa figura di Selassiè.
In Italia, naturalmente, non giunge notizia dei tentativi modernizzatori
etiopi. La stampa – e i commenti di Forges Davanzati ne sono un esempio
– si concentrano sulla necessità di dominio in una sorta di traduzione geopolitica darwiniana di selezione della specie che, in questo caso, autorizza
i più forti a sottomettere i più deboli. Questo aspetto, ovviamente, nella
297
Mirco Dondi
propaganda non è ridotto nei termini di forza bruta, ma è apparentemente
edulcorato dalla retorica della colonizzazione civilizzatrice. Appartiene a
un eurocentrismo razzista anche l’affermazione che «la politica dell’Italia nell’Africa orientale […] è una politica della quale deve essere giudice
l’Italia; è una politica che deve essere valutata in Europa, senza riferirsi al
formalismo ridicolo o malizioso di considerare l’Etiopia su un piano europeo, solo perché un giorno è entrata a far parte dell’ordine alfabetico degli
stati della Società delle nazioni»64. Il passaggio è contraddittorio. Non si
capisce come l’Italia possa essere giudice di una politica sulla quale finisce
per richiamare il giudizio degli altri. Agli interlocutori europei (soprattutto
Francia e Gran Bretagna), si vuole rammentare che l’Etiopia è un corpo
estraneo che non può pretendere di alterare gli equilibri decisionali dei paesi che comandano. Il fascismo non riconosce la parità (ancorché formale)
degli stati nella Società delle Nazioni e questa è una delle ragioni che accelera la crisi dell’organismo mondiale. Nella visione fascista l’Etiopia, non
può pretendere di allinearsi con le principali nazioni europee, nonostante
sia stato il primo stato africano ad essere entrato nel 1923 nella Società
delle nazioni, un aspetto che non si rivela soltanto un incomodo dettaglio.
L’aspetto più paradossale della vicenda è che, nel 1922, era stata proprio
l’Italia a battersi per l’inclusione dell’Etiopia nella Società delle nazioni e,
la Gran Bretagna, si era inizialmente opposta sostenendo che non si poteva
ammettere uno stato che al suo interno ammetteva la schiavitù65.
Gli strali che Forges Davanzati indirizza alla Società delle nazioni,
nell’estate del 1935, non sono ancora connotati dall’antisemitismo. La Sdn
è definita un «agente dell’imperialismo britannico», uno «strumento di
una congiura massonica», un «feticcio pseudo giuridico»66.
Nel discorso di Mussolini del 2 ottobre 1935 l’ostilità nei confronti
della Francia e della Gran Bretagna non è ancora presente perché le sanzioni contro l’Italia sono emanate dalla Società delle nazioni il 18 novembre,
dopo la condanna dell’aggressione italiana effettuata dalla Sdn il 7 ottobre. Alla vigilia dell’attacco, Mussolini indirizza a Francia e Gran Bretagna
messaggi d’amicizia. Entrambi gli stati, secondo il dittatore, sono composti
da un popolo «autentico», quello di Francia è definito anche generoso, di
contro si sottolinea l’assenza di dissidi tra Gran Bretagna e Italia67.
Nei mesi che precedono l’attacco italiano (già a novembre del 1934 gli
etiopi avevano inviato alla comunità internazionale formali proteste contro
gli sconfinamenti degli italiani nel loro territorio), il discorso propagandi298
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
stico, tipico dei commenti radiofonici di Forges Davanzati, tende a porre
in cattiva luce l’Etiopia rovesciando su questo stato le intenzioni dell’Italia.
Il 17 maggio 1935 Forges Davanzati afferma che «se c’è un colonialismo
crudele, spogliatore e violento è quello degli abissini» rimarcando l’inadempienza dell’Etiopia nei confronti della Società delle nazioni dato che lo
stato etiope si era impegnato ad abolire la schiavitù68. In effetti negli anni
venti – con Hailé Selassiè al governo in qualità di reggente – in Etiopia è
stato avviato un processo, che non ha trovato compimento, per superare i
rapporti semischiavistici di natura medioevale.
Il razzismo fascista alla radio tra il 1934 e il 1936, alla luce delle fonti
sinora disponibili, non sembra animato da propositi organici. Il topos della
colonizzazione civilizzatrice si associa a forme di razzismo bellico che investono principalmente Hailè Selassiè e sembrano risparmiare i costumi e il
modo di essere degli africani. I programmi e le argomentazioni cercano di
sollecitare soprattutto la razionalità dell’ascoltatore. Le ragioni che portano
a questa caratterizzazione sono legate al periodo (la guerra non è ancora
terminata e un razzismo più aggressivo legato alla difesa dell’impero non è
ancora disvelato) ma anche, in parte, alla considerazione che i programmi
italiani sono captati all’estero.
«Gerarchia» ovvero i giornalisti e i temi del regime
All’inizio degli anni trenta, e in forma sempre più accentuata nel corso
del decennio, il regime si avvia ad intensificare il controllo sulla carta stampata. Il salto in avanti si ha con il passaggio da un’informazione di giornalisti fedeli (o costretti alla fedeltà) a un’informazione più centralizzata e
controllata, come mostra la sempre più rigida strutturazione del ministero
della Stampa e propaganda che, con la riforma dell’ottobre 1936, assume
una struttura speculare al ministero Per la propaganda e l’educazione popolare tedesco69.
Attraverso le sue brevi note di informazione – più famose con il termine veline –, il ministero indica cosa e come evidenziare e cosa omettere. Il
mensile «Gerarchia» può essere assunto, in questo ambito di ricerca, come
una testata che offre ai giornali lo sviluppo tematico degli argomenti da
evidenziare. «Gerarchia» è la rivista ufficiale del fascismo, fondata nel 1922
da Mussolini. Si può leggere questa testata come espressione della Weltanschaung mussoliniana. Ecco perché il mensile «Gerarchia», benché non sia
299
Mirco Dondi
largamente diffuso, si presta ad essere un interessante osservatorio dei toni
e degli argomenti proposti all’attenzione dell’opinione pubblica.
Il raffronto di impostazione che viene qua proposto tra una rivista «alta» come «Gerarchia» e le pubblicazioni satiriche mostra, meglio di altri
esempi, come funziona la circolarità tra alta e bassa cultura politica nel
sistema fascista.
In questi anni «Gerarchia» è diretta da Vito Mussolini, nipote del dittatore, figlio del fratello Arnaldo. Nonostante la sua esistenza ricopra tutta
la vita del regime, «Gerarchia» si avvale di un numero ristretto di collaboratori alternando, nella sua composizione, politici, uomini di cultura e
giornalisti, un’élite di potere e prestigio accomunata dalla stretta osservanza
al fascismo. Tra i giornalisti si ritrova Forges Davanzati, ma anche Mario
Appelius, romanziere e giornalista fra i più noti, fascista della prima ora e
redattore del quotidiano della famiglia Mussolini «Il Popolo d’Italia». Appelius, come Davanzati, condivide l’esperienza del commento radiofonico.
Tra le principali firme di «Gerarchia» si trova sin dal 1922 Paolo Orano,
un giornalista che sostiene posizioni razziste prima che diventino legge
(comune posizione di antisemitismo clerico-fascista con Roberto Farinacci
anch’egli collaboratore della rivista e direttore del quotidiano «Il Regime
fascista»)70. Orano come Appelius ha rivestito un ruolo di rilievo nel quotidiano «Il Popolo d’Italia», ricoprendone la direzione tra il 1924 e il 1925.
La carriera di Orano investe anche l’ambito accademico. Mussolini
designa Orano titolare della cattedra di Storia del giornalismo a Perugia,
ma anche Forges Davanzati ottiene l’insegnamento nell’ateneo umbro nel
corso di Legislazione della stampa71. Un altro collaboratore di «Gerarchia»
è Fernando Mezzasoma che scrive nelle testate più militanti del regime (dirige «L’Assalto di Perugia», assume la condirezione di «Libro e moschetto»
che è il quindicinale delle organizzazioni giovanili del regime alla quale
collabora anche Paolo Orano) occupandosi della propaganda fra i giovani
e divenendo direttore generale della stampa nel 1942. Tra i direttori di
quotidiani scrive su «Gerarchia» uno dei più noti giornalisti italiani, Luigi
Barzini senior, che a metà degli anni trenta guida «Il Mattino» di Napoli.
Un altro tra i principali collaboratori di «Gerarchia» è Alfredo Signoretti, fascista della prima ora e tra i più noti giornalisti del regime. Su incarico
di Mussolini dirige la rubrica di politica estera del giornale per 13 anni (dal
1922 al 1935). Come Orano e Forges Davanzati, anche ad Alfredo Signoretti è assegnato un prestigioso incarico didattico avendo insegnato Politica
300
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
internazionale alla Scuola fascista di giornalismo. Signoretti dall’agosto del
1932 dirige «La Stampa» di Torino che riesce a rilanciare portandola ad
avere la seconda redazione per numero dopo quella del «Corriere della
Sera», e collocandola come secondo quotidiano più diffuso nel Paese riuscendo, in alcune circostanze, anche a superare il quotidiano milanese.
La nutrita presenza di uomini capaci di ricoprire più cariche come direttori di quotidiani (in vari momenti, tra quelli citati, Barzini, Farinacci,
Forges Davanzati, Malaparte, Mezzasoma, Orano, Signoretti e lo stesso
Vito Mussolini), come docenti e come alti gerarchi del regime, rende la
rivista come la migliore espressione dell’élite di potere. Benito Mussolini
affida al ruolo dei direttori dei giornali (più ancora che ai proprietari delle
testate) la chiave di controllo del regime sulla stampa72. Questi cenni ai
giornalisti che hanno collaborato con «Gerarchia» mostrano fedeltà indiscusse, percorsi incrociati, il travaso privilegiato – grazie al comune direttore – con «Il Popolo d’Italia» e posizioni di potere con dirette diramazioni
su più testate. Da queste annotazioni si evince il motivo che rende «Gerarchia» un importante riferimento nel panorama giornalistico italiano73. La
stampa diventa l’approdo, in quanto forma di potere, delle più eminenti
figure del regime (oltre a quelli già menzionati: Cesare Balbo direttore del
«Corriere padano», Giuseppe Bottai direttore di «Critica fascista», Virginio
Gayda portavoce semiufficiale per la politica estera, direttore del «Giornale
d’Italia», e commentatore radiofonico). Si riferisce probabilmente a questa
élite, Edward Tannenbaum quando definisce il fascismo come «regno dei
giornalisti» e individua nella stampa quotidiana il mezzo di comunicazione più congeniale per il regime che può valersi, nella stessa persona, di
dirigenti politici e professionisti della carta stampata, impegnati a a propagandare numerosi argomenti74. D’altro canto il regime ha sempre attribuito un’importanza cruciale alla stampa come strumento di educazione
collettiva e, per evitare ogni possibile distorsione del messaggio desiderato,
un ruolo chiave nel controllo della stampa è stato affidato alla censura,
che si è avvalsa – dal 1934 – degli stessi giornalisti come addetti stampa
nelle prefetture75. È probabilmente grazie a questo regno dei giornalisti
che Tannenbaum designa l’efficacia della stampa italiana per inculcare il
conformismo in una forma maggiore rispetto a quella nazista perché in
Italia, rispetto alla Germania, rimangono i migliori professionisti che prestano la loro opera per gli obiettivi del regime76. La considerazione vale
per la campagna di Etiopia, ma la rimarcata efficacia persuasiva tenderà a
301
Mirco Dondi
scemare negli anni successivi, nonostante il capillare impianto di controllo
sulla stampa77.
Come osservato per la radio, anche il territorio principale di diffusione
della stampa è la città, annotazione che va accentuata nel caso di una rivista
come «Gerarchia».
Le sanzioni del novembre 193578 contribuiscono a compattare l’opinione pubblica e a fornire al regime un tema di propaganda efficacemente sfruttato79. La disciplina sanzionatoria rinchiude ulteriormente l’Italia
esacerbandone i caratteri nazionalisti, permettendo la costruzione retorica
dell’uno (l’Italia) contro tutti. In questa sfida con il mondo, si sostiene che
il popolo italiano riesca a mostrare la sua superiorità: «l’antica dignità della
nostra stirpe, la più nobile di tutte, è stata ritrovata, riconsacrata in pieno».
La superiorità crea un divario al cospetto di «un’umanità che già fu civile».
Il popolo italiano resta l’unico testimone della civiltà del mondo, «unico
spettacolo veramente epico e commovente è quello della nazione italiana»
dimostratasi compatta «senza più intensificarsi di propaganda»80. Sono argomentazioni ipernazionalistiche del mensile «Gerarchia» che sostiene il
concetto razzista della superiorità italiana.
Nello stesso numero di «Gerarchia» del gennaio 1936, suffragando
una tendenza presente nella stampa già dal 1932, compare un articolo
che condanna l’uso dei termini stranieri nel linguaggio, rimandando a un
criterio extrascientifico di purezza che è parte della retorica razzista. Come
l’Italia è superiore agli altri popoli del mondo, allo stesso modo i lemmi
dell’italiano «sono espressioni intime che rivelano la superiorità del nostro
linguaggio». Il purismo linguistico non è sostenuto da necessità filologica,
ma è imposto da un’esigenza spirituale che deve unire in un corpo unico il
popolo di Mussolini. I termini stranieri non sono seri, «rovinano il legame
più saldo della nostra nazionalità» e sono disprezzati alla stregua di «cianfrusaglie», «arzigogoli», «bazzecole»81.
Come non ritrovare in queste considerazioni l’eco di Giovanni Gentile
sul fascismo come forma e spirito, o ancora di più, la campagna di italianizzazione forzata condotta dal segretario del Pnf Achille Starace, longa
manus di Benito Mussolini. L’attenzione nei confronti del linguaggio non
è un elemento sporadico in questi anni e costituisce un elemento di complemento, ma rafforzativo, delle campagne nazionalistiche totalitarie che
il regime intraprende. La difesa del linguaggio rientra anche nella programmazione radiofonica, come le conversazioni dedicate alla difesa della
302
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
lingua italiana. Non mancano iniziative più strutturate, con fini propagandistici, rivolte all’estero di cui un tipico esempio è l’Università radiofonica
italiana, attiva alla fine del 193882.
Il tema razzista, nel pieno corso della guerra contro l’Etiopia, compare
nelle pagine di «Gerarchia» e anche se non assume la frequenza che si riscontra durante la campagna antisemita del 1938, non è priva di toni netti
e sprezzanti. È il caso dell’articolo siglato Silus intitolato I popoli non si
inventano sul traliccio delle razze. Nel quadro dell’accesa polemica del regime contro gli stati europei (Francia e Gran Bretagna) che forniscono armi
agli etiopi, l’articolista nota che una mitragliatrice nelle mani di un abissino non ne eleva il livello di civiltà. Il riferimento alla civiltà è abbinato a
una visione razzista spirituale quando si afferma che la civiltà è «sull’anima
dell’uomo, sul suo valore morale e spirituale», tratti, come si evince dalla
elementare allusione, che l’etiope non possiede. Il valore della razza è stato
smarrito dalle democrazie occidentali europee (da qui i frequenti riferimenti alla loro decadenza) perchè vorrebbero «salvare una civiltà senza più
nemmeno la forza elementare della razza»83. (Per capire la pretestuosità di
queste accuse e la natura strumentale del razzismo italiano, si rammenti
che anche la Germania nazista fornisce armi all’Etiopia, nonostante si sia
ritirata dalla Società delle nazioni nel 193384. Naturalmente i media italiani non danno risalto a questo particolare).
In questa fase il razzismo fascista non è di natura biologica, ma è prevalentemente legato a una concezione storico-culturalista. L’evoluzione della
civiltà è letta come un percorso spirituale: se il comune possesso di un’arma
automatica avesse il potere di equiparare le civiltà «allora la storia si ridurrebbe a un progresso di utensili e di divise e di armi»85.
La filosofia della storia del regime lega, al percorso evolutivo della civiltà, il destino dello Stato che, nel caso italiano, ha conosciuto un percorso
ascendente legato a tre tappe: il Risorgimento (che ha unificato l’Italia), la
prima guerra mondiale (che nella visione mussoliniana segna l’irruzione
della volontà delle masse di mostrare il loro protagonismo attraverso la
volontà di combattere) e la rivoluzione fascista86.
L’Etiopia diventa lo sbocco per tornare una grande potenza; rinunciare a questa conquista significherebbe relegarsi a «Nazione di secondo e
terz’ordine», ma non si può tornare indietro dopo le tre tappe che hanno
ricostruito la nazione87.
Nel frattempo Mussolini nei suoi discorsi, tra la fine di marzo e l’inizio
303
Mirco Dondi
di maggio del 1936, costruisce il climax che parte dall’assedio europeo
dell’Italia, causato dalle sanzioni, alla proclamazione dell’impero. Nel discorso del 23 marzo il dittatore prepara l’opinione pubblica alla vittoria, la
lascia presagire, ma conclude con un riferimento nazionalistico – razziale:
«l’assedio societario [le sanzioni] ha collaudato la tempra della stirpe e,
come non mai, l’unità delle anime»88.
Il 5 maggio Mussolini proclama la conclusione vittoriosa della guerra
(in realtà il conflitto non è terminato e il controllo sull’Etiopia è destinato
a rimanere incompleto e si concentra sulle principali città) e dipinge i conquistati come genti mansuete «che hanno dimostrato per chiarissimi segni
di voler vivere e lavorare tranquillamente all’ombra del tricolore d’Italia»89.
Il percorso storico dell’Italia si compie con la proclamazione dell’impero, riannodando un destino interrottosi quindici secoli prima con la fine
dell’impero romano.
Nel corso del primo semestre del 1936 la visione delle popolazioni abissine non è omogenea tra i collaboratori di «Gerarchia». Renato Famea nel
suo articolo con velleità geopolitiche (secondo l’autore la Gran Bretagna è
contraria al controllo italiano dell’Etiopia perché ciò sarebbe una minaccia
sulla via di comunicazione con le Indie), descrive l’Abissinia come una terra «popolata da genti di un certo livello civile, che debitamente inquadrate,
potranno subito costituire un numeroso e temibile esercito»90.
Per quanto questa affermazione mantenga un carattere di indefinibilità, è in contrasto con quanto, nello stesso numero della rivista descrive
Raffaele Guariglia che riportando le affermazioni di Lady Simon, moglie
di un ex ministro degli Esteri britannico, afferma che in Etiopia ci sono
due milioni di schiavi su una popolazione di dieci milioni, che è presente
la servitù della gleba, che si praticano mutilazioni, torture, antropofagia in
un quadro di leggi primitive91. Chi, tra Famea e Guariglia, afferma il vero?
In realtà, come si vedrà nel caso delle vignette satiriche, la rappresentazione
dell’Etiopia è strumentale a ciò che in quell’istante si vuole dimostrare.
Soltanto due mesi dopo questi articoli, quando la conquista sull’Etiopia
appare prossima, lo sguardo del colonizzatore si presenta nella sua veste
più deteriore: gli etiopi diventano un popolo «di razza inferiore» e «la loro
spiritualità è trascurabile»; si tratta di uno strato sociale privo di opinione,
ormai educato ad obbedire a chi lo mantiene e tanto più obbedirà a chi lo
retribuisce del suo lavoro»92.
304
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Le riviste satiriche al servizio delle politiche razziste
La formula giornalistica può spingersi sino all’invettiva e all’insulto,
ma l’ironia consente di agire sui significati iperbolici e deformanti con
apparente leggerezza e maggiore efficacia. Il giornale può essere percepito
dal pubblico come uno strumento di convincimento, a differenza di altre
forme apparentemente più neutre o di svago, come la letteratura d’avventura, le canzoni, le vignette umoristiche e, più in generale, l’insieme dei
prodotti dell’industria culturale. Questi strumenti, meglio di altri, creano
lo spirito del tempo e producono una forma di persuasione indiretta che
agisce potentemente sulla costruzione dello stereotipo razzista.
La scelta di analizzare disegni e vignette è suggerita dalla considerazione che il razzismo, più di altre ideologie, ha bisogno di collegare le parole
con le immagini ed è attraverso l’efficace rappresentazione dell’altro (specie se deformata) che il messaggio razzista può diffondersi divenendo un
concetto facilmente assimilabile. Come la radio, in uno dei programmi
radiofonici di svago più amati degli anni trenta, I Quattro moschettieri, ha
permesso, meglio di altri strumenti, di consolidare luoghi comuni e pregiudizi nei confronti degli stranieri93.
Le riviste satiriche, dopo un periodo di congelamento in seguito al giro
di vite contro la stampa decretato da Mussolini nel gennaio 1925, tornano
a comparire quando il fascismo è consolidato. Nel 1931 nasce a Roma una
delle testate più popolari: «Marc’Aurelio». Dopo un iniziale periodo di difficoltà, a causa della presenza nella redazione di giornalisti provenienti dalla testata satirica antifascista «Il Becco giallo», «Marc’Aurelio», dopo avere
esaudito le richieste del regime, arriva a raggiungere in breve tempo una
tiratura di 100.000 copie, ma si spinge, nei momenti di maggiore successo,
intorno alle 600.000 copie considerando i due numeri settimanali94. In
questa stagione riprendono vita anche fogli con una tradizione alle spalle:
«Il Travaso delle idee», che fra questi è il più antico essendo nato a Roma
nel 1900, «Il 420» (compare a Firenze nel 1914) e «Il Guerin meschino».
Valutando il mercato satirico in espansione, l’importante editore milanese Angelo Rizzoli lancia nel luglio 1936 un nuovo settimanale, «Bertoldo»,
avvalendosi degli umoristi migliori del periodo, tra gli altri: Vittorio Metz,
Giovanni Mosca (provenienti dal «Marc’Aurelio»), e Giovanni Guareschi.
È infatti dopo la guerra di Etiopia che il mercato dei fogli umoristici
trova nuovo slancio, con sei pubblicazioni diffuse su tutto il territorio na305
Mirco Dondi
zionale. Il pubblico dei lettori si trova in larga misura fra i giovani, per lo
più studenti, per lo più cittadini che preferiscono «Marc’Aurelio» e «Bertoldo»95. Tra le riviste indicate, quella che maggiormente predilige i toni
politici è «Il 420», che ha i fasci littori disegnati nella testata, ed esprime
una satira rude e aggressiva. Per una rivista che affronta il tema politico –
con circa i tre quarti delle vignette nell’annata 1936 – la derisione non può
che indirizzarsi verso i politici stranieri o comunque al di fuori dell’Italia.
Queste pubblicazioni hanno un impatto non trascurabile considerando
che, mediamente, una copia è letta da tre o quattro persone. In conseguenza della crescente influenza della stampa satirica, il ministro Per la Stampa
e propaganda, Dino Alfieri, convoca il 20 gennaio 1937 una riunione con
i direttori dei sei principali periodici umoristici96. Il ministro consegna
un promemoria dove è specificato chi e che cosa si può denigrare. Gli
argomenti oggetto di derisione non sono semplicemente consentiti, ma
finiscono per diventare obbligatori perché – è scritto nel promemoria ministeriale – «la stampa umoristica ha il preciso dovere di prendere di mira
tutti gli atteggiamenti non in armonia con il modo di vita insegnato dal
fascismo»97.
Da questo punto di vista il messaggio razzista passa attraverso gli stessi
canoni nelle diverse riviste. La differenza tra una rivista e l’altra si può scorgere, soprattutto nei toni, legati ad altri temi98. Tra le direttive indicate nel
promemoria, quella sul razzismo è particolarmente eloquente: «La stampa
umoristica può e deve combattere l’ibridismo di razza facendo apparire
come inferiori, fisicamente e moralmente le razze di colore (per esempio
mettendo in rilievo la bruttezza delle negre, la distanza che separa in fatto
di civiltà i bianchi dai neri, ecc.)»99.
La circolare del gennaio 1937 non segna, in apparenza, nessuna novità.
La linea enunciata dal ministro appartiene a un registro già impiegato dalle riviste, le quali devono espungere dai loro contenuti ogni elemento di
esoticità affinché gli uomini che partono per l’Africa non abbiano relazioni
sessuali con donne del luogo.
La rappresentazione dell’inferiorità etiope conosce nel tempo ragioni
diverse, a seconda delle necessità politiche di ciascun momento.
Nelle vignette del biennio 1935-36 si possono distinguere almeno tre
approcci nei confronti dell’Etiopia. Esiste una linea minoritaria (tendenzialmente presente dal 1935 alla proclamazione della vittoria nel maggio
1936) di marca razzista, ma meno aggressiva e volgare, che si può definire
306
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
di colonizzazione civilizzatrice volta all’assimilazione.
Nell’ambito della colonizzazione civilizzatrice si rinviene un’altra linea,
più aggressiva, animata da un disprezzante razzismo bellico che non prefigura alcuna società futura100.
La terza linea, che rimane anche dopo il maggio 1936, assume i tratti
del razzismo separazionista. Queste tree linee si riferiscono a diverse pratiche razziste: il razzismo assimilazionista che integra i soggetti annullandone
la precedente identità culturale; il razzismo bellico che inculca la visione
del nemico come essere inferiore e diverso (alleggerendo gli scrupoli dei
soldati perché non combattono contro un nemico che è come loro) e il
razzismo separazionista (rintracciabile nei contributi satirici) che crea le
premesse per la costruzione di una società segregazionista volta ad escludere
i soggetti dalla comunità sulla base della diversità di appartenenza.
Colonizzazione civilizzatrice e assimilazione
Nei confronti dell’Etiopia non si afferma la linea assimilazionista. L’insistente derisione e disprezzo per le popolazioni etiopi consolida i pregiudizi e rende la distanza sociale incolmabile, elemento che favorisce l’accettazione della linea segregazionista.
La colonizzazione civilizzatrice appartiene al canone del razzismo paternalista europeo, che, convinto della sua «superiorità», ritiene di elevare,
lo stile di vita dei conquistati. La liberazione dalla schiavitù è un tema
utilizzato sia nelle vignette sia nelle cartoline coloniali diffuse fra l’esercito.
L’idea di affrancamento dalla schiavitù è un aspetto divulgato in ogni media e in ogni variante (come si vedrà anche per la canzone Faccetta nera).
L’insistenza con il quale l’argomento è richiamato, mostra come il regime
ritenesse il tema idoneo a convincere l’opinione pubblica, anche quella più
restia verso il fascismo. Allo stesso modo, l’argomento è sollevato dinanzi
all’opinione pubblica europea, per giustificare le ragioni dell’intervento.
Nei disegni la civiltà è indissolubilmente legata al fascismo, come appare
dalla serie di cartoline per l’esercito disegnate da Giovanni Bonora (fig.1).
In un corpo di cinque disegni sono rappresentati soltanto bambini italiani (vestiti da fascisti) e bambini locali (nudi o seminudi). I tratti addolciti del disegno – che investono di tenera simpatia anche i bambini africani
– allontanano dai soldati l’idea della guerra, immergendoli in un irreale, e
apparentemente innocente, mondo dell’infanzia. La serie mostra due bam307
Mirco Dondi
Figura 1
bini fascisti che liberano dalle catene i bambini africani (La liberazione),
due bambini italiani che delicatamente porgono il rancio ai bambini africani (Il rancio italiano). La cartolina – La doccia salutare – (fig.2) mostra
i due bambini italiani spruzzare la doccia su due bambine africane dentro
a un secchio. Il significato poco edificante che la scena evoca (gli africani
sono sporchi), è addolcito dal sorriso divertito di tutti e quattro i soggetti
ritratti. Nella figura 1 un’immagine è dedicata al tema della lezione. Gli
africani appaiono lieti di apprendere. L’atmosfera fra educatori ed educati è
gioviale, pur nel paradosso – intimamente razzista – di bambini della stessa
età (chi proviene da una civiltà «superiore» può insegnare all’altro). Il titolo, Attenti alla lezione, rimanda a qualche possibile errore di apprendimento – il bambino fascista ha una mano sull’orecchio del bambino africano
–, ma il rimprovero è benevolo e il bambino africano è assimilato, come
mostra il fez fascista, che indossa. Nella cartolina Comune allegria (fig. 1)
i due bambini italiani sono intenti in un ballo di coppia con le bambine
africane, altri due bambini italiani suonano tromba e fisarmonica (la danza e gli strumenti sono rigorosamente del colonizzatore) e un bambino
308
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Figura 2
africano salta felice da solo con la bandiera italiana. Sono bambini, ma le
scene di ballo evocano ai soldati l’idea di una possibile, facile intimità con
le donne africane.
Colonizzazione civilizzatrice e razzismo bellico
Giocando su un paradosso comico, il tema della schiavitù è ripreso
nella vignetta di Bruno Caluri, Le belle trovate abissine, dove si vede un
dignitario etiope che lamentando la requisizione del suo cavallo da parte
del Negus, allestisce un cavallo – ma l’effetto vuole che sia più simile a un
cammello – utilizzando due schiavi, una in fila all’altro, ricoperti da un
lenzuolo (fig.3)101.
Il filone della colonizzazione civilizzatrice parte da un razzismo istintivo, scarsamente meditato. In questo contesto «si scherza» dipingendo
gli africani come cannibali e spingendoli agli antipodi della civiltà. Nella
primavera del 1934 un commediografo fascista, Luigi Chiarelli, allestisce
una commedia, Carne bianca, che ha come protagonista un africano nero,
309
Mirco Dondi
Figura 3
colto, simpatico, ma cannibale102. Il cannibalismo è uno degli stereotipi
più radicati, specie in riferimento all’Africa nera. Il pentolone, nel quale
gli africani cucinano la loro vittima, è una raffigurazione tramandata da un
altro contesto, quello europeo dei diavoli e delle streghe, che ha inizio dalla metà del Cinquecento: «il calderone dei cannibali non viene dalla loro
cultura, ma dalla nostra»103. Come i diavoli e le streghe diventano – attraverso la pratica diabolica – categorie stigmatizzate, allo stesso modo questo
forte segnale di chiusura ed estromissione dalla civiltà tocca agli africani.
È un’ironia grossolana che utilizza la deformazione nella rappresentazione
figurata e nel linguaggio, in alcune occasioni all’interno dello stesso disegno (fig.4). La raffigurazione corporea dell’africano è costruita giocando o
sull’eccessiva magrezza o sulla grassezza, in quest’ultimo caso abbinandola all’antropofagia. In una vignetta del 1935 su «Marc’Aurelio» intitolata,
Africa mangia, si vede un africano disteso sotto una palma con una pancia
a forma di enorme pallone e due bianchi che osservando la scena commentano: «hai visto che affare hai fatto a insegnare a quel negro il gioco degli
scacchi? S’è mangiato la regina»104. Al di là di quello che il vignettista può
310
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Figura 4
considerare un aspetto ludico, il messaggio esprime l’inutilità e l’impossibilità di istruire gli africani, destinati a ricondurre gli insegnamenti ai loro
canoni e quindi a rimanere inferiori.
Da sempre il tratto della vignetta vuole che qualunque volto sia rappresentato deformato e caricaturizzato, accentuando o immettendo difetti.
Il principio, nel disegno dell’uomo africano, è applicato all’eccesso ricorrendo alla facile metafora zoologica, evidente nel profilo scimmiesco di
sproporzionate mascelle e nelle bocche grandi e deformi, altro segno che
rimanda all’antropofagia. I corpi, quasi sempre nudi, sono un altro segno
dell’assenza di civiltà così come gli oggetti portati dagli uomini – asce e
lance – rimandano a una civiltà ai primi passi. Non è soltanto l’apparenza
a denotare il carattere inferiore delle genti etiopi, anche l’interiorità delle
persone finisce per essere pesantemente offesa. Hailè Selassiè è rappresentato come un rimbecillito che scambia la corona con il vaso da notte105
mentre in una cartolina satirica di Ligrano, stampata nel 1935, si unisce il
tema dell’arretratezza con quello della codardia dei soldati. Il disegno del
vaso da notte, distribuito da un capo etiope armato di spada ai suoi uomi311
Mirco Dondi
ni, è l’unica arma che hanno i soldati per la difesa aerea106.
In ogni caso «lo scherzo» porta alla estraniazione del soggetto rappresentato. La ripetizione di quello che può apparire come uno stereotipo accidentale o una reminiscenza, introietta il modello di un razzismo sempre
più cosciente che finisce per rimandare a più significati.
Rientra in un modello che si sta staccando dalla colonizzazione civilizzatrice la vignetta di Bepi Russi Tra una «società» e l’altra, apparsa su «Il
420» del 28 luglio 1935. Qua il vignettista non si accanisce particolarmente sulla deformazione fisica dell’africano, ma il rimando al mondo animale
resta evidente nel significato dello scritto e negli altri oggetti del disegno;
siamo in piena campagna contro la Società delle nazioni colpevole di avere
emanato le sanzioni contro l’Italia. Il quadro di Russi ritrae, l’imperatore
etiope scalzo, i suoi piedi sono grossi e arrotondati certamente più simili a
una zampa. Dal ritratto esce un uomo barbuto, con un poncho corto, in
mano ha una specie di sombrero e un fucile primordiale mentre in testa
porta un copricapo corto di piume. L’abbigliamento non è propriamente
africano e si mescola ad elementi tipici di altre culture (quella messicana
con poncho e sombrero), in una composizione pacchiana dove l’effetto desiderato è quello della messa in ridicolo107. Il leader etiope non è chiamato
con il suo nome da imperatore (Hailè Selassiè) titolo che non gli viene
riconosciuto dal disegnatore, ma storpiando una parte del suo nome (Lij
Tafari Makonnen) dove Tafari diventa Tafanari. L’imperatore etiope si accinge a varcare il portone della Società delle nazioni, ma davanti all’entrata
è fermato dal portiere dell’edificio («il portiere intelligente» commenta il
vignettista al cospetto di «Tafanari» che non lo è. La situazione include
un altro messaggio: un qualunque portiere bianco è più intelligente di un
dignitario etiope). Sullo sfondo del disegno si vedono due costruzioni: la
Società delle nazioni con la sua architettura classicheggiante, con colonna e
capitello, e una più modesta casa colonica sulla quale si legge la scritta «Società protettrice degli animali». A questo punto il portiere «intelligente»,
indicando la Società protettrice degli animali, esclama: «Ma perché non si
rivolge a quella?».
La vignetta di Bepi Russo non rimanda più al messaggio della colonizzazione civilizzatrice. I numerosi significanti contenuti nel disegno sono
soliti rendere una vignetta particolarmente riuscita. In un disegno e in
una battuta, sotto il timbro dell’ironia, la vignetta sortisce l’effetto di condensare, con maggiore efficacia, l’editoriale del giornale. Il razzismo istin312
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
tivo è qua superato dall’ambizione di instillare un orientamento politico
all’interno di una precisa situazione. Rimanda a un messaggio di animalità
anche la vignetta, apparsa su «Il 420» il 2 febbraio 1936, intitolata Il civilissimo delegato etiopico a Ginevra, dove il diplomatico africano scambia un
negozio di ortopedia per una trattoria e chiede al primo ministro britannico, Antony Eden che si intravede di spalle ma che è responsabile della
situazione, come si mangia nel locale (fig. 5)108.
Accanto al disprezzo verso il nero si unisce il razzismo bellico nei confronti del nemico. Il bersaglio preferito dei giornali satirici, dal più elegante «Bertoldo» al più ruvido «Il 420», diventa Hailé Selassié, ras Tafari,
sciocco, pavido, marito inadeguato, impotente, sbeffeggiato dai bambini,
spietato con i sudditi e inviso dai suoi sudditi109. «Il 420» dedica un rubrica, in vignette e in brani satirici, alla vita coniugale di Selassié intitolata
«Tra Negusso e Negussa»110. Il Negus appare morbosamente attaccato al
denaro, spesso è raffigurato abbondantemente più basso della moglie (in
effetti era alto soltanto un metro e 62 centimetri, 4 centimetri in più del
re d’Italia) e, non di rado, viene anzitempo detronizzato (una vignetta lo
Figura 5
313
Mirco Dondi
ritrae come suonatore di strada mentre esegue Faccetta nera che la moglie
balla)111. La moglie, quasi sempre a seno scoperto, non ha mai le stesse
sembianze; a volte è disegnata con una fisiognomica animalesca, altre volte
è seducente.
Generalmente, se l’asserzione della moglie mette alla berlina il Negus,
la donna appare con tratti gradevoli112. L’aspetto che sembra divertire di
più i satiri, a giudicare dalla frequenza, è proprio quello della detronizzazione che conosce molte varianti, dal negus mendicante – e sono gli inglesi
a lasciare l’elemosina –, al negus fenomeno da baraccone, immaginato assieme agli altri ras abissini a esibirsi ballando il can can «sui palcoscenici di
Piccadilly» con reggiseno e culotte o, ancora, il Negus, rimpicciolito, nella
tuba di un prestigiatore al posto del coniglio113.
Un destino gramo, ma in definitiva migliore rispetto a quello di Selassiè, è riservato dalla satira al primo ministro britannico Antony Eden,
colpevole di proteggere l’Etiopia. Eden, pur odiato, non diventa lo zimbello dei satiri e la frequenza delle vignette a lui dedicate da «Il 420» è
inferiore.
Il personaggio di Eden è caricaturizzato, ha gli incisivi da coniglio, magari è travestito da donna, ma non è raffigurato, in quanto bianco, con tratti
animaleschi114. Eden rimanda all’immagine della Società delle nazioni che
ha difeso l’Etiopia, ma – ironizza macabramente una vignetta – se a Ginevra c’è nero su bianco (con le sanzioni), in Etiopia c’è bianco su negro115.
La donna africana: raffigurazioni dell’assimilazione e della segregazione
L’animalità degli africani conquistati ricorre nella loro nudità, alla quale spesso si accompagna un irsutismo scimmiesco che non risparmia nemmeno le donne. Specialmente nella raffigurazione femminile, l’ideologia
razzista può scandire i suoi codici estetici che stabiliscono un confine nella
riconoscibilità. Il razzismo assimilazionista può arrivare a concepire – come mostra la figura 7 – un passaggio di confine che invece resta invalicabile nel razzismo separazionista.
Fino alla proclamazione dell’impero, la tematica della colonizzazione
civilizzatrice è funzionale alla persuasione interna ed internazionale, ma
raggiunto l’obiettivo prefissato, la propaganda fascista si scosta dalla colonizzazione civilizzatrice quasi rinnegandola e arrivando persino a pole314
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
mizzare con chi, in maniera più convincente, l’ha sostenuta. Il predominio
assoluto del razzismo separazionista è un cambiamento di toni che impone
anche un cambiamento di abitudini agli italiani che vivono in Africa, ma è
reso possibile dal profondo substrato di disprezzo che il fascismo ha sempre
nutrito nei confronti delle popolazioni africane. Il cambiamento di toni è
il riflesso di un cambiamento di politica che, sul piano internazionale, vede
uscire l’Italia dalla Società delle nazioni e avvicinarsi alla Germania nazista.
L’idea della colonizzazione civilizzatrice appare ormai, irrimediabilmente,
un espediente momentaneo e strumentale.
L’itinerario della rappresentazione femminile è uno specchio fedele dei
due volti del razzismo fascista, all’interno di una convivenza dove l’elemento civilizzatore è un velo di apparenza e il razzismo più spietato è la sostanza. Ciononostante il passaggio da una visione rapace – assimilazionista a
una visione puramente separazionista impone, nel modello propagandista,
una decostruzione della precedente immagine esotica che, agendo su pratiche e convincimenti radicati, richiede tempi lunghi e sortisce scarso effetto
nel breve periodo.
Nei romanzi di ambientazione coloniale degli anni venti e dei primi
anni trenta si rivela una gerarchia netta ed immobile sulla base della razza
dei personaggi. La donna africana, ancorché gradevole nei tratti, appare
incapace di provare sentimenti autentici.
Per lo scrittore più prolifico di romanzi d’ambientazione coloniale, Gino Mitrano Sani, la donna, sia araba (quindi libica) o dell’Africa orientale,
è uno strumento del piacere dell’uomo anche quello più brutale e spietato.
Nel romanzo E per i solchi millenari delle carovaniere, della protagonista
araba, Auria, non si riporta nemmeno una parola. Ricorrente nella letteratura di quest’autore – che ha combattuto in Africa – la definizione di donna nei termini di «cosa», «bestiola» (appellativo che compare in Femina Somala)116. In queste pagine emerge il disprezzo verso gli arabi e una furiosa
volontà di dominio, sulle donne e sugli uomini, qualunque sia lo scenario
calcato. La donna somala non conosce il sentimento, ma l’abitudine ed è
un oggetto a disposizione di chi lo vuole utilizzare.
L’idea della colonizzazione civilizzatrice può convivere con l’esotico
purchè questo possa essere facilmente addomesticabile. Il tema esotico
rappresenta una variante, un’esca, soprattutto verso gli uomini, per suscitare curiosità e spirito d’avventura. Le vignette raccolgono le voci correnti
quasi a suffragarle. Nel gennaio 1936, nel pieno della campagna militare in
315
Mirco Dondi
Figura 6
Etiopia, la vignetta di Fernando Elefante, Terra… vergine (fig.6), incentra
sul tema esotico sessuale l’attrattiva all’arruolamento e, in ogni caso, incita
l’immaginario maschile portandolo ad essere ben disposto nei confronti
dell’Etiopia, raffigurata nelle vesti di una gradevole donna disponibile, seminuda, ingenua. Si tratta di rappresentazioni che, a livello più profondo,
possono indurre allo stupro coloniale117. La donna è vista come un frutto
della vittoria e in questa direzione il regime non indugia a stampare, con
successo, numerose cartoline di attraenti donne etiopiche, spesso ritratte
a seno nudo, sacrificando il moralismo cattolico al più importante fine
bellico118.
L’apice della rappresentazione della colonizzazione civilizzatrice e del
316
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
razzismo assimilazionista è segnato dalla vignetta di Giove Toppi che si
firma «Stop» L’evoluzione della donna abissina, apparsa il 21 giugno 1936, a
poco più di un mese dalla proclamazione dell’impero (fig.7). Toppi disegna
tre volte la stessa donna, in una sequenza temporale: ieri (prima dell’arrivo
del fascismo), oggi (con l’arrivo del fascismo), domani (con l’educazione
fascista). Sopra al titolo ieri, la donna è disegnata probabilmente vicina alla
realtà, almeno nell’aspetto. È una giovane con un sobrio e pudico vestito
tradizionale, aspetto non trascurabile rispetto alla prevalente raffigurazione del nudo. La donna è scalza e porta un bambino sulle spalle. I tratti
somatici non sono particolarmente deformati, si nota un accenno di steatopigia, ma nulla rimanda all’idea dell’animalità. Sotto al titolo «oggi» la
donna è trasformata, la sua espressione non è più triste, ma è sorridente. Al
cambiamento dello stato d’animo corrisponde un cambio d’abito. Ora la
donna indossa un occidentale, allegro, vestito lungo a pois e calza un paio
di scarpe con il tacco. Il bambino non è più in spalla, ma la mamma lo
sorregge in braccio stringendolo al petto. Rispetto alla raffigurazione «ie-
Figura 7
317
Mirco Dondi
ri», il bambino ha in mano il tricolore italiano. Nella raffigurazione «oggi»
la donna è mutata anche fisicamente, la sua steatopigia è scomparsa e la
sua figura è più slanciata. L’abbellimento fisico della donna è ancora più
pronunciato nella raffigurazione «domani». L’effetto realizzato è pari a un
intervento di chirurgia estetica, con la riduzione del naso e delle labbra. Il
messaggio è che l’acquisita bellezza dipende dall’assorbimento dell’educazione fascista. La rappresentazione della donna etiope in «domani» è iperbolica, ma in questo caso l’umorismo è involontario. La donna etiope ha
smarrito la sua identità africana e assomiglia piuttosto a una sophisticated
lady, a una diva dei telefoni bianchi, un modello decisamente irraggiungibile anche per la donna media italiana. Persino il colore della pelle, nella
raffigurazione «domani», è ormai schiarito e sono di gran pregio gli abiti
e gli accessori che la donna indossa, come la raffinata pochette, tenuta con
quella necessaria disinvoltura che impone il mutato portamento. Si assiste
a un ulteriore cambiamento anche nell’espressione. Dal sorriso ingenuo
della seconda raffigurazione si è passati espressione di cosciente fierezza.
Anche il fanciullo segue il percorso della madre: nell’ultima raffigurazione
è vestito da fascista con il fez e, autonomo ed orgoglioso, non è più in
braccio ma cammina.
La vignetta di Toppi è lo schema perfetto della colonizzazione civilizzatrice, i tratti razzisti sono, al tempo stesso, forti, ma non particolarmente
evidenti dinanzi al pubblico. È il razzismo paternalista dell’evoluzione del
conquistato, ma è pur sempre razzista perché si impone di omogeneizzare
il conquistato e di annullarne la precedente identità.
Lo spirito della vignetta di Toppi – la donna nera che diventa italiana e
fascista – si ritrova espresso nella popolarissima canzone cantata da Carlo
Buti e scritta da Renato Micheli, Faccetta nera, che diventa l’inno fascista
della guerra di Etiopia accompagnando le marce delle truppe italiane. Il
motivo è scritto dapprima in romanesco, nel 1935, e il suo straordinario
successo apre una disputa legale sui diritti. Il titolo Faccetta nera non è
dispregiativo, sia per il vezzeggiativo –ripreso anche nel testo «Moretta che
sei schiava» – sia per il riferimento al colore della pelle nera e non negra
(metricamente poteva essere usato il termine negra per quanto meno musicale e lirico di nera). Il brano è un crescendo di promesse a una schiava,
irrealisticamente immaginata mentre scorge dall’altopiano le navi italiane
«come in un sogno». La bandiera italiana ha un significato di liberazione
318
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
e di offerta: «un tricolore sventolar per te». Il messaggio è chiaro: siamo
venuti a liberarti, a liberarvi, «ti daremo un’altra legge e un altro re». Non
più schiavitù, se non «schiavitù d’amore», immancabile lirismo erotico per
soldati. La donna non è vista solamente come preda ed è nobilitata dal
fatto che ci sono «eroi caduti liberando te». Faccetta nera diventa fascista,
quasi si allude alla cittadinanza, «sarai in camicia nera pure tu», «sarai romana» e il testo si spinge oltre: «ti porteremo a Roma», non da schiava, ma
da persona libera (per quanto si potesse essere liberi sotto il fascismo) e,
quasi a dare un senso di parità di questa fascista tra i fascisti, nella chiusa si
promette: «noi marceremo insieme a te e sfileremo avanti al duce e avanti
al re». Ovviamente dentro a questo testo c’è anche altro, come l’associazione tra la terra da «liberare» – nel linguaggio lirico di facciata – e la donna
da conquistare.
«Il suo testo esprime la cultura e le relazioni sessuate che accompagnarono la conquista dei territori africani fino alle soglie dell’“impero” fascista e – da questo punto di vista si inserisce perfettamente in quella che
Anne McClintock definisce porno-tropic tradition – quella tradizione che,
da Colombo in poi, erotizza lo spazio geografico che il colonizzatore va
conquistando»119.
Una volta proclamato l’impero e resi palesi dal regime gli intenti separazionisti fra italiani e africani, il razzismo che omologa il conquistato
alla cultura del conquistatore non è più sufficiente, deve essere bandito.
Per quanto la canzone avesse contribuito a rendere popolare la guerra
d’Etiopia, diffondendo un’idea bonaria del fascismo che ne ha accresciuto
il consenso, Renato Micheli, subito dopo la proclamazione dell’impero,
subisce un cruento e non casuale attacco da parte del giornalista Paolo
Monelli, una delle penne più seguite del giornalismo fascista, anch’egli tra
i collaboratori di «Gerarchia». «La Gazzetta del popolo» di Torino è diretta
da Ermanno Amicucci (principale teorico e organizzatore del giornalismo
italiano) il quale imprime alla testata una linea così visceralmente fascista
al punto che Mussolini, quattro anni prima, aveva definito il giornale, in
un telegramma al direttore, «sulla china della quotidiana insulsaggine»120.
Proprio per questa ambizione di assoluta fedeltà, Amicucci – che è un alto
dirigente fascista – è pronto a divulgare la nuova posizione sul razzismo da
una testata che dispone di ingenti mezzi e si impone, anche per la tiratura,
come uno dei principali quotidiani italiani. L’articolo di Monelli, che ac-
319
Mirco Dondi
cusa la canzone Faccetta nera di incoraggiare i rapporti tra i soldati italiani
e le indigene, appare il 13 giugno 1936 in prima pagina con il titolo Moglie e buoi dei paesi tuoi121. Più che una scoperta tardiva è il segnale di un
cambiamento di politica da parte del regime. Tra le ragioni che spiegano
l’acrimonia nei confronti del motivo, la trasformazione d’uso del brano
che, proprio in virtù del suo successo, da canzonetta è diventata un inno
politico, collocato però ormai fuori dalla linea del regime. Le parole del
motivo musicale – indica Monelli – sono frutto di una mentalità («atteggiamento romantico e sdolcinato, corrotto dal vizio e dall’affettazione»)
che «dobbiamo assolutamente eliminare […] se vogliamo costruire un impero». Alle ragioni politiche legate all’idea dell’uomo nuovo fascista – che
per quanto chiare possono non arrivare a tutti –, Monelli associa le ruvide argomentazioni del razzismo segregazionista: le donne africane sono
sempre sporche e maleodoranti, «sfatte a vent’anni; per secolare servaggio
amoroso fatte fredde ed inerti fra le braccia dell’uomo». L’articolo contiene
un passaggio costruito come uno sketch di avanspettacolo, per amplificare
l’effetto di sbeffeggiamento. Sostiene Monelli che, se avesse avuto la possibilità, avrebbe voluto prendere l’autore della canzone per farlo «vivere due
o tre settimane, che dico? due o tre giorni, e giuraddio che basterebbero
anche due o tre ore in una capanna abissina con una facetta nera. Con
una di queste abissine, Galla o Amhara, o Sciangalla o Scioana, gli lascio il
piacere della scelta, tutte sudicie di un sudiciume antico»122.
La polemica sancisce la fine della rappresentazione del razzismo assimilatore che «Il 420», aveva raffigurato nella forma più efficace appena
quindici giorni prima con il disegno di Toppi L’evoluzione della donna
abissina. Quale immancabile eco agli strali di Paolo Monelli benedetti dal
regime, «Il 420» pubblica una crudele vignetta di Carlo Domenici che
alludendo all’articolo di Monelli, si intitola Le parole… e i fatti al burro
rancido (fig.8)123. Vi sono raffigurate due donne, magre ma deformi – piene di orecchini, ciondoli, anelli e collane – dai lineamenti scimmieschi;
una donna chiede: «Chi è quel bianco che passando di qua è scappato via
tappandosi il naso?» L’altra donna esibisce un’improbabile ma didascalica
risposta: «L’autore di Faccetta nera».
Il bianco che scappa dalla donna maleodorante suggerisce l’idea della
segregazione come una ovvia necessità, anche volendo la convivialità è impossibile e non servono altri contenuti.
Non soltanto la stampa satirica – come è normale nei processi di co320
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Figura 8
municazione – è strettamente legata, nei tempi e nei temi, alle polemiche
giornalistiche. Nell’omologazione del regime i satiri non possono che riadattare il concetto al loro linguaggio. La polemica contro Faccetta nera
spinge addirittura a indire un’importante conferenza coloniale (che si tiene
a Trieste all’inizio di luglio) nella quale il ministro della colonie, Alessandro Lessona, annuncia una rigida politica contro la promiscuità razziale. I
provvedimenti adottati sono a loro volta seguiti da una nuova campagna
di stampa che rimarca la necessità della separazione124.
L’immagine della donna africana diviene, ancor più di quella dell’uomo
africano, il punto reale dal quale si consolida il razzismo segregazionista per
la semplice ragione che la segregazione si impone laddove c’è possibilità
321
Mirco Dondi
di contatto (donna nera - uomo bianco). Il fascismo aveva incluso il genere femminile in una gerarchia di inferiorità (assenza del diritto di voto,
paga più bassa, scarsa tutela nel diritto familiare) che Mussolini ribadisce
postulando l’inferiorità psichica della donna. Nella nota intervista a Emil
Ludwig, il capo del fascismo aveva ribadito che «la donna deve obbedire» e «nel nostro Stato essa non deve contare». Le riflessioni di Mussolini
manifestano i contorni di uno spiccato razzismo sessista, del quale più di
altre, la mentalità fascista è portatrice. Durante il regime l’antifemminismo orienta le politiche verso la donna e la famiglia per ribadire e scandire
rigide gerarchie tra i sessi, in consonanza con la funzione gerarchizzante
di ogni razzismo. La donna è relegata ai ruoli della procreazione e della
maternità «la cosa più fascista che le donne possono compiere è quella di
pilotare molti figli», ricorda Mussolini in un discorso del 1934. Mussolini
afferma che la donna [italiana] non deve essere schiava125. In questa scala
gerarchica la donna africana non può che essere collocata, in una pratica
graduatoria di comportamenti e di leggi, al di sotto della già «inferiore»
donna italiana, con tutte le evidenti conseguenze del caso.
In definitiva, si mantiene una linea di continuità con il sorgere della
società di massa quando, la razza assieme al genere, erano divenuti i due
spettri di un pensiero reazionario intento a sfidare gli effetti sociali della
modernizzazione.
322
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Note al testo
* Desidero ringraziare Mauro Raspanti per i suggerimenti e il proficuo confronto.
1
Alessandro Triulzi, La costruzione dell’immagine dell’Africa e degli africani nell’Italia coloniale,
in Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870 – 1945, a cura di Alberto Burgio,
Il Mulino, Bologna 1999, p. 169, pp. 179-180.
2
Per ragioni di spazio questa riflessione non affronta i film e i cinegiornali. Sul pregiudizio razziale come «disposizione affettivo immaginaria legata a stereotipi etnici», si veda: Pierre André
Taguieff, La forza del pregiudizio, Il Mulino, Bologna 1994 [ed. orig. 1987], p. 289.
3
Nazionalismo e razzismo sono fenomeni legati all’emergere della società di massa e ai conflitti
della modernità. Il nazionalismo risulta funzionale a riorientare i conflitti sociali in conflitti
etnici e/o tra stati. Il razzismo si presenta come una scala culturale e/o biologica dei generi
umani e serve a scandire gerarchicamente le società dopo l’abolizione dei ceti seguita alla fine
dell’ançien regime. Michel Wieviorka, Il razzismo, Laterza, Roma-Bari pp. 5-7. La moderna
nozione di razza si afferma a partire dal XVIII secolo. L’autore non considera, ma l’elemento
può ritenersi implicito, che il razzismo è sempre esistito in tutte le epoche come segno di
ignoranza e di pregiudizio. Sul significato moderno della nozione di razza che si delinea nel
XVIII secolo concorda anche Etienne Balibar, Razzismo: un altro universalismo, in Razzismi,
in «Problemi del socialismo» , 2, 1989, p. 37.
4
È quanto sostiene, ad esempio, l’antropologo fascista Lidio Cipriani, Un assurdo etnico: l’impero etiopico, Bemporad, Firenze 1936. L’autore riprende questa visione negatrice del progresso
dei popoli in Lidio Cipriani, Fascismo razzista, Tumminelli & C., Roma-Milano 1940.
5
David Bidussa, I caratteri «propri» dell’antisemitismo italiano, in La menzogna della razza.
Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, Grafis, Bologna 1994, p. 114. Il
termine apartheid è stato coniato nel 1944 cfr. M. Wieviorka, Il razzismo cit., p. 46.
6
Il razzismo biologico, in La menzogna della razza cit., p. 224. Tra gli adepti di questa corrente gli
antropologi Lidio Cipriani e Guido Landra, i giornalisti Telesio Interlandi (direttore de «Il Tevere», del «Quadrivio» e di «Difesa della razza») e Giorgio Almirante, a lungo, nel dopoguerra,
segretario del partito neofascista Movimento sociale italiano (Msi). Interlandi va considerato
«il capo indiscusso dei razzisti biologici italiani». Cfr. Roberto Maiocchi, Scienza italiana e
razzismo fascista, La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 202. Si veda poi: Il nazional-razzismo, in
La menzogna cit., p. 241 che cita Giacomo Acerbo - che riceve il sostegno della rivista gesuita
«Civiltà cattolica» -, Alessandro Pavolini, l’endocrinologo Nicola Pende, il fisiologo Sabato
Visco, lo zoologo Alessandro Ghigi, rettore dell’università di Bologna e teorico del regime di
separazione nelle colonie. Si veda inoltre: Il razzismo esoterico-tradizionalista, in La menzogna
della razza cit., p. 249. Tra gli esponenti di quest’ultimo gruppo Julius Evola, apprezzato dai
nazisti e dai movimenti di estrema destra del secondo dopoguerra (Almirante lo definì «il
nostro Marcuse»). In questo gruppo si trovano anche un fascista delle origini come Roberto
Farinacci, Alberto Luchini e il giornalista Giovanni Preziosi, direttore della testata razzista «La
vita italiana».
7
Mauro Raspanti, I razzismi del fascismo, ibidem, p. 73.
8
George Mosse, Sessualità e nazionalismo, Roma-Bari 1984 [ed. orig. 1982], p. 153 afferma:
«Il razzismo fu una forma più intensa di nazionalismo».
9
Julian S. Huxley, Alfred C. Haddon, Noi europei. Un’indagine sul problema «razziale», Comunità, Milano2002 [ed. orig. 1935], p. 15 riportato da Michele Nani, Ai confini della
nazione. Stampa e razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Carocci, Roma 2006, p. 15.
10
Nella formazione della nazione italiana non mancano le correnti culturali che concepiscono la
323
Mirco Dondi
nazione in termini di razza, terra e sangue. L’ossessione della purezza razziale, lo stupro come
contaminazione della razza e l’odio verso gli stranieri, si ritrovano nella pagine di importanti
autori della letteratura italiana, cfr. Alberto Maria Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino 2000, in particolare il capitolo
Morfologia del discorso nazionale.
11
Giorgio Fabre, Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita,
Garzanti, Milano, pp. 267-268. Scrive L. Cipriani, Fascismo razzista cit., p. 10: «Il razzismo è
implicito nell’idea fascista».
12
Ci sono discipline, come l’antropologia, che si prestano, ormai in controtendenza rispetto a
Francia e Gran Bretagna, a suffragare le tesi nazionaliste e razziste del regime. Il caso più eloquente è rappresentato dall’antropologo Lidio Cipriani, fautore del razzismo biologico, teso a
dimostrare l’inferiorità della razza nera africana. Cipriani è tra i firmatari del Manifesto della
razza del 14 luglio 1938 ed è autore di diversi libri e di alcuni interventi sul mensile «Gerarchia», come ad esempio, Motivi antropologici dell’universalità di Roma, in «Gerarchia», n 8,
agosto 1936, pp. 521-525.
13
Rudyard Kipling (1865-1936) è il prototipo dell’intellettuale legato all’idea che all’Europa sia
assegnato il compito di civilizzare i nuovi «barbari» dell’Asia e dell’Africa.
14
Per una compiuta visione di questi orientamenti si veda lo scritto del nazionalista Enrico
Corradini, L’ora di Tripoli, Milano, Treves, 1911.
15
Queste considerazioni sono sviluppate in più punti da Nicola Labanca, Oltremare. Storia
dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna 2002.
16
Alberto Lessona, Scritti e discorsi coloniali, Arte e storia, Milano 1935, p. 149 riportato da
Renzo De Felice, Mussolini il Duce. Gli anni del consenso 1929 -1936, Einaudi, Torino 1978,
p. 604.
17
Renzo De Felice, Mussolini il Duce. Gli anni del consenso cit., p. 617. Non esiste regime che
possa contare sul pieno consenso, ma le preoccupazioni non appaiono trascurabili perché i
contraccolpi di una guerra persa si riflettono sulla stabilità del regime. Analogamente Simona
Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime 1929 – 1943, Laterza, Roma – Bari 2000 [1^
ed. 1991], pp. 183-4, p. 188.
18
Cfr: Nicola Labanca, Storia dell’Italia coloniale, Fenice Milano 2000, 1994, p. 48; S. Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime cit., pp. 188-9 La crisi del 1929 non è ancora risolta
e solo nel Meridione si contano 600.000 disoccupati.
19
Scrive R. De Felice, Mussolini il Duce. Gli anni del consenso cit., p. 642: «La guerra d’Etiopia
[…] assunse per [Mussolini] il valore di una missione che doveva far sì che la Nazione (presente
e futura) riconoscesse nella sua propria vocazione, il proprio dovere assoluto, e si realizzasse quindi quella identificazione tra vox ducis e vox populi che sino allora il fascismo era stato incapace
di realizzare veramente.» (I corsivi sono nell’originale). Il capo dell’Ufficio Studi e propaganda
sulla razza definisce la conquista dell’Africa una «missione razziale, morale e civile» nonchè
il completamento del Risorgimento, cfr. Alberto Luchini, Popolarità dell’Affrica in Italia,
Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1942, p. 5.
20
L’indicazione razzista è comunicata da Mussolini al capogabinetto del ministero degli Esteri
Pompeo Aloisi che questi annota nel suo diario: Pompeo Aloisi, Journal (25 juillet 1932 14
juin 1936), Plon, Paris 1957, p. 46. La citazione è riportata in nota da Giorgio Fabre, L’elenco.
Censura fascista, editoria e autori ebrei, Silvio Zamorani editore, Torino 1998, p. 27.
21
Sulla volontà di Mussolini di istituire la rivista: Roberto Maiocchi, Manifesto degli scienziati
razzisti, in Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, Einaudi,
324
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
Torino 2002, II, p. 88; sugli esordi della rivista: Valentina Pisanty, La difesa della razza.
Antologia 1938 – 1943, Bompiani, Milano 2006, pp. 47-51.
22
P. Aloisi, Journal cit., p. 185.
23
L’intera vicenda è ricostruita da G. Fabre, L’elenco cit., pp. 25-27. L’ultima citazione è a p.
28.
24
Benito Mussolini, La razza bianca non deve morire, in «Il Popolo d’Italia», 25 settembre
1934. Questo filone di pensiero è legato a un congiunto timore di regressione, dopo che gli
effetti espansivi della modernità avevano incluso anche la penetrazione coloniale, cfr. Ruth
Ben-Ghiat, La cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2000, p. 10.
25
Il regime fascista riesce ad occupare le principali città dell’Etiopia, senza riuscire ad avere il
pieno controllo del restante territorio, dove opera una guerriglia che l’esercito italiano non
riuscirà mai a debellare.
26
La genesi di questo ministero comincia come Ufficio Stampa di Mussolini guidato da Galeazzo
Ciano. Dal 6 settembre 1934 la struttura si trasforma Sottosegretariato, poi il 24 giugno 1935
diventa ministero della Stampa e propaganda e dal 27 maggio 1937 la denominazione cambia
nuovamente in ministero della Cultura popolare. Cfr. G. Fabre, L’elenco cit., p. 28. Ciano
rimane al vertice del ministero fino all’11 giugno 1936 quando lascia la carica di ministro a
Dino Alfieri. Su Alfieri: Adolfo Scotto Di Luzio, Dino Alfieri, in Dizionario del fascismo cit.,
I, p. 34; Alessia Pedio, Mussolini ha sempre ragione, in I volti del consenso. Mass media e cultura
nell’Italia fascista: 1922 - 1943, L’Unità, Roma 2004, p. 68.
27
«Con l’Etiopia abbiamo pazientato quarant’anni! Ora basta!» Il testo commentato del discorso:
Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Mondadori,
Milano 1989, p. 40. Commenta la manifestazione un giornalista inglese: «un popolo di reclusi condannati all’entusiasmo», in: S. Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime cit.,
p. 191.
28
Nel Corno d’Africa tra le popolazioni copte questa pratica preesisteva all’arrivo degli italiani,
cfr. Razzismo coloniale di stato in La menzogna della razza cit., p. 286. Al tempo della conquista
dell’Eritrea, negli anni che vanno dal 1885 al 1896, le autorità avevano favorito il madamato, ritenendo più dignitoso per un ufficiale avere una relazione fissa con una donna anziché
condividere una prostituta con la truppa. Il termine allora usato per gli ufficiali era quello di
«prendere madama». Giulia Barrera, Madamato, in Dizionario del fascismo cit., II, p. 69.
29
Richard Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale italiano (1935 – 1941), in
«Studi Piacentini», 3, 1988, p. 175 e p. 183.
30
Nicola Labanca, Colonialismo, in Dizionario del fascismo cit., I, p. 309.
31
Gianluca Gabrielli, Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista contro
i meticci, in Studi sul razzismo italiano, a cura di Alberto Burgio e Luciano Casali, Clueb,
Bologna 1996, pp. 61-2. Gli articoli eliminati dal Rdl n. 1019 vanno dal 18 al 20. Il tema è
affrontato anche da R. Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale italiano cit.,
pp. 175-6, p. 192.
32
Sulle veline: «4 gennaio 1936: Non pubblicare fotografie sul genere di quella pubblicata questa
mattina dal «Messaggero», che dimostrino intimità dei nostri soldati con abissini […] Si dia
l’impressione di benevolenza da parte dei nostri soldati verso gli indigeni ma non di cordialità,
di protezione ma non di affetto». I testi sono in: http://it.wikipedia.org/wiki/Velina_(giornalismo), 21 marzo 2007. Si veda anche: Alessandra Scarcella, Il ruolo della stampa nella
campagna razzista e antiebraica fascista (1937-1943), in «Clio», 3, 2000, p. 471.
33
Angelo Del Boca, Le leggi razziali nell’impero di Mussolini, in Il regime fascista. Storia e sto-
325
Mirco Dondi
riografia, a cura di Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario G. Rossi, Laterza, Roma-Bari
1995, p. 337. Secondo l’antropologo razzista Lidio Cipriani, Razzismo coloniale, in »La Difesa
della razza», 2, 20 agosto 1938, i meticci ereditano i loro caratteri fisici dalla madre (nera) più
che dal padre e «come negli animali domestici […] la riproduzione con una razza inferiore dà
sempre un prodotto scadente».
34
Eudemon, Il problema del meticciato nelle terre dell’impero, in «L’azione coloniale», 28 gennaio
1937. p. 1 riportato in Razzismo coloniale di stato, in La menzogna della razza cit., p. 289.
35
R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo fascista cit., p. 218.
36
Sulla politica razzista nelle colonie fornisce un’interessante documentazione il libro di memorie
del ministro delle Colonie Alessandro Lessona, Memorie, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 298-299.
Secondo A. Del Boca, Le leggi razziali nell’impero di Mussolini cit., p. 336 gli intendimenti di
Lessona, vanno anche oltre le direttive delle stesso Mussolini. Sulla divisione dei cinema per
indigeni e per italiani si veda il documento fotografico presentato da: Silvana Palma, L’Italia
coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p 157. La raccolta completa del repertorio fotografico
si trova in: Silvana Palma, L’Africa nella collezione fotografica dell’IsIAO (Il fondo Eritrea – Etiopia), Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma 2005.
37
Angelo Del Boca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Neri Pozza editore, Vicenza
2005, pp. 205-224 e passim.
38
R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo fascista cit., p. 157. Sul razzismo contro i neri statunitensi: Stefano Luconi, Etnia e patriottismo nella pubblicità per italo-americani durante la
guerra d’Etiopia, in «Italia contemporanea», 241, 2005, p. 515. Il settimanale italo-americano
«Italian Echo» nei numeri del 19 gennaio 1934 e del 1° giugno 1934 sottolinea la superiorità
dei prodotti gastronomici italiani e denuncia le «contraffazioni» avvenute negli Stati Uniti. I
maccheroni prodotti negli stati dell’Ovest diventano «fabbricati da negri». «Il consiglio del
giornale per proteggere la salute ed evitare il “putridume” riversato sul mercato da “sciacalli
stranieri” e da “negri” era, pertanto, di diffidare degli alimenti la cui genuinità non fosse garantita dalla produzione italiana».
39
Cfr. Fabio Levi, L’ebreo in oggetto. L’applicazione della normativa antiebraica a Torino, Zamorani, Torino 1991. Levi è stato tra i primi a sostenere che la legislazione antirazziale è stata concepita autonomamente dal fascismo e senza pressioni naziste. Si sottolinea che la politica contro
il meticciato in Africa sia stata la premessa alla legislazione antiebraica. R. Maiocchi, Scienza
italiana e razzismo fascista cit., p 220 mette in dubbio una visione così consequenziale degli
eventi sostenendo che il regime sottolinea la linea razzista del 1938 alla luce dei provvedimenti
del 1936. L’adozione dei provvedimenti segregazionisti nelle colonie non é seguita da un’ampia
pubblicistica che invece, sul tema coloniale, si sviluppa dalla fine del 1938 in poi, proprio per
sostenere una continuità di indirizzo tra le leggi del 1936 e quelle del 1938. In effetti escono
articoli sui principali quotidiani contro i meticci da parte degli intellettuali e dei giornalisti più
in vista. (Si ricordi, fra gli altri, quello di Indro Montanelli, Meticci di Ghinda, in «Corriere
della Sera», 15 novembre 1938). Maiocchi tuttavia sottovaluta l’ideologia dell’impero e la fissazione di precise gerarchie nella definizione del razzismo italiano.
40
Andrea Di Michele, I diversi volti del ruralismo fascista, in «Italia contemporanea», 199,
1995, pp. 243-267. L’autore sottolinea che esistono più ideologie ruraliste propagandate all’interno del regime e che in Italia le connotazioni del ruralismo non hanno una matrice biologica
antisemita come in Germania. Tra i giornali che sostengono un’ideologia ruralista c’è senz’altro
«Il Selvaggio» (dal 1924 al 1943) di Mino Maccari, il quale dà vita al movimento culturale di
Strapaese. Tra i bersagli polemici l’urbanizzazione, l’americanizzazione e, in questo contesto,
un forte razzismo contro i neri.
41
La campagna antiborghese che ha tra i suoi motti «noi siamo contro la vita comoda» è impor-
326
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
tante dal punto di vista propagandistico, per le ragioni sopra segnalate, ma non corrisponde
a una politica economica antiborghese del regime che vanta proprio nella piccola e media
borghesia la fetta più ampia del suo consenso popolare, cfr. Maria Malatesta, Borghesia, in
Dizionario del fascismo cit., I, pp. 190-3.
42
Dizionario mussoliniano. 1500 affermazioni del Duce su 1000 argomenti scelte e disposte in ordine alfabetico di soggetto, a cura di Bruno Biancini, Hoepli, Milano 1942 [1^ed. 1940], p. 75.
43
Gianni Isola, Abbassa la tua radio per favore… Storia dell’ascolto radiofonico nell’Italia fascista,
La Nuova Italia, Firenze1990, p. XIII dove si dice che la Rai ha cominciato a conservare i materiali della produzione a partire dal 1954.
44
Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Laterza, Bari 1975,
p. 252.
45
Cfr. G. Fabre, Mussolini razzista cit., p 267. L’autore rintraccia un’influenza di Filippo Maria
Marinetti su Mussolini osservando come nello scritto Democrazia futurista. Dinamismo politico, Facchi, Milano 1919, sia formulato un progetto di «Istituto di allevamento e di educazione
della prole» che somiglia assai da vicino a quello che fu poi, dopo qualche anno, l’Onmi
fascista.
46
Nicola Labanca, Etiopia, in Dizionario del fascismo cit., I, p. 492.
47
È un indizio fra gli altri la scarsa attenzione del giornale della famiglia Mussolini, «Il Popolo
d’Italia», verso la radio fino al 1936 cfr. G. Isola, Abbassa la tua radio per favore cit., p. 27.
48
Per il numero di abbonati: Alberto Monticone, Il fascismo al microfono. Radio e politica in
Italia (1924 – 1945), Edizioni Studium, Roma 1978, p. 55. Antonio Papa, Storia politica della
radio italiana, Guida, Napoli 1978, II, p.5. L’autore ritiene che il fenomeno dell’abusivismo
rientri nel 1936.
49
Franco Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista. Studi e documenti: 1922-1945,
Marsilio, Venezia 1976, p. 263.
50
Edward R. Tannenbaum, L’esperienza fascista. Cultura e società in Italia dal 1922 al 1945,
Mursia, Milano 1974 [ed. orig. 1972], p. 240: «I contadini, specialmente nel Meridione, non
avevano in pratica alcun contatto con la cultura popolare nazionale dei mass media, né con il
partito. Anche quand’erano costretti ad ascoltare Mussolini dall’altoparlante nella piazza del
paese, le parole passavano sopra le loro teste senza lasciare traccia».
51
Il settimanale raggiunge una tiratura di 200.000 copie nel 1938, cfr. E. R. Tannenbaum,
L’esperienza fascista cit., p. 260.
52
F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista cit., p. 114
53
Edward R. Tannenbaum, L’esperienza fascista cit., p. 247.
54
L’esempio di uno storico che ha operato in questa direzione si vede nel lavoro di G. Isola, Abbassa la tua radio per favore cit., il quale però non affronta questioni legate al razzismo.
55
Archivio centrale di Stato (d’ora in poi Acs), Ministero della cultura popolare, busta(d’ora in
poi b. 24, fascicolo (d’ora in poi f.) 350, Promemoria dell’Ufficio Stampa e Propaganda del governo generale dell’Africa Orientale Italiana, 7 giugno 1937. Il documento è pubblicato nell’appendice del volume di F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista cit., pp. 260-5.
56
R. De Felice, Mussolini il Duce. Gli anni del consenso cit., pp. 764-5.
Cfr. Mirco Dondi, The Fascist Mentality after Fascism in Italian Fascism. History, Memory and
Representation,a cura di Richard Bosworth e Patrizia Dogliani, Macmillan, London 1999, pp.
141 - 160.
58
Peppino Ortoleva, Niccolò Carosio, in Dizionario del fascismo cit., vol. I, p. 235. L’epiteto co57
327
Mirco Dondi
sta a Niccolò Carosio l’immediata interruzione della sua partecipazione ai mondiali che segna
anche la fine della sua carriera.
59
Definizioni rispettivamente di: G. Isola, Abbassa la tua radio per favore cit., p. 189; F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, cit., p. 126.
60
Paolo Murialdi, La stampa del regime fascista, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 116 – 7.
61
A. Monticone, Il fascismo al microfono cit., p. 123.
62
Roberto Forges Davanzati, Cronache del regime 6 maggio 1935 25 ottobre 1935, Mondadori, Milano 1936, p. 19 (trasmissione dell’8 maggio 1935), p. 33 (trasmissione del 15 maggio
1935).
63
Piers Brendon, Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, Carocci, Roma 2002 [ed.
orig. 2000], p. 273 e p. 270.
64
R. Forges Davanzati, Cronache del regime cit., p. 76.
65
P. Brendon, Gli anni trenta cit., p. 269.
66
F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, cit., p. 129.
67
M. Isnenghi, Le guerre degli italiani, cit. p. 40.
68
R. Forges Davanzati, Cronache del regime, p. 35 (trasmissione del 15 maggio).
69
Mauro Forno, La stampa del ventennio. Strutture e trasformazioni nello Stato totalitario, Rubbettino, Catanzaro 2005, p. 178, pp. 212 - 215.
70
Cfr. Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, Pinciana, Roma 1937: Roberto Farinacci, La Chiesa
e gli ebrei, Tipografia Tevere, Roma 1938. Con la guerra di Etiopia la posizione di Farinacci,
uomo di punta dello squadrismo fascista, torna ad essere legittimata (dopo un periodo di
esclusione), cfr. Matteo Di Figlia, Farinacci. Il radicalismo fascista al potere, Donzelli, Roma
2007, p. 208.
71
Mauro Forno, Fascismo e informazione. Ermanno Amicucci e la rivoluzione giornalistica incompiuta, Alessandria, Edizioni Dell’Orso 2003, pp. 99-100.
72
Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano. Dalle prime gazzette ai telegiornali, Gutemberg, Torino 2000, 1986, p. 125.
73
Si è qua accennato ai fedelissimi. Altri giornalisti, per lo più giovani collaboratori della rivista,
si sono distinti nel dopoguerra per le posizioni antifasciste. Dal tiepido antifascismo di Vittorio Gorresio e Indro Montanelli, a quello successivamente più militante di Ruggero Orlando
e Ruggero Zangrandi. Tra i collaboratori di «Gerarchia» figura uno dei giornalisti e scrittori
italiani più tradotti all’estero: Curzio Malaparte. Fascista estremista, direttore de «La Stampa»
dal 1929 al 1931, cade in disgrazia nel 1933. Cfr. Sergio Luzzato, Curzio Malaparte, in
Dizionario del fascismo cit., II, pp.78-80. Tra i fascisti che collaborano a «Gerarchia» e che non
va annoverato tra i fedeli, c’è anche Roberto Farinacci che a metà degli anni venti è stato in
profondo dissenso con Mussolini.
74
E. Tannenbaum, L’esperienza fascista cit., p. 247.
75
Adolfo Scotto Di Luzio, Censura, in Dizionario del fascismo, cit., vol. I p. 262.
76
E. Tannenbaum, L’esperienza fascista, cit., p. 251. Si veda anche: Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino 1979, in
particolare il capitolo La stampa dell’era fascista: giornalisti funzionari e giornalisti militanti, pp.
186 - 99.
77
Mauro Forno, La stampa del ventennio cit., p. 206, pp. 210-2.
328
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
78
Le sanzioni proibiscono agli stati aderenti alla Società delle nazioni di importare merci dall’Italia e di fornire materiali legati alla prosecuzione del conflitto ad eccezione però del petrolio, del
carbone e dell’acciaio. Complessivamente non si tratta di sanzioni draconiane. Nel luglio 1936
i provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Italia sono ritirati.
79
Al compattamento dell’opinione pubblica allude anche il settimanale satirico «420» nel numero del 12 gennaio 1936, p. 4, con una vignetta raffigurante il fascio littorio avvolto da una
lunga cinghia di sanzioni che recita: «Attento Eden! Con il tuo bavaglio ci unisci sempre di
più… E si muove la scure!»
80
Ruggero Orlando, Il partito, in «Gerarchia», gennaio 1936, p. 56. Ruggero Orlando, nel
dopoguerra, è indicato come uomo di area socialista e diventa uno stimato corrispondente
dagli Stati Uniti del telegiornale.
81
Antonio Casolo-Ginelli, Azione, pensiero e linguaggio, in «Gerarchia», gennaio 1936, pp.
53-54. A partire dal 1932 il quotidiano torinese «La Gazzetta del popolo» e il romano «La
Tribuna» dedicano spazio alla difesa della lingua italiana. Paolo Monelli, tra i più noti giornalisti del regime e collaboratore di «Gerarchia», conduce un’apposita rubrica sulla «Gazzetta
del popolo» i cui articoli sono stati pubblicati nel libro: Paolo Monelli, Barbaro dominio:
seicentocinquanta esotismi esaminati, combattuti e banditi dalla lingua con antichi e nuovi argomenti, storia ed etimologia delle parole e aneddoti per svagare il lettore, Igis, Milano 1943 [1^ ed.
1933 ridotta]. Su questi aspetti si veda anche P. Murialdi, La stampa del regime fascista cit.,
pp. 117-8.
82
F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista cit., p. 139.
83
Silus, I popoli non si inventano sul traliccio delle razze, in «Gerarchia», febbraio 1936, p. 114.
Su un più esteso riferimento di decadenza universale che non tocca invece l’Italia si veda: Ruggero Orlando, Il Partito, in «Gerarchia», aprile 1936, p. 284.
84
Peppino Ortoleva, Marco Revelli, Storia dell’età contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 1993, p. 541.
85
Silus, I popoli non si inventano sul traliccio delle razze cit.
86
Il testo che, meglio di ogni altro, esprime questa visione è quello di uno dei più noti storici
del tempo, Gioacchino Volpe, L’Italia in cammino, Treves, Milano 1927. Volpe collabora a
«Gerarchia» e nelle sue pagine elogia la politica colonialista intrapresa nell’ultimo decennio
dell’Ottocento da Francesco Crispi.
87
Renato Famea, Sanzioni, controsanzioni e rappresaglia, in «Gerarchia», febbraio 1936, p.
117.
88
Dal discorso del 23 marzo all’Assemblea delle Corporazioni, in «Gerarchia», aprile 1936, pagine
non numerate in apertura della rivista.
89
Il discorso della pace romana, in «Gerarchia», maggio 1936, pagine non numerate in apertura
della rivista.
90
R. Famea, Sanzioni, controsanzioni e rappresaglia cit.
91
Raffaele Guariglia, Il conflitto italo-etiopico, in «Gerarchia», febbraio 1936, p. 99.
92
Antonio Palombo, Nell’Africa orientale conquistata, in «Gerarchia», aprile 1936, p. 249.
93
Il programma radiofonico I quattro moschettieri è stato trasmesso in 36 puntate dal 18 ottobre
1934 al 4 luglio 1935 allestite dal comico Riccardo Massicci su testi di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, I Quattro moschettieri, S.A. Perugina, S. A. Buitoni, Perugia 1935. Sull’onda del
successo esce anche: Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, Due anni dopo: continuazione de
329
Mirco Dondi
I quattro moschettieri, , Perugina, Buitoni, Perugia – San Sepolcro 1937.
94
La satira razzista, in La menzogna della razza cit., p 147; sugli esordi del «Marc’Aurelio»:
Adolfo Chiesa, La satira politica in Italia, Roma-Bari 1990, p. 82 e p. 88. In questo testo si
riferisce (p. 82) che la vendita di copie del «Marc’Aurelio» fra il 1935 e il 1940 si attesta fra le
300.000 e le 350.000 copie.
95
P. Murialdi, La stampa del regime fascista cit., pp. 154-155. Il primo numero di «Bertoldo»
esce il 14 luglio 1936 e si caratterizza per un’ironia d’ambiente borghese che manifesta spunti
di originalità con qualche incursione nel non-sense, tipico nella rubrica sillogismi.
96
Si tratta de «Il 420», «Bertoldo», «Guerin meschino», «Marc’Aurelio», «Settebello», «Il Travaso
delle idee».
97
Acs, Ministero della Cultura popolare, b. 77 , f. vari.
98
Cfr. A. Chiesa, La satira politica in Italia cit., p. 121.
99
Acs, Ministero della Cultura popolare, b. 77 , f. vari.
Durante la Prima guerra mondiale, in Italia si è scatenato un razzismo bellico virulento contro
i tedeschi, definiti come gli unni e descritti nei loro comportamenti di sub-umanità, cfr. Angelo Ventrone, La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914 – 1918),
Donzelli, Roma 2003, p. 108.
100
101
Bruno Caluri, Le belle trovate abissine, in «Il 420», 16 febbraio 1936, p. 6.
G. Fabre, L’elenco cit., p. 28. La commedia ottiene inizialmente l’autorizzazione ad essere
rappresentata poi, in concomitanza con lo scandalo legato a Maria Volpi, subisce la censura
probabilmente perché l’africano risulta simpatico.
102
Clara Gallini, Giochi pericolosi. Dall’esotismo al razzismo in alcune pratiche simboliche, in
Razzismi cit., p. 155. In un altro passaggio: «L’imputazione di cannibalismo è stata precocemente rivolta dai bianchi agli indigeni del Nuovo Mondo (“caraibico” = “cannibale”) e quindi
estesa ai neri dell’Africa, per indicare un’universale caratteristica dell’uomo selvaggio, posto al
di fuori di ogni regola di cultura […] [Il] cannibalismo […] è sempre stato molto più raccontato che praticato», ivi, p. 154.
103
La vignetta è riprodotta, senza specificazione dl disegnatore, del giorno e del mese di uscita in
A. Chiesa, La satira politica in Italia cit., p. 99.
104
105
R. Ciani, Quando si perde la testa, in «Il 420», 8 marzo 1936, p. 2.
E. Ligrano, Preparativi di difesa aerea, cartolina coloniale dell’esercito riprodotta in La menzogna della razza cit., p. 171. La casistica della viltà e dell’arretratezza dell’etiope è presente
quasi in ogni numero ne «Il 420» del primo semestre del 1936. Si veda ad esempio la vignetta
«Irregolari abissini», 12 gennaio 1936, p. 3 dove un uomo nudo afferma: «Accidenti! Mi hanno
rubato gli abiti e ora non ricordo più se sono generale o soldato».
106
P. Brendon, Gli anni trenta cit., p. 269: «La maggioranza degli stranieri, però, era colpita
dalla raffinatezza dell’aspetto esteriore di Ras Tafari: capelli ricci tagliati quasi a zero, fronte
ampia, barba ricciuta accurata, lungo naso aquilino, grandi occhi neri».
107
108
Il civilissimo delegato etiopico a Ginevra, in «Il 420», 2 febbraio 1936, p. 3.
Numerose sono le situazioni di questo tipo riprese da «Il 420». «Bertoldo» nasce il 14 luglio,
dopo l’ondata propagandista contro l’Etiopia che tocca il suo culmine nel primo semestre del
1936. Nel secondo numero del 17 luglio un disegno grande di Bazzi, in prima pagina, raffigura
il Negus vestito da Pulcinella con la didascalia: Tafari calcherà le scene.
109
110
Si crea la situazione comica coniugale, alle volte il titolo muta leggermente o non compare.
330
Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa
111
Un bel dì vedremo… faccetta nera, in «Il 420», 26 gennaio 1936, p. 5.
Tra negusso e negussa, in «Il 420», 2 febbraio 1936, p. 3. In questo caso la donna è bella perché
riconosce che gli etiopi sono barbari.
112
Rispettivamente: Dopo la batosta, in «Il 420», 2 febbraio 1936, p. 7; Prossimo debutto del
balletto Ras Duncan girls, in «Il 420», 15 marzo 1936, p. 8; L’ultimo… rifugio, in «Il 420», 17
maggio 1936, p. 3.
113
Cfr. Distinzione, in «Il 420», 1 marzo 1936, p. 5 dove Antony Eden deve andare al parco delle
scimmie per incontrare il Negus. Si trova Eden vestito da donna su tutta la prima pagina con
due chiodi conficcati nelle tempie (uno è l’Etiopia, l’altro la Germania), Chiodo scaccia chiodo!,
in «Il 420», 22 marzo 1936, p. 1.
114
115
Differenze, ibidem, p. 7.
Il riferimento non è nuovo nella cultura razzista del tempo. L’antropologo Lidio Cipriani,
Considerazioni sopra il passato e l’avvenire delle popolazioni africane, Bemporad, Firenze 1932,
p. 10 afferma che nella donna «almeno in Africa, certi contegni vengono a perdere molto
dell’umano per portarsi assai prossimi a quelli degli animali». Cfr. A. Del Boca, Le leggi razziali nell’impero di Mussolini cit., p. 334. I romanzi indicati nel testo: Gino Mitrano Sani, E
per i solchi millenari delle carovaniere. Romanzo coloniale, Editore Plinio Maggi, Tripoli 1926;
Gino Mitrano Sani, Femina somala. Romanzo coloniale del Benadir, Edizioni Detken e Rocholl, Napoli 1933.
116
Silvana Palma, Fotografia di una colonia: l’Eritrea di Luigi Naretti, in «Quaderni storici», 109,
aprile 2002, pp. 104-5 riportato da Nicoletta Poidimani, «Faccetta nera»: i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa, in http:/www.nicolettapoidimani.it/documenti/
faccettanera.pdf, p. 5, 29 maggio 2007. La facilità dei costumi e il diverso concetto di morale
diventa l’attenuante per scagionare i cittadini italiani nei tribunali coloniali anche per uno
stupro nei confronti di una bambina di nove anni.
117
Sulla stampa delle cartoline: R. Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale
italiano cit., p. 177.
118
N. Poidimani, «Faccetta nera»: i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa cit.,
pp. 1-2. La citazione si riferisce a: Anne McClintock, Imperial Leather. Race, Gender and
sexsuality in the Colonial Contest, Routledge, New York-London 1995, p. 22.
119
120
P. Murialdi, La stampa del regime fascista cit. , p. 183.
«L’amore è soprattutto fabbrica di prole - sostiene l’autore -. Ora cosa vuol fare alla faccetta
nera il nostro cantastorie? Un figlio? Un meticcio? […] Ma noi dobbiamo popolare l’impero
di intatta gente nostra non disseminare intorno malinconici bastardi. […] Un popolo che
costruisce per sé uno splendido futuro non augura a sé eredi corrotti».
121
122
R. Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale italiano cit., pp. 178-179.
Carlo Domenici, Le parole… e i fatti, in «Il 420», 5 luglio 1936, p. 5. In un passaggio
dell’articolo, Paolo Monelli definiva le abissine «sempre fetide del burro rancido che cola a
goccioline sul collo». In realtà anche «Il 420» nel numero del 9 febbraio 1936, p. 7, nel brano,
Il negusso e la negussa, si descrive la moglie di Selassiè mentre si spande il burro rancido Coty
sulla chioma.
123
124
R. Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale italiano cit., p. 179.
Emil Ludwig, Colloqui con Mussolini, Milano, Mondadori, 1932. Le citazioni dei passi sopra
indicati sono in: Michela De Giorgio, Antifemminismo, in Dizionario del fascismo cit., I, pp
78-9. Per inciso: nel 1919 Mussolini era favorevole al voto alle donne.
125
331
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e
le sue strategie di assoggettamento*
di Pietro Costa
Non perseguo il temerario obiettivo di affrontare in poche pagine i
temi (‘classe’, ‘razza’, ‘sovranità’) adombrati nel titolo, ma mi propongo
soltanto di richiamare l’attenzione su alcuni schemi argomentativi ricorrenti nella cultura politico-giuridica dell’occidente europeo e sui nessi che
li collegano alla teoria e alla pratica della sovranità. Anche un siffatto programma, comunque, richiederebbe analisi ravvicinate di testi e contesti
diversi. In questa sede, sarà invece possibile soltanto presentare ipotesi e
‘modelli’ sprovvisti di qualsiasi apparato probatorio, nella speranza che essi
possano contribuire almeno all’impostazione del problema.
1. La rappresentazione dei soggetti e il loro ‘governo’: tre testi
‘esemplari’
Vorrei muovere da tre testi, in qualche modo esemplari nel disegnare
una precisa e suggestiva ‘antropologia politica’.
Francisco de Vitoria, Relectio de Indis (1532)1. Vitoria sta contrastando la tesi, che sarà resa celebre da Sepúlveda, della congenita irrazionalità
degli indios, quindi della loro naturale incapacità ad esercitare il dominio.
I nativi americani hanno, per Vitoria, «aliquem ordinem in suis rebus». È
vero che essi appaiono «insensati et hebetes», ma ciò dipende «ex mala et
barbara educatione». La loro debole razionalità li rende simili ai nostri rustici: «cum etiam apud nos videamus multos rusticorum parum differentes
a brutis animantibus»2. Gli indios come i «rustici», accomunati dal fatto
che solo una piccola differenza separa gli uni come gli altri dai bruti3.
Jeremy Bentham, Principles of the Civil Code4. Bentham sta illustrando
il nesso fra proprietà e sicurezza. La legge rende possibile, con la proprietà, la sicurezza, la moltiplicazione delle risorse, in una parola, la civiltà.
Al centro dell’ordine sta il nesso proprietà-civiltà. Questo nesso però è
333
Pietro Costa
anche un crinale, uno spartiacque: da un lato i proprietari, dall’altro i nonproprietari. I proprietari occupano l’area della società civile-moderna; la
non proprietà «is the primitive condition of the human race. The man
who lives only from day to day is precisely the man in a state of nature».
Emergono due figure, accomunate dalla penosa estraneità al mondo della
proprietà-civiltà: «the savage» e «the poor in society»5. Tutto era America in
origine, aveva scritto Locke. Bentham, il fiero critico del giusnaturalismo,
sta in questo caso adottando un’analogia già istituita dal giusnaturalistico
Secondo Trattato sul governo. Il barbaro indio come il rusticus ispanico; il
selvaggio come il non-proprietario: continua il gioco delle analogie.
Leggiamo ora un terzo testo: Walter Bagehot, The English Constitution,
18676. Per l’autorevole opinionista e poi direttore dell’«Economist», il genere umano presenta, nel suo sviluppo storico, straordinarie diversità: basta
andare col pensiero «agli albori dell’umanità» e alle «misere tribù» primitive e paragonarle con le popolazioni dell’Europa odierna. Questi estremi
non si collocano però solo sulla linea della temporalità. I medesimi contrasti si ritrovano, in termini sincronici, nel diagramma della stratificazione
sociale. «In una grande comunità come l’Inghilterra – scrive Bagehot – vi
sono moltitudini di persone appena più progredite della maggior parte dei
popoli di duemila anni fa». Le odierne società sono come «le grandi montagne»: sono composti di più strati; gli strati inferiori sono la sopravvivenza
dell’arcaico, mentre solo lo strato superiore è contemporaneo a se stesso, in
regola con lo Zeitgeist, compiutamente moderno7. La prova irrefutabile è
a portata di mano: basta andare «nelle proprie cucine» e toccare con mano
come i «lower orders» siano «narrow-minded, unintelligent, incurious»8.
Che uso fare di questi testi? Li ho introdotti solo per ricavarne qualche suggestione, assumendoli baldanzosamente come pars pro toto, come
avamposti o segnali di innumerevoli ma convergenti strategie discorsive.
Questi testi ci presentano una chiara e netta dicotomia: i barbari, i selvaggi, i primitivi si oppongono ai civilizzati, ai razionali, ai moderni. È il
gioco del ‘dentro’ e del ‘fuori’, di noi e degli altri, del familiare e dell’estraneo: noi, europei, civili, razionali, da un lato, e, dal lato opposto, i popoli
‘altri’, barbari e selvaggi. Questi testi però non si limitano a mettere in
scena una contrapposizione priva di contatti: stabiliscono (in diversi modi,
coerenti con le loro differenti coordinate culturali) un ponte fra i due mondi; non tanto una semplice analogia, quanto una precisa corrispondenza:
fra barbari e rustici, fra selvaggi e non-proprietari, fra razze inferiori e classi
334
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
subalterne. Questa corrispondenza non nasce per caso né è il frutto di un
superficiale esercizio retorico, bensì affonda le sue radici in una visione
del soggetto ampiamente condivisa nei rispettivi contesti storico-culturali.
Fra queste visioni e fra questi contesti non vi sono contatti significativi, se
non per un elemento: si fa leva su un soggetto eccellente, sul soggetto par
excellence, e su questa base si definiscono i soggetti ‘altri’.
Il soggetto perfetto e compiuto, per Vitoria e per la scolastica spagnola,
è il titolare del dominium: un individuo che esercita il suo potere sulle cose
perché prima lo esercita su se stesso. La proprietà è l’espressione di un soggetto che afferma, insieme, la sua libertà, la sua capacità di disporre di se
stesso e la sua piena razionalità. Il dominio è auto-dominio, è auto-nomia:
è l’espressione della ragione che governa l’istinto; il trionfo dell’alto sul basso, di ciò che è superiore su ciò che è inferiore. Il mondo è una piramide:
il vertice è occupato da un essere umano capace di ragione e di dominio,
mentre alla base si affollano individui provvisti di un grado minimo di
razionalità e di autonomia: il rusticus e l’indio, entrambi appartenenti al
genere umano, ma bisognosi di essere tutelati e governati.
Facciamo ora un salto acrobatico dalla Spagna della conquista all’Inghilterra benthamiana. Tutto cambia, ovviamente: l’antica immagine dell’ordine gerarchico viene meno e la rappresentazione della società è ora nettamente dicotomica: di qua gli inclusi, di là gli esclusi; di qua i governanti,
di là i governati. La linea divisoria è però ancora una volta costituita dalla
proprietà. Certo, la proprietà di Bentham non è la proprietà di Vitoria.
Per qualche aspetto però l’antico gioco si ripete: è ancora la proprietà il
parametro attraverso il quale definire il soggetto par excellence, di contro ai
soggetti ‘altri’; è ancora la proprietà l’espressione visibile della razionalità9.
Certo, la ragione si traduce ora nella capacità di differire e di risparmiare, di investire e di progettare, ma a questo scopo continua ad essere connessa con l’autocontrollo, con l’autodisciplina, con l’autonomia. È ancora
il nesso proprietà-razionalità-autogoverno a dividere i soggetti separandoli
in autonomi ed eteronomi: i selvaggi e i non proprietari, entrambi primitivi e inaffidabili, accomunati da una carenza di razionalità che impone, per
entrambi, un intervento governante.
È a questo punto che interviene la sovranità: il sovrano deve farsi carico di questo compito decisivo. Occorre però guardarsi dal separare la
rappresentazione antropologica del soggetto dalla logica della sovranità.
Rappresentazione e governo dei soggetti sono momenti strettamente in335
Pietro Costa
trecciati: sono il diritto e il rovescio della stessa medaglia. La famosa tesi
foucaultiana dell’immanenza del potere nel sapere, la valenza potestativa
del sapere e la produttività epistemica del potere trovano nel nostro caso
una puntuale illustrazione10. La rappresentazione di una classe di soggetti
come eteronoma e inaffidabile è al contempo l’attribuzione alla sovranità
di un compito specifico: il compito di governare11 (disciplinare, tutelare e
tenere a freno) quella classe o quelle classi di soggetti caratterizzati da una
razionalità, da un’autodisciplina, da un’affidabilità affievolite.
2. La regola e l’eccezione: fra sovranità ‘metropolitana’ e sovranità
‘coloniale’
La rappresentazione antropologico-politica dell’individuo non è la visione di un essere umano generico, di un soggetto ‘senza qualità’: al contrario, essa procede attraverso una sorta di ‘doppio movimento’ che, nel
momento in cui colloca in primo piano il soggetto eccellente (il soggetto
‘per eccellenza’) descrivendone le qualità che ne mostrano la pienezza e
la compiutezza umana, pone sullo sfondo una o più classi di individui in
qualche modo diminuiti e carenti. La rappresentazione degli uni è inseparabile dalla visione degli altri: soggetti ‘eccellenti’ e soggetti ‘diminuiti’
calcano il medesimo palcoscenico, si sostengono a vicenda, hanno iscritti
nella loro stessa struttura antropologica i ruoli ‘eternamente’ complementari di Sancio Panza e di Don Chisciotte, di Sganarello e di Don Giovanni,
del servo e del padrone.
È il nesso, insieme congiuntivo e disgiuntivo, fra il soggetto eccellente
e il soggetto diminuito il punto di congiunzione fra la rappresentazione
antropologica e il discorso (e la pratica) della sovranità: che presuppone
la differenza e si propone di gestirla e di renderla funzionale all’ordine
complessivo.
In questa prospettiva, potrebbe allora acquistare una suggestione e un
senso particolari l’accostamento (ricorrente nel discorso pubblico ‘moderno’) fra i ‘selvaggi’ extra-europei e quei non-proprietari che, in ragione
della loro diminuita razionalità, vivono nei bassifondi del grande edificio
della civiltà europea e mantengono qualcosa della primitiva ‘barbarie’.
Ciò che viene a mancare, tanto nei ‘barbari’ intra moenia quanto nei
‘selvaggi’ extra moenia, è il circolo virtuoso fra proprietà, autocontrollo,
razionalità e autonomia e proprio per questo in entrambi i casi occorre un
336
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
intervento che dall’esterno rimedi a quel vuoto di razionalità che si risolve
nell’incapacità di reggersi da soli: privi di autonomia, tanto i selvaggi quanto i non-proprietari devono essere ‘ordinati’ da un intervento ‘governante’,
da un’oculata ed efficace gestione delle ‘differenze’.
È comprensibile allora, alla luce di questa ipotesi, che in tutto l’arco della colonizzazione il tema della ‘civilizzazione’ divenga il principale
simbolo di legittimazione dell’espansionismo europeo: un simbolo prima
legato all’endiadi ‘civilitas-christianitas’ e poi, con il procedere della secolarizzazione, emancipato da un orizzonte strettamente cristiano (anche se in
realtà la dimensione ‘civile’ della cristianità e il radicamento ‘cristiano’ della
civiltà continuano ad essere presenti sullo sfondo)12.
L’opposizione ‘civiltà/barbarie’ domina il discorso coloniale otto-novecentesco determinando quella differenza fra soggetti che apre il varco
all’intervento della sovranità e anzi lo reclama come un diritto-dovere dei
popoli evoluti. È uno schema argomentativo che affonda le sue origini
nel Secondo Trattato lockiano, determinante nel tematizzare il nesso fra
la libertà, la proprietà e la razionalità del soggetto. Tutti gli uomini sono
proprietari (quanto meno del proprio corpo e del labour che attraverso
esso erogano), ma solo alcuni si mostrano in grado di impiegare compiutamente le loro capacità e la loro razionalità. In Europa quindi numerosi
individui possono soltanto offrire la forza del loro corpo in cambio di un
salario, mentre gli abitanti dell’America sono selvaggi che, collocati ancora
in un tempo ‘arcaico’, antecedente all’invenzione della moneta, allo sviluppo del commercio e allo sfruttamento intensivo della terra, non erogano
quella industry che legittima l’esclusione di qualsiasi ‘concorrenza’ esterna13. Ancora sostanzialmente lockiano è l’argomento adottato da Vattel, a
metà Settecento, per legittimare l’occupazione, da parte delle potenze occidentali, di terre che devono essere considerate ‘nullius’, perché la semplice
permanenza dei ‘selvaggi’ su di esse non dà loro alcun titolo di proprietà,
vista la loro incapacità di metterle a frutto e di moltiplicare la ricchezza
individuale e collettiva. Ancora negli anni del Congresso di Berlino, il divario fra civiltà e barbarie è un argomento utilizzato per giustificare l’occupazione coloniale di terre presentate come res nullius, dal momento che,
come la proprietà, così lo Stato e la sua sovranità sono espressioni obbligate
della civiltà (e viceversa la civiltà trova nella proprietà e nello Stato la sua
più alta espressione).
Il principale (anche se non sempre evidente) effetto retorico prodotto
337
Pietro Costa
dal nesso ‘colonizzazione-civilizzazione’ è ancora una volta la differenziazione dei soggetti. La rappresentazione del soggetto per eccellenza (il maschio proprietario, adulto, europeo, bianco) implica la rappresentazione
differenziale dei soggetti ‘altri’ e questa a sua volta evoca un potere capace
di governarli: esige l’intervento di un governo che ‘tenga a freno’ ma al
contempo utilizzi le risorse, assoggetti ma protegga, conquisti con la forza
ma si proponga un compito educativo e ‘civilizzatore’. La civilizzazione diviene quindi un diritto-dovere che grava sui soggetti ‘eccellenti’ in quanto
portatori di una civiltà superiore.
Siamo evidentemente di fronte a un circolo (è eccellente il soggetto appartenente alla civiltà europea e quest’ultima è la civiltà superiore perché è
composta da individui ‘eccellenti’ – autonomi-autocontrollati-proprietarirazionali –); e il circolo si regge su una filosofia della storia (la storia come
progresso, come una freccia che punta verso l’alto, come uno sviluppo che
si lascia alle spalle l’arcaico e culmina nella modernità) largamente condivisa dalla maggioranza dell’opinione pubblica ottocentesca.
Civilizzare significa governare, fuori d’Europa, le ‘differenze’, in modo
che (in un tempo ragionevolmente lungo) i selvaggi accedano alla modernità. La teleologia immanente alla civilizzazione-colonizzazione sembra dunque condurre all’auto-estinzione della colonizzazione stessa, dal
momento che, civilizzati i selvaggi, l’uomo bianco può deporre il suo fardello e abitare finalmente in un mondo ‘moderno-civile’ (in un mondo,
potremmo dire, ‘globalizzato’). E in effetti le vivaci dispute che impegnano la colonialistica intorno ai modelli di colonizzazione (assimilazione o
autonomia; rapida, ‘giacobina’, imposizione di norme ed usi occidentali
oppure valorizzazione delle autonomie locali in vista di un loro progressivo e ‘spontaneo’ avvicinamento alla civiltà) non avrebbero avuto senso se
non come varianti interne al dogma ‘civilizzatore’. Il punto è però che abbastanza rapidamente la colonialistica otto-novecentesca prese le distanze
dalle prospettive ‘assimilazionistiche’, ora ipotizzando il carattere ‘asintotico’ del loro compimento, ora più francamente sostenendo l’opportunità
di mantenere in vita le ‘differenze’. Appariva in altri termini sempre più
evidente anche alla teoria ciò che alla pratica non era mai sfuggito: ovvero
l’esistenza di uno stretto e provvidenziale nesso fra la differenziazione dei
soggetti e l’intervento governante del sovrano14.
La differenza fra i soggetti è la conseguenza obbligata del divario fra le
civiltà (o meglio fra la civiltà e la barbarie) e al contempo la condizione
338
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
di possibilità del governo coloniale. Non è un caso quindi che la retorica
della civilizzazione ospiti come proprio nucleo irriducibile una celebrazione delle differenze. È la radicale distanza che separa i colonizzati dai colonizzatori che, per un verso, permette di attribuire alla civiltà superiore il
diritto-dovere di espandersi, mentre, per un altro verso, impone un assetto
istituzionale e una prassi di governo che, in ragione delle peculiarità dei
contesti antropologico-sociali cui si riferiscono, non possono che divergere
nettamente dai modelli ‘metropolitani’15.
Tanto la evidenziazione delle differenze che separano la metropoli dalla
colonia quanto la necessità di approntare soluzioni istituzionali e giuridiche ad hoc per i paesi d’oltremare sono passaggi ricorrenti nella letteratura
giuscoloniale fra Otto e Novecento. Una priorità da tutti conclamata è la
necessità di approntare per le colonie un governo forte e spedito: emancipato dagli impacci di quel formalismo giuridico che nella metropoli continuava ad essere presentato come l’espressione del circolo virtuoso che
collega la civiltà, la libertà e la modernità.
Nella metropoli trionfa il diritto e la sovranità si esplica entro un complesso sistema di vincoli e limiti. Certo, il potere statuale continua ad essere pensato dai giuristi tardo-ottocenteschi come intrinsecamente assoluto
e perfettamente libero. Proprio in ragione della sua incontrastata libertà,
però, lo Stato sovrano, non limitabile da alcuna forza ‘esterna’, può liberamente decidere di limitare se stesso, di sottoporre la sua azione a una
norma da esso stesso creata: è questo il nucleo di quella teoria dell’autolimitazione dello Stato che, avanzata da Jhering e poi da Jellinek e adottata
dalla gran parte della giuspubblicistica europea coeva, permette di pensare
(e di realizzare) lo Stato come un Rechtsstaat, come uno ‘Stato di diritto’,
come uno Stato sottoposto al diritto16.
È questo Stato – lo Stato che, sottoponendosi al diritto da esso stesso
creato, fonda i diritti dei soggetti e legittima le loro pretese anche nei confronti dei pubblici poteri – la forma caratteristica della civiltà moderna. La
civiltà si è meritata sul campo lo Stato di diritto e questo Stato a sua volta
presuppone che gli individui cui esso attribuisce diritti siano quei soggetti autonomi, auto-disciplinati e razionali assumibili al contempo come il
frutto e il tramite della civiltà moderna.
Se dunque lo Stato di diritto è la forma politico-giuridica della modernità europea, quanto più le società extra-europee si allontanano dagli
standard etici e antropologici che la caratterizzano, tanto più le istituzioni
339
Pietro Costa
deputate a governarle (a tutelarle, a educarle) dovranno deviare dal costituzionalismo metropolitano e dai suoi dogmi17. È allora inevitabile (tanto
per fare qualche esempio) che il governatore svolga numerose ed eterogenee funzioni superando il principio della divisione dei poteri e ancor
più essenziale è stabilire una rigida distinzione fra coloni e colonizzati,
attribuire ai primi (e soltanto ad essi) lo status di cittadini e ai secondi
quello di sudditi e sospendere quindi per questi ultimi l’applicazione di
quel principio di eguaglianza politico-giuridica la cui conclamata ‘universalità’ si esplicava in realtà ancora una volta soltanto entro i confini storicogeografici dell’Europa18.
Se ciò è vero, la parabola della sovranità moderna non coincide senza
residui e senza ombre con il graduale affermarsi di una potestas sub lege,
con la marcia trionfale di uno Stato di diritto che sottopone al controllo
prima la propria attività amministrativa e poi addirittura (con il kelseniano
Rechtsstaat costituzionale) l’operato del legislatore. La sovranità moderna
è la parabola del potere frenato dal diritto, ma è anche lo sfrenato dispiegarsi della politica di potenza nelle terre d’oltremare. Una recente sintesi
di storia del diritto coloniale, redatta da Guillaume, impiega questa formula: il regime coloniale è il regime dell’eccezione, mentre l’ordinamento
metropolitano è il trionfo della norma (della ‘normalità’, della certezza del
diritto). Proprio per questo, aggiunge lo studioso francese, l’ordinamento
coloniale include tratti caratteristici dell’antico regime19: l’ampio potere
discrezionale del governo, l’arbitraire aborrito da Constant, scompare nella
metropoli, ma prospera nelle periferie coloniali.
La norma e l’eccezione; la regola e l’arbitrio: un’opposizione radicale
che divide due mondi abissalmente lontani – la metropoli e la colonia – e
rinvia a due traiettorie della sovranità moderna cronologicamente coincidenti, sincroniche, ma opposte nella loro direzione di senso.
Possiamo limitarci a constatare la contrapposizione fra questi due mondi. È però difficile non porre qualche domanda ulteriore, dal momento
che è pur sempre la medesima sovranità ad essere in gioco; è difficile non
interrogarsi più a fondo sulle complesse, e non sempre trasparenti, dinamiche della sovranità. Certo, per porsi questa domanda occorre evitare
le semplificazioni di un’onesta, ma datata, storia costituzionale: una storia costituzionale che, per un verso, contrappone la sovranità sub lege del
moderno Stato di diritto all’amministrazione ‘dispotica’ di antico regime,
mentre, per un altro verso, passa semplicemente sotto silenzio il versante
340
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
coloniale della sovranità moderna. Credo al contrario che convenga procedere in una direzione opposta: diffidare della consolatoria coincidenza
fra la sovranità moderna e lo Stato di diritto e tematizzare il nesso fra la
valenza ‘interna’ e la proiezione coloniale della sovranità.
Il nesso (o almeno uno dei nessi significativi) emerge a mio avviso quando si guardi alla rappresentazione dei soggetti e al suo punto di innesto sul
‘discorso della sovranità’ e si colga il rapporto che intercorre fra l’individuazione di una classe o più classi di soggetti come irrazionali e indisciplinati
e la messa a punto di una teoria e di una pratica funzionali al loro governo:
è questo uno dei molteplici fili della complicata trama della sovranità, una
componente ‘di lunga durata’ della sua traiettoria, che, se opportunamente
messa a fuoco, può rivelare qualche collegamento fra realtà troppo spesso
assunte come separate e prive di contatti significativi: la metropoli e la
colonia, l’Europa e l’oltremare, il ‘dentro’ e il ‘fuori’.
Quando si prenda simultaneamente in considerazione la sovranità intra
moenia e la sovranità extra moenia, sembra di assistere a uno strano gioco
delle parti, come se il sovrano soffrisse di uno sdoppiamento di personalità:
un nobile dottor Jekyll impegnato a costruire nella luce meridiana il moderno Stato di diritto e un impresentabile Mr. Hyde che, nel cuore delle
tenebre, tiene in vita l’antico, anti-moderno dispotismo. Ma veramente
Jekyll e Hide non hanno alcun interesse o linguaggio in comune? Oppure, al contrario, entrambi condividono almeno l’esigenza di governare i
soggetti, per l’appunto quei soggetti antropologicamente incapaci di autocontrollo e di autonomia? La mia impressione è che in questa esigenza
vada rintracciata, almeno per un lungo tratto dell’itinerario moderno della
sovranità, una caratteristica condivisa dalle diverse manifestazioni (intra ed
extra moenia) della sovranità.
Governare i soggetti significa non soltanto tenerli a bada controllandone, se necessario con la forza, le velleità ribellistiche, ma anche disporre
delle loro energie, renderli docili e produttivi. Governare i soggetti significa non soltanto impedire che compiano danni, ma ottenere che producano
azioni vantaggiose, incrementino la ricchezza e la potenza collettive. I più
diversi mezzi possono servire a questo scopo: premi e divieti, sanzioni giuridiche e strumenti economici, interventi diretti o pressioni indirette.
Di questa esigente, multiforme e inventiva prassi governante il famoso
Panopticon è divenuto un emblema perché riunisce in sé, plasticamente,
visivamente, le diverse istanze: il controllo del comportamento, il discipli341
Pietro Costa
namento morale, la tutela dei governati, la messa a frutto delle loro forze
produttive20.
È l’esigenza di governare i soggetti in quanto deboli, irrazionali e inaffidabili che getta un ponte fra le diverse manifestazioni della sovranità: ed
è questa esigenza che, soddisfatta diversamente in Europa o nei territori
coloniali, dà conto delle diverse manifestazioni della medesima sovranità
di qua o di là dall’Oceano.
È vero che, entro i confini della cittadella europea, l’Otto-Novecento è
un’ ‘età dei diritti’. I diritti però non nascono per partenogenesi da una sovranità spontaneamente disposta a moderare, intra moenia, quella volontà
di potenza che essa dispiega senza limiti extra moenia. I diritti sono, insieme, le pedine e la posta di una complicata e incerta partita condotta in Europa da diversi e conflittuali attori sociali. Che cos’altro è la critica kantiana della felicità dispensata dal provvido sovrano wolffiano se non la rivendicazione di un diritto contrapposto alle pretese governanti dell’autorità?
Non sono comunque soltanto i diritti di libertà ad assumere la valenza
di un argine posto alle pressioni e alle invadenze del sovrano: è l’intero
processo di moltiplicazione dei diritti, caratteristico dell’Otto-Novecento
(l’età dei diritti, appunto), ad esprimere l’aspirazione di larghi strati della
popolazione a impadronirsi della propria vita, a sottrarla alla gestione da
parte di forze estranee. È questo, mi sembra, il senso più profondo della
rivendicazione socialista dei diritti sociali e del conseguente rifiuto di uno
‘Stato amministrativo’, di un riformismo autoritario à la Bismarck.
I diritti sono inseparabili da quella ‘lotta per i diritti’ che costituisce
uno delle grandi linee di sviluppo del discorso e della prassi politica ottonovecentesca e la ‘lotta per i diritti’ è, a sua volta, la resistenza, in nome dei
diritti, alla pressione esercitata dalle potenze governanti. Lo Stato di diritto, e lo Stato dei diritti, nascono in Europa come punto di intersezione e
precario stato di equilibrio fra le politiche di assoggettamento del governo
e la resistenza dei soggetti governati.
Una medesima istanza governante si esplica in Europa come nelle terre
d’oltremare. La politica di assoggettamento, però, se in Europa si confronta con molteplici e sempre diversi punti di resistenza, extra moenia si
dispiega nel vuoto di una resistenza efficace e costruttiva. Nello scenario
coloniale, alla conquista manu militari si oppongono ribellioni aperte o
striscianti e poi ancora il boicottaggio o il rifiuto del lavoro (la famigerata
‘pigrizia’ delle razze inferiori, peraltro non dissimile dall’indolenza irre342
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
sponsabile dei ‘poveri oziosi’ europei). Ci sono ribellioni e boicottaggi, ma
non scatta il circolo, in qualche modo virtuoso, del potere e della resistenza
non soltanto a causa della flagrante sproporzione delle forze, ma per l’assenza di linguaggi comuni e di valori condivisi: manca la partecipazione a
una medesima comunità politica, manca la condivisione delle medesime
‘forme di vita’, non c’è un unitario campo da gioco dove impegnarsi, tutti
insieme, nella partita dell’assoggettamento e della resistenza. Proprio per
questo la medesima istanza governante produce effetti diversi nel centro
metropolitano o nella periferia coloniale: in quest’ultima realtà manca
l’ambiente nel quale può formarsi ed esercitarsi la resistenza dei soggetti,
diviene impossibile la ‘lotta per i diritti’ e il potere sfrenato del sovrano si
manifesta di conseguenza nella sua attuale e non solo virtuale e contrastata
illimitatezza. Resta quindi ferma l’abissale distanza che separa il mondo
aereo dell’Europa dei diritti dall’infernale suburra dei paesi colonizzati.
Non mancano però connessioni e reciproci rinvii fra l’alto e il basso, fra
l’iperuranio e gli inferi.
In primo luogo, è vero che, nelle terre d’oltremare, l’eccezione prevale
sulla regola. Il governo delle colonie non è però un potere informe e primitivo, ma è un potere che si articola e si organizza attraverso il diritto. E
in questo nesso (tipico della tradizione giuridica europea) fra potere e apparati normativi e istituzionali, il diritto, per un verso, rafforza il dominio,
rendendolo più preciso e sistematico, ma, per un altro verso, lo razionalizza, lo contiene, in qualche misura lo frena e lo modera.
In secondo luogo, se è vero che l’istanza governante è frenata dalle azioni di resistenza disseminate nella società europea, se è vero che la sovranità
è vincolata da un numero crescente di diritti-poteri che pretendono di
controllarne e indirizzarne gli interventi, è anche vero che lo Stato di diritto (lo Stato dei diritti) non può essere considerato un’acquisizione aere
perennius, un portato irreversibile della civilizzazione: esso è piuttosto un
fragile e mobile punto di equilibrio fra forze contrapposte, un dispositivo
la cui applicazione non è automatica, ma deve essere reiteratamente voluta
e decisa.
La metropoli è il trionfo della norma e la colonia è il regime dell’eccezione. È vero. A patto però di non irrigidire la differenza; a patto di
tener presente l’unità di fondo del processo di assoggettamento. E allora:
il regime coloniale è, sì, un regime eccezionale, ma è anche un regime che
produce norme, le applica, le utilizza per garantirsi una sua ‘regolarità’ (in
343
Pietro Costa
ogni senso) di funzionamento; e, viceversa, il regime metropolitano è, sì,
il regime della norma, ma la sua normalità è fragile e contrastata, continuamente esposta al rischio di essere travolta dalla sfrenatezza del potere,
sempre pronto a invocare lo ‘stato di necessità’.
L’eccezione non riguarda soltanto il diritto coloniale; essa è l’ombra
ineliminabile dell’intera parabola dello Stato di diritto21. È difficile pensare la sovranità ‘normata’ senza cogliere al contempo il gioco delle forze
che rende possibile, hic et nunc, la ‘normalità’, ma può anche produrre
l’effetto contrario, quando mutino gli equilibri interni a vantaggio delle
strategie di assoggettamento del sovrano governante. Non importa essere
schmittiani per cogliere, al fondo della parabola moderna dei diritti e della
legalità, la forte connessione fra norma ed eccezione: un’eccezione che non
si manifesta soltanto negli episodi clamorosi e (se mi si passa il bisticcio)
‘eccezionali’ (i cannoni di Bava Beccaris, per intenderci), ma incide sulla
quotidiana gestione del potere, sempre esposto alla tentazione di un governo illimitato dei soggetti.
3. Dal ‘governo delle differenze’ alla ‘politica assoluta’
Norma ed eccezione; assoggettamento e resistenza: la trama della sovranità moderna, pur con tutte le sue, anche radicali, differenziazioni e discrasie, include una strategia che rappresenta una classe di soggetti – i selvaggi,
le classi subalterne – come irrazionali ed eteronomi e come tali destinati
ad essere governati. Questa strategia agisce al fondo di molteplici e diverse
costellazioni ideologiche e dimostra una singolare capacità di durare nel
tempo proprio perché capace di adattarsi a molti tornanti dell’itinerario
moderno della sovranità.
A molti, ma non a tutti. Questa strategia infatti si interrompe là dove
viene meno il presupposto che costituisce insieme la sua forza e la sua debolezza: l’immagine della storia come progresso.
Si pensi all’immagine di Bagehot: i selvaggi sono primitivi e irrazionali;
le classi subalterne sono lo strato arcaico di una società che è compiutamente ‘moderna’ solo nei suoi vertici; la storia però è in movimento e l’arcaico può essere sospinto verso il moderno. Non a caso il principale ideologema della colonizzazione ottocentesca è la ‘civilizzazione’: l’Europa come
levatrice di un progresso cui altrimenti i selvaggi non potrebbero accedere.
Certo, si tratta soltanto di un’ideologia, nel senso marxiano del ter344
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
mine. Anche le ideologie però hanno una logica precisa e inderogabile; e
una strategia di assoggettamento situata nell’orizzonte di una filosofia del
progresso ha un tallone di Achille: include la possibilità di un mutamento,
prevede l’ipotesi della sua fine. I soggetti irrazionali potrebbero cessare di
esserlo; o, peggio, potrebbero sostenere, con buoni argomenti, di non esserlo più e divenire quindi indocili e ingovernabili. È comprensibile allora
che prenda campo il tentativo di rafforzare le differenze, di scoraggiare una
volta per tutte le resistenze, di mutare insomma il quadro di riferimento e
la connessa strategia di assoggettamento.
Un importante mutamento interviene con il diffondersi di una nuova
antropologia e di una nuova teoria delle razze, quando, fra Ottocento e
Novecento, la differenziazione dei soggetti e la loro disposizione gerarchica
vengono fondate sulle inappellabili sentenze della scienza22. Uomo e donna, normale e criminale, bianchi e neri, ariani ed ebrei vengono differenziati sulla base di oggettivi, naturali, biologici, quindi insuperabili e immodificabili tratti costitutivi. L’inferiorità di alcune classi di soggetti appare
un dato accertato e indiscutibile. La famosa boutade (‘non sono razzista: è
lui che è nero’) esprime con efficacia l’assunto: i fatti sono i fatti.
I fatti sono fatti e producono conseguenze. Una prima conseguenza: diviene compiutamente pensabile un dominio senza limiti e senza resistenze.
La naturalizzazione delle differenze e delle soggezioni, e quindi la loro assolutizzazione, evoca la possibilità dell’assolutizzazione del dominio. Emerge
già in nuce, in questo contesto, la pensabilità di una politica assoluta: di
una politica che, non prevedendo l’ipotesi di una resistenza, esercitandosi,
per così dire, su corpi inerti, si immagina priva di remore e di vincoli.
Una seconda conseguenza: le differenze fra soggetti, intra moenia, continuano ovviamente a esistere, ma cessano di essere politicamente significative; non sono più un problema, non devono esserlo. La politica non deve
esaurire il meglio delle sue energie nel gioco interminabile dell’assoggettamento e della resistenza entro la piccola cerchia della società metropolitana. La politica guarda al mondo: il ‘fuori’ catalizza e assorbe ogni energia e
attira nella sua orbita il ‘dentro’. Il governo dei soggetti non scompare, ma
viene realizzato come momento di una complessiva trasformazione della
politica: la politica come guerra.
Se la politica è lo slancio aggressivo di un popolo unito contro il nemico (e il nemico par excellence è il nemico razziale), non si danno resistenze
intra moenia: si danno semmai tradimenti e defezioni. La politica come
345
Pietro Costa
guerra trasforma i soggetti ‘esterni’ nel nemico razziale e i soggetti interni
in una gerarchizzata ma al contempo unitaria massa di manovra, in un
esercito che, come ogni esercito di fronte all’emergenza della guerra, non
conosce altra regola se non il comando irresistibile del suo condottiero.
Una siffatta trasformazione della politica trova la sua più compiuta e
radicale realizzazione nel nazionalsocialismo tedesco proprio perché l’antropologia razziale è parte integrante del suo patrimonio ideologico fin
dalle sue origini. Se però il nazionalsocialismo è un perfetto caso di scuola
per cogliere gli effetti politico-giuridici di un’ideologia razziale (dall’attacco all’eguaglianza giuridica dei soggetti – il rifiuto di attribuire all’individuo ‘come tale’ anche soltanto la capacità giuridica, il ‘diritto ad avere
diritti’ – alla teoria del rapporto fra il popolo, il partito e lo Stato, dal culto
dell’omogeneità alla costruzione – e distruzione – del nemico), esso non
si presta a saggiare la nostra ipotesi, dal momento che l’esperienza coloniale tedesca si era interrotta con la sconfitta subita dalla Germania nella
prima guerra mondiale. Da questo punto di vista, è piuttosto il fascismo
ad offrire una verifica sperimentale del circolo che si viene sviluppando fra
l’antropologia razziale e la dinamica della sovranità.
L’adozione di una precisa antropologia razziale è per il fascismo abbastanza tardiva: anche se non mancano riferimenti sparsi alle differenze e
alle gerarchie razziali nella letteratura del regime, è solo con la guerra di
Etiopia che l’elemento della razza acquista un inedito rilievo e un nuovo
ruolo23. Prima di questa vera e propria svolta, la politica coloniale del fascismo aveva ereditato dalla tradizione precedente il consolidato sistema della
‘differenziazione’, ma al contempo lo aveva approfondito e irrigidito in
nome di quella celebrazione della forza e del dominio ‘puro’ che costituiva
uno dei tratti originari e caratteristici della sua ideologia.
Accreditandosi come restaurazione dell’autorità e della forza dello Stato,
adottando la visione (già rocchiana e corradiniana) della nazione aggressiva
ed espansionistica, il fascismo vede nella colonizzazione l’esplicazione naturale di quella volontà di potenza che esso considera come il segno della
sanità e della vitalità della stirpe.
Il governo coloniale continua a porsi, in teoria e in pratica, come ‘governo delle differenze’, ma la tradizionale differenziazione fra sudditi e
cittadini si accentua, si esplica in un crescente divario fra colonizzati e
colonizzatori e infine si irrigidisce in un preciso sistema di divieti e sanzioni e si traduce in una politica finalizzata ad un regime di esclusione e di
346
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
ghettizzazione nel momento in cui la rappresentazione dei ‘nativi’ abbandona lo scivoloso terreno del confronto fra civiltà per adottare una solida
visione biologico-razziale24. La radice della differenza risiede non più nella
‘cultura’, nella ‘storia’, ma nella ‘natura’ e rende di conseguenza definitiva e
irremovibile quella condizione di inferiorità che fa del selvaggio il suddito
‘naturale’ dello Stato colonizzatore25.
Allo stesso modo, il dominio coloniale continua ad essere presentato come il ‘governo dell’eccezione’ (sempre più apertamente sfrondato, in
nome del ‘realismo’, da qualsiasi orpello ‘umanitario’), ma viene accentuata l’istanza ‘governante’, l’esigenza (già presente nella tradizione coloniale
dell’Italia liberale) di esercitare un dominio efficace e diretto, il più possibile emancipato da regole e vincoli. Continua dunque in qualche misura il
consueto gioco delle parti: l’eccezione e la regola, lo Stato patrimoniale e lo
Stato di diritto, il barbaro e il civile, l’arcaico e il moderno. Mutano però,
nel corso dell’intera parabola del fascismo, la logica della sovranità e le sue
manifestazioni ‘interne’ ed ‘esterne’.
All’interno, l’esigenza di ‘governare’ (controllare, disciplinare, utilizzare) i soggetti ‘inferiori’ (un’esigenza caratteristica della sovranità moderna e
un minimo comun denominatore delle sue manifestazioni ‘metropolitane’
e ‘coloniali’) acquista con il fascismo un crescente risalto, con il risultato
(apparentemente paradossale) di diminuire, da questo punto di vista, la
distanza fra la sovranità intra ed extra moenia. Nemmeno nella metropoli
lo Stato di diritto è per il fascismo la più alta e solenne concrezione della
modernità. Senza indulgere a clamorosi rifiuti nei confronti dello Stato
di diritto, il fascismo tende ad ammetterlo come una cornice normativa
utile per il funzionamento ‘quotidiano’ della società (e soprattutto per la
tutela degli interessi ‘privati’)26. Il destino etico-storico dello Stato-nazione
non è però contenibile negli schemi formalistici ereditati dalla tradizione
liberale ed esige di prendere sul serio l’impulso della stirpe alla potenza e
all’espansione.
Non è allora soltanto un occasionale espediente retorico la celebrazione
che il tardo fascismo fa della propria vocazione imperiale (anche se non
deve essere sottovalutato il suo impatto propagandistico)27. L’impero è la
celebrazione del dominio ‘come tale’: l’impero significa, al contempo, attrazione dei popoli inferiori nella sfera di potere della civiltà dominante ed
espansione di quest’ultima entro uno spazio limitato soltanto dalle concorrenti pretese delle altre civiltà imperiali. La differenziazione dei soggetti,
347
Pietro Costa
per un verso, si irrigidisce, dal momento che fra noi e loro, fra i bianchi e i
neri, sussistono immodificabili e invalicabili differenze biologiche, ma per
un altro verso muta di senso, rapportandosi ad un unico parametro: la potenza della sovranità imperiale e il suo assoluto dispiegarsi pur nel quadro
di una precisa gerarchizzazione dei soggetti.
Nel simbolo dell’impero finisce allora per concentrarsi ed esprimersi
una radicata vocazione del fascismo (e, in diverso modo, del nazionalsocialismo) a una politica che vorrei dire ‘assoluta’28: una politica che, libera
da vincoli formali, governa capillarmente i soggetti nel quadro di rigide e
irreversibili asimmetrie; una politica che si identifica con lo stato di eccezione e ritiene di poter finalmente spezzare il nesso (fino a quel momento
tenacemente resistente) fra norma e decisione, fra regola e governo, fra
assoggettamento e resistenza; una politica infine che si proietta contro un
nemico che, per essere sconfitto, richiede l’omogeneità della società e l’irresistibilità del comando.
È l’assolutizzazione del nemico (esterno ed interno) che rende la politica finalmente assoluta e l’assoggettamento totale e senza residui. Il nemico
assoluto rende assoluta la politica e la politica assoluta si impegna in un
titanico sforzo di annullamento di qualsiasi limite: non solo dei vincoli
giuridici, non solo di quella pallida larva che è ormai lo Stato di diritto
d’antan, ma anche di quella opaca ma ultimativa resistenza opposta dai
corpi finalmente addomesticati dei sudditi-soldati. L’utopia o la distopia
della politica assoluta è il sogno di un dominio che si esercita nel vuoto di
qualsiasi resistenza: un dominio che si immagina dispensato dal confronto
con l’irriducibile alterità dei dominati.
Note al testo
* Il testo è stato pubblicato anche in Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in
Europa tra XVI e XX secolo, a cura di F. Benigno e L. Scuccimarra, Viella, Roma 2007, pp.
239-254.
1
Francisco de Vitoria, Relectio de Indis, a cura di L. Pereña e J.M. Perez Prendes, Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid 1967.
2
Ivi, pp. 29-30.
3
Cfr. B. Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo XXI Ed., Cerro del
Agua, Madrid 1994, p. 16.
348
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
4
J. Bentham, Principles of the Civil Code, in Id., The Works, a cura di J. Bowring (Tait, Edinburgh 1838-1843), Russell and Russell, New York 1962, vol. I.
5
Ivi (1962), p. 309.
6
W. Bagehot, The English Constitution, Oxford University Press, London-New York-Toronto
1955 (trad. it. La costituzione inglese, il Mulino, Bologna 1995).
7
W. Bagehot, La costituzione inglese cit., pp. 48-49.
8
W. Bagehot, The English Constitution cit., p. 6.
9
Cfr. P. Costa, Proprietà e cittadinanza nell’Europa moderna: una mappa tematica, in «ParoleChiave», 30, 2003, pp. 31-60.
10
Cfr. M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana e P. Pasquino,
Einaudi, Torino 1977.
11
Cfr. M. Foucault, La ‘governamentalità’, in «Aut Aut», 167-168, 1978, pp. 12-29; Id., Biopolitica e liberalismo, a cura di O. Marzocca, Medusa, Milano 2001. Cfr. anche Studies in Governamentality, with two lectures by and an interview with Michel Foucault, a cura di G. Burchell,
C. Gordon e P. Miller, Harvester Wheatsheaf, London 1991.
12
Cfr. A. Anghie, Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law, in «Harvard International Law Journal», 40, 1999, 1, pp. 1-79 e M.
Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 18701960, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pp. 98 ss. Cfr. anche G. W. Gong, The
Standard of ‘Civilization’ in International Society, Clarendon Press, Oxford 1984. Per Schmitt,
«la Weltanschaung civilizzatrice […] è l’ultimo relitto di un’altra epoca, nella quale l’Europa
era ancora il centro sacrale della terra; è una secolarizzazione ormai scaduta a caricatura» (C.
Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello‘jus publicum europaeum’, Adelphi,
Milano 1991, p. 272).
13
Cfr. J. Tully, Aboriginal Property and Western Theory: Recovering a Middle Ground, in Theories
of Empire 1450-1800, a cura di D. Armitage, Ashgate, Aldershot 1998, pp. 345-72; B. Arneil,
John Locke and America. The Defence of English Colonialism, Clarendon Press, Oxford 1996.
Cfr. anche D. Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University
Press, Cambridge 2000, pp. 95 ss.
14
Mamdani parla di «decentralized despotism» (M. Mamdani, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1996,
pp. 37 ss.).
15
Un recente e ricchissimo quadro generale della vicenda coloniale italiana è offerto da N. Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il Mulino, Bologna 2002.
16
Cfr. Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, a cura di P. Costa e D. Zolo, Feltrinelli, Milano
2002.
17
Cfr. (con particolare riferimento all’India) N. Hussain, The Jurisprudence of Emergency. Colonialism and the Rule of Law, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2003.
18
Sul rapporto fra sudditi e cittadini cfr. E. Capuzzo, Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza
coloniale italiana dell’età liberale, in «Clio», 1995, 1, pp. 65-95. Sul potere giurisdizionale in
colonia cfr. L. Martone, Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d’Africa dall’età
giolittiana al fascismo, Jovene, Napoli 2002.
19
P. Guillaume, Le monde colonial, Armand Colin, Paris 1999, p. 128. Il rilievo di Guillaume è
peraltro corrente presso i cultori di diritto coloniale fra Otto e Novecento. Cfr. ad esempio M.
349
Pietro Costa
D’Amelio, L’ordinamento giuridico della colonia eritrea (estratto dalla Enciclopedia Giuridica
Italiana, vol. III, p. 2°, sez. II), Società editrice libraria, Milano 1911; S. Romano, Corso di
diritto coloniale, Athenaeum, Roma 1918.
20
Cfr. P. Costa, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico, Giuffrè,
Milano 1974, pp. 364 ss.; M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975; D. Melossi, M. Pavarini, Carcere e fabbrica, il Mulino, Bologna 1977.
21
Sullo ‘stato di eccezione’ cfr. G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer, II, I, Torino, Bollati
Borighieri 2003. Cfr. anche Darker Legacies of Law in Europe. The Shadow of National Socialism
and Fascism over Europe and its Legal Tradition, a cura di Ch. Joerges e N. Singh Ghaleigh,
Hart, Oxford-Portland (Oregon) 2003.
22
Cfr. ad esempio G.L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza, RomaBari 1985; Le teorie della razza nell’età moderna, a cura di G. Gliozzi, Loescher, Torino 1986;
T. Todorov, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, Einaudi, Torino 1991;
G. Gliozzi, Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna, Vivarium, Napoli 1993;
W.H. Tucker, The Science and Politics of Racial Research, University of Illinois Press, Urbana
and Chicago 1994; Race. The Origins of an Idea 1760-1850, a cura di H.F. Augstein, Thoemmes Press, Bristol 1996; I. Hannaford, Race. The History of an Idea in the West, The Woodrow
Wilson Center Press, Washington 1996. Cfr. anche P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza
in Europa, 3., La civiltà liberale, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 405 ss.
23
Sulla ‘politica razziale’ del fascismo cfr. F. Grispo, Sulla politica indigena nell’Africa Orientale
italiana, in «Clio», XIX, 1983, 2, pp. 249-75; L. Goglia, Note sul razzismo coloniale fascista,
in «Storia Contemporanea», XIX, 1988, 6, pp. 1223-66; R. Pankhurst, Lo sviluppo del razzismo nell’impero coloniale italiano (1935-1941), in «Studi Piacentini», 1988, 3, pp. 175-97; L.
Goglia, F. Grassi, Il colonialismo italiano da Adua all’impero, Laterza, Roma-Bari 1993, pp.
223 ss.; A. Del Boca, Le leggi razziali nell’impero di Mussolini, in Il regime fascista, a cura di
A. Del Boca, M. Legnani e M.G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 329-51; G. Gabrielli,
La persecuzione delle ‘unioni miste’ (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito
giuridico, in «Studi Piacentini», 20, 1996, pp. 83-140; G. Gabrielli, Un aspetto della politica
razzista nell’impero: il ‘problema dei meticci’, in «Passato e presente», XV, 1997, n. 41, pp. 94105; B. Sòrgoni, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali
nella colonia Eritrea (1890-1941), Liguori, Napoli 1998; «I viaggi di Erodoto», XIII, 1999,
38/39, pp. 57-91 (ivi saggi di R. Bonavita, E. Collotti, G. Gabrielli); N. Labanca, Il razzismo
coloniale italiano, in Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1970-1945, a cura di
A. Burgio, il Mulino, Bologna 1999, pp. 145-63; G. Barrera, Patrilinearità, razza e identità:
l’educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934), in «Quaderni storici», 109, 2002 [La colonia: italiani in Eritrea, a cura di A. Triulzi], pp. 21-53; L. Martone,
Giustizia coloniale, cit., pp. 300 ss.
24
Cfr. A. Triulzi, La colonia come spazio di esclusione, in «Quaderni Fiorentini» (L’Europa e gli
‘Altri’. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento), 33-34, 2004-2005, pp. 359-378.
25
Cfr. A. Burgio, Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano, in Studi sul razzismo
italiano, a cura di A. Burgio e L. Cavalli, Clueb, Bologna 1996 pp. 19-28 e in generale Nel
nome della razza, a cura di A. Burgio, cit.
26
Cfr. P. Costa, Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, in
«Quaderni fiorentini», XVIII, 1999, pp. 285-399.
27
Cfr. le importanti osservazioni di N. Labanca, Oltremare cit., pp. 217 ss. Cfr. anche M.
Isnenghi, Il mito di potenza, in Il regime fascista, cit., pp. 139 ss.; E. Gentile, La Grande Italia.
Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, Mondadori, Milano 1997, pp. 181
ss.; P. Costa, Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica
350
‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’: la sovranità e le sue strategie di assoggettamento
italiana, in «Quaderni Fiorentini» (L’Europa e gli ‘Altri’. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento),
33-34, 2004-2005, pp. 169-257.
28
Alessandro Pizzorno dedica un importante contributo al concetto di politica assoluta in Le
radici della politica assoluta, Feltrinelli, Milano 1993, pp. 43 ss. Per Pizzorno, si ha una concezione ‘assoluta’ della politica quando si ritiene la politica «come il tipo di attività preposto a
dettare le regole di condotta per tutte le attività sociali rilevanti; mentre queste, a loro volta,
vengono valutate essenzialmente per le conseguenze politiche che possono produrre»; queste
conseguenze, a loro volta, vengono proiettate verso il futuro: «ciò che conta non è il benessere
degli esseri umani presenti, quanto invece la felicità attingibile da un’umanità futura» (pp. 4344). Ho mutuato da Pizzorno l’espressione ‘politica assoluta’ e la ho impiegata in Civitas. Storia
della cittadinanza in Europa, 4, L’età dei totalitarismi e della democrazia, Roma-Bari, Laterza,
2001, pp. 360 ss. dando ad essa un significato parzialmente diverso, per mettere a fuoco soprattutto, per un verso, l’annullamento della dialettica fra diritto e politica, e, per un altro verso, la
manipolazione illimitata dei soggetti entro il discorso ‘totalitario’ della cittadinanza.
351
Africa e dintorni
Omar El Mukhtar.
La costruzione della sua memoria ed il gruppo
insurrezionale che ne porta il nome
di Marco Boggero1
Questo articolo propone un’applicazione tanto tematica quanto transnazionale della teoria del nazionalismo come fonte di identità e un’applicazione di concetti sociologici nello studio della creazione della figura
di martire. Dato il ruolo svolto da cultura e letteratura nella formazione
dell’identità nazionale, messo in luce, ad esempio, nella teoria delle comunità immaginate, risulta interessante approfondire l’analisi di icone e miti,
o martiri nel caso specifico; in altre parole, gli eroi del libro di Benedict
Anderson2. L’approccio che abbiamo scelto si basa su due presupposti: in
primo luogo l’assunto iniziale è che il modello delle comunità immaginate
si possa legittimamente applicare ad almeno alcuni dei paesi arabi3; secondariamente riteniamo di non dover attenerci, in senso stretto, alle sue
originarie applicazioni4. L’articolo si compone quindi di quattro sezioni.
Nella prima introduciamo la figura di Omar El Mukhtar nel suo contesto
storico ed illustriamo le circostanze della sua morte. Di seguito prendiamo
in esame la memoria collettiva ufficiale, concentrando l’attenzione su due
casi. Nella terza e quarta sezione esponiamo elementi che indicano come
Omar El Mukhtar possa far parte, insieme ad altri eroi d’antica fama, di
una «comunità immaginata» araba: la terza sezione è dedicata in particolare all’origine del processo di costruzione del martiro negli anni trenta e al
suo successivo sviluppo; nella quarta prendiamo in esame le brigate Omar
El Mukhtar, un gruppo insurrezionale apparso sulla scena nelle due ultime
decadi, che ad oggi non è stato studiato, e che costituisce un elemento
d’identità peculiare e degno d’interesse.
353
Marco Boggero
Martirio e genocidio in Cirenaica
Omar El Mukhtar (il suo nome completo era Omar El Mukhtar bin
Omar bin Farhat) nacque nel 1858; apparteneva alla famiglia Ghiet e del
clan Farhat, quest’ultimo appartenente alla tribù beduina Manfaha di Burqa, in Libia. Suo padre era conosciuto come un uomo coraggioso e un
guerriero. Sua madre, Aesha bint Muhareb, allevò Omar e i suoi fratelli
secondo i principi devozionali e gli insegnamenti dell’Islam. In seguito gli
venne assegnato come insegnante Ahmed Sharif al-Senussi in una zavia,
ovvero una scuola senussita5. Risulta che Omar El Mukhtar abbia avuto
solo un figlio, al-Haj Muhammed Omar al-Mukhtar6.
Solo nel 1931, dopo vent’anni di lotta, Ornar El Mukhtar fu infine
preso prigioniero. Alla guida di poche migliaia di uomini aveva affrontato
un esercito coloniale di ben ventimila, dotato di aeroplani e armi moderne.
Le sue tecniche di guerriglia, basate su attacchi rapidi e circoscritti, dopo
i quali si ritirava svanendo nel deserto, provocavano a tal punto l’ira degli
italiani che questi ricorsero ai metodi peggiori. I fascisti bombardarono i
loro nemici con gas velenoso, inaugurarono nel paese una politica di pulizia etnica (che portò all’eliminazione di 100.000 persone), colpirono le
loro città sante7, espropriarono le zavie, esiliarono i leader religiosi. Infine,
arrivarono a tagliare le linee di rifornimento costruendo un muro di filo
spinato e ridotte8, un’impresa di costi e proporzioni enormi. Nel settembre
del 1931 venne catturato. Dopo un processo farsa, Omar El Mukhtar venne giustiziato, impiccato pubblicamente come se fosse un bandito, davanti
al suo stesso popolo nel campo di concentramento di Soluch9. Omar El
Mukhtar fu il simbolo della resistenza libica al colonialismo e divenne il
martire della rivolta in Cirenaica. Oltre a lui, anche altri ricoprirono un
ruolo fondamentale nel movimento di resistenza: Sayid Idris, negoziatore
capo e più tardi re della Libia; Ramadan al-Suwaylihi, consigliere di stato
della Repubblica tripolitana; Sayid Ahnled Sharif, leader militare che affrontò i francesi dal 1902 al 1912, gli inglesi in Egitto e gli italiani e gli
inglesi in Cirenaica nel 1916.
Tuttavia, Omar El Mukhtar è l’eroe della resistenza che più rimase nella
memoria. Ma come si costruisce il suo ricordo? Come era ed è interpretato
il suo martirio da chi è sopravvissuto, e che genere di emulazione viene
suggerita dai militanti? La parola martire ha un significato etimologico
piuttosto chiaro di «testimone». D’altra parte, le sue numerose definizioni
354
Omar El Mukhtar
conducono ad abusi del termine, a possibili fraintendimenti o espressioni
di fanatismo10. Generalmente, un martire è qualcuno che decide di soffrire
o morire pur di non rinunciare ai propri principi o al proprio credo. Molti
autori distinguono da un lato il martire attivo, che cerca attivamente la
morte e la sofferenza, e dall’altro l’individuo che accetta passivamente la
sorte che gli viene imposta11. La resa di El Mukhtar ad una sentenza di
morte ingiusta, all’età di 73 anni, non costituì in alcun modo un gesto di
autodistruzione. Non si trattava di una scelta attiva bensì passiva. Prima del
processo farsa che lo condannò all’impiccagione, avrebbe potuto salvarsi la
vita sottomettendosi alle forze coloniali occupanti. Egli non si arrese ma
non predico neppure il martirio, né per sè, né per i suoi uominii. suo martirio fu quindi involontario, o passivo. Ciò non impedisce che il messaggio
può essere oggi, come spesso accade, oggetto di varie interpretazioni.
Può venire codificato e reinterpretato. Si possono plagiare i militanti
perché credano di stare emulando la condotta di un martire e suppongano/
presumano erroneamente che egli stesso si sia volontariamente immolato.
L’esempio di Hussein, martire e nipote di Maometto, è illuminante12.
Anche se fu ucciso durante la famosa battaglia di Serbala, fece tutto ciò
che era in suo potere per evitare la lotta ed ottenere la pace. «Si avventurò
perfino sul campo di battaglia reggendo un neonato tra le braccia e invocando misericordia». Nonostante ciò, come evidenzia Davis, la «banda
dell’11 settembre credeva che avrebbe ricalcato le orme di Hussein». Senza
dimenticare questa differenza, utilizziamo l’analogia con Hussein per sottolineare come Omar El Mukhtar non avesse intenzioni di autosacrificio.
Questi non inviò alle sue truppe alcun ordine di proseguire in una lotta
disperata dopo la sua cattura; lasciò invece a ciascun combattente la libertà
di scegliere.
Abbiamo così posto le basi per la successiva discussione sulle brigate
Omar Mukhtar nella sezione quattro. Il suo martirio fu involontario. Lo si
può considerare un martire difensivo più che offensivo13.
Memoria collettiva
I martiri sono alla mercé del tempo. Non si convertono immediatamente in «miti riconosciuti». Prima di elevarsi ad un rango più alto, spesso
entrano a far parte di in una categoria diversa (quella di traditori o criminali, solo per citare alcuni esempi), o, talvolta, vengono dimenticati per un
355
Marco Boggero
lungo tempo. Le identità nazionali traducono le loro diverse narrative storiche attraverso eroi e martiri nelle diverse epoche. Prendiamo ora in esame
due casi, diametralmente opposti nel risultato finale, in cui lo Stato ha distorto o manipolato la figura di martire di Omar EI Mukhtar. Nel primo,
in Libia, il martire entrò e uscì dai discorsi ufficiali per quarant’anni; nel
secondo, in Italia, fu (ed è tuttora) eliminato dai libri di testo e censurato.
L’eroe nazionale libico
Sotto l’ondata di propaganda fascista, il ricordo della rivolta in Cirenaica sbiadì rapidamente su entrambe le sponde del Mediterraneo. La Libia
si appellò ufficialmente a Omar El Mukhtar dopo la guerra, quando il
nascente nazionalismo era alla ricerca di un’icona. Lisa Anderson nella sua
analisi dell’insorgere del sentimento nazionalista in Libia traccia il ritratto
di diversi patrioti: Ramadan al-Suwaylihi, Azzam Bey, al-Baruni, ma pochi
tra loro dimostrano lo stesso potere suggestivo di El- Mukhtar. Tuttavia,
la sua morte e il perdurare della sua memoria si trasformarono in una
minaccia successivamente alla rivoluzione. Infatti, il nome dello shahid
richiamava la monarchia di Idris al-Senussi, estromesso dai ribelli, e contribuiva ad intensificare le tendenze separatiste in Cirenaica. Tuttavia, dopo
la rivoluzione la sua morte e il permanere del suo ricordo si trasformarono
in una minaccia. Infatti, il nome dello shahid, oltre a richiamare la monarchia di Idris al-Senussi, deposto dal colpo di stato, risvegliava tendenze
separatiste in Cirenaica.
Si può osservare questa considerevole e generale discontinuità in almeno due ambiti: la storiografia e i monumenti. La prospettiva libica sulla
storiografia è interessante. Lisa Anderson scrive che, nel corso del ventesimo secolo, «la Libia ha conosciuto tre diversi periodi di storiografia
politica: durante l’occupazione italiana, l’enfatica rievocazione dell’eredità
romana; sotto la monarchia, l’attenzione verso lo sviluppo della confraternita religiosa della Senussia [...]; e, con il regime di Gheddafi, l’esaltazione
della resistenza popolare all’imperialismo italiano»14. È degno di nota il
fatto che, dopo il 1945 la «stessa propensione italiana per l’etnografia e
antropologia nel corso della storia […] si sarebbe riflessa negli studi libici». Un testo come I Senussi di Cirenaica rimase «virtualmente l’unico
testo storico per vent’anni» per quanto riguardava «l’interpretazione anglosenussita degli studi storici libici»15. Dopo il 1969, il regime rivoluzionario
356
Omar El Mukhtar
inaugurò un nuovo approccio alla storia. Nel giro di poco tempo, le nuove
pubblicazioni divennero meno lusinghiere nei confronti dei Senussi, nonostante gli elogi per i singoli, come Ramadan al-Suwayhli16 o Omar El
Mukhtar. Al-Hudayri, un afferma che i suoi libri su El Mukhtar, per
quanto venissero donati alle biblioteche libiche, vennero confiscati e
non arrivarono mai sugli scaffali17.
Il secondo ambito di discontinuità riguarda monumenti pubblici
e commemorativi. In Libia si trovano tuttora strade intitolate a Omar
El Mukhtar; esistono un’Università Omar El Mukhtar ad Al Baida e un
ambizioso piano di sviluppo in campo idrico, il Grand Omar El Mukhtar
Reservoir, parte di un progetto conosciuto anche con il nome di Great
Man-Made River, «il grande fiume artificiale»: un bacino-acquedotto finalizzato a trasportare acqua dolce dal deserto nel sud del paese alle zone
costiere. Tuttavia, il monumento costruito a Benghazi per commemorare
il suo martirio venne demolito nel 2000 per volontà di Gheddafi, che ordinò inoltre la demolizione di al-Nadi al-Ahli («il circolo del popolo») in
via Omar al-Mukhtar a Benghazi. Il circolo era noto per ospitare membri
politicamente attivi e sostenitori degli insegnamenti di El Mukhtar18. Le
recenti dichiarazioni riguardo al processo e all’impiccagione di Saddam
Hussein rientrano in questo schema di alternanze. Di fatto, in seguito al
processo si sono proposti paragoni con Omar El Mukhtar19. Dopo l’esecuzione, il regime ha proclamato che si sarebbe creato un monumento duplice dedicato a Omar El Mukhtar e Saddam. La Libia ha inoltre dichiarato
tre giorni di lutto dopo la morte di Saddam ed ha annullato le cerimonie
pubbliche in occasione della festa di Eid al-Adha; le bandiere degli edifici
governativi sventolavano a mezz’asta.
Vi sono ragioni per l’ambiguità che abbiamo delineato. Da un lato,
come abbiamo ricordato sopra, il regime doveva prendere le distanze da
simboli che potevano alimentare simpatie nei confronti dei Senussi o ambizioni di indipendenza della Cirenaica. D’altra parte, il martire era ed
è prezioso per almeno quattro motivi. Innanzitutto, Omar El Mukhtar
trasmette un messaggio di valori religiosi tradizionali in un tempo di incessante modernizzazione sociale ed economica. Secondariamente, il suo
messaggio raggiunge gruppi specifici di destinatari come gli anziani, soprattutto nelle campagne, persone che nei loro ricordi d’infanzia annoverano almeno parte del periodo coloniale; studi di scienze politiche hanno
talvolta posto in evidenza la natura tribale e tradizionalista del popolo li357
Marco Boggero
bico20. Inoltre, Omar El Mukhtar attrae quei settori della popolazione,
in particolare i giovani, che possono essere sedotti da ideali panarabi: di
recente, nella sessione inaugurale di un summit, Gheddafi ha esortato gli
africani «ad ispirarsi nelle loro opere alle grandi azioni dei grandi leader del
continente come Samori Toure, Omar El Mukhtar e Gamal Abdel Nasser
e altri che nel corso della storia dell’Africa rifiutarono di accettare una vita
di schiavitù e oppressione»21. Infine, rappresenta la retorica antioccidentale
e, in momenti specifici, un implicito richiamo alla causa palestinese. Nella
sua analisi dei discorsi di Gheddafi, pubblicati dal Green Book Center di
Tripoli, Vandewalle scrive:
colpiscono il numero e la forza dei riferimenti all’idea di una storia comune che ha
posto i libici in competizione con l’Occidente. […] I ricordi della brutalità fascista, la
cattura e l’impiccagione di Umar al-Mukhtar, l’esilio della popolazione locale dalla sua
stessa terra in favore dei coloni italiani: tutto ciò ha costituito una parte costante ed
essenziale della retorica di Gheddafi22.
Le analogie dell’occupazione e, recentemente, del muro, sono evidenti
per i giovani arabi, che conoscono bene la storia ampiamente divulgata del
martire, e mirano a suggerire un parallelo tra fascismo e sionismo.
Amnesia storica collettiva
Quando Omar El Mukhtar fu giustiziato, la stampa italiana, strettamente controllata dal regime, fornì un resoconto pomposo ma in qualche
modo limitato23. Più avanti, dopo la guerra, si ottenne con grande difficoltà un’ammissione dei crimini del genocidio (e quindi della storia di
Omar El Mukhtar) da parte degli storici ufficiali italiani24. Fu l’inizio di
un’amnesia storica collettiva che ha durato fino ad oggi. Omar El Mukhtar
non rappresentava altro che un episodio nello studio del colonialismo, un
episodio del quale la storiografia italiana non intraprese una revisione critica per un lungo tempo. Nella difficoltà di fare i conti con il fascismo, lo
stesso studio del colonialismo in Libia subì una specifica e apparente rimozione25. Soltanto negli anni ’70 gli archivi militari furono resi pubblici.
Finalmente, uno storico militare pubblicò un saggio dedicato alla repressione in Libia (diventato in seguito un libro dal titolo Colonialismo Italiano), nel quale definisce la repressione in Cirenaica un genocidio, citando i
358
Omar El Mukhtar
dati inquietanti di 40.000 morti su 100.000 deportati. Nel 1980 lo studio
militare di Rochat, tradotto in inglese, arabo e francese, decretò insieme a
Gli Italiani in Libia di Del Boca l’inizio di una nuova fase nella ricerca26.
Nel 1982, tuttavia, la distribuzione del film Il leone del deserto, che raccontava la storia di Omar El Mukhtar, non fu autorizzata27. A tutt’oggi, si
può proiettare solo con un permesso speciale28. Mentre l’Italia attraverso
rivelazioni sofferte faceva luce su certe verità riguardanti il corno d’Africa29,
alcuni osservano che è ancora l’emblema della rimozione storica30.
La manipolazione di un simbolo, o il suo uso retorico e utilitaristico,
evoca in parte i «simboli machiavellici insinuati» da un’ideologia nazionalista (B. Anderson), o l’impiego, da parte di Hobsbawn e Ranger, di
materiale antico per «costruire tradizioni fittizie di tono romanzesco e per
scopi altrettanto romanzeschi»31. In Italia, in senso negativo, si verificò una
restrizione imposta dallo Stato, come parte di un processo di ricostruzione
nazionale. In Libia, al contrario, le istituzioni legate a un simile processo di
«costruzione della nazione» (il museo, la carta topografica e il censimento
della popolazione), menzionavano assiduamente il martire. Il monumento a
Omar El Mukhtar vanta una storia peculiare32. Nondimeno, Omar El Mukhtar vive nella memoria della Libia come uno dei suoi «padri fondatori» .
La costruzione di un martire
In questa sezione studiamo come avvenne la mitizzazione del martire.
Innanzitutto, il martirio poteva contare su un processo di costruzione narrativa con un contesto ed un momento specifici. Inoltre l’immagine venne
immortalata dalla letteratura, con celebrazioni pubbliche e commemorazioni che assunsero forme diverse. Una rilevazione accurata dell’utilizzo
del martire, al cui riguardo questo articolo indica solo dati in corso di
elaborazione, mostra che Omar El Mukhtar divenne infine un simbolo in
Africa e in Asia, e nel mondo arabo in particolare.
Un clima di tensione
Un coraggio indiscutibile non è di per sè sufficiente per elevare una
morte ingiusta a martirio. Un’ampia propaganda e l’eliminazione del dissenso sono cruciali per il processo di costruzione del martirio33. Nel settembre 1931, il nome di Omar El Mukhtar venne citato costantemente
359
Marco Boggero
in Asia e Africa. Si celebrarono molti funerali a Damasco, in Palestina,
a Haifa, a Tripoli, e in molte moschee si tennero preghiere per il morto.
I sermoni esortarono a boicottare i prodotti italiani ed i negozi rimasero
chiusi. Migliaia di persone si riversarono per le strade, manifestando la
propria protesta contro l’esecuzione Tali eventi commemorativi nell’intero
mondo arabo furono interpretati come una dimostrazione dell’unità di
arabi e musulmani nella lotta contro l’occupazione e la presenza straniera
nella regione.
È rilevante notare che le celebrazioni si svolsero in un momento di
forti contrasti anticoloniali. La cattura e la morte di Omar El Mukhtar
avvennero solo poche settimane prima del Congresso islamico mondiale
a Gerusalemme. La tensione era così alta che il Mufti dovette garantire
che non si sarebbe detto nulla di provocatorio. In particolare, gli fu dato
ordine di controllare che non si accennasse all’«asserita usurpazione ebraica
dei luoghi sacri […] e che si tacesse sull’argomento dell’azione italiana a
Tripoli»34. Al Congresso musulmano, il martirio di Omar El Mukhtar proiettò un’immagine vivida, presente e persuasiva di come i poteri coloniali
stessero cacciando i musulmani dalle loro terre. Questo unì i delegati nella
loro determinazione contro il pericolo del sionismo. Abderrahman Azam
Bey affrontò il tema energeticamente. Un lungo applauso segnò la fine del
suo discorso e furono richiesti cinque minuti di silenzio35.
Nell’intero mondo islamico, le reazioni proliferavano. In Indonesia, i
giornali promossero un boicottaggio di tutti i prodotti italiani.
L’occasione del Congresso islamico mondiale naturalmente fornì la
cornice per un più ampio riconoscimento sociale di Omar El Mukhtar
come un martire. Si trattò della principale via di trasmissione del racconto
del martirio che determinò l’immortalità postuma di El Mukhtar. Fu a
Gerusalemme e nel corso del Congresso musulmano che un commentatore elevò l’eroe ad un rango superiore; ed è in Palestina che osserviamo
il primo esempio di un’associazione intitolata al martire con narrative e
sentimenti antisionistici.
Propaganda e censura
La censura e gli sforzi necessari per aggirare gli ostacoli frapposti non
scoraggiarono i sostenitori. Il tentativo di imbavagliare il dibattito durante
i giorni di lutto non minò la popolarità di Omar El Mukhtar.
360
Omar El Mukhtar
In Europa, solo pochi giornali trattarono la notizia. Il «London Times»
pubblicò un editoriale successivamente all’esecuzione36. «Le Cri du Peuple» a Parigi chiamò El Mukhtar l’«Abd el-Krim» della Cirenaica37. Ma la
denuncia più efficace giunse da «La Nation Arabe», un periodico di linea
polemica con un pubblico attento e affezionato. Il suo fondatore, l’intellettuale libanese Shakib Arslan, coprì la notizia con estrema veemenza38.
Arslan si può considerare come il «martirologo» che riuscì a «raccontare
i nudi fatti rendendoli eventi di rilevanza sociale»39. Mantenne il nome di
Omar El Mukhtar d’attualità tra il 1930 e il 1931 scrivendo una quantità
considerevole di articoli. In particolare, la condizione della popolazione cirenea era descritta in modo preciso e dettagliato. Si riporta la cifra di 80.000
rifugiati, una buona approssimazione della realtà40. Lo stesso messaggio
viene ripetuto più e più volte nell’estate del 1931. Il giorno subito dopo la
morte di Omar El Mukhtar, Arslan scrive un lungo articolo a lui dedicato.
Tale articolo presenta due fili conduttori. Con il primo, l’autore mira
a giustificare la lotta del guerriero libico: «Omar El Mukhtar non era un
ribelle», ribadisce Arslan. La forza occupante non aveva alcuna legittimità
nell’occupazione e «il ribelle è colui che rifiuta di obbedire all’autorità legittima». Con il secondo, costruisce un racconto da una prospettiva eroica.
La celebrazione romanzata includeva la descrizione di un prode soldato,
catturato tramite «intrighi e corruzione»41. Un combattente leale: mai, afferma il giornalista, El Mukhtar aveva ucciso un solo prigioniero italiano42.
Come molti altri, lo paragona a Abd el-Krim and Abd-el-Kader . Infine,
aggiunge una nota personale su un incontro che avevano avuto nel 1911, e
su un colloquio privato nel quale El Mukhtar gli aveva rivelato di presagire
in qualche modo la propria fine43. Possiamo da ultimo ricostruire il percorso compiuto dalla notizia del martirio in quel momento in costruzione.
Subito si propagò al di fuori del mondo arabo e raggiunse l’Asia. Il nazionalismo islamico globale di Arslan spesso trascendeva infatti la causa araba:
Modellò l’immagine della protesta su quella usata nella campagna contro il dahir berbero e trasmise la propria contestazione traducendola in simboli islamici. Comunicò
ai suoi lettori che gli italiani, una volta conquistata Kufra, la ridussero ad una taverna,
dove brindavano allo sterminio dei musulmani44.
Shakib Arslan fu un personaggio chiave. La mera quantità di pubblicità
da lui creata in termini di articoli, lettere e telegrammi lascia impressiona361
Marco Boggero
ti, ed era indiscusso nel mondo arabo il riconoscimento del suo ruolo di
profeta. «Era il ‘Lawrence d’Arabia’, che diffondeva il contagio del panarabismo»45. Un maestro d’eloquenza che diede al martirio una dignità simbolica, che rinviava a riferimenti interni alla cultura islamica, e che avrebbe
contribuito in maniera cruciale alla memoria del martire. Conoscendo il
modo in cui questa in origine fu costruita, possiamo iniziare a comprendere come al martire si richiamino sostenitori di una causa radicale.
Dunque, grazie ad Arslan e in particolare durante Il Congresso islamico
mondiale, la fama di Omar El Mukhtar ebbe una forte eco in Palestina.
Questo corrispose all’apice del processo di costruzione del martire. Al fine
di commemorarlo, il sindaco di Gaza, Fahmi al Husseini, decise di intitolare a Omar El Mukhtar la strada più grande della città, fatto che irritò
nuovamente gli «italiani, in particolare il consolato a Gerusalemme46. Torneremo su questi aspetti più avanti. Anche al di fuori di Libia e Palestina,
Omar El Mukhtar divenne il nome di strade, piazze ed università. Esistono
moschee Omar El Mukhtar da Khartoum a Baghdad.
Se Arslan aveva costruito un’immortalità quasi letteraria, Ahmad
Shawqi lo avrebbe seguito, per convertirsi in uno dei principali custodi
della memoria del martire. Il famoso poeta egiziano compose la sua elegia
più conosciuta dedicandola a El Mukhtar. Non è una coincidenza il fatto
che Shawqi fosse intimo amico di Shakib Arlsan47. Nel suo componimento, Shawqi narra delle caratteristiche eroiche di Omar El Mukhtar, descrivendolo e paragonandolo ad un guerriero del deserto della poesia araba
medievale. In quanto agli aggressori, sono rappresentati come selvaggi che
attendono la cattura di un candido agnello. L’elegia di Shawqi impose una
forte tendenza tra diversi poeti arabi moderni e contemporanei. Anche Gibran Khalil Gibran scrisse un’elegia dedicata ad Omar, così come il poeta
tunisino Mahmoud Abi Ruqaibah48. Oltre a ciò, si pubblicarono vari libri
non accademici dedicati alla memoria di Omar El Mukhtar49. Nel vasto
regno della cultura popolare, vale la pena di citare il film Il leone del deserto (1981) con Anthony Quinn, prodotto e diretto dal defunto regista di
origina siriana Moustapha Akkad. Il film è tuttora considerato un grande
successo nel mondo arabo e i giornali informano che sta godendo di una
rinnovata popolarità. Un’altra importante iniziativa culturale dedicata alla
memoria del martire è quella della creazione di festività lui dedicate. Dentro e fuori della Libia vennero poi organizzati speciali eventi e festeggiamenti in occasione di anniversari. Tra questi, una celebrazione interessante
362
Omar El Mukhtar
fu organizzata dal Jaffa Center for Study and Research al Cairo. Nel 2000,
la ricorrenza non fu dedicata solo a El Mukhtar ma anche all’Intifada palestinese.
Icone, immagini, disegni e dipinti di Omar El Mukhtar hanno spesso
accompagnato la narrativa scritta sulla sua vita e morte. Per secoli, la pittura delle icone ha costituito uno dei principali mezzi di espressione pittorica. Grazie in special modo ad un noto pittore di icone, Nicola Sayigh,
e ad uno dei suoi allievi, abbiamo trovato delle prime vivide raffigurazioni
del Leone del deserto.
Nel 1933 si tenne una mostra personale di dipinti ad olio del suo allievo Zulfa al-Sa’di
(1905-88) nel padiglione Palestina della Prima fiera panaraba, nelle sale del Consiglio supremo islamico a Gerusalemme. L’esibizione di una serie di lussuosi ritratti che
riproducono eroi storici e nazionali: Saladino, che liberò Gerusalemme dai crociati;
Umar al-Mukhtar, il combattente libico che era stato giustiziato dai fascisti due anni
prima dopo aver condotto una guerriglia ventennale contro l’occupazione italiana;
Sharif Hussein della Mecca e Amir Faisal, che guidarono la rivolta araba contro gli
ottomani durante la prima guerra mondiale50.
Omar El Mukhtar e l’Intifada palestinese
Non sorprende a questo punto che la memoria di Omar el Mukhtar
rimanga particolarmente vivida in Terra Santa.
La figura del martire è, sensibilmente, un’icona popolare nella topografia dei territori. Come menzionato sopra in rapporto a Gaza, molti sindaci
decisero di immortalarla nei nomi delle strade. Al giorno d’oggi, l’Autorità
palestinese innalza la bandiera nazionale e ha posto la sede dell’assemblea
legislativa in un edificio dalla cupola monumentale in via Omar Mukhtar,
la strada principale che collega il mercato centrale di Gaza al mare. Omar
Mukhtar è anche il nome di una delle sue moschee più grandi. In uno
studio più approfondito sulle origini dell’ identità nazionale palestinese si è
scoperto che Omar El Mukhtar è uno dei pochi personaggi della storia politica recente ad essere stato commemorato in città arabo-palestinesi prima
del 194851. Omar El Mukhtar ha lasciato tracce profonde per generazioni
nelle strade arabe ed in Palestina in particolare.
Vi sono molti elementi che mostrano un legame tra la figura del martire e la Palestina e, più specificatamente, con la stessa Intifada. Il suo uti363
Marco Boggero
lizzo come simbolo per le Brigate Omar El Mukhtar è documentato da
Reuven Paz. Molti attacchi si verificarono all’inizio della seconda Intifada.
I martiri costituiscono delle figure fondamentali nell’altamente espressiva
cultura e storiografia palestinese. Lo studio dei suoi martiri in questo contesto richiederebbe ben più ampi spazi. Accenniamo solo, brevemente, alla
relazione del fenomeno con quelle che Ted Swedenburg chiama «memorie
subalterne». Nella sua opera identifica i simboli di più vecchia data, risalenti alle origini del movimento, che si sono integrate nella lotta odierna52.
Mostra come i miti attuali derivano da memorie di insurrezioni precedenti, a partire dalla rivolta del 1936-39.
Tuttavia, colpisce che un martire non palestinese, come Omar El Mukhtar, venga largamente evocato durante la seconda Intifada. Si deve supporre che Omar El Mukhta rappresenti una valida alternativa nella lotta
contro la politica coloniale israeliana, e forse, di conseguenza, un’icona
dalla carica emotiva pari ad altri simboli ed eroi locali.
In realtà la politica di censura di Israele aveva inizialmente mirato ad
estirpare ogni tendenza che potesse incoraggiare sentimenti nazionalisti
palestinesi. Poiché «gli scritti palestinesi erano regolamentati severamente;
la parola Filastin o Palestina veniva a volte rimossa dalla carta stampata, ed
era illegale esibire i colori nazionali (rosso, nero, verde e bianco) insieme»53
si dovettero cercare miti alternativi anche se altri martiri avrebbero potuto
elevarsi a simboli egualmente evocativi. In conclusione, aggiungiamo che
negli anni trenta, quando Omar El Mukhtar si stava trasformando in un
martire iconico specialmente grazie all’abile prosa di Arslan, il suo nome
divenne segno di forti narrative sostitutive in Palestina simili ad una forma
di «memorie subalterne».
Brigate Omar Mukhtar
La seguente sezione è dedicata al gruppo insurrezionale che porta o ha
portato il nome del martire. Tale gruppo costituisce una novità peculiare,
che può rivelare elementi d’identità e nazionalismo. L’analisi delle brigate
Omar El Mukhtar (d’ora in avanti Omb) è sfuggente perché gli eventi abbracciano più di due decadi. I dati disponibili mostrano 18 casi di incidenti (vedi tavola 1, p.15) e un modello ciclico di apparizioni con tre ondate
che corrispondono al 1986, al 2000-2001 e al 2004-2006.
364
Omar El Mukhtar
Fonti e definizioni
Molti studi sul terrorismo sottolineano la cautela necessaria nell’accettare come «dati» prove empiriche che possono essere dubbie e controverse.
Facciamo assegnamento sulla letteratura secondaria e su nuove fonti, tanto
attendibili quanto possono esserlo. Ci affidiamo anche a vari da archivi
elettronici accessibili al pubblico. Il primo tratta del terrorismo internazionale. Nella sua relazione annuale, Patterns of Global Terrorism, il dipartimento di stato degli Stati Uniti segue gli incidenti di matrice terrorista.
Il secondo è l’archivio della Rand Corporation. Il terzo e il più specifico contiene i dati dell’Ict, che si focalizzano sulla «seconda fase» dei casi palestinesi.
Per quanto riguarda le definizioni, innanzitutto, quello che chiamiamo
incidente non rappresenta necessariamente un atto di terrorismo; combina
invece atti di guerriglia e di terrorismo. Il dipartimento di stato Americano
definisce il terrorismo come «violenza premeditata, politicamente motivata,
perpetrata contro obiettivi non belligeranti da gruppi subnazionali o agenti
clandestini, di solito diretta a influenzare un pubblico»54. I non belligeranti
includono sia i civili sia il personale militare che al momento dell’attentato
sono disarmati e/o fuori servizio. In secondo luogo, si potrebbe mettere
in discussione quali minacce siano da includere negli eventi considerati.
Alcuni qualificano la violenza in termini tanto ampi da includere ogni
atto che risulti in una sofferenza mentale; altri preferiscono restringere il
campo alla sua dimensione fisica. Sono necessarie presupposizioni sulla
trattabilità; di conseguenza includiamo minacce e incidenti in base alla
connessione intrinseca apparente tra gli eventi del 2004 e del 2006. Se,
infatti, tutti gli episodi riportati del 2004 erano di natura non belligerante,
gli incidenti più recenti furono violenti. La terza definizione è quella delle
Omb come un gruppo transnazionale. «Quando un incidente di origine
terrorista in un paese coinvolge vittime, esecutori o pubblico di due o più
paesi, il terrorismo assume un carattere transnazionale»55. Pertanto, i primi
incidenti si considererebbero transnazionali (l’interferenza libica a Cipro),
gli episodi della seconda ondata si possono anch’essi ritenere tali, mentre,
per quanto riguarda la terza ondata (2004 – 2006), non siamo in possesso
di dati sufficienti per una valutazione in questo senso. Tuttavia, al fine di
preservare l’unità dell’analisi, abbiamo scelto di applicare anche nell’ultimo caso la definizione di transnazionale.
365
Marco Boggero
I primi episodi
Nel 1986 apparve per la prima volta un Commando Nazionale Rivoluzionario Omar al-Mukhtar, che prese di mira gli interessi tanto britannici
quanto americani in Libano, sostenendo che si trattasse di una rappresaglia
contro l’«aggressione americana» alla Libia.
Il 3 agosto 1986, alcuni terroristi attaccarono la base britannica a Akrotiri (Cipro),
con mortai, granate con propulsione a razzo, fuoco da armi piccole. Nel rivendicare la
responsabilità per l’attacco, l’Organizzazione nasseriana unita citò il Gruppo martire
Omar al-Mukhtar. Un gruppo con un nome simile rivendicò la responsabilità di un
attacco missilistico alla residenza dell’ambasciatore britannico a Beirut due giorni dopo il raid statunitense56.
Un terzo evento, nel 1986, comportò la cattura a Beirut di un ostaggio
americano, Frank Herbert Reed, dalle «Cellule arabe rivoluzionarie – Brigata Omar El Mukhtar»57. L’ostaggio rimase sotto sequestro per 44 mesi58
ma la rivendicazione di responsabilità, giunta cinque giorni dopo il sequestro, non venne mai verificata59. Secondo il «Washington Post», il gruppo
avrebbe rapito e ucciso Peter Kilbum nel 1986, apparentemente come rappresaglia per il bombardamento in Libia da parte degli Stati Uniti. Sembra inoltre che abbia partecipato nell’uccisione di tre cittadini britannici
nell’aprile 198660. Di fatto, il Memorial Institute for the Prevention of
Terrorism (Mipt) cita solo quatto episodi nel 1986, escludendo quindi gli
ultimi due avvenimenti descritti. Tutti gli attacchi agli interessi americani
e britannici facevano parte della reazione agli eventi del Golfo di Sidra e,
in senso ampio, di un momento turbolento del terrorismo, con una rete
crescente sostenuta da Gheddafi dagli anni sessanta e settanta61.
La seconda fase
In seguito, un gruppo palestinese iniziò ad usare il nome «Forze di
Omar El Mukhtar» nei suoi attacchi a Israele nei Territori occupati62. La
cooperazione tra i gruppi palestinesi e le Omb ha prodotto, come riferisce
Reuven Paz, «dozzine di attacchi» nel 2001, per quanto siamo stati in grado
di documentarne solo sette nel periodo del 2000-01. Secondo Reuven Paz:
In un articolo sul quotidiano «Al-Khalij», si afferma che le Forze di Omar al-Mukhtar
366
Omar El Mukhtar
appartengono a Hamas63. Questo secondo gruppo apparve per la prima volta nell’aprile 1998 quando, d’accordo con il giordano Al-Dustur, rivendicò la responsabilità per
un attacco compiuto il 19 aprile contro i coloni israeliani insediati a Maon, presso la
città di Hebron. «Per quattro mesi, dal 28 settembre, il gruppo ha rivendicato la responsabilità di dozzine di operazioni in 23 comunicati pubblicati sul sito web di «The
Free Arab Voice»64.
Rivendicò, insieme ad altri due gruppi minori, un attacco ad un autobus scolastico vicino a Kfar Darom, nella striscia di Gaza65. Il gruppo diffuse poi un pamphlet a Gerusalemme est, nel quale minacciava l’uccisione
dei palestinesi a Gerusalemme accusati di essere collaborazionisti di Israele66. Al momento attuale, non è possibile sapere se tutti gli incidenti siano
collegati. Un’altra questione è se si debba dare per scontata l’appartenenza
ad Hamas. Yonah Alexander ed alcune nuove fonti menzionano il gruppo
come affiliato a Fatah67. Come terza e ultima annotazione, vogliamo ricordare la possibilità che la cellula sia stata smantellata dalla polizia israeliana
nel 2001. Ciò sembrerebbe attestato dalle indagini della polizia, che riportano come i sei residenti dei territori arrestati fossero arruolati nella cellula
«Omar El Mukhtar», cui obiettivo era di commettere omicidi e attacchi
all’interno della Linea Verde68. Tale smantellamento sarebbe anche confermato dal fatto che alcuni tipi di attacco terminarono nel 2001.
La terza fase
Vi sono episodi più recenti, in particolare numerose minacce dirette a paesi che sostengono l’intervento in Iraq, tanto direttamente quanto
indirettamente (Paesi Bassi, Italia, Arabia Saudita, Mauritania, Turchia,
Australia, Polonia, Bulgaria, San Salvador; tutti nel 2004). Nel settembre
2006, un Omb irachena attaccò con road bomb e fuoco di mortai cinque
pattuglie americane69. Quest’attentato venne rivendicato dalle Omb e dalle
Brigate Salah al-Din al-Ayubi; parte, queste ultime, di un’organizzazione
ad ombrello che si costituì quando diversi gruppi di resistenza sunniti nel
nord dell’Iraq unirono le forze, secondo la Rand Corporation. Un altro tema richiede attenzione: la relazione con le Brigate islamiche del Tawhid70.
Tuttavia, fino ad oggi se ne sono rinvenute poche prove.
Innanzitutto, ci interroghiamo su cosa suggerisca la relazione con Omar
El Mukhtar. Perché la sua figura viene evocata e presa ad esempio dai mi367
Marco Boggero
litanti? In molte fonti arabe, ci si riferisce a El Mukhtar come lo sceicco.
Gli vengono anche attribuiti i nomi quali il maestro, il maestro della Jihad,
il militante, il costante, il guerriero, il cavaliere, il cavalleresco, il combattente anticoloniale, il maestro della guerriglia, l’eroe, il ribelle libico e il
condottiero, tra molti altri71. Esistono ragioni che possono spiegare perché
il martire venga citato instancabilmente con intenti radicali. Per prima
cosa, la cattura ed il processo di Omar El Mukhar, che condussero alla
sua esecuzione, costituiscono un forte ricordo di ingiustizia. El Mukhtar
ispirò generazioni per quanto riguarda il diritto di vivere liberamente nel
proprio paese e di difenderne il territorio. Il suo fermo impegno può venire
interpretato come una chiamata alle armi per proteggere il proprio paese
e, nella misura in cui si spingono avanti le letture più radicali, si traduce
in una disposizione al martirio. In questo senso, il suo messaggio possiede
una componente più laica. In secondo luogo, si erige a modello di pietà
religiosa nel comando. La sua istruzione negli insegnamenti islamici è fonte di ispirazione per i giovani musulmani che vivono in regimi autoritari
nel mondo arabo. Da ultimo, Omar El Mukhtar è riconosciuto come il
maestro della guerriglia che era. Con i suoi attacchi rapidi che colpivano
il nemico di sorpresa, dimostrò di costituire un’arma efficace contro un
esercito occupante. Per i gruppi militanti in tutto il mondo, e in special
modo per i gruppi palestinesi, il martire settantenne è considerato l’eroe
principale della guerra arabo-libica contro Roma.
Un altro obiettivo che ci siamo proposti è quello di investigare se esista
una logica nella violenza che si è manifestata. In generale, sono presenti
quattro caratteristiche comuni. Per cominciare, la maggior parte degli eventi presenta un basso livello di violenza. L’unica vivida eccezione è un caso
di «prova d’iniziazione», consistente nel barbaro assassinio di una donna
innocente in Israele. In secondo luogo, non esistono legami evidenti con
la rete di Al Qaeda72, o con forme di jihadismo globale73. Inoltre, gli eventi
associati con le Omb sembrano suggerire una polarizzazione del conflitto.
Le tre fasi corrispondono al 1986, al 2000-01 ed al 2004-06, vale a
dire la guerra civile libanese, la seconda Intifada e il conflitto iracheno. La
ciclicità dello schema è in relazione con una radicalizzazione del terrorismo internazionale o con l’intensificarsi della violenza locale. Infine, non
si osserva l’uso di operazioni di martirio. Questo è un dettaglio eloquente e
concentreremo l’attenzione su tale ultimo punto, per spiegarne la rilevanza.
Innanzitutto, lo studio delle Omb richiede lo studio di Omar El Mu368
Omar El Mukhtar
khtar in quanto simbolo organizzativo e ispiratore. La scelta di un simbolo
può rendere più comprensibili motivazioni, credenze e convinzioni. Oltre
a ciò, il fenomeno delle missioni suicide è diventato l’atto definitorio della
violenza politica della nostra epoca74 che è cresciuto da una media di tre
all’anno negli anni ottanta a circa dieci all’anno nei novanta75. Sembra
quindi pertinente domandarsi il perché non si mettessero in atto operazioni di martirio. Fino ad oggi, infatti, non disponiamo di prove per documentare alcuna operazione suicida legata al nome di Omar el Mukhtar,
né per gli episodi libanesi né per quelli in Palestina o in Iraq. L’attuale
tendenza di attentati suicidi si inaugurò in Libano, con attacchi all’esercito
israeliano nel 1982 ed offensive a Beirut nell’ottobre 1983. È dal Libano
che si diffuse in Palestina e in Medio Oriente. Nella regione mediorientale
gli attacchi delle Omb del 1986 e del 2000-2001 (che, sottolineiamo, non
presentavano alcun collegamento tra loro per natura e presunta affiliazione) coincidono con due dei picchi nele quattro ondate di attacchi suicidi
identificate da Ricolfi76 (guerra del Libano, inizio della prima Intifada,
adempimento degli accordi di Oslo, seconda Intifada).
Tanto in termini assoluti quanto nell’indice di frequenza , l’autore rintraccia una propensione alle missioni suicide. La è, pertanto, perchè gli
attacchi delle Omb non imitano Hezbollah, Hamas o la Jihad islamica
palestinese (Pij), replicandone le operazioni di martirio? Il problema del
perché alcune organizzazioni non ricorrano a missioni suicide viene affrontato in un’opera di Kalyvas e Sanchez-Cuenca77. Tra le spiegazioni che
propongono, una è applicabile alle Omb: quella della scelta normativa. Gli
autori parlano di costrizioni morali assunte volontariamente, in base ad
una prospettiva religiosa, ideologica o di altro genere, che porta gli insorti
a credere di essere parte di una guerra giusta.
All’inizio di questo documento, abbiamo esemplificato come i militanti possano venire ingannati e convinti di stare emulando un martire. Se
presumiamo un tentativo di emulazione del personaggio storico, sarebbe
quindi completamente fuorviante fare un idolo di Omar Mukhtar per proporre una «missione di martirio». Sopra, abbiamo utilizzato l’esempio di
Hussein per chiarire questo punto. La resa di Mukhtar ad una sentenza di
morte non rappresentò in alcun modo un atto di autodistruzione, come
nel caso di Hussein. Dunque, possiamo apparentemente presupporre una
scelta normativa, ovvero una costrizione morale. Assunta volontariamente
da parte dei militanti delle brigate Omar Mukhtar, la scelta di non parteci369
Marco Boggero
Tavola 1
1
data
località
evento
appartenenza
marzo 1986
Beirut
Rapimenti
(Reed, Ciccippio)
Omb alias Commando
rivoluzionario nazionale
(Libia)
Attacchi dinamitardi alla sede
Omb alias Commando
del John Kennedy Center,
rivoluzionario nazionale
vicino all’Università americana
(Libia)
di Beirut
2
28 marzo 1986
Beirut
3
28 marzo 1986
Beirut
Missili sull’ambasciata
americana a Beirut ovest
Omb alias Commando
rivoluzionario nazionale
(Libia)
Omb alias Commando
rivoluzionario nazionale
(Libia)
4
29 marzo 1986
Beirut
Bombardamento (fallito)
dell’ufficio della British Airways e attacco missilistico
agli uffici dell’ American Life
Company
5
aprile 1986
Beirut
Attacco missilistico alla
residenza dell’ambasciatore
britannico
Omb alias United Nasserite Organization (UNO)
(Libia)
6
agosto 1986
Akrotiri, Cipro
Attacco con mortai ed armi da
fuoco di piccole dimensioni
alla base britannica
Sconosciuta
7
gennaio 2000
Hadera
Bombardamenti a
controllo remoto
Sconosciuta
8
novembre 2000
striscia di Gaza, Spari contro automobile civile
valico di Rafah
israeliana
Fatah
9
novembre 2000
striscia di Gaza,
Kfar Darom
Attacco ad una pattuglia
dell’esercito israeliano
Fatah
10
novembre 2000
striscia di Gaza,
Kfar Darom
Attacco ad una postazione
dell’esercito israeliano
Fatah
11
novembre 2000
Israele
Minacce
Fatah
12
gennaio 2001
13
aprile 2001
Galilea
Cittadini israeliani
pugnalati
Fatah
14
ottobre2001
Haifa
Omicidio di una donna
Sconosciuta
striscia di Gaza, Bombardamenti a controllo
Kfar Darom remoto sull’esercito israeliano
Fatah
15
2004
Varie
Minacce
Sconosciuta
16
settembre 2006
Iraq
Road bomb
Sconosciuta
17
novembre 2006
Iraq
Road bomb
Sconosciuta
18
dicembre 2006
Iraq
Fuoco di mortai
Sconosciuta
370
Omar El Mukhtar
pare a missioni suicide deriverebbe da una precisa volizione individuale, o
di gruppo, e non sarebbe dovuta a motivi contingenti. Ai fini della nostra
analisi delle Omb e per motivi di spazio, restringiamo per ora il campo di
discussione agli aspetti normativi78.
Conclusione
Una delle questioni più vaste che questa ricerca analizza è quella di
come il martirio di Omar El Mukhtar venne costruito nel corso del tempo
e come oggi sia narrato. Il processo di costruzione del martirio è caratterizzato da aspetti transnazionali. La figura del martire fu generata e propagata in Medio Oriente negli anni trenta e solo successivamente reclamata
dall’Africa: in contesti africani, in cui alcuni retaggi ed usanze vengono
importati, forma parte delle tradizioni locali e costruisce uno degli «ideali
di resistenza popolare al colonialismo»79. Nel contesto di un’opera in corso
di elaborazione, descrivo la preservazione della memoria e la diffusione
della figura del martire, assimilandola a a una tradizione inventata. I riferimenti ad Omar El Mukhtar non sono collegati in modo vago; sono
piuttosto segno di un’identità specifica e di una «comunità immaginata»
internazionale. Questa figura di martire rappresenta la giustizia, la fiera
indipendenza, la pietà religiosa nel comando, lo spirito della lotta e la determinazione. Sotto il peso del suo impiego recente e più militante, , il
messaggio originale di giustizia e rettitudine può risultare parzialmente
oscurato. Nondimeno, l’idea di Omar El Mukhtar come parte di un’identità e un’appartenenza nazionale risulta un elemento fondamentale all’interno del messaggio. Ciò è stato dimostrato attraverso esempi di diverse
gradazioni, dal contesto palestinese toponomastica delle strade arabe. La
diffusa popolarità di Omar El Mukhtar nel mondo arabo suggerisce che la
figura sia, alla pari con il Saladino, uno dei simboli immortali dell’identità
araba. Il fatto che le brigate Omar al-Mukhtar presentino aspetti transnazionali si attaglia allo schema identificato. Di per sé, lo studio del gruppo
insurrezionale costituisce un fenomeno interessante, che merita ulteriore
approfondimento.
Traduzione dall’inglese di Silvia Benedetti
371
Marco Boggero
Note al testo
1
Documento preparato per l’ Africa Conference all’Università del Texas ad Austin 2007. I miei
ringraziamenti vanno a William J. Foltz, Ellen Lust-Okare, Angelo Del Boca, Nicola Labanca,
Giorgio Rochat, Aleta Wenger, Lisa Anderson, Sihem Ghédira, Peter Bergen, Reuven Paz,
Gabriel Weimann.
2
B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifesto
Libri, 1996 (Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalism. Verso,
New York 1983).
3
Cfr. Israel Gershoni, Old and new Narratives, in Rethinking Nationalism in the Arab Middle
East, a cura di Israel Gershoni e James Jankowski. Gershoni osserva che il modello delle comunità immaginate proposto da Benedict Anderson si può applicare ad alcuni paesi arabi.
4
Benedict Anderson si occupa nella sua analisi principalmente di come le nazioni vengono immaginate, più che di cosa loro stesse immaginano di essere. Tuttavia, nelle opere precedenti
si può trovare un interesse verso il tema, che sembra essere uno sviluppo complementare allo
studio del nazionalismo. Per i saggi tematici scritti prima della pubblicazione di Comunità
immaginate nel 1983. cfr. l’interessante Cartoons and Monuments: The Evolution of Political
Communication under the New Order in Language and power: exploring political cultures in Indonesia, Cornell University Press, 1990. Per il dibattito più recente sulle «comunità immaginate»
cfr. Pheng Chea e Jonathan Culler, Grounds for Comparison: Around the Work of Benedict
Anderson, Routledge, New York 2003.
5
Per fonti sulla Senussia cfr. Edward Evan Evans-Pritchard, Sanusi of Cyrenaica, Clarendon
Press, Oxford 1954 o Nicola Ziadeh Sanusiyah: a study of a revivalist movement in Islam, E.
J. Brill, Leiden 1958, o Jean-Louis Triaud, Légende noire de la Sanûsiyya:une confrérie musulmane saharienne sous le regard français (1840-1930), Éditions de la Maison de sciences de
l’homme, Paris 1995.
6
Viene menzionato sia sotto il nome di Mohammed Sahle (secondo gli atti del processo riprodotti in Enzo Santarelli, Giorgio Rochat, Luigi Goglia, Romain Rainero, Omar alMukhtar e la riconquista fascista della Libia, Marzorati, Milano 1981, p. 259), sia sotto quello
di al-Haj Muhammed Omar al-Mukhtar
7
Città di Kufra. Cfr. Angelo Del Boca, Gli italiani in Libia: dal fascismo a Gheddafi, Mondadori, Milano 1994, p.198.
8
Un muro di filo spinato di 270 chilometri venne costruito contro Omar Mukhtar, tra la Cirenaica e l’Egitto (con una linea telefonica, tre posti fortificati maggiori, sei fortini e tre basi
aeree).
9
Cfr. cap. 8 «Soluch like Auschwitz» in A.Del Boca, Italiani brava gente?, Neri Pozza, 2005,
pp. 165-182.
10
La storia del concetto di martirio è rilevante. Islam e cristianesimo identificano entrambi il
concetto di martire con quello del testimone della tradizione greca, romana ed ebraica. Tuttavia la parola shahīd, spesso tradotta come martire, aveva alla sua nascita un altro significato:
indicava semplicemente l’individuo che seguiva una condotta di vita appropriata e devota. Si
riferiva originariamente alla jihad, ma in termini di atteggiamento difensivo e resistenza non
violenta. Di conseguenza, la traduzione di shahīd come martire «intorbida le acque», cfr. Brian
Wicker, Witnesses to Faith? Martyrdom in Christianity and Islam, Ashgate, Aldershot 2006. pp.
2-4, 88-89.
11
Eugene Weiner e Anita Weiner, The martyr’s conviction: a sociological analysis, Scholar Press,
372
Omar El Mukhtar
Atlanta (Ga), 1990, pp. 9-10.
12
Joyce M. Davis, Martyrs: Innocence, Vengeance and Despair, Cambridge University Press,
2003, pp. 16-17 e 47-9.
13
Farhad Khosrokhavar, Les nouveaux martyrs d’Allah, pp.. 36-45.
14
Lisa Anderson, Legitimacy, Identity, and the Writing of History in Libya, in Statecraft. in the
Middle East, a cura di E. Davis e N. Gavrielides, Florida University Press, Tampa 1991, p. 73.
15
Lisa Anderson, Legitimacy, Identity, and the Writing of History in Libya cit., p. 82.
16
Su Ramadan al-Suwaylihi, consigliere di stato in Libia, cfr. Ramadan al-Suwaylihli: Hero of the
Lybian Resistance, in E. Burke, Struggle and Survival in the Modern Middle East, I.B. Tauris,
London 1993; sulla breve storia della repubblica libica, il primo esempio nel mondo arabo,
della stessa autrice The Tripoli Republic. 1918-1922 in Social and Economic Development of
Libya, a cura di E. G. H. Joffe e K.S. Mc Lachlan, Menas Press, 1982.
17
Al-Hudayri, Omar al-Mukhtar in the Sixtieth Anniversary of his Death, p.122.
18
Si possono trovare resoconti sull’associazione in Majid Khadduri, Modern Libya: a study in
political development, John Hopkins Press, Baltimora 1963, pp. 62-66. Si fornisce un primo
ritratto dei membri e delle pubblicazioni, così come la rilevante distinzione tra i distaccamenti
in Tripolitania e in Cirenaica. Gli scritti del Jam’iyyat ’Umar al-Mukhtar furono raccolti da uno
dei suoi membri: Muhammad Bashir al-Mughayiribi, Wata’q Jam’iyyat ’Umar al-Mukhtar
safhat min ta’rikh Libya, Mu’assasat Dar al-Hilal, Cairo 1993. Un resoconto interessante si
trova in Anna Baldinetti, Note sul nazionalismo libico: l’attività dell’associazione ‘Umar alMukhtar’, «Journal of Libyan Studies», 2,1, uscito nel 2001.
19
A’ishah Mu’ammar Al-Gheddafi, membro del comitato di difesa di Saddam e figlia del colonnello Gheddafi, ha affermato: «Quello che sta accadendo oggi ci ricorda lo sceicco dei mujahidin, Omar al-Mukhtar, in piedi di fronte al tribunale fascista. La storia si ripete con nuovi volti
e nuovi eroi. Se Saddam, Dio ci salvi, doveva essere giustiziato, la sua vita durerà comunque
più di quella dei suoi giustizieri.» Trascrizione dalla Tripoli Great Jamahiriyah TV, 5 novembre
2006. Disponibile su Word News Connect.
20
Sembrano non esistere pubblicazioni aggiornate di recente disponibili, ma per un’analisi basata su rilevazioni dello sviluppo politico della Libia rurale ed urbana cfr. O. I. El Fathaly e
Monte Palmer, Political Development and Social Change in Libya, Lexington 1980; per studi
tematici cfr. M. Deeb e M. J. Deeb, Libya Since the Revolution: Aspects of Social and Political
Development, Praeger, New York 1982.
21
Mena, Cairo, 1° giugno 2006. Trascrizione, disponibile su World News Connect.
22
Cfr. Symbols, Myths, Islam and opposition in Dirk Vandewalle, A History of Modern Libya,
Cambridge University Press, New York 2006, pp.124-130.
23
Cfr. E. Santarelli, G. Rochat, L. Goglia, R. Rainero, Omar al-Mukhtar e la riconquista
fascista della Libia cit., pp. 287-295. Interessante il commento: «la morte di Omar non suscitò
molto interesse tra gli antifascisti o almeno non abbastanza da essere usata come argomento
di propaganda anticoloniale», p. 300. Al contrario, la stampa nel mondo arabo reagì energicamente alla notizia: da Al-Arham al Cairo, fino a Al-Akla Ul-Watani a Baghdad, dal Marocco a
Giava. A Gerusalemme e Aleppo, il principe druso Shekib Arslan ne divenne il campione. Cfr
A.Del Boca, Italiani brava gente? cit, p. 208 e pp. 222-232.
24
Cfr. R. J. B. Bosworth, Mussolini, Oxford University Press, Oxford 2003.
25
Labanca parla di «blocco o silenzio», in Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo. Atti del
Seminario di studi storici italo libici, Siena - Pistoia,13-14 gennaio 2000, a cura di Nicola Laban-
373
Marco Boggero
ca e Pierluigi Venuta, Editrice CRT, Siena 2000, p. 21.
26
Ibidem, p.27.
27
Alcuni sostengono che i cinema rifiutarono di metterlo in cartellone temendo di provocare gli
stessi disordini suscitati in Francia dal film La battaglia di Algeri. Cfr. A. Del Boca, Italiani
brava gente?, nota 36, p. 184.
28
Cfr. quanto dice Angelo Del Boca in Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo cit., nota
73, p. 392.
29
Per un resoconto completo, v. I gas di Mussolini: il fascismo e la guerra d’Etiopia, a cura di A.
Del Boca, Roma 1996, dove l’autore descrive come il suo primo tentativo revisionista del 1965
sia stato accolto con disprezzo e insulti.
30
Così Fabio Giannelli in Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo cit., p. 27.
31
Cfr. Invention of tradition, a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, Cambridge University
Press, Cambridge 1983.
32
Il monumento di Bengasi venne eretto e poi distrutto; si è dichiarato che verrà ricostruito
insieme ad un altro dedicato a Saddam Hussein. La mappatura dei monumenti di Omar Mukhtar è tuttora in corso e rientra nel lavoro intrapreso per questa ricerca.
33
Sul modo in cui l’idea del martirio si presta all’analisi topica, cfr. Eugene Weiner e Anita
Weiner, The martyr’s conviction cit., pp. 9-10.
34
Il Congresso venne convocato per ordine di Amin al-Husayni, il gran Mufti di Gerusalemme,
le cui intenzioni ed azioni venivano monitorate attentamente dalle autorità britanniche. In
quest’occasione il Mufti aveva garantito che non si sarebbe detto nulla di provocatorio riguardo
all’«asserita usurpazione ebraica dei luoghi sacri [...] e nulla sull’argomento dell’azione italiana
a Tripoli», telegramma dall’alto commissario per la Palestina al segretario di stato per le colonie,
21 novembre 1931. Ristampato in Islamic Movements in the Arab World, 1913-1966, 19251933, v. 2, a cura di A.L.P.Burdett, Archive Editions 1988.
35
«La Nation Arabe», novembre-dicembre 1931, p. 8. Aggiunge che «il governo italiano non
poteva prevenire un’esplosione di rabbia dalle ampie ripercussioni nel mondo musulmano e
richiese l’espulsione di Azam Bey dalla Palestina.»
36
«London Times», 17 settembre 1931, p. 13.
37
«La Nation Arabe», settembre-ottobre 1931, p. 4.
38
Cfr. William L. Cleveland, Islam against the West: Shakib Arslan and the Campaign for Islamic
Nationalism, University of Texas Press, Austin 1985.
39
Eugene Weiner e Anita Weiner, The martyr’s conviction, cit., p.21. L’autore riconosce a
Methvin il credito per aver studiato i «martirizzatori» e documentato il processo di creazione
dei martiri; v. Eugene H. Methvin, The riot makers; the technology of social demolition, Arlington House, New Rochelle, N.Y. 1970.
40
«Un formidabile movimento anti-italiano si è diffuso nel mondo musulmano nelle ultime tre
settimane, in seguito all’occupazione di Kufra da parte delle truppe italiane. L’occupazione è
stata effettuata in modo barbaro ed ha causato l’esodo di 80.000 arabi[…]. La smentita ufficiale dei rappresentanti italiani al Cairo, a Gerusalemme, Baghdad, nelle Indie non ha convinto
nessuno.», «La Nation Arabe», luglio-agosto 1931, p. 23, traduzione dell’autore. Gli 80.000 citati sono gli abitanti espulsi dalla Cirenaica, ma egli scrive che la popolazione totale allontanata
dai fascisti arriva al quarto di milione. Vedi anche Les Quatre-vingt mille Arabes de Cyrenaique
seraient-ils rapatriés dans leurs foyers?, «La Nation Arabe», settembre-ottobre 1931, pp. 48-50.
374
Omar El Mukhtar
41
«Il fut pris par la ruse et la corruption», «La Nation Arabe», settembre-ottobre 1931, p. 4. Questo è stato in parte accertato, nonostante la ricognizione aerea abbia giocato anch’essa un ruolo.
Cfr. G. Rochat in E. Santarelli, G. Rochat, L. Goglia, R. Rainero, Omar al-Mukhtar e la
riconquista fascista della Libia cit.
42
«La Nation Arabe», settembre-ottobre 1931, p. 3. Questa è ovviamente propaganda. Per quanto meno crudeli dei loro nemici, i soldati di Omar Mukhtar uccisero alcuni prigionieri, perfino
degli ufficiali. Il caso del ten. Beati è documentato.
43
«Omar Mukhtar non mi ha mai scritto. Tuttavia, due o tre mesi fa m iringraziò per un articolo
che avevo pubblicato riguardo alle atrocità italiane e mi assicurò che quella era soltanto una
parte dell’intera verità. […] Terminò la sua lettera dichiarando che avrebbe lottato fino alla
fine», «La Nation Arabe», settembre-ottobre 1931, p. 6.
44
W. L. Cleveland, Islam against the West, p. 100.
45
«Era il ‘Lawrence d’Arabia’, che diffondeva il contagio del panarabismo, modellava le opinioni
degli studenti marocchini e tunisini a Parigi ed emanava da Ginevra direttive che venivano
seguite a Rabat e Constantine; era il profeta ed il demagogo del panarabismo, la sua parola era
seguita come un faro dall’opinione pubblica arabo-islamica». J. Desparmet e P. Jalabert, citati
in W. L. Cleveland, Islam against the West cit., note 77 e 78 a p. 111.
46
Ahmad al-Zawi, Al-Tahir, Omar al-Mukhtar cit., p.191. Quando Fahmi al-Hussieni dichiarò la sua intenzione di intitolare una delle più grandi strade di Gaza ad al-Mukhtar, il consolato
italiano sollecitò un incontro tra il governatore britannico di Gaza e al-Hussieni. Il sindaco di
Gaza scrisse una lettera al governatore britannico affermando: «Ogni città ha un sentimento,
ed ogni municipalità di una città ha il diritto di riflettere questo sentimento. Così come la
municipalità di Tel Aviv ha il diritto di commemorare Hertzl e Belford […], la municipalità
di Gaza ha il diritto di commemorare una figura universalmente amata e rispettata fra la gente
di Gaza. Se la memoria di al-Mukhtar offende l’Italia è a causa di ciò che ha commesso l’Italia
e non della municipalità di Gaza. Pertanto, credo che l’obiezione italiana non sia appropriata.
20° del Ramadan 1350, Fahmi al-Hussieni, sindaco di Gaza», p. 191.
47
W. L.Cleveland, Islam against the West cit, p. 11. Shakib Arslan ebbe con Shawqi «una delle
amicizie più profonde nel panorama dell’élite culturale».
48
Mi riferisco all’opera di prossima pubblicazione di Boggero e Hala Kh. Nassar, «Journal of
Northern African Studies», giugno 2008. Per ulteriore poesia dedicata alla memoria di alMukhtar, vedi anche Omar al-Mukhtar fi al-Tarikh wa al-Adab wa-fi Uyun al-Shurara (Omar
al-Mukhtar in History, Literature and in the Eyes of Poets), Al-Huda press, Cairo 1999.
49
Riguardo l’importanza del film per il pubblico, cfr. «The Boston Globe», 15 aprile 2005, dove
si sostiene che il film è reperibile in ogni piazza e in ogni mercato del mondo arabo. Secondo il
giornale, sta godendo di una seconda vita perché ricostruisce una campagna imperialista condotta in maniera grandiosa. Altre fonti osservano che Omar El Mukhtar è divenuto il «volto
televisivo della rivolta irachena». «Il viso dell’attore Anthony Quinn, con la barba e l’abito da
beduino, appare di continuo. Tagliata da un popolarissimo film degli anni ottanta, la scena è
immediatamente riconoscibile per un pubblico arabo. Sta interpretando il ruolo di Omar Mukhtar, un eroe della gente del deserto che lottò contro l’occupazione italiana in Libia. “Noi non
ci arrenderemo”, afferma. “Vinceremo o moriremo” Parte una musica e l’immagine svanisce,
lasciando il posto ad uno slogan: “Al-Zawraa – vittoria o morte!” Questo è il volto televisivo
della rivolta irachena, un canale satellitare 24 ore su 24 che trasmette filmati macabri, che glorificano detonazioni di automobili, colpi di mortai e attacchi di cecchini, in milioni di case in
Iraq e in tutto il Medio Oriente», «The Irish Times», 17 febbraio 2007.
50
K. Boullata, Asim Abu Shaqra: The Artist’s Eye and the Cactus Tree, «Journal of Palestinian
375
Marco Boggero
studies», 2001, n.30, 4.
51
Maoz Azaryahu e Rebecca Kook, , Mapping the Nation: Street Names and Arab Palestinian
Identity: Three Case Studies, in Nation and Nationalism, 2002, n. 8, 2, p.210.
52
Ted Swedenburg, Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebelllion and the Palestinian National
Past, University of Minnesota Press, 1995.
53
Ted Swedenburg, The Palestinian Peasant as National Signifier, «Anthropological quarterly»,
1990, n.63, p. 24.
54
Dipartimento di Stato, Patterns of global terrorism: 1986, 2006, riprodotto in Declassified Documents Reference System, Farmington Hills, Mich., Gale Group.
55
Water Enders e Todd Sandler, «Southern Economic Journal», 2005, 467, vol. 71.
56
Sito web del MIPT, consultato l’11 aprile 2006. Dalla stessa fonte si apprende che «malgrado
gli esecutori dell’attacco non fossero penetrati nel perimetro della base, prima che si ritirassero
due donne rimasero ferite. Le informazioni disponibili delineano un forte legame della Libia
con l’attentato, che venne intrapreso senza dubbio come rappresaglia per il sostegno britannico
alle incursioni aeree americane di aprile. Si affermò che la base di Akrotiri fosse stata utilizzata
dall’aviazione statunitense coinvolta nel raid».
57
«The Washington Post», 3 novembre 1986. In un articolo successivo, che riconosce dissensi
duraturi tra gli analisti di intelligence, la si menziona tra i dieci principali gruppi terroristi che
operano in Libano e si sostiene che le cellule arabe rivoluzionarie, le brigate Omar Mukhtar o
le cellule di commando rivoluzionario siano la stessa cosa. «The Washington Post», 8 agosto
1989.
58
Nella crisi dei sequestri in Libano, l’ultimo ostaggio rilasciato fu Terry Anderson, dopo sette
anni di prigionia. Cfr. il suo resoconto in Den of lions, Crown, New York 1993.
59
«Frank Herbert Reed, il direttore di una scuola privata locale, e Joseph James Ciccipio, controllore della gestione dell’Università americana e del suo ospedale. Un gruppo che si dà il nome di
Cellule rivoluzionare arabe – Forze Omar al-Mukhtar ha rivendicato il rapimento di entrambi.
Si pensa ad un legame fra il gruppo e la figura del palestinese conosciuto come Abu Nidal»,
«The New York Times», 17 settembre 1986.
60
Le autorità libanesi rinvennero i corpi dei tre britannici nelle montagne di dominazione drusa,
a circa 16 chilometri a sud-est di Beirut. Un uomo telefonò alla stazione radio Voce cristiana
del Libano e disse: «Siamo l’Unità 23 giugno delle Forze Al Mukhtar. Abbiamo portato a termine l’attacco di questa mattina come rappresaglia contro il sostegno (britannico) all’attacco
americano contro la Libia.
61
Per un dibattito interessante, cfr. Brian L. Davis, Qaddafi, Terrorism and the origins of the U.S.
attack on Libya, Praeger, NY, Westport, London 1990.
62
«Molti attacchi rivendicati da tale gruppo furono in effetti portati a termine da membri del
Tanzim, anche se Hamas ha dichiarato che in realtà il gruppo era costituito da membri delle
Brigate Izz a-Din al-Qassam di Hamas, che operavano sotto un nome differente al fine di evitare indagini e prosecuzione legale». Dal sito del MIPT all’indirizzo http://www.tkb.org/Group.
jsp?groupID=277, consultato l’11 aprile 2006
63
E non a Fatah-Intifada. Spiega come e perché il braccio armato del movimento iniziò ad usare
il nome per le sue operazioni, in luogo di quello più familiare ‘Brigate Al-Qassam’.
64
http://www.ict.org.il/articles/cooperative_terrorism.htm
65
Radical Palestinian group claims Gaza attack, «Reuters News», 23 novembre 2000.
376
Omar El Mukhtar
66
http://www.ict.org.il/articles/cooperative_terrorism.htm
67
Cfr. Yonah Alexander, The Palestinian Secular Terrorism, AFP, 12 luglio 2001. Cita le Forze
Omar al-Mukhtar come parte del braccio armato di Fatah-Intifada chiamato al-Asifa (derivato
dalla fazione di Fatah di Yasser Arafat).
68
http://www.israel.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiquies/2001 consultato nell’aprile
2006.
69
V. tavola 1. Salah al-Din al-Ayubi Brigades Issue Statement 77, Claim Attacks on US Forces,
October 20, 2006. Jhiadist Websites - OSC Report; available through World News Connection.
70
Sono state associate a un solo attacco nella loro storia. Il 17 ottobre 2004 si verificarono tre
esplosioni quasi simultanee di automobili nella penisola del Sinai, che provocarono 36 morti
e 171 feriti.
71
Faccio riferimento all’opera di prossima pubblicazione di Hala Kh. Nassar.
72
Corrispondenza con Peter Bergen, maggio-giugno 2006.
73
Per una definizione, facciamo riferimento a M. R. Hebeck, Knowing the enemy: jihadist ideology and the War on Terror, Yale University Press, New Haven 2006.
74
Diego Gambetta, Making sense of suicide missions, Oxford University Press, Oxford 2005,
p. 13.
75
Robert A. Pape, Dying to win: the strategic logic of suicide terrorism, Random House, New York
2005. Cfr l’introduzione.
76
Luca Ricolfi in Diego Gambetta, Making sense of suicide missions cit., pp. 84-96.
77
Stathis Kalyvas e Sánchez-Cuenca in Diego Gambetta, Making sense of suicide missions, 2005,
pp. 209-232.
78
Inoltre, non possiamo trascurare un aspetto relazionato ai costi. Gli attacchi suicidi sono una
scelta strategica, basata su calcoli di costi e benefici, effettuata da gruppi deboli con risorse
limitate che puntano a intraprendere una guerra contro avversari formidabili. Cfr. Mohammed M. Hafez, Manufacturing human bombs: the making of palestinian suicide bombers, D. C.,
United States Peace Press, Washington 2006, p.25. I costi sono anche umani: la disponibiltà di
individui. In questo senso, più l’organizzazione è di dimensioni ridotte, meno è probabile che
si adottino missioni suicide, o perché la squadra dei possibili membri è limitata, oppure perché
i costi del reclutamento sono alti. Ibidem, p. 225.
79
Terence Ranger mostra come il ripudio di culture e retaggi stranieri portò Ngugi, nel contesto
keniota, «ad abbracciare la tradizione della resistenza popolare keniota al colonialismo», p.
262. Il termine «tradizione inventata» intende includere «entrambe le tradizioni effettivamente
inventate, quelle costruite e formalmente istituite e quelle che emergono in modo meno facilmente rintracciabile in un periodo breve ed identificabile (forse una questione di pochi anni) e
che si stabiliscono con grande rapidità». Cfr. Invention of Tradition cit.
377
La marcia del Marocco verso l’indipendenza.
Il nazionalismo marocchino dalle origini
alla seconda guerra mondiale
di Stefano Fabei
Il Marocco dagli inizi della contesa coloniale al XX secolo
Il processo di penetrazione europea in Marocco risale al XV secolo
quando i portoghesi, in lotta contro la pirateria araba, occuparono molti
porti fra cui quelli di Ceuta nel 1415 e di Tangeri nel 1471. La caduta nel
1492 del regno di Granada, ultima roccaforte islamica in Spagna, determinò una consistente migrazione di profughi, molto ostili ai cristiani e
favorevoli al jihād, portando alla riconquista araba di parecchi porti. Nel
1580 Ceuta passò agli spagnoli che dal 1496 controllavano anche il porto
di Melilla.
Divenuto con le sue coste atlantiche un importante punto d’attracco
nella rotta verso l’Oceano Indiano, nel XVI secolo il Marocco, risparmiato
dall’espansione ottomana, cominciò ad essere una meta commerciale degli
spagnoli.
Dopo una serie d’alterne vicende, il potere fu conquistato nel 1659
dalla dinastia alawita (regnante fino ai nostri giorni) che dette al Paese
un’organizzazione amministrativa e militare tale da permettergli di contrastare inglesi e spagnoli nel controllo delle città costiere. Questo tuttavia non impedì ai vari sovrani che si succedettero di sottoscrivere trattati
commerciali con la Francia e con la Gran Bretagna, suscitando numerose
rivolte antieuropee che si intensificarono dopo l’occupazione francese di
Algeri nel 1830.
All’inizio del XIX secolo – periodo in cui l’Europa cominciò a occuparsi direttamente dell’Africa mediterranea – il Marocco era uno stato islamico indipendente, con un sistema amministrativo di tipo feudale. Era
governato dal sultano e da un consiglio ristretto, chiamato makhzen, con
funzioni soprattutto consultive. Gli alawiti per lungo tempo erano riusciti
a evitare l’ingerenza straniera limitando i contatti esterni ai soli scambi
379
Stefano Fabei
commerciali nei porti di Tangeri e Mogador, ma adesso il Marocco, come ha scritto Fieldhouse, viveva una situazione simile a quella della Cina:
entrambi erano Stati sovrani nei cui confronti gli europei, mossi da spinte
imperialistiche, mostravano un crescente interesse economico e politico1.
Dopo che, con le battaglie di Tètouan e Gueldras (1859-1860), gli
spagnoli ebbero rafforzato il predominio sui porti in loro possesso, anche i
francesi, con le vittorie di Bugeaud e d’Isly e i bombardamenti di Tangeri e
Mogodor, riuscirono a consolidare la propria influenza sulla parte del Paese formalmente posta sotto la sovranità del sultano. Le altre zone rimasero
invece sotto il dominio delle tribù berbere.
Con il passaggio nel 1862 di Tètouan dalla Spagna all’Inghilterra e la
convenzione di Tangeri che l’anno dopo assegnava il Marocco alla Francia
in opposizione agli interessi della Germania che sosteneva il sultano, il Marocco divenne una delle zone coloniali più disputate dalle potenze europee.
La situazione d’aperto contrasto non venne meno dopo la conferenza di
Madrid che nel 1880 negò i diritti di Parigi sul Paese africano che fra il
1900 e il 1903 fu invaso dai francesi.
Dallo Stato dei «due paesi» all’inizio del mandato francese
Prima dell’instaurazione del protettorato il Marocco risultava tradizionalmente diviso in due aree: il Bilād el-Makhzen («il paese del Governo»)
comprendente il territorio sottomesso al sultano, costretto alle imposte e
obbligato alla coscrizione, ed il Bilād el-Sibā («il paese della ribellione»),
praticamente dissidente, che comprendeva l’insieme di quelle regioni in
cui vivevano le tribù berbere che ancora non avevano riconosciuta l’autorità del sultano. Queste si rifiutavano di pagare i tributi e di sottoporsi al
servizio militare, conservando inalterate le proprie istituzioni e tradizioni
culturali. Le profonde differenze tra arabi e berberi – risalenti al VII secolo, alla conquista araba del Nord Africa – rendevano debole il Paese nel
momento in cui l’Occidente andava consolidando, politicamente e ideologicamente, le sue strutture capitalistiche e imperialistiche. Il Marocco si
trovò ad affrontare una grave crisi interna che lo avrebbe condotto nell’orbita di queste strutture. Provocata dalla continua ribellione delle tribù dissidenti e aggravata dall’indebolimento della monarchia, la crisi sfociò in
una situazione molto critica.
Per uscire dal difficile frangente il sultano ‘Abd el-‘Azīz (1894-1908) e
380
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
il makhzen fecero ricorso a ingenti prestiti internazionali che, ottenuti in
gran parte da banche inglesi, francesi e tedesche, determinarono la completa dipendenza economica, e politica, del Marocco dalla finanza europea. Questa precaria situazione interna, non molto diversa da quelle di
Tunisia ed Egitto, accelerò il processo di sfaldamento dell’impero e di penetrazione da parte delle nazioni europee. Gli Stati che avevano maggiori
interessi nel Paese nordafricano erano l’Inghilterra, la Francia, la Spagna e
la Germania.
La prima di queste potenze cercava di mantenere i privilegi acquisiti
con il trattato anglo-marocchino del 1856, mirando soprattutto al control-
La copertina della rivista «Maghreb»
381
Stefano Fabei
lo della costa prospiciente Gibilterra.
La Spagna conservava interessi legati più a importanti questioni strategiche, storiche e di prestigio che ad interessi economici e commerciali,
preoccupata soprattutto di mantenere i suoi presidios nella parte settentrionale del Paese.
La Francia – con la conquista dell’Algeria nel 1830 e l’instaurazione del
protettorato sulla Tunisia nel 1881 – era la maggior potenza interessata al
territorio nordafricano per ragioni economiche e finanziarie oltre che di
geostrategia. Parigi, allorché il potere del sultano aveva cominciato a vacillare, temendo la possibilità di disordini cronici al confine con l’Algeria
e un eventuale, conseguente, intervento tedesco e/o inglese, aveva iniziato
un’intensa attività diplomatica fin dal 1900. Dopo una serie d’accordi stipulati nel dicembre del 1900 con l’Italia (accordi Visconti-Venosta-Barrère)
e quattro anni dopo con la Spagna e la Gran Bretagna (Entente cordiale),
nel 1905 la Germania rimase la sola potenza capace di ostacolare un’azione
francese. La Weltpolitik condotta da von Bülow e dal kaiser Guglielmo II,
riuscì per un certo periodo a contenere le mire di Parigi suscitando una
tensione generalizzata che si manifestò con le crisi internazionali del 1905
e del 1911. Nel 1904 i francesi si accordarono per spartire il Marocco con
gli spagnoli, cui fu riservata la parte settentrionale, e gli inglesi. La risposta
tedesca fu lo sbarco a Tangeri di Guglielmo II nel 1905, momento cruciale
di una crisi che fu sul punto di trasformarsi in un conflitto di ben diverse
proporzioni. Con la conferenza di Algeciras nel 1906 il Marocco fu posto
sotto il controllo internazionale, ma il problema della spartizione rimase
irrisolto. Dopo l’occupazione francese di Udida e Casablanca e l’incidente
di Agadir il 4 novembre 1911 si giunse alla pace di Caillaux per cui la zona
centrale del Paese fu affidata alla Francia, che in cambio cedeva territori del
Congo francese (nell’attuale Camerun) alla Germania, quella settentrionale e meridionale alla Spagna.
Con la convenzione di Fès del 30 marzo 1912, il Marocco fu posto ufficialmente sotto il protettorato di Parigi, entrando così a far parte dell’Africa occidentale francese. Alla Spagna fu riconfermato il controllo delle zone
occupate lungo la fascia costiera settentrionale, ad amministrare le quali
fu posto un Alto commissario spagnolo e un khalīfa (delegato), designati
dal sultano su proposta di Madrid2. Fu inoltre delimitata la zona di Tangeri, affidata all’autorità di un rappresentante del sultano, il mandūb, e dal
1923, in seguito alla convenzione di Parigi, sottoposta a controllo interna382
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
zionale. Il Marocco, dopo tredici secoli d’indipendenza, si ritrovò pertanto
limitato nella sua sovranità e integrità territoriale e sottoposto al diretto
controllo politico europeo che da un lato favorì l’inizio del processo di
modernizzazione in senso tecnologico e d’occidentalizzazione delle strutture sociali e politiche del Paese, dall’altro fece nascere un comune spirito
unitario e nazionale che dal 1930 avrebbe avuto un peso effettivo nella vita
politica marocchina.
Gli anni della «pacificazione» francese
Nel Marocco francese fu nominato residente generale il maresciallo
Louis Hubert Gonzalve Lyautey (1912-25), che se da un lato riorganizzò
tutta l’amministrazione del Paese cercando di contemperare questa operazione con la salvaguardia delle usanze locali – tanto che fu soprannominato
«le Marocain» per la comprensione e sensibilità dimostrata nei confronti
delle tradizioni e degli usi della popolazione indigena – dall’altro cercò di
contrastare le frequenti rivolte, la maggiore delle quali, guidata da ‘Abd elKrīm, fra il 1921 e il 1926 scosse la regione del Rif.
Lyautey promosse delle spedizioni militari nelle regioni più interne, in
cui risiedevano le tribù berbere che ancora non avevano riconosciuto l’autorità del sovrano e del Makhzen, un’autorità più formale che sostanziale
perché il trattato di Fès aveva lasciato sussistere il sultano come Imām e
Khalīfa, cioè come capo politico e religioso, col compito di notificare leggi,
la cui formazione, come la designazione dei funzionari, non era però di sua
competenza. Del potere effettivo, non diverso da quello di un sovrano vero
e proprio, era detentore il residente generale e non il sultano, né il Makhzen che, sotto il regime di protettorato, fu anche ridotto a quattro visir,
tutti imposti e controllati da Parigi per mezzo di un segretario generale del
Governo sceriffiano.
Le aree su cui si svilupparono le suddette operazioni militari erano particolarmente infide per le continue rivalità fra le varie tribù, ma anche per
il fatto di essere molto ampie e soprattutto desertiche.
Gli sforzi del residente per stabilire nel Paese un’amministrazione di
tipo indiretto risultarono vani e il protettorato, invece di evolversi verso
una forma di autonomia politica, si trasformò in un «sistema coloniale»
tout court, in cui ogni tentativo di cambiamento interno venne bloccato
dal ruolo oppressivo esercitato dalle autorità francesi. In Marocco vennero
383
Stefano Fabei
‘Allāl el-Fāsī
pertanto a trovarsi di fronte, senza alcuna possibilità di fusione, due apparati sovrapposti: quello francese che comandava e quello marocchino che
obbediva. Insomma, nessuna autonomia, né per la popolazione locale né
per il sultano. Il principale ostacolo alla pacificazione fu costituito dalle
tribù dei berberi del bilād che si opposero con una violenta attività di
guerriglia ai francesi i quali procedettero alla progressiva occupazione delle
regioni dissidenti e al loro inserimento nel nuovo contesto istituzionale
sotto la diretta autorità del sultano e quindi del residente generale3.
Alla base delle rivolte che, numerose, si susseguirono nel corso degli
anni venti ci fu la politica di progressiva espropriazione da parte dei coloni
francesi di estesi appezzamenti di terreno che indusse le tribù berbere a
rifugiarsi nelle più interne regioni montagnose. Ad una di queste tribù,
quella dei Beni Ouriaghel, e più precisamente alla frazione degli Aīt Khettab, apparteneva ‘Abd el-Krīm (Ajdir, 1882 - Il Cairo, 1963), animatore
nel 1921, fra le montagne del Rif, della rivolta più violenta che portò nel
febbraio dell’anno successivo alla costituzione della Repubblica delle tribù confederate del Rif. Questa leggendaria figura di capo guidò i berberi
384
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
contro il governo militare spagnolo riuscendo, dopo la vittoria di Anual
(1921), a respingere l’esercito nemico, ma non a riconquistare i territori marocchini occupati dai francesi, che ben presto furono investiti dalla rivolta. Sconfitto nel 1926 dalle truppe franco-spagnole, ‘Abd el-Krīm
venne deportato nell’isola di Réunion in cui rimase fino al 1947, quando
riuscì a fuggire e a rifugiarsi al Cairo4.
Se la guerra del Rif servì a focalizzare l’odio della popolazione autoctona nei confronti dello straniero, rappresentò un sentimento ancora troppo isolato e circoscritto per poter dar luogo ad un più vasto movimento
comune. Ciononostante alcuni storici hanno voluto vedervi la prima, per
quanto debole, manifestazione del nazionalismo marocchino moderno,
mentre altri hanno considerato la rivolta solo come un periodo di «gestazione» di quest’ultimo5. Al di là delle varie interpretazioni è indubbio
che questa grande ribellione – separatistica, autonomistica e a sfondo religioso – esercitò una notevole suggestione su alcuni giovani che sarebbero
poi diventati i capi del nazionalismo marocchino. Ai loro occhi ‘Abd elKrīm divenne l’iniziatore e il primo leader del movimento di liberazione,
l’erede spirituale dei grandi sultani che nel passato si erano opposti alla
penetrazione europea. Malgrado la realizzazione di alcune infrastrutture e
l’inizio di un certo sviluppo economico, l’ostilità dei marocchini contro gli
europei crebbe progressivamente durante gli anni venti. Pertanto nel 1930
dal regime di protettorato si passò all’amministrazione diretta: il sultano
conservò solo poteri di carattere religioso, Parigi diventò il vero centro
politico decisionale, mentre fu portata avanti l’esautorazione delle autorità
musulmane nelle zone berbere.
Ciononostante nell’arco di tempo compreso tra il 1912 e il 1934 – i
cosiddetti anni della pacificazione francese – emerse l’esistenza di una coscienza unitaria e nazionale più profonda di quanto l’Europa avesse fino allora pensato. La Francia fu sempre più costretta a fronteggiare la crescente
ostilità e la resistenza del popolo marocchino che, al di là delle particolari
tradizioni culturali trovò nell’Islām il più importante fattore di coesione.
Aumentarono i contatti fra le parti più evolute della popolazione e si costituì un primo gruppo di persone accomunate dalla presa di coscienza del
fatto coloniale; esso era formato per lo più da membri delle classi borghesi
che avrebbero dato vita ai primi movimenti nazionalisti.
385
Stefano Fabei
Il Dahīr berbero quale strumento di separazione del popolo marocchino
Oltre che militarmente, i francesi operarono politicamente ricorrendo
nel maggio del 1930 ad un apposito decreto che riuscì a suscitare non solo
la prevedibile reazione negativa dei marocchini ma anche l’opposizione
della stampa straniera.
La Francia, già dai primi anni della sua presenza in Marocco, aveva
riconosciuto la specificità e le consuetudini tribali dei berberi nelle regioni
da questi abitate, tutelando in tal modo uno stato di fatto che si perpetuava
ormai da tempo ed era tollerato dai sultani, i quali però non lo avevano
mai ufficialmente riconosciuto o legalizzato. L’11 settembre 1914 Parigi
aveva strappato al sultano il dahīr in base al quale «le tribù berbere sono e
permangono regolate ed amministrate secondo le loro consuetudini sotto
il controllo delle autorità francesi»6, ma a causa dello scoppio del conflitto mondiale la Francia non aveva potuto sistemare in modo definitivo il
problema, per cui il 14 febbraio 1924 Lyautey aveva con un proprio atto
proceduto alla costituzione di un organo provvisorio, composto da notabili berberi, cui spettava il compito di applicare la legge consuetudinaria
locale. Il 16 maggio 1930, spinto dal residente generale, Lucient Saint,
il sultano Sīdī Mohammed V, succeduto al padre Mulay Yūsuf nel 1927,
emanò le Dahir Berbère, con cui non soltanto era riconosciuta ai capi tribù la competenza per la repressione delle infrazioni commesse da soggetti
marocchini nelle regioni berbere, ma venivano anche istituiti tribunali locali competenti in materia civile, commerciale, mobiliare e immobiliare e
creati tribunali di appello con competenza in materia penale. In pratica il
diritto consuetudinario berbero veniva ufficialmente riconosciuto e legittimato ad amministrare la giustizia presso quelle tribù che, non essendo
musulmane, non avevano tribunali della Sharī’a7.
Grazie al dahīr una parte della popolazione marocchina fu quindi sottratta alla giurisdizione civile e penale del sultano, e sottoposta all’amministrazione giudiziaria dei capi tribali e dei tribunali francesi. Si trattava di
una vera e propria inversione di tendenza della linea politica portata avanti
fino ad allora dai francesi, i quali dall’instaurazione del protettorato avevano sempre favorito il processo di arabizzazione del Marocco anche per
soddisfare le aspirazioni delle élite tradizionali del sultano e del Makhzen.
L’emanazione del dahīr consentiva adesso alla Francia di pervenire, dopo
386
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
averne occupati i territori, alla pacificazione coi berberi da sempre ribelli e
ostili a qualunque processo di islamizzazione e soprattutto di arabizzazione.
Non diversamente da quanto fatto altrove dalla Francia, così come in altre parti del mondo dall’Inghilterra, Parigi fece ricorso all’applicazione del
principio del «divide ut imperes», offendendo lo spirito unitario del popolo marocchino e sottraendo una parte di questo alla giurisdizione dei qādī8.
Il decreto, incrinata l’autorità morale del sultano, simbolo dell’unità
nazionale marocchina, oltre a dividere gli arabi dai berberi, espose questi
ultimi ad un processo di cristianizzazione e di francesizzazione. Non meraviglia pertanto il fatto che in tutti i Paesi musulmani il dahīr suscitasse
molte proteste contro la Francia, colpevole di voler allontanare i berberi dalla Sharī’a. La stampa del vicino oriente, richiamandosi alle garanzie
contenute nell’articolo primo del Trattato di Fès, sottolineò le aspirazioni
e le intenzioni del moderno Islām, esprimendo un giudizio di totale condanna sul sistema instaurato dalla Francia in Marocco e sulle sue evidenti
contraddizioni9. L’Associazione dei giovani musulmani del Cairo e la Delegazione siro-palestinese a Ginevra, con il suo organo, «La Nation Arabe»,
diretto da Shakīb Arslān e Ihsān el-Giābirī, sottolinearono la gravità del
provvedimento che faceva uscire le tribù berbere dall’Islām.
Per calmare gli animi dei giovani nazionalisti e dei musulmani il sultano fu costretto ad intervenire spiegando che le disposizioni del dahīr
erano state male interpretate e che i berberi non erano diventati cristiani:
«Noi abbiamo stabilito che ogni tribù berbera la quale chieda che in essa
vengano applicate le norme della Scerìa, sia immediatamente aiutata in
ciò e le sia nominato dalla nobile parte Nostra un qādī, bramando Noi di
salvaguardare la sua religione e di dimostrare quanto Noi difendiamo la
santità dell’Islām nei loro paesi»10. Nonostante i tentativi di tranquillizzare
gli animi messi in atto anche dalla Residenza generale, negli anni a seguire
il 16 aprile, giorno dell’emanazione del decreto, divenne un anniversario
da ricordare sia per i nazionalisti arabi del Marocco sia per i loro sostenitori
panislamici.
Volendo rimediare alla grande perdita di prestigio agli occhi degli arabi
e dei musulmani in seguito all’emanazione del Dahir Berbère, Parigi l’8
aprile 1934 emanò un nuovo decreto che, pur emendando quello di quattro anni prima, lasciava inalterato il principio del riconoscimento ufficiale
della tradizione culturale dei berberi, in evidente contrasto con la legge coranica. Le agitazioni e le proteste s’intensificarono trasformandosi in moti
387
Stefano Fabei
di rivolta xenofoba sempre più connotati ideologicamente in senso nazionalista, con il riconoscimento, la presa di coscienza e la valorizzazione delle
proprie tradizioni culturali. Questo «risveglio» emerse inizialmente fra gli
intellettuali di Fès, Salé e Tètouan, che intravidero nella politica berbera
messa in atto dai francesi un’evidente volontà di rottura del fronte arabo
e islamico, la cui unità si stava rivelando con lo sviluppo di movimenti
panarabi e panislamici sia in Nord Africa sia in Medio Oriente.
I primi movimenti nazionalisti e il ruolo di Shakīb Arslān
Fu il 1934 l’anno in cui, in contemporanea con la fine delle operazioni
militari per l’occupazione della zona non sottomessa, si ebbe la chiara percezione dell’esistenza di un movimento patriottico che, sorto già da qualche tempo, riusciva solo adesso con alcune sue manifestazioni a richiamare
l’attenzione sia degli arabi sia degli europei.
Nonostante fossero fortemente caratterizzati da una decisa ostilità nei
confronti del Vecchio continente, i primi gruppi nazionalisti marocchini,
come quelli analoghi del Maghreb opera di uomini appartenenti all’intellighenzia locale, furono senza dubbio all’inizio un fenomeno di ispirazione
europea che, sorto in un contesto arabo-islamico, proprio in quanto tale
era destinato a inserirsi nel più ampio quadro politico-culturale del panarabismo e del panislamismo11. In merito alle origini di questo nazionalismo l’orientalista Ettore Rossi scrive: «Anche per il Marocco, come per
l’Algeria e più per la Tunisia, vale l’osservazione che la guerra europea del
1914-1918, la partecipazione di soldati delle colonie e dei protettorati ai
combattimenti e ai lavori bellici, la comunione di vita nelle trincee e nelle
retrovie, ove gli Africani conobbero il buono e il brutto della vita francese,
le promesse di Wilson e degli uomini politici europei non restarono senza
traccia sugli animi e sulle menti degli Arabo-Berberi dell’Africa Settentrionale. Per il Marocco l’incubazione durò più a lungo che in Tunisia per le
condizioni di maggiore segregazione del paese e di minor sviluppo d’una
borghesia istruita con sistemi occidentali»12. Tra i primi ad accorgersi del
sorgere del nazionalismo marocchino ci fu Lyautey che già in un rapporto
al suo governo nel 1920 aveva riconosciuto come l’occupazione francese
del 1912 e poi la guerra del 1914-1918, l’andata di marocchini in Francia e
l’arrivo di algerini e tunisini evoluti in Marocco avessero qui destato sentimenti nuovi. Il residente generale riconosceva non soltanto che la situazio388
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
ne era molto delicata, giacché questo Paese nordafricano, da secoli, costituiva un’entità etnica e statale a sé, con proprie tradizioni e quindi con gli
elementi essenziali per fondare un serio movimento nazionalista, ma anche
che il protettorato non era esercitato dalla Francia come richiesto dall’interpretazione ortodossa di tale istituto, nel senso cioè di assistenza a un
governo capace di reggersi con propri ordinamenti, in modo autonomo: il
sultano era infatti tenuto lontano da ogni affare, i suoi ministri erano poco
al corrente delle cose pubbliche e privati d’autorità e d’iniziativa, mentre
chi governava erano in realtà i francesi, che sviluppavano sempre più il loro
intervento nell’amministrazione «diretta» del Paese. Tale sistema, oltre ad
essere in contrasto con lo spirito del protettorato, avrebbe secondo Lyautey
comportato brutte conseguenze, poiché acuiva i sentimenti di libertà del
popolo marocchino, il quale «anche se non è ammesso a partecipare alla
vita pubblica e gli si negano le scuole, ha tanti modi per seguire le cose del
mondo suo e di fuori, si tiene in contatto con elementi stranieri che hanno
interesse a risvegliare il suo nazionalismo e con ambienti islamici. Non passerà molto tempo e una ridesta gioventù marocchina si leverà a reclamare
le riforme, la partecipazione al governo del paese e l’osservanza ai termini
del Protettorato»13.
Fin dall’inizio una parte molto importante nella lotta di liberazione fu
svolta da giovani studenti che, come ‘Allāl el-Fāsī, Ahmed Belfareğ e Mohammed al-Wazzānī, erano destinati ad assumere la leadership del movimento nazionalista. Furono, infatti, loro, tra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta, ad organizzare nella clandestinità i primi movimenti
di riforma che si proponevano di combattere contro le violenze perpetrate
dal regime d’occupazione imposto dalla Francia, anche in nome dell’Islām.
Non a caso le moschee e gli altri luoghi dove i musulmani si raccoglievano
ogni giorno per pregare diventarono dei centri di discussione, confronto
e preparazione dell’attività di propaganda14. Oltre agli studenti, aderirono
ai movimenti riformisti membri delle tribù del bilād, che avevano subito
l’esproprio di grandi appezzamenti di terreno durante la «pacificazione»,
ed esponenti del ceto mercantile e intellettuale di Fès e di Rabat che si erano visti privati delle cariche politiche e dei ruoli dirigenziali.
Tra le voci critiche suscitate in tutto il mondo arabo e in quello islamico
dall’emanazione del dahīr del 1930 una delle più importanti fu quella del
già citato emiro druso Shakīb Arslān che, esponente di punta dell’«internazionalismo arabo-islamico», attraverso l’organo ufficiale della delegazione
389
Stefano Fabei
siro-palestinese a Ginevra intratteneva relazioni dirette con la gioventù marocchina esercitando una notevole influenza sugli esponenti nazionalisti di
quel Paese. Nato nel 1869 da una potente famiglia del Libano meridionale,
Arslân nel 1919 per ragioni di studio aveva raggiunto l’Europa. Nel 1921
si era stabilito a Ginevra, dove era diventato il maggior rappresentante
dell’unità araba presso la Società delle Nazioni. Anche in questo ruolo,
auspicando la creazione di un’unica nazione araba attraverso il conseguimento dell’indipendenza dei singoli Stati, aveva instaurato rapporti con
molti leader musulmani dei Paesi arabi mediorientali e del Maghreb15. A
Ginevra, per dar voce alle sue tesi, aveva fondato «La Nation Arabe» una
rivista in francese che ebbe molto successo anche tra i nazionalisti del Marocco16.
Nel 1930 Arslān a Parigi conobbe Ahmed Belfareğ che ritrovò di lì a
poco, insieme ad ‘Allāl el-Fāsī, a Madrid, dove fondò una Associazione
ispano-islamica. In agosto l’emiro druso aveva poi raggiunto Tangeri e, una
volta espulso da qui, Tètouan, città in cui s’intrattenne più volte, nel corso
dei suoi frequenti viaggi, con il grande notabile nazionalista ‘Abd el-Khāliq
Torrēs. Da allora i suoi legami coi patrioti marocchini divennero più stretti. Oltre che con Mohammed el-Wazzānī, il quale tra il 1930 ed il 1933
funse da suo segretario a Ginevra, e con Ahmed Belfareğ che si recava spesso a trovarlo, Arslān mantenne stretti contatti con Mohammed al-Makkī
en-Nāsirī e Mukhtār Ahardane, un libraio di Tangeri ritenuto il suo agente
di collegamento coi circoli nazionalisti di Fèz, Rabat e Tètouan.
In questo periodo, forse proprio grazie agli amici marocchini, l’emiro
entrò in contatto con alcuni circoli anticolonialisti della sinistra francese,
con il gruppo responsabile della rivista «Maghreb» e in particolare con
il suo avvocato Jean Longuet, rafforzando, sempre tramite questi intermediari, i rapporti con i responsabili dell’Associazione degli studenti musulmani nordafricani in Francia (Aemnaf ), che, fondata nel 1927, aveva
quale segretario ‘Allāl el-Fāsī. Tramite quest’associazione – che nel periodo
tra le due guerre mondiali svolse un ruolo molto importante nella storia
dei nazionalismi maghrebini, fungendo da punto d’incontro e discussione
per uomini provenienti da esperienze politiche e formazioni ideologiche
diverse e da fucina dei futuri quadri dirigenti nordafricani – Arslān avrebbe
stabilito contatti anche con la Stella nordafricana e il suo dirigente Messālī
Hâjj e con militanti del vecchi e del nuovo Destūr tunisino. Pare addirittura che gli stessi dirigenti dell’ Aemnaf non nascondessero di ricevere diret390
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
tamente istruzioni dal vecchio uomo politico libanese17. Questa influenza,
secondo Juliette Bessis, si può far risalire al terzo congresso dell’associazione, previsto inizialmente a Fèz dal 19 al 23 settembre 1933, ma che,
interdetto dalle autorità francesi anche in considerazione delle agitazioni
nazionalistiche in corso in Tunisia e in Algeria, fu tenuto nella capitale
francese al palazzo della Mutualità il 26 dicembre dello stesso anno con la
partecipazione di molti personaggi destinati a giocare un ruolo di tutto riguardo nella storia dei loro paesi: gli algerini Messālī Hājj e Farhat ‘Abbās,
il tunisino Habīb Thāmer futuro segretario generale dell’organizzazione) e
i marocchini el-Fāsī e Belfareğ «la cui eloquenza soggiogò l’assemblea»18.
Durante la seduta d’apertura del congresso, cui Arslān, nonostante fosse
stato invitato, non poté partecipare perchè gli fu interdetto l’accesso al territorio francese, il segretario generale ‘Allāl el-Fāsī salutò il Congresso degli
studenti asiatici riunito in quegli stessi giorni a Roma da Mussolini. Questi
venne addirittura elogiato per il fatto di aver ricevuto i congressisti riuniti
nella capitale, sottolineando in tal modo il ben diverso atteggiamento dei
due governi, l’italiano e il francese, riguardo ai movimenti nazionalisti che
lottavano per la liberazione e l’emancipazione dal colonialismo19. Ovviamente, l’intervento del segretario che rivelava come le sue posizioni fossero
molto vicine a quelle di Arslān, non fu condiviso da tutti i partecipanti al
congresso dove emersero posizioni e tendenze differenti.
Alle origini del nazionalismo marocchino, un ruolo certamente significativo nella sua nascita e nel suo rafforzamento tra la fine degli anni venti
e i primi anni trenta fu svolto anche dall’università di el-Qarawiyyīn, a
Fès, importante centro di agitazione e di propaganda nazionalista. Era qui
infatti che si riunivano sia gli studenti di formazione europea, come i sopraccitati Belfareğ ed al-Wazzānī, sia quelli più vicini alla tradizione e alla
cultura islamica, come ‘Allāl el-Fāsī, il quale proprio a Fès guidava l’Union
des étudiants, un’organizzazione a carattere religioso che raccoglieva elementi provenienti da ricche famiglie borghesi ostili al mondo occidentale.
Ispirata a istanze puramente politiche, tendenzialmente laica, era invece la
Société des amis de la verité, creata nello stesso periodo a Rabat, da Ahmed
Belfareğ insieme ad un gruppo di giovani. Oltre alle due sopraccitate, sorsero altre associazioni come quelle dei Giovani Scouts che, grazie a rapporti
stretti con l’ambiente universitario di el-Qarawiyyīn, formarono i primi
club e i primi circoli politico-letterari20.
Al di là delle differenti ispirazioni di questi gruppi numericamente mol391
Stefano Fabei
to esigui – limitati a poche persone in grado di leggere e scrivere e pertanto provenienti dalla fascia medio-alta della popolazione – era comunque
l’Islām l’unico elemento capace di garantire una certa coesione tra le diverse componenti etniche e tribali di un Paese dal forte spirito autonomistico.
Questo anche perché nella diffusione degli ideali nazionalisti tra le masse
analfabete un ruolo determinante fu svolto proprio dalle moschee, luoghi
di quotidiano incontro per la preghiera e la discussione.
Tra i dirigenti nazionalisti marocchini cominciò ad emergere il giovane
Mohamed Hasan al-Wazzānī che, nato a Fès nel 1908, figlio di un grande
proprietario terriero, dopo gli studi liceali in Marocco, si era diplomato nel
1930 alla Libera scuola di scienze politiche di Parigi, dove aveva seguito
anche corsi di lingue orientali e di giornalismo. Dopo esser stato imprigionato a Tāzah per aver preso parte alle manifestazioni contro l’emanazione
del decreto berbero, aveva lasciato nuovamente il Marocco per stabilirsi a
Ginevra come segretario di Shakīb Arslān. Avvicinatosi al Partito socialista
francese (Sfio), unico disposto nel panorama politico europeo a sostenere
la causa marocchina, al-Wazzānī, con altri studenti marocchini residenti a
Parigi, sostenuto da personalità politiche radicali e socialiste, aveva lanciato
L’ emiro druso Shakīb Arslān
392
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
nel 1932 «Al Maghreb», la già citata rivista mensile di documentazione
sociale ed economica in cui trovarono espressione le rivendicazioni marocchine21. Quindi era stato fondatore, nell’agosto 1933, e redattore capo de
«L’Action du Peuple», un settimanale in cui erano rivendicate le più importanti libertà politiche ed auspicate riforme nel campo dell’insegnamento,
della giustizia, dell’agricoltura. Il nuovo organo nazionalista – redatto in
francese nella convinzione che combattere l’occupante con la sua stessa
lingua avrebbe favorito un legame tra l’opinione pubblica francese e la società marocchina – invocava riforme sostanziali miranti al mantenimento
della sovranità marocchina, pur accettando l’opera di modernizzazione intrapresa dai francesi con il trattato di Fès. «L’Action du Peuple», sostenuta
dalle associazioni degli ex allievi dei collegi musulmani, si lanciò in una
serie di campagne politiche che nel 1934 avrebbero portato a pubbliche
manifestazioni di passione nazionalistica in occasione di un viaggio del
sultano a Fès22. Il successo del giornale, il cui comitato di redazione funse
ben presto da polo d’attrazione per insegnanti e studenti dell’università di
el-Qarawiyyīn, suscitò le preoccupazioni del governo di Parigi che il 16
marzo 1934 lo soppresse, non impedendo tuttavia ai nazionalisti di continuare a svolgere la loro attività clandestinamente.
Il Comitato d’azione marocchina e il «Piano per le riforme»
La soppressione de «L’Action du Peuple», contrariamente alle aspettative dei francesi, sollecitò i nazionalisti a dotarsi di una vera e propria struttura politica che prese il nome di Comitato d’azione marocchina (Kutlat
al-’amāl al watanī al maghribiyyah). I redattori del giornale, che avevano
registrato una progressiva crescita di adesioni e consensi alle loro tesi, ritennero maturi i tempi per elaborare un piano di riforme (Matālib ash-sha’b
al maghribī) sottoscritte, all’atto di nascita del primo partito marocchino,
da ‘Abd el-‘Azīz ibn Idrīs, Mohammed ed-Dīwrī, Mohammed ibn el-Hasan al-Wazzānī, Mohammed el-Yazīdī, Mohammed el-Makkī en-Nāsirī,
‘Omar ibn ‘Abd el-Gelīl, Mohammed ‘Allāl el-Fāsī, Abū Bakr el-Qādirī,
Mohammed Ghāzī, Ahmed esh-Sharqāwī23. Il testo del programma fu redatto in arabo e in francese e presentato contemporaneamente al sultano,
Sīdī Mohammed V, al residente generale, Henry Ponsot, e a Pierre Laval,
capo del governo di Parigi.
In questo documento erano formulate varie rivendicazioni, che sareb393
Stefano Fabei
bero state poi pubblicate e fatte proprie, pur con qualche adattamento,
dal Movimento dell’Unione Marocchina e dal Partito riformista nazionale,
entrambi del Marocco spagnolo: sul piano politico, la libertà di stampa,
di riunione e d’associazione, la creazione di organi municipali, l’elezione
di un’assemblea nazionale; sul piano economico: l’abolizione di alcune imposte, l’istituzione di camere di commercio regionali e la nazionalizzazione delle più importanti risorse e dei mezzi di produzione locali (miniere,
petrolio, trasporti, energia elettrica). Sul piano delle riforme sociali veniva
chiesta l’obbligatorietà dell’istruzione elementare tanto nelle città quanto nelle campagne e si chiedeva che l’educazione elementare fosse basata
sull’insegnamento del Corano, della lingua araba, della religione islamica,
della storia e della geografia del Marocco. Venivano chieste poi, tra le altre
cose, l’istituzione di un’università e l’estensione dell’istruzione elementare
e media alle ragazze con l’aiuto di insegnanti musulmane orientali. Si reclamavano inoltre la rinuncia alla «politica berbera», l’abrogazione dei dahīr e
degli altri decreti emanati dopo il 1914 a questo scopo, il divieto per i missionari di svolgere opera di penetrazione tra i musulmani, l’uso dell’arabo
come lingua ufficiale della corrispondenza e dei tribunali, la pubblicazione d’una edizione in arabo della «Gazzetta Ufficiale», l’uso della bandiera
marocchina da issare sugli edifici pubblici, l’osservanza del riposo negli
uffici durante le feste musulmane, la menzione del nome del sultano nella
preghiera del venerdì e in occasione delle festività, l’abolizione del termine
«croce» nelle decorazioni sceriffiane di qualsiasi grado. Queste solo alcune delle molte rivendicazioni formulate. Il protettorato francese, tuttavia,
non era ancora messo in discussione, nonostante ne fossero denunciate le
ingiustizie.
L’atteggiamento di disinteresse della Francia verso l’agitazione nazionalistica, che si sviluppò in modo pacifico avanzando le suddette proposte,
indusse il Comitato d’Azione ad assumere una posizione più radicale e
ad ampliare la propria base. Il momento pareva favorevole per l’appoggio
trovato presso il partito socialista francese, per la crisi economica che affliggeva il Marocco e per la situazione internazionale tormentata dal conflitto
italo-etiopico e dalla guerra civile in Spagna. Con il sostegno del partito
socialista francese il nuovo soggetto politico aveva cominciato a darsi una
più salda organizzazione e il 25 ottobre del 1936 si riunì per il primo congresso a Rabat.
A causa dei violenti disordini che il mese dopo ebbero luogo a Fès, a
394
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
Salé e a Casablanca, i capi del Comitato di Azione Marocchina, fra cui
‘Allāl el-Fāsī, Mohammed al-Wazzānī e Mohammed el-Yazīdī, furono arrestati per essere poco tempo dopo liberati dietro intervento del residente
Henri Noguès24. Questo gesto distensivo non servì tuttavia a calmare gli
animi e a riportare la situazione alla normalità, anzi; il 18 marzo 1937 la
Francia arrivò a sciogliere il partito accusandolo non solo di violazione del
dahīr del maggio 1914 relativo alle associazioni, ma anche di pretendere
dai suoi affiliati un giuramento che costituiva un grave attentato al sultano e alle regole tradizionali dell’Islām. Il provvedimento costituì un duro
colpo ma non scoraggiò i nazionalisti tra i quali, tuttavia, cominciarono ad
emergere due correnti distinte.
Una, più tradizionalista, legata alla cultura marocchina e alla religione
islamica, faceva capo a Mohammed ‘Allāl el-Fāsī il quale, dopo lo scioglimento del Comitato di azione marocchina, fondò il Partito nazionalista
per il conseguimento delle riforme (al-hizb al-watanī litahqīq al-matālib),
che si proponeva la realizzazione delle rivendicazioni formulate nel 1934.
Oltre ad el-Fāsī guidavano il partito, da cui sarebbe poi nato l’Istiqlāl, Ahmed Belfareğ e Mohammed el-Yazīdī25. La corrente modernista, tendenzialmente repubblicana e democratica, era invece denominata Movimento
Popolare (al-Harakah al-qawmiyyah) e riconosceva quale suo capo Mohammed al-Wazzānī, che, avendo studiato in scuole francesi e assimilato
idee occidentali, aveva una formazione culturale e politica molto diversa
da quella di ‘Allāl el-Fāsī26.
Mentre il partito guidato da quest’ultimo riuscì ad instaurare un rapporto diretto con le masse, il Movimento Popolare di al-Wazzānī, da cui
sarebbe nato nel dopoguerra il Partito Democratico dell’Indipendenza, divenne un partito di élite, anche perché rappresentativo soprattutto delle
istanze della piccola borghesia di Casablanca27. Ciò che, di là dalle differenze, accomunava i due nuovi soggetti politici era la condanna della politica economica e dell’invadenza, in tutti i rami dell’amministrazione, della
Francia il cui governo era accusato di non fare niente per rimediare alle
condizioni di miseria in cui viveva la maggior parte del popolo marocchino
e di agevolare gli interessi dei colonizzatori e dei grandi monopoli.
Vani risultarono i tentativi di sanare la rottura tra el-Fāsī e al-Wazzānī
messi in atto dall’emiro Arslān il quale, all’inizio del 1937 si era riavvicinato alla Francia, sia su pressione dei suoi amici maghrebini, sia in seguito
alla firma, nel settembre 1936, di un accordo franco-siriano in cui era fis395
Stefano Fabei
sato un calendario per l’accesso del Paese mediorientale all’indipendenza,
accordo da lui ritenuto positivo ed espressione di un mutato atteggiamento
francese nei riguardi degli arabi. La «riconciliazione» fu sancita da una
visita a Parigi dove l’Aemna, in occasione dell’’īd kabīr, offrì un banchetto
un suo onore il 21 febbraio.
Figura incontestata della lotta per la liberazione dei popoli islamici
sottoposti al dominio coloniale, campione dell’unità araba, propagandista
instancabile e fautore della coesione tra tutte le diverse correnti nazionaliste, l’emiro libanese rifiutò sempre l’accusa di essere al soldo di Mussolini
o, addirittura, una spia di Hitler, rivendicando tuttavia al tempo stesso il
diritto di essere l’unico giudice delle sue amicizie personali, con il Kaiser
Guglielmo II, con il Duce e con il Führer. Per lui, machiavellicamente, e
in questo per molti aspetti simile al Gran Mufti di Gerusalemme, contava
non tanto il mezzo quanto il fine, l’obiettivo finale. Non stupisce quindi
il fatto che sotto la sua alta autorità una delegazione marocchina si recasse
a Madrid per ottenere quello stesso tipo di appoggio invocato presso il
Fronte Popolare francese.
Del resto la situazione politica internazionale intorno alla metà degli
anni trenta era molto fluida, in continua evoluzione, e non può quindi più
di tanto meravigliare il fatto che nel Marocco spagnolo – dove Francisco
Franco preparava la sua rivolta politico-militare contro il governo repubblicano di Madrid – gli esponenti nazionalisti arabi, diffidenti sia nei riguardi
del Fronte popolare e del suo programma rivoluzionario, sia nei confronti
delle forze conservatrici e reazionarie, si mostrassero disposti a negoziare il
loro sostegno alla repubblica in cambio dell’indipendenza. E non meraviglia nemmeno che, di fronte alle titubanze e alle incertezze delle autorità
governative madrilene (ad eccezione, per la verità, degli autonomisti catalani nettamente favorevoli all’indipendenza del Marocco spagnolo) che
promettevano – forse in tal senso consigliate da Parigi – riforme sociali
profonde, rinviando però ogni negoziato sull’indipendenza o l’autonomia
del Marocco al momento in cui fosse stata superata la situazione di crisi,
Arslān raggiungesse Tètouan, dove le autorità franchiste moltiplicavano le
dichiarazioni favorevoli ai nazionalisti accordando loro ogni libertà, non
risparmiandosi in promesse di autonomia e lasciando che si parlasse di
indipendenza. I nazionalisti si avvicinarono al franchismo e facilitarono
un consistente reclutamento di soldati marocchini per la conquista «fascista» della Spagna: «Mentre i ribelli franchisti rafforzano i loro legami con
396
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
i marocchini, il governo francese del Fronte Popolare, pur moltiplicando
le dichiarazioni di buona volontà, resta molto intransigente sui suoi diritti
“irreversibili” a colonizzare l’Africa del Nord. La libertà d’espressione accordata largamente ai nazionalisti in Tunisia ed anche in Algeria rimane in
Marocco più ridotta»28.
Grazie ai buoni uffici di Arslān le autorità franchiste in Marocco autorizzarono la celebrazione a Tètouan, il 21 ottobre 1936, del congresso
dell’Aemna. Inizialmente era previsto che questo si tenesse a Rabat dove
non poté aver luogo a causa di un incidente provocato dal residente generale Marcel Peyrouton, il quale pretendeva, quale condizione per lo svolgimento, di presiedere l’assise. Il portaparola di quest’ultima, Mongī Slīm,
rifiutò la richiesta ritenuta inaccettabile e il congresso non ebbe luogo a
Rabat ma, appunto, a Tètouan, sotto il controllo delle autorità marocchine della zona, con la presidenza di ‘Abd el-Khāliq Torrēs e presente l’Alto
commissario Beigbeder. L’iniziativa mise in una situazione imbarazzante
quei maghrebini che cercavano un punto d’intesa con Parigi e solo un
numero piuttosto limitato di delegati provenienti dalla zona francese poté
prendervi parte: ciò sia per i pochi visti concessi dalle autorità francesi, sia
per l’indisponibilità di alcuni delegati a compromettersi. Alla riunione intervennero solo alcuni rappresentanti degli ‘ulamā’, un osservatore inviato
da Messālī e alcuni marocchini. Il congresso pertanto fu rimandato sine
die. L’ Aemna ne chiese il rinvio a Fèz per il febbraio dell’anno successivo,
ma il nuovo residente, il generale Noguès, pur non opponendo un formale
rifiuto, rinviò la concessione del permesso nel momento in cui le condizioni fossero state favorevoli.
La Francia intensifica la repressione e i nazionalisti marocchini
guardano all’Asse
Nella seconda metà del 1937 la tensione salì per le proteste messe in
atto dai nazionalisti e per gli incidenti che ebbero luogo a Miknās, a causa
dell’acqua sottratta agli arabi per irrigare le terre dei coloni francesi, e a
Marrākesh dove in occasione della visita, il 24 settembre, del residente
generale e del ministro dei Lavori Pubblici francese, la popolazione aveva
protestato di fronte alla richiesta di abbellire la città mentre languiva in
uno stato di miseria.
Il 13 ottobre i seguaci di ‘Allāl el-Fāsī, riuniti nella casa di un notabile di
397
Stefano Fabei
Rabat, Ahmed esh-Sherīf, elaborarono un «Patto Nazionale» (al-mīthāq alwatanī), in cui – considerati: l’imbavagliamento della stampa libera; la violenta repressione nei confronti di centinaia di appartenenti al movimento
riformista e di semplici cittadini; la situazione di crisi, morale e materiale,
del Paese dovuta alla politica oppressiva della Residenza generale e alla
sordità del Protettorato di fronte alle richieste dei marocchini nei campi
dell’assistenza, delle condizioni sociali e della giustizia; la chiusura delle
scuole coraniche e la persecuzione a danno degli studenti e degli insegnanti
musulmani mentre era favorita l’attività di penetrazione missionaria da
parte dei cristiani – stigmatizzavano tutte le persecuzioni reclamando la
liberazione degli arrestati, si impegnavano combattere contro gli abusi con
tutti i mezzi legali, respingevano le accuse mosse al Partito Nazionale di
essere al servizio di paesi stranieri, escludevano qualunque intesa con il
governo finché questo non avesse smesso di soffocare le libertà, interrotto
le persecuzioni e iniziato a risolvere i problemi del Marocco.
Nella seconda metà di ottobre atre manifestazioni di protesta provocarono una serie di conflitti per fronteggiare i quali la Francia mise in
atto ancora una volta una serie di provvedimenti repressivi che, insieme
alla soppressione della libertà di stampa e di associazione, sortirono quale
unico effetto l’aumento delle rivolte specialmente nei grandi centri come
Rabat e Fès. Alla repressione fece seguito la messa fuori legge del Movimento Popolare e del Partito Nazionale e la deportazione dei principali
capi nazionalisti: ‘Allāl el-Fāsī fu arrestato a Fès il 25 ottobre e confinato a
Libreville, nel Gabon, mentre al-Wazzānī fu confinato nel sud del Paese, ad
Asā nel Wādī Nūn. Soltanto Ahmed Belfareğ riuscì a rifugiarsi a Tangeri29.
Incarcerati i principali leader, l’agitazione nazionalista fu tenuta desta
nei giornali arabi di Egitto e di altri paesi. Nel Marocco spagnolo, dove si
erano rifugiati alcuni capi, cominciò ad agire un Ufficio di difesa nazionale
(maktab ad-difā’ al-watanī) con sede a Tetuán e diretto da un cugino di
Mohammed al-Wazzānī, Ibrāhīm al-Wazzānī. Ventinovenne, aveva studiato all’università religiosa di el-Qarawiyyīn e preso parte alle manifestazioni
contro il Dahīr berbero nel 1932. Spedito in residenza forzata a Tāzah,
dove aveva fondato una piccola scuola coranica riformata, il 19 maggio
1934 era stato nuovamente arrestato e condannato a due anni di carcere
per attività sediziosa. Scampato agli arresti nell’ottobre del 1937, aveva
raggiunto Tètouan dove diresse, con ‘Abd el-Qādir el-’Alamī, il suddetto
ufficio che sviluppò una campagna di propaganda tra i musulmani a favore
398
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
della lotta di liberazione dei marocchini, contro il colonialismo francese e
la massoneria accusati di soffocare la rinascita nazionale e religiosa del Marocco e di voler assimilare la razza marocchina alla razza francese.
Alla fine del 1939 il nazionalismo marocchino risultava limitatamente
esteso nelle masse continuando ad essere un fenomeno elitario: pochi i suoi
dirigenti, pochi gli aderenti. Se è vero che soltanto particolari circostanze
avevano fatto confluire nella sua agitazione le sommosse dei malcontenti,
va sottolineato che l’aspirazione a migliori condizioni di vita politica e civile poteva ormai ritenersi diffusa nel ceto più evoluto del Paese.
Per il momento, comunque, la Francia riuscì o, meglio, credette di
essere riuscita a sedare le agitazioni nazionalistiche e l’impressione fu effettivamente questa, anche perché l’opinione pubblica internazionale andava
sempre più appuntando la propria attenzione sui fatti che stavano portando
allo scoppio del secondo conflitto mondiale, distogliendola, in parte o del
tutto, dagli sviluppi del nazionalismo nei Paesi extraeuropei come il Marocco. I marocchini stessi parevano adesso più preoccupati dalla scelta delle
alleanze internazionali che da precisi programmi di riforma. Da alcuni anni poi i principali leader del mondo arabo, fra cui Shakīb Arslān e il Gran
Mufti di Gerusalemme, avevano manifestato la loro simpatia per la Germania da cui si attendevano un valido appoggio per la causa dell’unità araba30.
Quando nel giugno 1940 la Francia sconfitta venne divisa in una zona
occupata ed un’altra amministrata dal governo di Vichy, il residente generale, H. Nogues, dichiarò che avrebbe continuato la lotta. Il 6 settembre
il generale Veigand, che aveva intanto chiesto, con un appello personale al
Noguès di rimanere fedele a Vichy, fu inviato in Africa settentrionale come
delegato governativo e comandante delle forze francesi d’oltremare e fissò
la sua residenza ad Algeri.
Le commissioni tedesche d’armistizio, giunte in Marocco con il compito di controllare le forze francesi, stabilirono il loro quartier generale a
Fédala. Uno dei loro compiti pare fosse quello di «fare un inventario delle
possibilità marocchine al fine di inserire l’Impero sceriffiano nel sistema
hitleriano: Europa-Africa del Nord»31. La funzione di controllo venne affidata al consigliere d’ambasciata Auer, affiancato, per la propaganda indigena, dall’aiutante Langeheim, un valente arabista dotato di una buona
conoscenza della cultura locale. L’attività di propaganda dell’Asse, da parte
della Germania, tramite Radio Berlino, e dell’Italia, con Radio Bari, già
da alcuni anni aveva investito il mondo arabo posto sotto il controllo del399
Stefano Fabei
la Francia e della Gran Bretagna, esprimendo simpatia nei riguardi dei
movimenti di liberazione, nazionalisti e islamici. Adesso però le radiotrasmissioni tedesche verso il Marocco tendevano più o meno esplicitamente
a far passare il messaggio per cui con la vittoria del Terzo Reich anche
questo Paese avrebbe conseguito la sua indipendenza, e gli agenti nazisti
incoraggiavano quei nazionalisti che avevano trovato rifugio nel Marocco
spagnolo, come Hāğğ Ahmed Belfareğ e ‘Omar ibn ‘Abd el-Gelīl.
Non diversamente da quanto avvenne in altri paesi arabi e islamici, in
Africa e in Asia, lo scoppio della seconda guerra mondiale fu salutato anche in Marocco come l’occasione per conseguire l’indipendenza.
Con l’invasione da parte delle truppe tedesche della Francia, ai nazionalisti marocchini, soprattutto a quelli che si trovavano nel protettorato
spagnolo, parve che la liberazione dai detestati colonialisti, in primis francesi, fosse possibile e imminente. Spinti dall’altisonante campagna propagandistica tedesca, che prometteva in nome del Führer la liberazione del
mondo arabo, molti all’inizio non soltanto pensarono alla possibilità di
giocare la «carta tedesca» ma addirittura giunsero a immaginare un’azione
militare contro il Marocco francese con l’appoggio logistico germanico.
Consapevoli però delle pretese coloniali della Spagna sopra questa parte
del Paese, dovettero ben presto rassegnarsi a partecipare alle conversazioni
e perfino agli intrighi con gli agenti nazisti e le autorità spagnole. Si trattò
di un sogno di breve durata, giacché l’8 novembre 1942 ebbe luogo lo
sbarco delle forze alleate.
Il 14 luglio 1940 il colonnello spagnolo Segura, per ordine di Francisco Franco, occupava militarmente Tangeri e il 4 novembre successivo il
comandante delle forze d’occupazione assumeva la carica di governatore
e delegato dell’Alto commissario spagnolo in Marocco. Il 23 novembre
1940 una legge del Caudillo disponeva che le norme governative da emanarsi per il «Protectorado» avessero vigore anche nella zona di Tangeri e che
dal l° gennaio 1941 la legislazione spagnola e ispano-khaliffana vigente nel
«Protectorado» fosse applicata nella zona internazionale.
In applicazione di questo provvedimento, il 13 dicembre l’amministratore Manuel Don Manuel Amieva cedeva gli uffici dell’Amministrazione
al maggiore Gonzalo Gregori, che l’assumeva assieme al titolo di «Capo
dei servizi amministrativi della Zona di Tangeri», dipendente direttamente
dall’Alto commissario della «Zona Jalifiana». Con l’estensione del regime
giuridico di questa zona a quella, si operava altresì l’estensione del regime
400
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
amministrativo e i servizi propri dell’una (Affari indigeni, Finanze e Lavori Pubblici) si diramavano nell’altra mediante speciali delegazioni, e così
pure il Corpo di sicurezza del protettorato spagnolo mediante un distaccamento. Infine era dichiarato abolito l’ufficio del mandūb (il delegato del
sultano), e ripristinato l’ufficio di Pascià della città, nominando a questa
carica il qādī di Tangeri stessa, Sayyid el-’Arbī ibn Sīdī Mohammed etTemsamānī.
Tutti questi provvedimenti d’autorità presi dal governo franchista mutavano la condizione di fatto della zona internazionale del Marocco ottenendo il consenso italiano e la protesta e la riserva della Gran Bretagna, cui
premeva che Tangeri non fosse fortificata.
Il nazionalismo della zona spagnola si manifestò favorevole all’occupazione militare, interpretandola come un’impresa delle truppe khalifiane e
propugnando sin d’allora l’abolizione del regime internazionale e l’annessione della città. Ma tra le file nazionaliste c’era chi si sentiva più vicino
alla Spagna in nome della «solidarietà ispano-marocchina» e chi s’ispirava
all’ideale d’indipendenza del Marocco settentrionale come quanti erano
organizzati nel Partito nazionale separatista e il Partito riformista nazionale
Ahmed Belfareğ nel 1927 (seduto)
401
Stefano Fabei
(Hizb al-islāh al-watanī), che disponevano il primo di un suo foglio settimanale, ar-Rīf, il secondo del quotidiano al-Hurriyyah, stampati entrambi
a Tètouan32.
La Germania di Hitler e il futuro del Marocco
Alla vigilia della seconda guerra mondiale la Germania era disinteressata a rivendicazioni di carattere coloniale, sia per la contrarietà al colonialismo di alcuni ambienti nazionalsocialisti sia, soprattutto, per una scelta di
Hitler che aveva voluto fare i conti con la politica estera guglielmina e con
quella weimariana. Messa da parte qualsiasi possibilità di espansione oltre
il vecchio continente, riteneva che i tedeschi dovessero orientarsi verso l’est
europeo, dove, a suo giudizio, si trovava il lebensraum, lo «spazio vitale»
necessario al loro popolo. Già nel Mein Kampf aveva anticipato questa sua
posizione circa la questione coloniale: «Noi, nazionalsocialisti, tiriamo una
riga sulla politica estera dell’anteguerra e la cancelliamo. Noi cominciamo
là, dove si terminò sei secoli fa. Mettiamo termine all’eterna marcia germanica verso il sud e l’ovest dell’Europa e volgiamo lo sguardo alla terra
situata all’est. Chiudiamo finalmente la politica coloniale e commerciale
dell’anteguerra e trapassiamo alla politica territoriale dell’avvenire»33.
«L’esperienza militare del Führer – ha scritto Henri Michel – era quella
di un soldato, il mare non lo attirava ed egli ne ignorava tutto. Pertanto
egli individuava i suoi obiettivi di guerra all’Est dell’Europa, per la costruzione di un Reich millenario, attraverso la conquista di terra coltivabile sui
territori popolati dagli Slavi»34. Questo fatto non impedì tuttavia alla Germania di sviluppare tra il 1933 e il 1939 un’intensa attività di propaganda
nel Nord Africa – e non soltanto in quest’area, ma in tutto il mondo arabo,
dal Maghreb all’Iraq35 – presentandosi come una potenza anticolonialistica
pur continuando a reclamare al contempo, in nome dell’uguaglianza dei
diritti tra le nazioni, la restituzione delle colonie sottrattegli dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale (protettorati del Togo e del Camerun,
possedimenti nell’Africa sud-occidentale ed orientale). Per quanto riguarda in particolare il Marocco, nel 1937, in occasione degli incidenti e delle
sommosse verificatesi a Miknās, Khemisset e Fèz, sulla stampa tedesca apparivano articoli di condanna dei metodi di pacificazione usati dalle autorità coloniali francesi e di aperta simpatia per il movimento di liberazione
arabo e per la lotta da esso condotto in quel Paese e altrove. Secondo i ser402
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
vizi informativi francesi i tedeschi incoraggiavano i movimenti nazionalisti
del Maghreb anche attraverso la propaganda antiebraica sviluppata dagli
ambienti musulmani in Europa, in particolare dall’Associazione dei Giovani Musulmani con sede a Berlino. Fondata per merito del dottor ‘Abd
al-Giabbār al-Keirī al-Hindī nel 1922, aveva nel 1937 come presidente
Riyād Ahmed Mohammed, segretario della Missione Scientifica Egiziana e
come segretario Habīb al-Rahmān al-Hindī, corrispondente dei principali
giornali indiani dalla Germania. L’associazione si reggeva sui fondi dei soci
e sulle oblazioni dei musulmani che capitavano a Berlino. Si sforzava di
raccogliere tutti i fedeli di Allāh residenti in Germania e di far conoscere
l’Islām diventando così uno dei punti di incontro in Europa per i fautori
della libertà araba. Sul giornale cairota «al-Muqattam» del 6 ottobre 1936
si leggeva: «L’Associazione, per tutto quello che desidera pubblicare, incontra benevola accoglienza presso tutta la stampa tedesca ed alta considerazione da parte del governo. In occasione dei giochi olimpici l’associazione
accolse i musulmani venuti in Germania, offrendo loro un ricevimento
d’onore che si chiuse con gli evviva dei Musulmani a Hitler secondo l’uso
nazista, giacché i principi del Socialnazionalismo non sono in disaccordo
con l’Islām ed i suoi insegnamenti».
Nel Maghreb gli sforzi dei tedeschi miravano a fomentare attività antiebraiche e ad incoraggiare le diserzioni dalla Legione Straniera. A coordinare gli sforzi della propaganda nazista era l’Auslandorganisation del
Nsdap, cioè il settore esteri del partito nazista. Le sezioni locali di questo e
dell’Arbeitsfront installate ad Algeri, Orano, Tètouan servivano come base
agli agenti nazisti e ai loro corrispondenti.
Il «Servizio Orientale» del dottor Rudiger, collegato al ministero della Propaganda, benché si occupasse principalmente del Medio Oriente,
non trascurava di agire anche nel Maghreb e soprattutto in Marocco. Per
sua iniziativa venivano stampate e largamente diffuse edizioni popolari del
Mein Kampf con una fascia su cui era scritto «L’uomo più forte del mondo». In questo Paese il Reich aveva solo un consolato, ma i tedeschi erano
molto numerosi a Tètouan, dove agivano in coordinamento con un attivo
centro di propaganda nazista.
Le numerose comunità musulmane (Islamische Gemeinde) attiravano nel Reich molti studenti arabi, facilitandogli le possibilità di studio.
Stretti legami erano stati stabiliti grazie all’attività del marocchino ‘Abd
al-Wahhāb, capo della Comunità islamica di Berlino e alla mediazione
403
Stefano Fabei
dell’Unione degli Studenti Arabi, anche con alcuni capi nazionalisti del
Comitato d’azione marocchina, fra cui al-Wazzānī, el-Makkī en-Nāsirī, e
‘Abd es-Salām Bennūna, che avevano la propria sede all’Islamischer Kulturbund di Vienna, fondato dall’emiro Arslān.
Sempre a Berlino, nel 1938, erano sorti, oltre al «Comitato per la difesa
della Tunisia» un «Comitato di difesa araba del Maghreb Arabo» e un«
Comitato dei rifugiati politici del Nord Africa». Lo stesso anno i servizi
segreti francesi segnalavano la preoccupante attività di un gran numero
di ufficiali tedeschi che, arrivati, clandestinamente nel Maghreb, avevano
preso contatto con diverse tribù nomadi. Nel 1939 la Germania moltiplicò
i gesti amichevoli nei confronti del mondo arabo. Dopo che la legazione del Reich a Baghdad pubblicò un comunicato in cui si dichiarava che
la Germania non aveva ambizioni territoriali nel vicino Oriente, Hitler
ricevette un inviato di Ibn al-Sa’ûd cui promise un’attiva partecipazione
germanica al rafforzamento dell’esercito saudita. Il 21 giugno dello stesso
anno il ministro degli Esteri Ribbentrop rese pubblica una dichiarazione in
cui veniva deplorata la situazione degli Arabi nel mondo ed assicurava che
la Germania avrebbe fatto il possibile affinché le loro aspirazioni nazionali
fossero realizzate.
Tali proposte non lasciarono indifferenti i nazionalisti maghrebini che
subito accentuarono le loro manifestazioni di simpatia per i tedeschi e alcuni, come il marocchino Ahmed Belfareğ, espressero agli agenti nazisti la
loro entusiastica solidarietà ed amicizia.
Per raggiungere i marocchini e le masse maghrebine furono poi utilizzate dai tedeschi, oltre che dagli italiani, le trasmissioni radiofoniche. Dal
1934 in poi le apparecchiature radio avevano cominciato ad avere una
certa diffusione nei paesi arabi e le emittenti europee avevano iniziato a
rivolgersi a questa parte del mondo con una certa frequenza. Ciò per tutta
una serie di motivi: per gli interessi che in questi Paesi avevano le potenze
europee; per le specifiche condizioni politiche di questi Stati; per il numero
rilevante, nel mondo, degli arabi (allora trentasei milioni) e dei musulmani
che comprendevano l’arabo. Va anche tenuto presente che tra gli arabi
c’era un’altissima percentuale di analfabeti e ciò costituiva un ostacolo alla
propaganda e alla comunicazione per mezzo della stampa. La mancanza o
scarsità di passatempi quali il teatro, il cinema, lo sport, a differenza dei
Paesi occidentali; l’abitudine di passar molto tempo nei bar; il tipo di vita
domestica; l’amore per la musica, l’eloquenza, per le bellezze della propria
404
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
lingua: tutte queste cose favorivano un diffuso ascolto della radio nel mondo arabo. Se le condizioni economiche non permettevano ai più l’acquisto
di un apparecchio radio, è anche vero che le trasmissioni nei locali pubblici
erano seguite da un gran numero di persone. La stazione radio di Bari
iniziò le trasmissioni in arabo il 24 maggio 1934, quella del Cairo il 31
maggio dello stesso anno, radio Algeri nel 1935, radio Gerusalemme il 30
marzo 1936, radio Baghdad il 12 luglio 1936, radio Angora il 12 gennaio
1937, radio Londra il 3 gennaio 1938, radio Beirut il 3 settembre 1938,
radio Berlino il 25 aprile 1939.
Dopo gli accordi italo-inglesi dell’aprile 1938, che avevano messo fine
alla guerra delle radio in lingua araba scatenata da radio Bari, la Germania aveva preso il posto dell’Italia, conducendo, con una ben superiore
efficacia, una campagna antiinglese ed antifrancese nei paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa. L’emittente di radio Berlino (Zeesen), insieme a
quella di Stoccarda, aveva iniziato dal 25 aprile 1939 a diffondere notiziari
e commenti in lingua araba e francese. Più tardi furono utilizzate anche
altre stazioni quali Monaco, Francoforte e Saarbrücken. I programmi comprendevano: recitazione del Corano, musica araba, lettura di testi letterari
e notiziari politici. I principali annunciatori arabi nella capitale del Reich
erano: Farrāj Allāhverdī, Taqī al-Dīn Hilālī e Kemāl al-Dīn Gelīl. Da radio Berlino parlava poi un nazionalista iracheno che ben presto divenne
celebre, Yūnus al-Bahrī. Ascoltato con rispetto ed ammirazione dai circoli
religiosi e nazionalisti, questo oratore si esprimeva in un arabo letterario
«colto» che non era molto ben inteso in Marocco, al contrario di Taqī alDīn Hilālī, lettore marocchino di lingua araba all’università di Bonn, un
polemista di talento considerato il luogotenente dell’emiro Arslān.
Radio Zeesen trasmetteva in arabo dialettale, marocchino e tunisino, in
berbero marocchino ed in dialetto cabilo: a partire dal 15 novembre 1939
tre erano i bollettini di informazione quotidiana. Dal 1940 le stazioni radio tedescbe aumentarono il numero delle trasmissioni in arabo; portando a cinque le emissioni quotidiane, il Reich si proponeva una costante,
convincente e massiccia opera di propaganda nel mondo arabo. Altrove
abbiamo indagato i temi di questa continua opera di propaganda, che per
quanto riguarda il Marocco, come vedremo, non cambiarono nemmeno
quando questo paese passò sotto il controllo alleato36.
Alla luce di quanto sopra detto non meraviglia l’attitudine molto favorevole dei marocchini nei confronti della Germania prima e durante il
405
Stefano Fabei
Mohammed el-Wazzānī al centro e alla sua destra Mohammed al-Makkī en-Nāsirī.
conflitto. A conferma di questo atteggiamento potremmo citare, fra i tanti
episodi, le manifestazioni che, sconfitta la Francia, ebbero luogo in alcuni
centri marocchini fra cui Tétouan dove venne fatta la parodia del funerale
della Francia e furono innalzate bandiere con la croce uncinata; oppure
l’alto numero di volontari che si offrirono per andare a lavorare nell’Europa occupata. I francesi si opposero al loro reclutamento e fecero interdire
dalla polizia l’accesso al consolato germanico di Casablanca a quanti si
presentavano per raggiungere la Germania e la Francia, provocando, nel
luglio 1942, un grave incidente diplomatico con i tedeschi. Alla sconfitta
della Francia nella primavera del 1940 seguì un armistizio, quello di Rethondes il 21 giugno, che non comportò per la nazione vinta né la perdita
del suo esercito né, tanto meno, del suo impero coloniale, soprattutto in
Nord Africa37.
Tre giorni dopo, nei pressi di Roma, firmando un analogo armistizio,
406
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
quello italo-francese, i plenipotenziari Galeazzo Ciano e Pietro Badoglio,
nonostante le pressioni di Mussolini, riuscivano a ottenere soltanto la smilitarizzazione del confine francese e libico-tunisino e l’uso del porto di
Gibuti, e questo anche per la ferma volontà di Hitler di non imporre misure eccessivamente punitive ai francesi, che voleva far rientrare nell’orbita dell’Asse, evitando che quanto rimaneva delle loro forze potesse unirsi
all’Inghilterra38. Insomma, bisognava mantenere i possedimenti nordafricani della Francia per neutralizzare il regime di Vichy, togliendo a Philippe
Pétain il pretesto per cadere nelle braccia degli inglesi: Hitler era convinto
che, se le forze dell’Asse non avessero attaccato le colonie francesi queste
sarebbero rimaste fedeli al vecchio maresciallo e quindi, indirettamente, a
lui stesso39.
Senza tener conto delle preoccupazioni d’alcuni ambienti politico-militari sul Marocco il 18 giugno 1940 il governo di Berlino ribadiva che il
Mediterraneo, inclusi i possedimenti francesi nordsahariani, corrispondevano alla sfera d’influenza italiana. Il 24 ottobre 1936, giorno immediatamente precedente la costituzione dell’Asse, Hitler aveva infatti dichiarato
a Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri italiano: «Il Mediterraneo è un
mare italiano. Qualsiasi modifica futura nell’equilibrio mediterraneo deve
andare a favore dell’Italia. Così come la Germania deve avere la libertà di
azione verso l’Est e il Baltico; orientando i nostri due dinamismi esattamente opposte, non si potrà mai avere un urto di interessi tra Germania
ed Italia»40. In altri termini, secondo Hitler, i paesi arabi sotto controllo
francese ed inglese quasi nella loro totalità facevano parte della sfera d’interesse dell’alleato. Questo era stato poi ribadito dal ministro degli Esteri,
Ribbentrop, il quale il 12 novembre 1940 aveva detto a Molotov che il
Reich aveva delimitato le sue aree d’influenza e che la necessità d’estendere
il proprio lebensraum lo spingeva verso sud, verso l’Africa centrale, dato che
quella settentrionale e mediterranea spettava a Roma41.
A giudizio del generale Walter Warlimont, dal 1938 al 1941 capo della
Sezione difesa territoriale presso il comando della Wehrmacht, l’area nordafricana, parte dello spazio mediterraneo e in quanto tale di competenza italiana, non avrebbe creato grandi problemi all’Italia dopo la vittoria
decisiva conseguita dal Reich sulle forze francesi e inglesi42. Il fatto che il
governo del Reich si disinteressasse, almeno direttamente, del Nordafrica,
non impedì comunque ad alcuni settori tedeschi di sviluppare un’attiva
propaganda in tutto il Marocco e delle trattative con i nazionalisti maroc407
Stefano Fabei
chini, in un’area, la parte spagnola del Paese, che era vista dai servizi informativi nazisti come un’appendice di una ben più importante piattaforma
operativa, quella di Madrid. Qui, in principio, molti pensarono che, grazie
alla sconfitta della Francia, fosse finalmente possibile procedere a qualche
rivendicazione immediata come ricompensa per il ruolo di intermediario
svolto al momento dell’armistizio franco-tedesco. Il 17 giugno 1940 il ministro degli Esteri spagnolo, colonnello Juan Beigbeder, chiese all’ambasciatore Josè Félix de Lequerica di reclamare presso il governo francese una
modifica della frontiera franco-spagnola del Marocco con l’integrazione
dei territori dei Benī Zirwāl e dei Benī Snāsen43.
Le pretese di Madrid in seguito non riguardarono soltanto qualche limitata richiesta, ma si estesero all’intero Marocco francese e furono avanzate
fino al novembre 1942, momento in cui le forze anglo-americane comandate dal generale Dwight Eisenhower sbarcarono in Marocco e in Algeria
incontrando una debole resistenza da parte delle truppe del governo di Vichy. L’8 agosto 1940, ad esempio, Eberhard von Stohrer, ambasciatore del
Reich a Madrid, inviava a Berlino un memorandum in cui affermava che
tra le richieste di Franco per un allineamento della Spagna con le potenze
dell’Asse c’era il soddisfacimento delle sue pretese territoriali nel Marocco
francese. Queste ultime vennero ancora una volta ribadite in settembre dal
cognato di Franco, Serrano Suñer, in visita a Berlino come ministro degli
Esteri; successivamente dal Caudillo in persona che il 23 ottobre, incontrando Hitler a Hendaye, rifiutò di entrare in guerra. Franco si dichiarò
disponibile a pagare il debito di riconoscenza contratto con la Germania
e l’Italia durante la guerra civile, ma chiese tempo per prepararsi e avanzò pretese che il Führer giudicò eccessive: armi, granaglie e…il Marocco
francese: richiesta quest’ultima inammissibile per chi, come Hitler, voleva
che la Francia continuasse a far parte della coalizione antibritannica44. Il
dittatore tedesco non riuscì nemmeno a ottenere il permesso per le sue
truppe di attraversare la Spagna per conquistare Gibilterra, come previsto
dal piano «Felix».
Mentre avevano luogo queste trattative riguardanti il destino del Marocco, anche i più diretti interessati, i marocchini, si interrogavano sul
ruolo del loro Paese nel conflitto in corso. Il giornale nazionalista ar-Rīf il
28 maggio 1940 scriveva che dopo la sconfitta della Francia l’ultima parola
spettava ai marocchini: la Spagna aveva un debito di riconoscenza con loro
che dopo aver combattuto lealmente al suo fianco durante la guerra civile,
408
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
ristabiliti l’ordine e la sicurezza, erano tornati a casa propria; era giunto
adesso il momento di contraccambiare nella stessa maniera nella zona del
sultano. Qualche tempo dopo, il 1° agosto, sull’organo del Partito delle
riforme nazionali, al-Hurriyyah, si leggeva che nel caso in cui il popolo marocchino fosse stato ritenuto, suo malgrado, incapace di governarsi, il compito di guidare e sostenere il Marocco avrebbe dovuto essere affidato alla
Germania o, eventualmente, alla Spagna. Il Terzo Reich, tuttavia, era ritenuto la potenza più capace di assolvere il suddetto ruolo e più in linea con
gli interessi e i sentimenti del popolo marocchino. Qualora, però – aveva
avvertito Mohammed Dawūd su ar-Rīf del 14 giugno – avesse sostenuto
la Francia in Marocco, esso sarebbe stato combattuto, così come la Spagna
nel caso in cui questa avesse mirato a prendere il posto della Francia45.
L’atteggiamento dei marocchini nei riguardi dei tedeschi era molto
benevolo e fiducioso sia perché risultò chiaro il disinteresse di Hitler a
occupare militarmente il Marocco, sia perché dopo la sconfitta della Francia si intensificò, soprattutto nella zona spagnola, un’intensa opera di informazione e propaganda iniziata, come abbiamo detto, ben prima dello
scoppio della guerra. I rapporti tra i nazionalisti marocchini di quest’area
e i nazionalsocialisti risalivano probabilmente al 1933, quando ‘Abd elKhāliq Torrēs si era recato a Berlino. La cosa era nota alle autorità consolari
francesi di Tètouan come risulta da una nota del 26 febbraio 1936: «Senza
alcun dubbio esistono tra gli indigeni elementi favorevoli ali tedeschi […]
le relazioni di Torrēs con i tedeschi sono note […] i nostri nemici sono
sempre disposti a ricevere direttive e qualche aiuto economico contro di
noi»46. Con la sconfitta della Francia i nazionalisti costituirono una commissione incaricata dei rapporti coi tedeschi, di cui facevano parte oltre a
Torrēs, capo del Partito delle riforme nazionali, Thāmī al-Wazzānī, Taib
Bennouna e Mohammed Tnana. Loro interlocutori erano agenti segreti
nazisti dipendenti della Wilhelmstrasse, cioè del ministero degli Esteri, o
militari, membri delle SS. Secondo un influente membro del Prn, Mohammed el-Khatīb, gli emissari del suo partito avevano rapporti con il
viceconsole del Reich a Tètouan, Krüger – che, al di là di questo ruolo
di copertura, era soprattutto un agente dell’Abwehr II – e con il console
generale tedesco a Tangeri, Wiedemann47.
Nei mesi successivi alla vittoria sulla Francia, la Germania e la Spagna
non bloccarono lo stretto di Gibilterra né occuparono il Marocco francese
che rimase sotto il controllo delle forze di Pétain. Tuttavia le trattative dei
409
Stefano Fabei
nazionalisti arabi con gli agenti nazisti proseguirono, con l’obiettivo (pura
illusione?) di organizzare, grazie all’appoggio logistico tedesco, una sollevazione militare contro il Marocco francese. L’occasione che si presentava
al Marocco era unica, affermava Torrēs sul periodico al-Hurriyyah il 1° settembre 1940, chiedendosi quale fosse il giusto atteggiamento da assumere
di fronte agli eventi in corso: aspettare passivamente lo sviluppo dei fatti
mantenendosi neutrali, oppure schierarsi con una delle parti in causa? Per
compiere questa scelta era però necessario avere l’appoggio di tutta quanta
la società marocchina. Ricevutolo, niente avrebbe impedito di affrontare
l’avventura. Va da sé che le simpatie di Torrēs andavano apertamente alla
Germania con i rappresentanti della quale stava trattando. Contemporaneamente i patrioti marocchini si incontravano con Carlos Asensio, l’alto
commissario spagnolo, che li consigliava a confidare nelle promesse tedesche, chiedendo loro però al contempo, di escludere dal futuro Marocco
indipendente la città di Tangeri che, in considerazione del conflitto in corso, doveva rafforzare le enclaves spagnole di Ceuta e Melilla48.
Il generale Asensio incoraggiava indirettamente i nazionalisti marocchini a negoziare con la Germania l’indipendenza del Paese ritenendo che
questi avrebbero potuto svolgere un’utile funzione: quella del «cavallo di
Troia» con cui la Spagna avrebbe occupato il Marocco francese. Per Madrid, insomma, i patrioti che stavano trattando con i tedeschi, erano uno
strumento da utilizzare per i propri obiettivi, e se per conseguire questi
ultimi occorreva spingerli a buttarsi tra le braccia dei tedeschi il rischio
doveva essere pur corso.
In merito al progetto di rivolta contro le forze d’occupazione francesi
tra il 1940 e il 1941 Mohammed Tnana, allora incaricato di preparare i
saharaui all’uopo, intervistato dallo storico ‘Abd el-Magīd Ben Gellūm il
23 marzo 1978, dichiarò che gli spagnoli avevano cercato di utilizzare i patrioti come lui per esercitare pressioni sulla Francia e per occupare la zona
francese del Marocco: «Quanto ai progetti specifici del nostro movimento
nazionalista, si riassumevano semplicemente nel fatto che anche noi volevamo esercitare pressioni sulla Spagna affinché ci concedesse l’autonomia
interna. L’obiettivo non era raggiungere l’indipendenza di tutto quanto
il Marocco[…]. La si reclamava, certamente, ma si sapeva che era ancora molto lontana»49. Sebbene i nazionalisti sospettassero di costituire una
carta che le forze in campo volevano giocare per i loro specifici interessi,
continuarono a far pressioni sui tedeschi per ottenere un maggior sostegno
410
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
Mohammed el-Wazzānī al centro e Mohammed el-Yazīdī, ultimo sulla sinistra, nel 1936.
alla loro causa e cercarono di profittare delle tensioni germano-spagnole.
Questo nonostante il 16 settembre 1940 Richter, il console tedesco di
Tètouan, gli avesse mostrato un telegramma proveniente da Berlino in cui
si ribadiva come tutta l’Africa del Nord, Marocco compreso, facesse parte
dell’area d’influenza italiana.
Sembra che proprio in seguito a tale precisazione ‘Abd el-Khāliq Torrēs
avesse deciso di andare nella capitale del Reich all’inizio del 1941 per cercare di convincere i tedeschi a sostenere la causa dell’indipendenza marocchina. Di questo viaggio pare non ci sia traccia nella documentazione conservata negli archivi tedeschi. Certamente Torrēs raggiunse Madrid dove
incontrò alcuni responsabili nazisti che forse lo sconsigliarono di raggiungere Berlino perché, comunque, non sarebbe riuscito ad ottenere più di
quanto gli avessero promesso loro. Tornato in Marocco l’8 febbraio avrebbe riferito ai suoi uomini e soprattutto agli spagnoli di aver incontrato tutti
i più importanti gerarchi nazisti, e questo probabilmente per rafforzare la
sua posizione di fronte alle autorità del protettorato e per attribuirsi un
peso maggiore quale negoziatore con gli spagnoli. Indipendentemente dal
fatto che abbia o no compiuto il viaggio a Berlino il capo del Pnr dovette
prendere atto dell’impossibilità di ottenere qualcosa di più concreto delle
411
Stefano Fabei
promesse e dei buoni propositi. Ciononostante mantenne i rapporti con i
tedeschi, così come il Partito delle riforme nazionali.
Non solo i nazionalisti continuavano a nutrire speranze sulla Germania:
il 29 maggio 1941, il figlio del Califfo, Mulay Hassan, al corrispondente
da Tètouan del «Berliner Borsen Zeitung» che gli chiedeva di esprimersi
sulla guerra che l’Iraq di Rashīd ‘Ālī al-Gaylānī stava sostenendo, appoggiato in misura limitata e tardivamente dall’Asse, contro le forze britanniche
presenti in quel Paese, dichiarava: «È superfluo dire che le simpatie di tutti
i marocchini sono per l’Iraq. Sono persuaso che è giunto il momento in
cui bisogna regolare un vecchio conto e in cui i paesi musulmani oppressi
dovranno essere liberati dal giogo della dominazione straniera.
L’Inghilterra ha sempre mancato alla parola data: essa è il grande nemico per il quale tutti gli arabi nutrono il più profondo odio e disprezzo. Noi
marocchini siamo fieri dei nostri fratelli di razza e di religione nell’Egitto e
nell’Iraq, i quali finalmente tengono fronte al comune nemico, l’Egitto rifiutando di lasciarsi costringere a dichiarare la guerra alle Potenze dell’Asse,
e l’Iraq opponendosi alle violenze inglesi». Alla domanda su cosa pensasse
dell’esito della guerra Mulay Hassan rispondeva: «Il popolo islamico prega
nelle sue moschee per la vittoria dell’Asse. Noi marocchini non dubitia-
Foto di gruppo di alcuni nazionalisti marocchini. Sono riconoscibili ‘Allāl el-Fāsī al centro e,
sulla destra, entrambi con il fez, Mohammed ibn el-Hasan al-Wazzānī e Mohammed el-Yazīdī.
412
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
mo un istante che il Grande Reich tedesco e i suoi alleati riporteranno
una grande vittoria sul nemico del mondo, l’Inghilterra; le nostre simpatie
sono e saranno sempre per il Grande Reich tedesco, per il suo fondatore
Adolf Hitler e per il popolo tedesco ed io sono convinto che ogni musulmano ortodosso condivide questo mio punto di vista. Gli arabi non
hanno dimenticato la lunga serie di tradimenti, di persecuzioni sanguinose
e di oppressioni di cui l’Islām è stato vittima per opera dell’Inghilterra».
Interrogato, infine, sull’atteggiamento che credeva avrebbero assunto i
Paesi islamici di fronte al Nuovo Ordine in Europa, il futuro re del Marocco dichiarava: «Il Nuovo Ordine Europeo ci permetterà finalmente di
allacciare rapporti commerciali diretti con i paesi europei amici. Fra noi e
questi paesi vi è stato finora il capitalismo ebraico che sfruttava l’Oriente
a suo proprio vantaggio: nei paesi sottoposti alla dominazione della Gran
Bretagna gli inglesi procuravano, da parte loro, di ostacolare anziché di
facilitare il nostro commercio con le potenze continentali. lo sono convinto che la vittoria dell’ Asse avrà come conseguenza un cambiamento in
tutti questi territori. La lotta iniziata dall’Islām contro il comune nemico
di tutti i credenti spianerà contemporaneamente la via per la creazione di
una federazione panaraba la quale, appoggiata dalla nuova Europa, vedrà
assicurare il suo avvenire»50.
Anche il sovrano, pur molto prudente, simpatizzava per le forze dell’
Asse. Egli stesso avrebbe rivelato ai tedeschi, nel settembre 1942, l’imminenza dello sbarco americano e chiesto, nel gennaio successivo, l’appoggio
immediato dell’Asse. Una delegazione da lui inviata avrebbe preso contatto, il 2 gennaio 1943, col vice console tedesco Krüger, capo dell’Abwehr a
Tangeri, ed offerto la sua collaborazione.
Da una lettera di Richter al ministero degli Affari Esteri del 4 agosto
1941 risulta come Torrēs, tre mesi prima dello sbarco alleato, continuasse a
sperare nell’aiuto tedesco e come fosse infastidito dal ruolo da intermediari
con cui gli spagnoli si interponevano nelle relazioni germano-marocchine.
Torrēs era convinto che la Germania potesse ancora svolgere una funzione
importante nella liberazione del Marocco e che, soprattutto nel caso di
un’invasione, l’opinione del suo popolo avrebbe dovuto essere tenuta nella
debita considerazione dai tedeschi. Di questo pareva convinto lo stesso
Richter il quale suggeriva l’opportunità che gli spagnoli non partecipassero
alle conversazioni tra gli arabi e i tedeschi. Il diplomatico aggiungeva poi di
aver constatato, dopo gli incontri con il segretario generale Garcìa Figueras
413
Stefano Fabei
e con Torrēs, come da parte spagnola non fosse stato fatto alcunché per
influire sulla stampa marocchina come richiesto dai tedeschi51.
L’11 novembre 1942 a Tetouán il fratello del Califfo, principe Mohammed, disse al console del Reich che le Potenze dell’Asse dovevano fare
una dichiarazione in cui venisse garantita l’indipendenza del Marocco: «In
questo momento in cui non c’è più motivo di avere riguardi per la Francia,
non bisogna far altro che tener conto degli interessi spagnoli e per questo
noi possiamo trovare facilmente un rimedio»52.
Qualche giorno dopo ‘Abd el-Khāliq Torrēs presentava una sua richiesta in cui si affermava testualmente: «I marocchini terranno conto degli
interessi spagnoli nel Marocco solo nel caso in cui il governo tedesco farà
una dichiarazione sull’indipendenza del Marocco e ne garantirà l’osservanza»53. Il console germanico si mostrò favorevole ma c’era chi, come il suo
collega Mohr, giudicava la richiesta inconciliabile con gli interessi spagnoli: «La Spagna considererà ciò come una insopportabile ingerenza tedesca.
La Germania potrebbe tutt’al più dare la sua approvazione alla costituzione
di un impero unificato sotto la direzione della Spagna o, con il consenso
di quest’ultima, sotto la direzione della Germania»54. Il console generale
temporeggiò: aveva bisogno, per sviluppare la propaganda tedesca, dei capi
nazionalisti e dei loro militanti nella zona francese: «Il punto più delicato
della collaborazione coi nazionalisti è che essi esigono la completa indipendenza del Marocco e questo è diretto sia contro il protettorato francese
che contro quello spagnolo»55. Gli spagnoli furono riconoscenti al console
tedesco e gli permisero di accentuare la propaganda, ma i capi nazionalisti
ebbero l’impressione di essere stati mollati e da allora non contarono più
sulla Germania.
Il 27 novembre 1941, l’alto commissario spagnolo a Tètouan, Luis Orgaz, riferiva al ministro degli Esteri, Ramón Serrano Suñer, la voce secondo
cui, su richiesta di Torrēs, un agente dell’intelligence tedesca aveva raggiunto di nascosto la sua casa e che i due avevano avuto una conversazione
su quanto stava accadendo nel Paese e sull’operato dei tedeschi e degli
spagnoli. Dalla lettera risultava anche che il politico marocchino da allora
aveva cominciato a collaborare con altri elementi dei consolati di Tètouan
e Tangeri da Orgaz definiti incontrollati e irresponsabili.
Difficile, per mancanza di fonti, stabilire con certezza la natura e i fini
dei rapporti tra i patrioti marocchini e i tedeschi dopo lo sbarco alleato.
Taqī al-Dīn Hilālī nel 1977 dichiarò a Benjelloum che l’8 novembre aveva
414
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
‘Abd el-Khāliq Torrēs al Cairo nel 1958, con il presidente egiziano Giamâl Abd en-Nâsser e il re
del Marocco Mohammed V.
fatto da interprete nell’incontro tra Torrēs e un agente tedesco il quale
gli aveva dato 7.000 marchi e offerto delle armi che il notabile nazionalista rifiutò dicendo che con gli americani in Marocco questo non era più
possibile. Il sogno di Torrēs e del suo partito di liberare il proprio Paese
o di ottenere, nella parte spagnola, l’autonomia interna, era finito. Ciononostante la campagna propagandistica a favore dell’Asse intrapresa dai
nazionalisti marocchini proseguì.
La propaganda tedesca in Marocco dopo lo sbarco alleato
Le commissioni tedesche installate, come abbiamo detto, dopo la firma dell’armistizio, erano piuttosto articolate, comprendendo oltre ad uno
stato maggiore incaricato dei rapporti con le autorità militari francesi, a
una sezione di controllo delle forze fedeli a Pétain e a una specializzata
nella guerra sul mare, nuclei di militari e civili che dovevano occuparsi
della vita culturale ed economica del Marocco. Dalle loro basi, poste a Fèz,
Marrākesh e Fédala, queste commissioni si sarebbero spostate all’interno
del Paese. A presiedere queste attività di controllo i tedeschi designarono il
415
Stefano Fabei
sopra citato consigliere d’ambasciata Auer, un renano dotato di un consistente bagaglio culturale ed ottimo conoscitore del francese e dell’inglese.
Dipendente direttamente da Ribbentrop, il ministro degli Esteri di Berlino, Auer si avvaleva della collaborazione dell’arabista Langeheim e di un
vecchio agente della Lufthansa nell’Africa orientale francese, già console a
Bathurst, Klaub.
Le commissioni militari tedesche addette al controllo delle forze francesi, che all’inizio del 1942 comprendevano almeno 200 ufficiali, erano
dirette dal generale Schultheiss, giunto a Casablanca il 20 maggio 1941.
Quella addetta al controllo dell’esercito all’inizio era presieduta, a Fédala,
dal tenente colonnello Von Lossnitzer e si articolava in tre sottocommissioni dislocate a Marrākesh, Miknās e Fèz. A presiedere la commissione
incaricata di controllare le forze di marina c’era il capitano di vascello Hoffmann, mentre l’incaricato per le forze dell’aviazione era il comandante
Monk. Queste commissioni, unitamente ad un’altra, posta agli ordini del
comandante Sack, oltre a svolgere la loro attività di controllo e accertamento dell’effettiva capacità delle forze militari francesi, erano controllate
da agenti speciali molti dei quali esperti conoscitori del Marocco, che dovevano preparare in modo dettagliato l’insediamento delle forze tedesche
di occupazione. Klaub, con l’aiuto del capitano di corvetta Gibbarth e del
tenente di vascello Rualt-Frappart, organizzò un servizio informativo molto efficace ed in grado di eludere il controllo da parte dei francesi.
Auer, grazie ai validi collaboratori e agli ingenti fondi a sua disposizione, studiò a fondo la realtà marocchina dal punto di vista politico ed economico, riuscendo nel novembre 1942 a crearsi un’estesa ed efficace rete
di rapporti con uomini che erano stati protagonisti della fortunata politica
tedesca prima del 1912.
La popolarità dei tedeschi, e del loro capo, il cui nome era spesso menzionato nel corso delle preghiere, era così grande che essi venivano qualificati con il titolo onorifico di Hājj, usato adesso per Hitler come alcuni
decenni prima per il Kaiser Guglielmo II56. L’ammirazione dei marocchini
per la forza e la disciplina di un popolo che aveva il grande merito, oltre
a quello di aver sconfitto la Francia, di non aver mai colonizzato popolazioni musulmane, e l’antipatia per gli ebrei furono elementi che permisero
alla propaganda nazista di svilupparsi in modo efficace, anche grazie alla
collaborazione di alcuni musulmani al servizio della diffusione radiofonica
di Berlino: il citato Yūnus al-Bahrī, «il grande tenore mondiale della propa416
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
ganda panislamica», ‘Abd ar-Rahmān Yāsīn, Hamad Turqui e alcuni vecchi
dirigenti della Stella Nordafricana, come Mustafā Radi, Rouzed Tajedjinne, Radjef Belqāsem e ‘Abd es-Salâm Bouker. Costoro, da Radio Berlino,
Radio Paris Mondiale e Radio Bari combatterono la loro guerra delle onde
in favore dell’Asse, anche dopo lo sbarco alleato in Nordafrica. Qui di seguito riportiamo alcuni testi tratti dal libro Nationalism marocaine ritenuti
da Taillard riassuntivi e paradigmatici dei temi favoriti dalla propaganda
dell’Asse all’inizio del 1943.
Il primo fu diffuso in lingua araba e cabila alle ore 13,30 del 28 gennaio:
Fratelli musulmani d’Algeria, Tunisia e Marocco, Giuda Giraud, che ha tradito il Maresciallo Pétain, vuole mobilitarvi in massa per mandarvi a farvi uccidere nei settori
pericolosi per risparmiare la vita dei soldati inglesi e americani.
Resistete in tutti i modi agli ordini di richiami collettivi.
Scegliete dei soldati forti, solidi ed abili, dislocateli negli eserciti dei traditori e degli
ebrei al fine di procurarvi delle armi e delle munizioni che vi serviranno un giorno per
cacciare i traditori e gli ebrei.
Allāh, soltanto, protegge la vostra impresa57.
Questo il testo diffuso in berbero alla stessa ora:
Fratelli musulmani d’Algeria, Tunisia e Marocco, amici miei, fate sapere intorno a voi,
nelle pianure e sulle montagne, che in seguito a un accordo concluso tra il Maresciallo
Pétain e il Cancelliere Hitler, coloro tra voi che sono stati costretti a prendere le armi
per conto degli anglo-sassoni e degli ebrei non saranno considerati prigionieri di guerra se cadranno nelle mani delle truppe dell’Asse. Essi saranno smobilitati sia in Tunisia
sia in Francia dove ritorneranno alla vita civile.
Algerini e marocchini, fratelli miei, comprendete bene il vantaggio che vi è offerto.
Che Dio vi assista!58
Alle 20,25 e alle 21 fu mandato in onda questo testo, prima in arabo e
poi in berbero:
La Gran Bretagna ha riempito il corpo musulmano di ferite e di pus. Con le sue usurpazioni e le sue ingiustizie, la Gran Bretagna ha obbligato i musulmani d’Arabia, delle
Indie e di tutto il vicino Oriente a rinunciare alle loro tradizioni e a ribellarsi contro
di lei. Gli arresti in massa operati dagli inglesi a Gerusalemme e nel vicino Oriente
suscitano la più esacerbata indignazione nel cuore di tutti i musulmani.
Musulmani, fratelli miei, voi non ignorate che gli inglesi hanno fucilato alcuni dei
417
Stefano Fabei
vostri fratelli a Gerusalemme nel 1937 ed issato sulla tomba del grande Santo di questa
regione la bandiera giudaica. Voi non ignorale allo stesso modo l’odio e il disprezzo con
i quali i vostri fratelli musulmani del vicino Oriente sono trattati. Questi martiri sono
diventati gli schiavi dei barbari ebrei i quali non lavorano che per il loro sterminio.
La Gran Bretagna ha ucciso e imprigionato più musulmani in un anno di quanti ne
nascono nello stesso periodo. È per questa ragione che io adesso esorto voi africani alla
rivolta contro questi barbari che hanno invaso il suolo della vostra Patria già provata
dai maneggi ebraici.
Gli inglesi e gli ebrei che voi disprezzate non sono che la stessa cosa. Combatteteli con
tutti i mezzi, sabotate tutte le loro imprese.
Hitler è sempre al vostro fianco per aiutarvi; di qui a poco vi saranno inviate delle armi
e dei mezzi di cui vi sarà data comunicazione più avanti, dal momento che la tecnica
della guerra moderna a bisogno di uomini guerrieri come voi ed il cui valore come
combattenti è stato parecchie volte apprezzata dai vostri nemici.
Ciascun africano ha il desiderio di compere un’azione segreta do sabotaggio e di fare
nuocere così agli invasori ebrei.
Io non penso che voi abbiate dimenticato la vostra vecchia parola d’ordine “combattere i giudei e gli empi fino alla vittoria totale”. Ripetendo queste parole voi avrete
più resistenza e zelo, perché l’esercito vittorioso non è mai stato altro che quello degli
Arabi. Essi sono sempre stati gli eterni vincitori. Combattete, combattere e ribellatevi
contro gli anglosassoni che coprono il corpo islamico di ferite e pus.
Il musulmano non rinuncia mai al combattimento, malgrado i deboli mezzi.
Noi conosciamo la vostra miseria, ma anche l’alto morale che vi anima. I vostri passi
sono sicuramente guidati dalla divinità. Allah è il solo vostro protettore e il vostro
maestro. Non accettate mai che gli ebrei siano i vostri padroni. Alla conferenza tenuta
a Casablanca dagli anglosassoni il solo obiettivo discusso è stato il vostro sterminio
totale. Gli anglosassoni lo hanno promesso agli ebrei59.
Questo, infine, il testo trasmesso in arabo e in berbero alle 13, 30 del
5 febbraio 1943:
Fratelli musulmani dell’Africa del Nord, per tentare di spezzare la vostra resistenza, gli
anglosassoni stanno forse decidendo di distribuirvi alcuni metri di tessuto e camicie
che vi hanno promesso da sì lungo tempo. Rifiutate ciò che gli ebrei e gli anglosassoni
stanno per offrirvi, perché ciò non rappresenta nemmeno la millesima parte di quello
che essi hanno rubato sul vostro territorio. Non accettate alcuna intesa con loro e continuate sempre a considerarli come i vostri più mortali nemici, poiché essi non hanno
che un obiettivo: consegnarvi agli ebrei e sterminarvi.
Ricordatevi le parole di Roosevelt che l’anno scorso, nel suo messaggio inviato agli
ebrei di Palestina. ha dichiarato: “La Palestina sarà dopo la guerra uno stato indipendente ebraico. I musulmani saranno sotto il controllo e agli ordini dei figli di
Abramo”.
418
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
Il presidente Roosevelt e Churchill non fanno la guerra che per imporre al mondo la
razza ebraica, odiata già molti secoli prima di Gesù Cristo.
Noi sappiamo quanto grande sarebbe disgrazia (sfortuna) se i barbari anglosassoni
vincessero la guerra, poiché non ignoriamo tutti i mali che si abbatterebbero su di voi,
sapendo che gli ebrei sono i vostri più crudeli nemici.
Musulmani, fratelli miei, resistete agli anglosassoni attendendo la vostra liberazione
dalle nostre truppe. Il Cancelliere Hitler non interromperà in nessun momento la
lotta, fino allo sterminio degli ebrei. Tutti i mali che si abbattono sul mondo d’oggi
sono dovuti agli ebrei.
La stella della liberazione brillerà ben presto nei cieli perché le armate dell’Asse sono
guidate dalla saggezza dell’azione divina.
Musulmani, fratelli miei, noi siamo al vostro fianco. Viva l’Islam! Abbasso gli ebrei!60
Questi i toni di una campagna che continuò ad inondare l’etere dalle
stazioni radio dell’Asse e che vide protagonisti, oltre ai sopra citati speaker,
anche Ahmed Belfareğ, mentre Ibrāhīm al-Wazzānī faceva tessere gli elogi
della Germania da cantastorie inviati nei mercati delle zone interne del
Marocco61.
Note al testo
1
Cfr. D. K. Fieldhouse, L’età dell’Imperialismo (1830-1914), Laterza, Bari, 1975, p. 316.
2
Cfr. S. Nava, Regime e problemi internazionali del Marocco, in «Oriente Moderno», XXI, 9,
settembre 1941, pp. 437-445.
3
Vedi a proposito A. Ayache, Le Maroc, bilan d’une colonisation, Hachette, Paris, 1956; R.
Bidwell, Morocco under colonial rule, French administration of tribal areas, Frank & Cass Company United, London, 1973.
4
Sulla figura di Mohammed Ibn ‘Abd el-Krīm vedi L. Gabrielli, Abd el Krim et les événements
du Rif 1924-1926, Editions Atlantides, Casablanca 1953.
5
Cfr. H. Cambon, L’Histoire du Maroc, Hachette, Paris 1952, pp. 178-183; J. P. Halstead,
Rebirth of a nation. The origins and rise of Moroccan nationalism 1912-1944, University Press,
Cambridge 1967, p. 161.
6
A. Cepollaro, Il problema della giustizia nel Marocco francese, in «Africa», 7, 1954, p. 203.
7
La Sharī’a è la legge islamica che il Corano impone al musulmano nella sua triplice qualità
di credente, di uomo e di cittadino. Interprete della rivelazione, detta al credente lo statuto
familiare, il diritto penale, il diritto pubblico, le relazioni con i non musulmani; regola infine
419
Stefano Fabei
la sua vita religiosa, politica e sociale, di cui si riserva di sorvegliare le svariate manifestazioni,
e di dirigere il complesso ritmo.
8
Qādī: magistrato che amministra la giustizia secondo il diritto islamico. Giudice unico nella sua
giurisdizione, dirime questioni di diritto civile e penale e la sua sentenza è inappellabile.
9
L’aricolo n. 1 del «Traité pour l’organisation du Potectorat Français dans l’Empire Cherifien
conclu à Fes le 30 Mars 1912» così recitava: «Il Governo della Repubblica francese e Sua Maestà il Sultano concordano nell’istituire in Marocco un nuovo regime che introdurrà riforme
amministrative, giudiziarie, scolastiche ed economiche, finanziarie e militari ove il Governo
francese riterrà utile sul territorio marocchino. Questo regime salvaguarderà la situazione religiosa, il rispetto e il prestigio tradizionale del Sultano, l’esercizio della religione musulmana e
delle istituzioni religiose...». (Hassan II, Le Defi, Albin Michel, Paris 1976, pp. 205-206).
10
E. Rossi, Il movimento nazionalista nel Marocco francese, in «Oriente Moderno», XIX, 1939,
p. 424.
11
Sui vari movimenti nazionalisti del Nordafrica vedi L.Duclos - J.Duvignaud, Les nationalismes maghrebines, Fondation National de Sciences Politiques, Paris 1965.
12
E. Rossi, Il movimento nazionalista cit., p. 422.
13
Ibidem, pp. 422-423.
14
Vedi a riguardo A. Zouggari, Islam et nationalisme au Maroc, École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris 1977; M.Chaoui, Islam et politique au Maroc, Seuil, Paris 1980 ;
S.Amin, Le Maghreb moderne, Berger-Levrault, Paris 1971.
15
Negli anni trenta e quaranta Shakīb Arslān continuò a svolgere la sua azione che lo portò spesso ad avvicinarsi all’Italia di Mussolini e alla Germania di Hitler Dal 1945 si ritirò dalla vita
politica, stabilendosi in Brasile, dove morì quasi dimenticato. Su di lui vedi: J. Bessis, Chékib
Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb, in «Revue Historique», aprile-giugno 1978,
pp. 467-489; W. Cleveland., Islam against the West. Shakib Arslan and the campaign for islamic
nationalism, London 1985; R. Rezette, Les partis politiques marocains, Colin, Paris 1955.
16
Vedi a proposito D.Ashford, Political change in Morocco, University Press, Princeton 1961.
17
Cfr. J. Bessis, Chékib Arslan et les mouvements nationalistes cit., p. 480
18
Ibidem, p. 481. Il primo congresso dell’associazione s’era tenuto a Tunisi nel 1930, il secondo
ad Algeri nel 1932.
19
Sull’argomento vedi: S. Fabei, Un ponte verso l’Oriente, in «Studi Piacentini», 32, 2002.
20
Cfr. E.Rossi, Il movimento nazionalista cit., pp. 417-420.
21
La rivista era diretta da Robert-Jean Longuet, figlio del deputato Jean Longuet, e si avvaleva
della collaborazione del deputato socialista Pierre Renaudel e di altri uomini politici francesi
e spagnoli.
22
Cfr. S. Bernard, Maroc 1943-1956, Hachette, Paris 1962, p. 43.
23
I firmatari erano diversi tra loro per origine e formazione: ‘Abd el-’Azīz ibn Idrīs era un uomo di cultura prettamente araba, al contrario di ‘Omar ibn ‘Abd el-Gelīl, figlio di un’antica
famiglia di Fès, di formazione europea; Mohammed ed-Dīwrī era un ricco mercante, il grande
finanziatore del partito; ‘Allāl el-Fāsī era un fervente musulmano di sentimenti marcatamente
anti-occidentali; Abū Bakr el-Qādirī era un famoso libraio di cultura araba; Mohammed alMakkī en-Nāsirī proveniva da una ricca e conosciuta famiglia di intellettuali di Rabat; Mohammed Ghāzī, originario di Fès, era il teorico del partito.
24
Sui disordini vedi «L’Afrique française», 8, 1936, pp. 528-546.
420
La marcia del Marocco verso l’indipendenza
25
Nato nel 1907 da una famiglia di dotti a Fès,’Allāl el-Fāsī, dopo aver studiato all’università
religiosa della moschea el-Qarawiyyīn, si era avvicinato al movimento della Salafiyyah che auspicava una specie di ritorno alla pratica delle prime generazioni musulmane. Nel 1928 si era
messo in luce arringando i musulmani nella moschea Idrīs a Fez durante una manifestazione
di protesta contro la decisione delle autorità del protettorato di dare ad agricoltori francesi
l’acqua della città, nel 1930 prendendo posizione contro il decreto berbero. Dopo la prigionia
e il confino a Tāzah e in Francia, tornato a Fès, aveva ripreso la sua attività di propaganda con
prediche e lezioni molto seguite ed apprezzate nelle moschee e creato il Comitato d’Azione
Nazionale, un’associazione segreta la cui esistenza fu rivelata solo nel 1934.
26
Mohammed ibn el-Hasan al-Wazzānī aveva studiato in scuole francesi e assimilato idee politiche occidentali segnalandosi con articoli pubblicati sulle riviste «Maghreb», edita a Parigi,
e «al-Maghrib al-gadīd» di Tetuán. Sulla prima aveva tradotto in arabo un libro di H. Laoust
sul movimento della Salafiyyah; sulla seconda aveva denunciato l’azione del Protettorato e le
violazioni del Trattato franco-marocchino del 1912. Tra il 1934 e il 1936 fu al fianco di ‘Allāl
el-Fāsī.
27
Riuniti i suoi seguaci nel Partito del Movimento Popolare al-Wazzānī diffuse le sue idee tramite
«L’Action du Peuple» e il giornale in arabo «ad-D’ifā’» («La Difesa») sui quali attaccò l’invadenza francese nell’amministrazione del Paese, l’eccessiva quantità di funzionari francesi che gravavano in modo considerevole sul bilancio del Marocco. Appoggiatosi inizialmente al Partito
socialista francese ne criticò in seguito i dirigenti, accusati di non mantenere le promesse fatte
dell’amnistia, dell’abolizione delle leggi e dei decreti eccezionali vincolanti la libertà di stampa
e d’associazione. Questi i principi su cui si basava il programma del Movimento Popolare:
l’Islām, l’Arabismo, il Marocco, il Trono e la Consultazione (ovvero un governo costituzionale
(Cfr. E.Rossi, Il movimento nazionalista cit., pp. 430-431).
28
J. Bessis, Chékib Arslan et les mouvements nationalistes cit., p. 484.
29
Cfr. R. Le Tourneau, Evolution politique de l’Afrique du Nord musulmane, Armand Colin,
Paris 1962, pp. 175-179.
30
Sul Gran Mufti di Gerusalemme vedi S. Fabei, Una vita per la Palestina, Mursia, Milano
2003.
31
F. Taillard, Le nationalisme marocaine, Seuil, Paris 1947, p 145.
32
Vedi a proposito S. Nava, Regime e problemi internazionali del Marocco cit, p. 443, e sempre in
«Oriente Moderno», XXI, 9, settembre 1941, le notizie di cui alle pp. 199, 202, 307-308.
33
A.Hitler, Mein Kampf, Monfalcone 1977, p. 317.
34
H. Michel, La guerre en Méditerranée 1939-1945, Atti del Colloque International di Parigi,
8-11 aprile 1969, C.N.R.S., Paris 1971, p. 777.
35
Vedi a proposito S. Fabei, Il fascio, la svastica e la mezzaluna, Mursia, Milano 2002.
36
S. Fabei, La politica maghrebina del Terzo Reich, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parma 1988
37
Su questa relativa tolleranza dei tedeschi vedi W.Warlimont, Cinq ans au G.Q.G. de Hitler,
Elsevier-Sequoia, Paris – Bruxelles 1975, p. 79.
38
Cfr. H. Michel, La seconde guerre mondiale, PUF, Paris 1968, vol. I, p. 156. Vedi pure R.
Aron, Histoire de Vichy, I, Fayard, Paris 1954, p. 102.
39
Cfr. E. Wiskeman, L’Axe Rome-Berlin, Payot, Paris 1950, p. 254.
40
R. Mosca, L’Europa verso la catastrofe: 184 colloqui di Mussolini, Franco, Chamberlain, ecc.,
accordi segreti, corrispondenza diplomatica, raccolti da Galeazzo Ciano (1936-1942), I, Milano
1966, pp. 99-106.
421
Stefano Fabei
41
La vérité sur les rapports germano-soviétiques de 1939 à 1941, Editions France-Empire, Paris,
1948, pp. 155-156.
42
Ibidem, pp. 81-82.
43
Cfr. F.-C.Roux, 5 mois tragiques aux Affaires Etrangères, 21 mai – 1 er novembre 1940, Plon,
Paris 1954, p. 49.
44
Cfr. La seconde guerre mondiale, I, PUF, Paris, 1968, p. 196.
45
Cfr. Abdelmajid Benjelloum, El sueño de la libertad, in «Historia 16», 203, marzo 1993,
pp. 15-17.
46
Ivi.
47
Cfr. P. Pillole, Services spéciaux, Robert Laffont, Paris 1978, p. 342.
48
Cfr. Mohammed el Khatib, L’estate 1940 a Tétuan, in «el-Alam», 22 gennaio 1969.
49
Abdelmajid Benjelloum, El sueño de la libertad cit., p. 19.
50
«Berliner Borsen Zeitung », 29 maggio 1941.
51
Cfr. Auswärtiges Amt, Bonn, Archivio dell’ambasciata di Germania a Madrid, J.N., 959/41,
473/2.
52
S. Fabei, La politica maghrebina del Terzo Reich cit., pp. 33-34.
53
Ibidem, p. 35.
54
Ivi.
55
Ivi.
56
Hâjj: è il termine arabo, significante «pellegrinaggio», con cui si indica la visita alla Kahba che
il musulmano deve compiere almeno una volta nella propria vita, qualora ne abbia la possibilità. Del titolo di Hâjj, nel senso di «pellegrino», può fregiarsi il musulmano che ha adempiuto
a tale dovere religioso.
57
F. Taillard, Le nationalisme marocaine cit., p 147.
58
Ibidem, pp. 147-148.
59
Ibidem, pp. 148-149.
60
Ibidem, pp. 149-150.
61
Su Ibrāhīm al-Wazzānī e la sua attività in questo periodo vedi: W. B. Cline, Nationalism in
Morocco, in «The Middle East Journal», I, Washington 1947, p. 25.
422
Non c’erano «giovani turchi»
nelle forze armate fasciste1
di Giorgio Rochat
Il 20-21 settembre 2007 ho partecipato a un convegno a Metz organizzato dal professore François Cochet sul tema De Gaulle et les «Jeunes
Turcs» dans les armées occidentales 1930-1945: Une génération de la réflexion
à l’action. Il pretesto, se così si può dire, era che De Gaulle aveva pubblicato il più noto dei suoi scritti, Vers l’Armée de métier, nel 1934 quando era
tenente colonnello in servizio a Metz. Da qui partiva lo studio dei «giovani
turchi», un termine diffuso oltralpe per indicare i giovani ufficiali che tra le
due guerre mondiali, in particolare negli anni trenta, misero in discussione
la cultura dominante della guerra, ancora ferma alle trincee della prima
guerra mondiale. Studiosi noti come B. H. Liddel Hart e J. F. C. Fuller per
la Gran Bretagna, H. Guderian per la Germania, Ch. De Gaulle appunto
per la Francia e altri meno conosciuti divennero i sostenitori di un nuovo
modo di fare la guerra con formazioni motocorazzate (carri armati e automezzi) e l’appoggio diretto dell’aviazione, in sostanza anticipando la guerra
combattuta dal 1940 al 1945.
Mi era stato chiesto di parlare dei «giovani turchi» italiani degli anni trenta, gli studiosi capaci di cogliere in anticipo le caratteristiche della guerra moderna. Non ne ho trovati. Giulio Douhet, il «profeta» della
guerra aerea come strumento decisivo dei conflitti, il solo teorico militare
italiano conosciuto in tutto il mondo (forse più che da noi), appartiene
infatti alla generazione precedente, muore nel 1930.
Il testo che segue è la mia comunicazione al convegno di Metz, nei cui
atti sarà pubblicata. Con qualche modifica secondaria, per i lettori italiani
non è necessario ricordare chi fossero Cadorna e Diaz
Prologo. Il vivace dibattito del dopoguerra sulla riorganizzazione
dell’esercito2
La primavera 1919 vede lo sviluppo di un infuocato dibattito politico
423
Giorgio Rochat
sulla guerra appena conclusa, che raggiunge i toni più alti con l’abolizione
della censura sulla stampa il 1° luglio e poi la pubblicazione dell’inchiesta
sulla disfatta di Caporetto. I socialisti, non pochi cattolici e liberali moderati, molti reduci dalle trincee denunciano drammaticamente le scelte
del governo e soprattutto la gestione della guerra di Cadorna, le grandi
offensive, i massacri di soldati, gli eccessi di una disciplina già molto dura
(oltre mille fucilati). Nel settembre il presidente del consiglio F. S. Nitti
chiude il dibattito con l’esonero di alcuni generali e una larga amnistia ai
210.000 condannati dai tribunali militari. Negli anni seguenti si esauriscono le grandi polemiche sulla guerra, che man mano diventa sacra, non
sarà mai più discussa3.
Continua però un dibattito di grande vivacità e interesse sulla riorganizzazione dell’esercito. Ricordiamo le tre correnti principali, tutte patriottiche. Molti giovani ufficiali di complemento chiedono la fine dell’esercito
di caserma e la «nazione armata» della tradizione democratica, ferme brevi
per tutti e slancio patriottico, con un piccolo nucleo di ufficiali di carriera
di alta professonalità. Altri giovani colonnelli propongono l’esercito «lancia
e scudo», un piccolo esercito di pace pronto, bene addestrato, con quadri
efficienti e armi moderne, da ampliare per la guerra con il reclutamento
di massa. Gli alti comandi, i «generali della vittoria», chiedono invece il
ritorno al 1914 con una limitata modernizzazione, sviluppo dell’artiglieria
e riduzione della cavalleria.
Non mancano i teorici rivoluzionari, giovani colonnelli convinti che
le nuove armi abbiano radicalmente cambiato la guerra. Sono soprattutto
sostenitori della nuova efficacia del binomio aereo e gas (Douhet non è
un isolato), altri credono nel ruolo decisivo dei carri armati. Quasi tutti
criticano aspramente i governi liberali del conflitto e del dopoguerra; e
chiedono la «nazione armata» o «organizzata», formule diverse per indicare la necessaria supremazia dei militari nella preparazione della prossima
guerra. Per fare un nome, nel 1922 il ten. col. N. Pentimalli, sostenitore
della «nazione organizzata», scrive:
Se nella infausta mattina del 4 agosto 1914 i tedeschi avessero avuto la possibilità oggi tutt’affatto reale - di lanciare su Parigi […] 400 aeroplani […] carichi ciascuno di
due tonnellate di bombe; o anche soltato 40 apparecchi portanti ciascuno due tonnellate di liquido generatore di gas velenosi, la Francia in pochi minuti avrebbe perduto,
insieme con la sua capitale, il suo cervello e il suo cuore, la guerra sarebbe finita nello
424
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
stesso giorno. Due milioni e mezzo di morti avrebbero risparmiato i dieci milioni di
morti della guerra quadriennale, i milioni di feriti e mutilati4.
Temi analoghi sono ripresi da altri ufficiali, con tutte le varianti possibili e evidenti esagerazioni. Costoro però non trovano appoggio negli ambienti militari e politici, che continuano a pensare che «dalla guerra delle
macchine è uscito vittorioso l’uomo».
Il primo governo Mussolini, 31 ottobre 1922, segna il successo dei
«generali della vittoria». Mussolini ha bisogno dell’appoggio dell’esercito,
quindi sceglie come ministro della Guerra il generale Diaz e per la Marina l’ammiraglio Thaon di Revel, le due più autorevoli figure del mondo
militare. Nasce un’alleanza lunga vent’anni, gli alti comandi sosterranno il
governo di Mussolini e poi il suo regime, in cambio di una piena autonomia nella gestione delle forze armate. E perciò l’esercito ritorna con poche
modifiche al modello 1914, con la ferma di 18 mesi e un numero di divisioni superiore alle disponibilità di bilancio, a scapito dei mezzi moderni e
dell’addestramento.
Limiti della cultura militare nel ventennio fascista
La cultura delle forze armate italiane nel regime fascista è stata studiata soprattutto da V. Ilari, F. Stefani, F. Botti e A. Sema5, poi anche da L.
Ceva, N. Labanca, M. Montanari e dal sottoscritto. In sintesi (sono studi
ancora da approfondire) possiamo dire che fino a metà degli anni trenta
questa cultura ha la stessa impostazione tradizionale di quella francese (la
Grande Guerra resta il riferimento essenziale), un buon livello per lo stato maggiore e l’artiglieria, inferiore per la fanteria6, poco interesse per le
innovazioni7. Le direttive ufficiali per l’impiego delle grandi unità sono di
buon livello, prevedono un’offensiva sulla base delle esperienze della prima
guerra mondiale, fanteria e cannoni. Il difetto principale dell’esercito rimane l’insufficienza dell’addestramento, con poche eccezioni.
All’interno del corpo ufficiali troviamo un altro elemento di debolezza.
La sovrabbondanza di giovani generali e ufficiali superiori nel 19198 provoca una crisi delle carriere. Gli ufficiali rimasti in servizio dopo discussi
e insufficienti provvedimenti di sfollamento (diedero le dimissioni anche
alcuni degli elementi migliori perché non avevano prospettive di carriera)
erano troppi, quindi le promozioni furono poche e lente fino al 1935, per
425
Giorgio Rochat
anzianità assai più che per merito. Anche per gli ufficiali più brillanti era
difficile emergere. Inoltre fino al 1925 la discussione sulle riviste militari
era libera, un tenente poteva polemizzare con un colonnello. E invece nel
1925 il gen. Cavallero9 si adegua al regime dittatoriale e sopprime la libertà
di stampa e di discussione: tutti gli scritti di ufficiali in materia tecnica
vengono sottoposti a una censura preventiva. Anche la diffusione della
stampa estera politica e militare è fortemente limitata. Poco dopo Balbo10
impone la stessa censura per gli ufficiali dell’aeronautica. Viene così fortemente ristretto il dibattito, gli ufficiali possono pubblicare soltanto ciò
che è accettato dagli alti comandi; viene premiato il conformismo a scapito
dello spirito di iniziativa e della vivacità culturale.
Per sottrarsi alla chiusura degli ambienti militari alcuni ufficiali cercarono uno spazio di affermazione negli ambienti fascisti. Fino al 1935
il regime aveva una politica di difesa tradizionale, ricercava la grandezza
e l’affermazione nazionale soprattutto con una moderna propaganda e la
spregiudicata politica estera di Mussolini11; anche lo sviluppo dell’inquadramento paramilitare della gioventù (dalla fine degli anni venti tutti gli
scolari, maschi e femmine, portano la camicia nera) e poi di notevole parte
della popolazione era volto al consolidamento della dittatura, non alla preparazione bellica. La «vocazione militare» del fascismo si esprimeva nella
milizia fascista12, un corpo nato per la difesa del regime con compiti interni
di polizia e controllo, nonché l’aspirazione a un ruolo militare in confusa
e velleitaria contrapposizione all’esercito13. Quindi gli ufficiali dell’esercito
che cercavano di emergere collaborando con il regime potevano soltanto
riprendere il tema tradizionale della superiorità delle forze morali e dell’uomo sul materiale, s’intende dell’uomo fascista e del suo spirito guerriero.
Insistevano perciò sull’importanza dell’addestramento militare della gioventù, da sviluppare in collaborazione con l’esercito nella prospettiva di
una guerra di masse di fanteria, senza molto interesse per le nuove armi,
né per una guerra diversa da quella del 1914. Un impegno poco gradito
dall’esercito che detestava la milizia.
Il quadro cambia dal 1935 con le vittorie dell’Italia fascista in Etiopia
e in Spagna, che la propaganda del regime esalta senza riserve. In realtà
queste vittorie hanno grossi limiti14, ma l’esercito e ancor più l’aeronautica
evitano di analizzarle criticamente e si fanno gloria dei successi di immagine. E invece dal 1935 siamo dinanzi a una crisi della preparazione militare,
le straordinarie spese per la conquista dell’impero d’Etiopia (e in minor
426
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
misura per l’intervento in Spagna) assorbono tutte le risorse disponibili15 e
bloccano la modernizzazione dell’esercito e dell’aeronautica, che entreranno in guerra nel 1940 con gli aerei, i carri armati e le artiglierie del 193516.
La crisi è coperta dalla propaganda, che garantisce la preparazione e la
modernità delle forze armate.
In questo quadro non c’era spazio per dei «giovani turchi», degli innovatori radicali, come andiamo a vedere con più particolari.
Douhet e il «douhettismo» dell’aeronautica
Non ci occupiamo in questa sede della dottrina di Douhet, ma del
suo ruolo nella cultura e nello sviluppo delle forze armate italiane. Nato
nel 1869, ufficiale d’artiglieria, poi di stato maggiore, già nel 1910-1911
Douhet era sostenitore del ruolo decisivo dell’aviazione e della sua necessaria autonomia. Nel 1912-1915 organizzò le prime unità aeree italiane; poi
il suo carattere aggressivo e l’intransigenza con cui sosteneva la superiorità
dell’arma aerea troncarono la sua carriera e l’obbligarono a lasciare il servizio attivo17. Nel 1921 Douhet pubblicò la sua opera più nota, Il dominio
dell’aria18, che presentava il bombardamento strategico come l’arma decisiva dei conflitti. Il grande successo internazionale della sua dottrina merita ancora di essere studiato. In Italia Douhet ebbe un successo parziale,
malgrado la sua vivace produzione su giornali e riviste, anche perché non
risparmiava critiche all’aeronautica italiana nata nel 1923. Poi nel 1927
Italo Balbo, dinamico ministro dell’Aeronautica, impegnato nella sua valorizzazione, aprì a Douhet le pagine della nuova «Rivista aeronautica»
permettendogli di sviluppare la sua intransigente battaglia per l’indipendenza dell’aviazione contro l’esercito e la marina con una serie di brillanti
articoli, a patto di non criticare lo sviluppo dell’aviazione italiana.
Ciò che interessa in questa sede è l’operazione politica condotta da
Balbo. Douhet fu proclamato profeta e teorico dell’aeronautica italiana;
il «douhettismo», la dottrina del bombardamento strategico come arma
risolutiva, divenne quella ufficiale dell’aviazione di Balbo (che non esitava
a parlare dell’impiego terroristico dei gas) e del suo successore Valle19, che
utilizzò l’iprite in Etiopia20. In questa guerra come in Spagna l’aviazione
italiana fu impiegata soprattutto in appoggio alle forze di terra, con notevole efficacia; ma gli alti comandi, invece di studiare e valorizzare queste esperienze di cooperazione, continuavano a ripetere che il vero ruolo
427
Giorgio Rochat
dell’aviazione era il bombardamento strategico da condurre in piena autonomia.
La realtà era ben altra, lo sviluppo dell’aeronautica italiana tra le due
guerre non è molto diverso da quello francese: gli aerei da bombardamento
non hanno la priorità su quelli da caccia e da ricognizione. Il ruolo privilegiato a livello di immagine spetta ai piloti da caccia, malgrado i grandi
successi delle crociere transatlantiche di Balbo. Il ruolo decisivo del bombardamento stategico in sostanza è un bluff, basti considerare le modeste
prestazioni degli apparecchi disponibili; vale soltanto a livello propagandistico, la nuova potenza dell’aviazione fascista, e nei rapporti interforze
il rifiuto di ogni collaborazione con l’esercito e la marina. È interessante
rilevare il successo di questa propaganda; come scrive F. Pernot, gli stati
maggiori francesi hanno tutte le informazioni necessarie per una valutazione realistica, ma continuano a sopravvalutare «le potentiel de l’aviation militaire italienne, comme si la politique d’intoxication qu’a pratiqué le Duce
en faisant se multiplier les vols spectaculaires avait réussi à convaincre les
Français que l’Italie était une grande puissance aérienne»21.
In questo quadro non c’era spazio per proporre alternative alla dottrina
ufficiale. L’autonomia dell’aviazione e il rifiuto di una cooperazione con le
forze di terra e di mare erano dogmi indiscussi per tutti gli aviatori. Mancava anche il tempo, non erano soltanto le crociere di Balbo e la ricerca di
primati eclatanti a impegnare l’aeronatica italiana, che negli anni prima
della guerra mondiale contava una media di 1.000 aerei in patria, 300 in
operazione in Etiopia e altri 300 in Spagna, con non più di 2.000 ufficiali
piloti di carriera22. I quali vivevano in un clima di esaltazione, si può forse
capire cle non avessero il tempo per discutere le vittorie in Etiopia e in
Spagna, né rendersi conto del crescente ritardo dell’industria nazionale,
che produceva troppi aerei di prestazioni insufficienti.
In un clima di conformismo e di entusiasmo, abbiamo un solo «giovane turco», così almeno lo presentano Ilari e Botti: il col. Amedeo Mecozzi
(nato nel 1892, pilota da caccia nella guerra mondiale, generale nel 1937),
prolifico autore di studi sul ruolo dell’aviazione, noto soprattutto per la sua
lunga battaglia per l’aviazione d’assalto23. Mecozzi critica la cieca fiducia
di Douhet nel bombardamento da alta quota, ne evidenzia l’incertezza dei
risultati e contrappone l’attacco a bassa quota delle forze nemiche e delle
retrovie. Il col. Botti così riassume la tesi di Mecozzi:
428
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
l’aviazione militare deve essere composta al 50% da aerei d’assalto, capaci di azioni di
bombardamento, ma non troppo diversi dagli aerei da caccia, apparecchi multiruolo
dalle caratteristiche ambiziose, in grado di condurre ricognizioni, di attaccare gli aerei
nemici sia in quota che rasoterra, anche di intervenire sul mare sia con le bombe che
con i siluri24.
Le proposte di Mecozzi sono interessanti, ma hanno due limiti di fondo. Mecozzi, come Douhet, è un convinto sostenitore dell’indipendenza
dell’aeronautica. L’aviazione d’assalto deve agire in piena autonomia e di
fatto assumere il ruolo strategico che Mecozzi nega agli aerei da bombardamento. Il che spiega perché Valle gli permettesse di criticare Douhet
(ricordiamo che un ufficiale dell’aviazione non poteva scrivere senza l’approvazione dei superiori), la battaglia di Mecozzi per l’aviazione d’assalto
non metteva in discussione il dogma del ruolo indipendente e decisivo
dell’aeronautica. In realtà il rifiuto di ogni cooperazione interforze, già
criticabile in Douhet, è insensato in Mecozzi: come si può pensare che
l’aviazione intervenga sul campo di battaglia senza un collegamento con le
forze di terra? Secondo, Mecozzi, ancora come Douhet, è un teorico che
non si preccupa dei problemi tecnici; nel decorso degli anni può proporre
diverse versioni dell’aereo d’assalto perché non tiene conto del modesto
livello dell’industria italiana, incapace di produrre un tipo moderno. Alla
vigilia della guerra mondiale il bombardiere in picchiata SM.85 fu un pieno fallimento, così come il bimotore d’assalto Ba.88. Nel 1940 l’aviazione
d’assalto italiana non disponeva di aerei adeguati, fu costretta a impiegare
gli aerei da caccia che non potevano più competere con gli inglesi; fino al
1942 continuò a utiizzare soprattutto il biplano CR.42, versione di poco
migliorata del caccia CR.32 già superato dopo il 1935, armato di due sole
mitragliatrici25.
L’esercito e la «guerra di rapido corso»
Ilari e gli altri autori già citati ricordano diversi ufficiali che tra il 1925
(chiusura dei vivaci dibattiti del dopoguerra) e il 1935 (entusiasmo per le
grandi vittorie fasciste) cercarono di superare il conformismo della cultura
dell’esercito. Nomi diversi, un alto generale come F. S. Grazioli, ufficiali
superiori come U. Guadagnini, R. Morretta, S. Visconti Prasca, E. Canevari e altri. Nessuno di costoro ha però la capacità di andare oltre una
429
Giorgio Rochat
severa e spesso acuta critica della dottrina ufficiale, né di sostenere il ruolo
decisivo delle nuove armi, carri e aerei, nè di condurre una vera battaglia
di rinnovamento.
Facciamo tre casi26. F. S. Grazioli, comandante di corpo d’armata nel
1918, generale di moderna cultura, fu l’unico tra gli esponenti dell’establishment a criticare apertamente la dottrina ufficiale ancora basata sulle esperienze della guerra di trincea. La sua richiesta di una guerra di movimento
si fermava però alle divisioni «celeri», introdotte nell’esercito nei primi anni trenta: due reggimenti di cavalleria e due di bersaglieri ciclisti con un
debole supporto di batterie di artiglieria a cavallo e pochi automezzi. Continuare a contare sui reggimenti di cavalleria non aveva senso, eppure le
divisioni «celeri» continuarono a far parte dell’esercito anche dopo il 1940,
con la motorizzazione dei bersaglieri; una fu inviata in Russia nel 1941.
Anche S. Visconti Prasca, più giovane, è un uomo dell’establishment,
addetto militare a Parigi, nel 1935 colonnello capo della piccola segreteria
di Badoglio. Nel 1934 pubblica il volume La guerra decisiva27, un’intelligente rivisitazione delle esperienze della prima guerra mondiale, con una
denuncia delle scelte conservatrici degli alti comandi e la riaffermazione del
ruolo delle forze morali. Un volume di buona cultura, nulla di veramente
nuovo. La sua brillante carriera porta nell’ottobre 1940 Visconti Prasca a
comandare le truppe in Albania e a appoggiare la decisione di Mussolini
di attaccare la Grecia nell’ottobre con la certezza di un facile successo. Il
disastroso fallimento dell’offensiva determina la fine della sua carriera.
Il maggiore E. Canevari era un brillante comandante di battaglione
coloniale in Libia. Nel 1929 Badoglio, che come nuovo governatore della
colonia si proponeva di combattere la corruzione diffusa, lo fece arrestare
con l’accusa di malversazione dei fondi del suo battaglione. Nel successivo
processo Canevari venne assolto, non pochi nemici di Badoglio vennero
a testimoniare a suo favore, una certa disinvoltura nella gestione dei fondi
era prassi corrente per i battaglioni coloniali. Canevari fu però costretto
a lasciare l’esercito e diventò il consigliere militare di Farinacci, il leader
dell’oltranzismo fascista, anche il più critico verso l’establishment militare.
Non fu Canevari a introdurre in Italia il pensiero di Clausewitz, come
scrivono Ilari e Botti, una bella svista. Il merito spetta a Nicola Marselli, il
maggiore studioso militare italiano della fine Ottocento. I volumi che Canevari dedica a Clausewitz sono una volgarizzazione della cultura tedesca,
non hanno particolari elementi di novità, salvo la consueta affermazione
430
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
dell’importanza delle forze morali28. Senza dimenticare che per l’esercito Canevari era un uomo screditato perché legato all’estremismo fascista.
Non merita credito il suo racconto di avere appoggiato nel 1933 le ambizioni di Balbo alla carica di capo di stato maggiore generale con un piano
di radicale ammodernamento dell’esercito29. Gli rimane il merito di avere
promosso la prima traduzione italiana del Vom Kriege, ma con una versione
così approssimativa che l’Ufficio storico dell’esercito ne dovette affidare la
revisione al gen. Bollati30. Che un personaggio di così discussa levatura (a
prescindere dalle sue successive vicende31) sia considerato da Ilari e altri
come il maggiore protagonista del dibattito culturale degli anni trenta vale
soprattutto a evidenziare il basso livello di questo dibattito.
In realtà la mancanza di «giovani turchi» nelle forze armate italiane
non è dovuta soltanto ai limiti accennati di cultura e dibattito, ma soprattutto alla «fuga in avanti» della dottrina ufficiale. Abbiamo già visto come
per l’aeronautica la dottrina «douhettiana» del bombardamento strategico
fosse accettata da tutti gli aviatori perché giustificava la loro esigenza di
autonomia. Quindi non poteva essere messa in discussione, anche se nelle guerre condotte in Etiopia e in Spagna l’aviazione era stata impiegata
soprattutto in appoggio alle forze di terra. A quali eccessi (a quale follia)
potesse arrivare la dottrina ufficiale è dimostrato dal piano di operazioni
messo a punto nella primavera 1939 dall’alto comando dell’Aeronautica
per una guerra a fianco della Germania. Un piano che prevedeva una straordinaria quantità di obiettivi: 58 basi aeree mediterranee da Gibilterra
alla Turchia da bombardare e neutralizzare nella prima settimana di guerra, poi l’estensione dell’offensiva aerea a 35 basi aeree francesi (di cui 10
nella regione parigina), infine 59 obiettivi francesi richiesti dall’esercito
(ponti, strade, ferrovie). E poi Parigi e addirittura Londra, che per ragioni
di prestigio non potevano essere lasciate all’aviazione tedesca32. Un delirio,
un libro dei sogni. Un clima in cui un ufficiale poteva soltanto lasciarsi
trasportare dall’entusiasmo, non certo riflettere e contestare.
Veniamo all’esercito. Fino al 1935 il suo sviluppo, come ordinamenti,
armamenti e dottrina, non è molto diverso da quello francese, su dimensioni inferiori. È iniziato un parziale rinnovamento dell’armamento della
fanteria, è stato introdotto il carro armato da 3 tonnellate. Poi l’aggressione all’Etiopia nel 1935 cambia le prospettive. L’ultima e più grande
guerra coloniale ha aspetti di grande modernità sul piano organizzativo:
mezzo milione di uomini inviati in Eritrea e Somalia in pochi mesi e mes431
Giorgio Rochat
si in grado di operare in regioni prive di risorse, con la motorizzazione
dei rifornimenti, una rete di aeroporti per 450 aerei creati in pochi mesi,
collegamenti radio efficienti, una cartografia del’Etiopia realizzata con la
fotogrammazione aerea, servizi metereologici e altro. Aspetti che però passano in secondo piano perché il regime, l’esercito, l’aviazione esaltano soprattutto le facili vittorie contro forze abissine inferiori sotto tutti gli aspetti, numero, organizzazione, armamenti. E poi dimenticano che la guerra
continua senza successi risolutivi contro la resistenza abissina che controlla
buona parte dell’impero fino al 194133. Dal 1935 al 1940 l’Italia fascista
vive in un clima di esaltazione guerriera senza limiti, con un aumento della
militarizzazione di facciata che non indietreggia dinanzi al ridicolo34.
Vale per l’esercito quanto abbiamo detto per l’aviazione: non c’è spazio
per «giovani turchi». Gli ufficiali vivono in un clima di entusiasmo sia
sincero sia obbligato, nelle guerre in Etiopia e in Spagna ritrovano prestigio, avventure e nuove possibilità di carriera. Chi ha dei dubbi non può
permettersi di esprimerli. Pesano la censura e la mancanza di informazioni
su quanto accade all’estero35. E invece trionfa la nuova dottrina ufficiale
dell’offensiva a oltranza, una «fuga in avanti».
Non è facile definirlo un «giovane turco», ma troviamo il più convinto
sostenitore della guerra di movimento proprio al vertice dell’esercito. Il
generale Alberto Pariani, nato nel 1876, una brillante carriera come uomo
dell’establishment (non è un fascista militante), sottocapo di stato maggiore dell’esercito nel 1934, dall’ottobre 1936 all’ottobre 1939 ha il pieno
controllo dell’esercito con la doppia carica di sottosegretario con funzioni
di ministro (ministro era Mussolini) e di capo di stato maggiore. Ha una
«missione impossibile», preparare un esercito moderno all’altezza delle ambizioni di Mussolini senza i fondi necessari36. Abbiamo già detto che le
straordinarie spese per la conquista e lo sviluppo dell’impero d’Etiopia (e
in parte minore per l’intervento in Spagna) provocano una diminuzione
degli stanziamenti per l’esercito, quindi la rinuncia alla produzione di nuovi carri armati, artiglierie e automezzi. Pariani crede nella guerra di movimento, ma le divisioni corazzate e motorizzate che costituisce sono prive
di mezzi moderni, hanno pochi automezzi e i carri L/3 da tre tonnellate
(soltanto alla fine del 1940 entrano in servizio gli scadenti carri M/11 da
undici tonnellate). Ciò non gli impedisce di lanciare la «guerra di rapido
corso», una guerra di movimento che conta sulle gambe e sull’aggressivo
spirito fascista dei soldati (su cui è lecito avere qualche dubbio)37. Una
432
Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste
guerra di fanterie appiedate, Pariani ci crede tanto che non esita a sconvolgere l’organizzazione dell’esercito. Le divisioni con tre reggimenti di fanteria e circa 15.000 uomini erano la regola negli eserciti degli anni trenta,
Pa