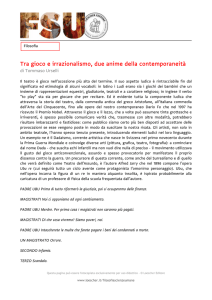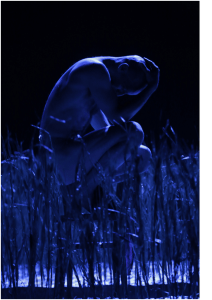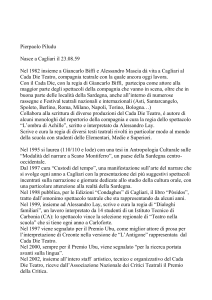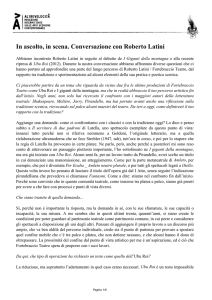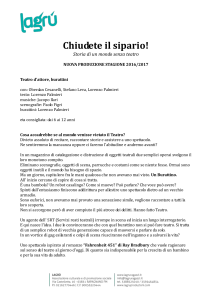fortebraccio teatro
UBU ROI
di Alfred Jarry
adattamento e regia
Roberto Latini
RASSEGNA STAMPA
www.universy.it
di Sam Krapp
29 marzo 2012
In scena Ubu Roi di Roberto Latini
Tra il genio e la follia dello spettacolo al Teatro India
Nel vedere “Ubu Roi” si capisce subito che per il regista Roberto Latini non è stato sufficiente
creare uno spettacolo con degli ottimi attori o con un ottimo testo, ciò che gli premeva era dare
un contribuito personale e decisamente originale a un’opera che ha segnato un capitolo
importante nella storia della drammaturgia.
Quello che si vede nello spettacolo è una reinterpretazione del testo di Jarry che, con un
linguaggio nuovo, spiega quello che il drammaturgo aveva intenzione di dire.
Ubu Roi è una delle più riuscite critiche alla sete di potere, scritto con una drammaturgia che
apre le porte a quello che successivamente prende il nome di teatro dell’assurdo; staccandosi
dalle canoniche righe della regia e della messinscena, Latini è riuscito a rendere con una
precisione quantomai rara il significato che Jarry avrebbe voluto dare all’opera.
Difficilmente a teatro si riesce a vedere un lavoro ugualmente ben fatto; spesso i registi hanno
come un timore: metterci troppo del proprio, significherebbe mancare di rispetto all’autore,
vanificare tutto l’impegno che ha riversato su quei fogli rischiando, però, di comunicare solo in
parte – o addirittura per niente – il suo messaggio; ma dove va a finire il processo comunicativo
che parte dall’autore e, attraverso il palcoscenico, arriva allo spettatore se la compagnia non sa
fare da tramite? In un paese dei balocchi per istrioni Latini introduce un singolare Pinocchio che
cita Shakespeare e Carmelo Bene, li mette in ridicolo, deride l’intero teatro in tutta la sua storia
proprio come Jarry deride il potere. Eccolo il tramite.
Se le parole di Jarry possono avere un significato diverso e più recondito, allora forse anche ciò
che viene visto deve essere interpretato diversamente: se lo scettro del re è una metafora,
allora non è poi così sbagliato rappresentarlo con un megafono.
In questa rappresentazione dell’Ubu Roi non si può fare a meno di notare che nulla è stato
lasciato al caso; il testo, per quanto sovvertito, è stato studiato con uno scrupolo quasi
maniacale.
Per rendere tutto ciò, però, non è sufficiente un ottimo regista quale è stato Latini ma è
necessario l’aiuto di un eccezionale cast che sia in grado di tenere un ritmo spinto sempre oltre i
limiti di velocità, che sia disposto a essere folle e a sudare (anche letteralmente parlando).
Non è facile essere originali e sicuramente non lo è quando si decide di non utilizzare mezzi
costosi o scenari sofisticati, tuttavia è nella scelta di semplicità che spesso nasce il genio (come
diceva Braque: troppo colore uguale nessun colore) ed è per questo che ritengo geniale lo
spettacolo andato in scena al teatro India; non c’è da meravigliarsi che non è da tutti i giorni
vedere un teatro simile, purtroppo – o per fortuna – spettacoli così capitano solo in pochi
fortunati momenti.
www.teatrionline.it
“Ubu Roi”, fantasia al potere
di Marco Togna
La guerra è un enorme telo rosso che copre l’intero spazio scenico (una scatola interamente bianca):
un mare in movimento, onde colorate che rievocano una mattanza, e lì in mezzo marionette urlanti e
gridi di battaglia. Ma anche la guerra finisce, e nel lento ritrarsi del drappo scarlatto – scomparendo
d’un lato, come nella vasta risacca di uno tsunami – ecco affiorare uno scheletro annerito, rimasto lì
sotto a indicare l’assurdità e la morte. La capacità di fare immagini di Roberto Latini e della
compagnia Fortebraccio Teatro (attiva da più di un decennio) è continua e sorprendente, e si
conferma anche stavolta. Lo spettacolo è “Ubu Roi”, il “classico” del teatro mondiale scritto dal
drammaturgo francese Alfred Jarry nel 1896, in scena al Teatro India di Roma fino a domenica
25 marzo.
Un’occasione per riflettere sugli archetipi del teatro, offrendo attrazioni e trovate, che Latini, forte del
personale talento registico e della qualità espressiva propria e dei sette attori che lo accompagnano,
sfrutta pienamente. Certo, il testo aiuta. Nel senso che è un’efficace allegoria del potere (la storia
ruota attorno al personaggio volgare e vuoto di Padre Ubu, alla sua violenta ascesa al trono e alla
successiva caduta), divisa in brevi scene: un testo aperto da ogni lato, a ogni interpretazione e
ricomposizione. Lo sguardo di Latini è altrettanto ingordo quanto è Padre Ubu: affida a un indifeso
Pinocchio incatenato, da lui stesso interpretato, il ruolo rigoroso di guida (di regista direttamente in
scena), tessitore e testimone del succedersi degli eventi, per lasciare il campo circostante preda di
una girandola di invenzioni, maschere (tutte uguali, inespressive, la cui energia è del tutto affidata
alla maestria attoriale), numeri circensi.
Latini ci offre un teatro dell’esasperazione, in cui tutto è sul limite della forzatura: l’estrema cura del
dettaglio (come i guanti rossi di Madre Ubu nella prima scena o le vere cornici che i personaggi di più
alto lignaggio tengono attorno al volto) e le citazioni macbethiane (ma anche di gruppi storici della
ricerca italiana come i Magazzini Criminali), l’esplorazione delle voci e l’ampio uso di amplificazioni,
l’uso del corpo come contenitore di emozioni, spinto nei suoi eccessi fisici e nella sua identità plurale.
Appaiono palloncini, piume, fiori finti, parrucche, ombrellini cinesi, scope su cui volare. E capita che a
farci prendere fiato, in questa corsa urlata e autodistruttiva che è il destino di Ubu, siano iper-reali
scenette d’amore, con una coppia di orsetti vestiti da adolescenti, alle prese con corteggiamenti e
batticuori da cartoon. Un’eruzione della fantasia, insomma, che l’attore-regista esplica pienamente,
ben sorretto dal gruppo degli attori e dalle luci evocative di Max Mugnai, le (intensissime) musiche e
tappeti sonori di Gianluca Misiti, la scenografia sospesa di Luca Baldini, i meravigliosi costumi (che
pescano da Kubrick al fetish) di Marion D’Amburgo.
www.ilsole24ore.com
01 aprile 2012
Avaro e Ubu orfani di tournée
di Antonio Audino
Misteri del teatro italiano: è capitato di vedere al Teatro India di Roma nelle scorse
settimane due spettacoli tra i più importanti di quest'ultima stagione, come l'Avaro di
Molière per la regia di Arturo Cirillo e l'Ubu Roi che Roberto Latini trae dall'opera di
Jarry, e di scoprire che, non avendo tournée, il loro esiguo giro di repliche finiva lì.
Misteri, in fondo, piuttosto chiari, visto che i motivi risiedono ancora una volta nella
malandata gestione dei grandi enti di produzione pubblica della scena nostrana. E
dire che in entrambi i casi si è registrato il tutto esaurito ovunque, con ovazioni e
apprezzamenti della critica. Certo, questo non è, a quanto pare, un dato significativo
per chi dovrebbe avere il compito di far girare queste creazioni artistiche, e, guarda
caso, si tratta di teatri stabili, quelli di Napoli e delle Marche per Cirillo, quello di
Prato per Latini. Si sa, dunque, che per queste imponenti strutture la logica è quella
degli scambi con altre istituzioni di pari rilevanza, e nel baratto entrano soprattutto le
regie dei direttori artistici. Per il resto, dare vita ad altre creazioni serve soltanto a
far vedere a chi ripartisce il Fondo Unico per lo spettacolo che si sono prodotte cose
belle e intelligenti, ma a che serve farle circolare? Tanto i costi sono coperti dal
denaro pubblico.
Ecco dunque andare in soffitta il meglio di questa annata, a partire da quella
sottilissima operazione che Cirillo mette in campo con un testo oramai ostico di
Molière, riservandosi la parte del vecchio tirchio e modulandola su una durezza tutta
interiore, su una radicale anaffettività, che a volte deflagra nelle impennate
improvvise e disarticolate del suo camminare. Intorno a lui si dispone un delicato
teatrino meccanico di figure che oggi ci sembrano umanamente distanti, ma che
funzionano perfettamente nel condurre la nevrosi del protagonista fino alle estreme
conseguenze e nel rivelarci la chiave farsesca, tutta italiana, del testo di Molière. Con
attori formidabili in continuo andirivieni tra le grigie cornici concentriche di Dario
Gessati e nel frusciare degli splendidi abiti di Gianluca Falaschi, tra citazione e
rilettura.
Altrettanto radicale e sorprendente quell'Ubu che Latini compone con infinita
ampiezza di immaginazione scenica, in un bianco allucinato, dove le vicende
dell'ambizioso personaggio che diviene sovrano e di sua moglie slittano su inattesi
accostamenti shakespeariani, magari suggeriti da un Pinocchio alla Carmelo Bene,
facendo scattare continui corto circuiti intellettuali. Si amplia così quella catena di
rovesciamenti di senso che il re e la moglie provocano, inconsapevoli non soltanto
della
loro
follia
autodistruttiva
ma
di
aver
messo
in
moto
il
definitivo
scompaginamento del teatro contemporaneo. Anche in questo caso attori formidabili
in un gioco serrato e acutissimo. Incuriositi? Nulla da fare. Questi due spettacoli
fanno già parte del passato della nostra scena.
09/02/2012
di Massimo Gonnelli
Ubu e Pinocchio incatenati al caleidoscopico mondo di Shakespeare
Roberto Latini firma una nuova lettura del testo precursore del surrealismo e del
teatro dell’assurdo
Il surrealismo patafisico di Ubu roi non trova limiti nella nuova messinscena di Roberto Latini,
prodotta da Teatro Metastasio Stabile della Toscana e Fortebraccio Teatro, presentata al Fabbricane di
Prato in prima nazionale e in replica fino all’11 febbraio.
Il testo cardine di Alfred Jarry, antesignano del movimento surrealista e del teatro dell’assurdo dei
vari Beckett, Genet e Ionesco, è una miscela di provocazioni grottesche, parodie e fitto umorismo.
La nuova lettura del regista/attore è densa inoltre di accentuate simmetrie shakespeariane: dai guanti
rosso sangue di Madre Ubu (“Lady Machbet”), a due orsi innamorati (“Romeo e Giulietta”), fino ai
naufraghi de “La Tempesta” e al fantasma del padre di “Amleto”. I parallelismi con il Bardo, nascono
da parole, battute, voci integranti, congiunte alla storia di Padre Ubu da catene lontane evocanti
Carmelo Bene e il suo Pinocchio.
Scena minimaliste negli oggetti quanto nei colori, dove il bianco la fa da padrone rendendo lo spazio
scenico incontaminato. Vecchie figure primordiali intente a pescare salcicce su di una piastra rovente,
fanno da preambolo alla battuta ancestrale: “Merdre!”, genitrice di Padre e Madre Ubu e della loro
proteiforme natura. Inizia così l’assurdo e immaginifico viaggio di Padre Ubu verso l’avidità e la brama
di potere, antinomia del “Candide” voltairiano alla ricerca del migliore dei mondi possibili, che lo vedrà
divenire «un re di stracci e di toppe, uno scherzo di re».
La pièce è ben scandita da cambi scena roboanti, figli di una “tradizione” contemporanea, coadiuvati
da un sottofondo sonoro brulicante di rumori e suoni, sapientemente creati da Gianluca Misiti, che
rendono viva e compiuta la scena.
Efficace la scelta delle maschere che danno respiro e ampliano lo spazio fantastico: teste di vecchio
dai tratti scimmieschi, un mix che richiama alla memoria frammenti di vecchi film hollywoodiani
(“2001: Odissea nello spazio” e “Il Pianeta delle scimmie”).
Buona la prova attoriale dell’intero cast guidato da Savino Paparella e Ciro Masella, rispettivamente
nei panni di Padre Ubu e Madre Ubu: goffi, vanagloriosi e labili al punto giusto, megafoni antitetici
modulano voce e anima agli estremi, dai toni gutturali di Padre Ubu ai falsetti esclamativi di Madre
Ubu.
Roberto Latini incarna un Pinocchio effimero come la follia che regna nell’intera opera, parente stretto
di Ubu, legato a lui da una catena, come un vecchio marinaio sfida la sorte, disseppellendo fantasmi
lontani e visioni coleridgiane.
Lo stesso Latini firma una regia puntuale, ineccepibile e vivace nel contenuto e nella forma, quadri
d’insieme e minuzie vengono curati all’estremo, fornendo una pulizia scenica invidiabile, dove si
percepisce la forza di una sperimentazione ancora possibile.
Ripetuti applausi di un pubblico entusiasta e divertito.
Lunga vita all'Ubu Re
22/02/2012
L'indimenticato personaggio di Alfred Jarry restituito alle scene dall'allestimento di Roberto Latini:
sbuca dal nulla e ci squaderna davanti un complesso gioco di scatole tutto teatrale, che va dai testi di
Shakespeare al Pinocchio rivisitato da Carmelo Bene. Ma è molto di più del solito rosario di citazioni...
di Igor Vazzaz
Merdra! Non si può iniziare altrimenti. La storpiatura escrementizia con cui ha inizio il testo del
giovane Jarry è sciente disarticolazione logico-sonora che rompe un silenzio atavico per lasciar dietro
sé il cadavere del linguaggio, un simulacro tumefatto e inerte. Arrivare a Ubu dal niente assoluto,
dal nitore di quella scatola vuota che è la scena: la prima visione offertaci da Roberto Latini
e Fortebraccio Teatro è muta, sospesa in una dimensione metafisica e inquietante. Un sole
(o un gong?) disegnato dalle luci sul fondale ed ecco l’ingresso silente di glabre maschere umanoidi,
figure vestite di tuniche bianche. Identiche, eppure diverse, incedono tra il monastico e lo scimmiesco
nella gelida rarefazione che cattura il pubblico, solcando lo spazio d’un altrove collocatosi prima, o
oltre, la Storia. La memoria scivola a certe sequenze kubrickiane, apparentando i primati dell’Odissea
spaziale a queste tacite presenze antropomorfe.
Non personaggi, sono potenze, incarnazioni teatrali di forza inusitata, quella della maschera.
Brandiscono legni con spaghi legati alle cime, simulano una pesca che è forse la concretizzazione della
cautela necessaria a qualsiasi teatrante che voglia avvicinare Ubu. Cimentarsi con la paradossale
creatura partorita dal genio adolescente di Jarry rappresenta una sfida, una follia, e solo
tornando al silenzio, nella sospensione d’ogni essenza, si può sperare d’entrare in contatto
col mistero del teatro. Ché Ubu è questo: anarchica detonazione carnevalesca, irriducibile
alla logica, antipodica al verosimile, allergica al conveniente. È follia decostruttoria, teppismo
guignolesco, voragine in grado di ricuperare autenticamente alla scena nientemeno che Shakespeare.
E questo Ubu roi comprende, e supera, quanto appena illustrato, nella pienezza d’una scrittura
scenica che è l’essenza stessa del teatro: non il rispetto ossequioso, onanistico del testo, non la
filologia necrotica dei pirandelli a inflazionare i cartelloni, ma la ricerca profonda, rischiosa dello spirito
d’una pièce, negli effetti di risonanza, amplificazione e potenza, ottenuti da accostamenti poetici, crasi
testuali, citazioni. È Teatro, è Gioco. E lo spettacolo assume una forma tripartita: c’è la
scatola bianca della sospensione (la pésca afasica), c’è la recita dell’Ubu vero e proprio,
violenta, grottesca, e c’è il convitato di pietra, quel burattino quasi contemporaneo alla
creatura jarriana che è Pinocchio, Latini stesso. La puntuale costruzione sonora chiosa e alterna
le fasi, accompagnata dal disegno luci: un suono e il palco muta, in scena il personaggio collodiano.
Tutto bene, vien da dire, anzi, bene Bene, ché il Pinocchio è tributo, per nulla fuor di luogo,
a quello, mitico, di Carmelo, catena al collo inclusa, nella pratica d’un teatro che della
gemmazione fa la propria arma in più. È Latini-Pinocchio-Bene a destarsi, come a sognar Ubu Roi, per
farsi poi attraversare da lacerti scespiriani (a memoria, ricordiamo d’aver ascoltato brani da Macbeth,
Amleto, Romeo e Giulietta, La tempesta), o è l’Ubu sospeso a immaginare Pinocchio?
Già il solo Ubu, nel senso della recita, sarebbe sufficiente: Ciro Masella è una Madre azzeccatissima e
baffuta, dal vociare squittente e sfrontato, Savino Paparella un Roi ventrale e pantagruelico, per non
dir della Regina Rosmunda nell’eloquio astratto del bravo Sebastian Barbalan. Tutti gli elementi, però,
funzionano a meraviglia, nei quadri visivi perfettamente allestiti, dominati da contrasti cromatici
efficaci, nella dimensione circense e ludica che mescola la commedia originale a languidi inserti in cui
due attori con maschera da orso (un lui e una lei) si scambiano effusivi segnali. Sarebbe sufficiente,
ma è nulla in confronto a ciò che resta di questo spettacolo magnifico, nella sapiente dilatazione delle
sequenze musicali, nella con-fusione feconda di citazioni che, si permetta il bisticcio, mai
puzzano di citazionismo. Ché un conto è riprendere à la mode de, strizzando ruffianamente
l’occhio allo spettatore pseudocolto, altra cosa è operare una costruzione teatrale
complessa, in cui ogni singolo elemento presenta l’attributo non solo della giustificazione,
ma dell’urgenza. E giustificata e urgente è l’amplificazione vocale del Pinocchio, ulteriore dettaglio
beniano, nell’uso creativo della tecnologia; giustificato e urgente è accostar Jarry, Shakespeare e
Collodi, non un mero vezzo intellettualistico a compiacere, consolare, rassicurare.
Tutto tiene e ci riporta a teatro e al Teatro, a quella profonda e spaventosa libertà
rappresentata da Ubu, che dalla caricatura insolente del professore di fisica Hébert,
attestato prototipo ubuesco, giunge nell’altrove immoto della scatola magica di Roberto
Latini, per uno spettacolo che, vivaddio, non potremo certo dimenticare.
http://gazzettadimodena.geloca.it/cronaca
03 marzo 2012
“Ubu Roi”, una prova riuscita per Roberto Latini e i suoi attori
di Andrea Marcheselli
MODENA
Insegna, Alfred Jarry, che imparare a ridere di noi stessi, delle nostre ambizioni, sarebbe l’unico
antidoto disponibile per quell’allucinazione volontaria che è la vita. Sarà anche per questo che la sua
opera più famosa, l’“Ubu Roi” divenuto ormai un classico del teatro contemporaneo, è in fondo un
grottesco intreccio di metafore e allegorie che, dietro una parvenza vagamente umoristica, costituisce
un reiterato invito a riflettere sull’esistenza allucinante che conduciamo, o, meglio ancora, siamo
indotti a condurre.
Roberto Latini, da tanto tempo assai prossimo ai giochi surreali della patafisica creatura dello scrittore
francese, si è pertanto esercitato su quella vera e propria palestra di congetture e azioni surreali che è
l’opera di quest’ultimo, interpolandola con citazioni da mondi paralleli o anche incongruenti, di cui non
sempre, in verità, è così immediato cogliere il significato ultimo. Se, ad esempio, nella vicenda di Ubu
che, spinto dall’ambizione della moglie, usurpa il trono di Polonia dopo averne ucciso il sovrano, per
poi finirne cacciato, Latini inserisce citazioni da “Pinocchio”, se ne possono intuire la comune matrice
marionettistica e la sostanza favolistica-moraleggiante; viceversa, la storia d’amore fra due orsi bruni
che si intercala fra una nefandezza ubuiana e l’altra ci è risultata un po’ misteriosa...
Ma nel complesso lo spettacolo, prodotto da Fortebraccio Teatro e dal Teatro Stabile della Toscana,
presentato da giovedì fino a questa sera al Teatro delle Passioni, ci è sembrato uno dei più
convincenti allestimenti del testo di Jarry di questi ultimi anni, anche perché ne restituisce il senso
fondamentale, “aggiornato”, potremmo dire, con una metalinguistica riflessione sulla natura del
linguaggio teatrale.
In scena sette attori, oltre a Latini, che si fanno beffe del teatro naturalistico, mentre vaghi accenni ai
drammi shakespeariani appaiono ad intermittenza, soprattutto al “Macbeth” che chiaramente ha
ispirato l’inqualificabile figura di Madre Ubu. Lo spettacolo si avvale delle scene di Gianluca Misiti ma
soprattutto dei costumi di Marion D’Amburgo, come di una serie di maschere sfacciatamente
inespressive che tuttavia finiscono per assumere incredibili e inattese sfumature.
Alla riuscita dello spettacolo contribuisce, peraltro, l’ottima prova di tutti gli attori, fra cui spiccano
Savino Paparella e Ciro Masella, eterocliti Padre e Madre Ubu
L’Ubu di Latini profuma di Shakespeare
di Lorenzo Galletti
09/02/2012
Nel 2005 Roberto Latini ha il suo primo incontro con Alfred Jarry. In quella occasione mette in
scena un Ubu incatenato facendo un uso importante della tecnologia motion capture: ogni movimento
dell’attore è ripetuto simultaneamente dal suo doppio (il personaggio) nel mondo virtuale proiettato
intorno a lui. Sei anni dopo Latini torna a misurarsi col padre della patafisica e con il suo più degno
esponente, invertendo decisamente la rotta. E lo fa con drastica coerenza: per realizzare il suo Ubu
roi il regista-attore pesca in fondo al dramma francese, dove alberga l’anima scura del simbolismo.
La storia è nota: Padre Ubu è un dignitario di Venceslao re di Polonia. Spinto dalla moglie, e grazie
all’aiuto del capitano Bordure, uccide il re e ne prende il posto; ma dalla strage della famiglia reale si
salva il quattordicenne principe Bugrelao. Re Ubu adotta fin da subito una politica autoritaria fondata
sul terrore, la cui vittima più illustre è Bordure. Questo, fuggito alle catene, mette la propria spada al
servizio dello zar Alessio e conduce quindi la guerra contro Ubu. Su un secondo fronte è Bugrelao a
guidare l’esercito del popolo polacco in rivolta contro il dittatore. Ubu e la moglie riusciranno a
sfuggire ai loro inseguitori imbarcandosi verso l’Europa occidentale. Al di là dei fatti narrati, il nodo
centrale del racconto di Jarry è la grettezza dei coniugi Ubu. Per loro anche il coraggio e la viltà non
sono che strumenti per un disegno più grande: la conquista del potere.
La scena realizzata da Luca Baldini è uno spazio bianco e asettico, qualcosa a metà tra il non-luogo
e il mondo del sogno. Allo stesso effetto concorrono le luci di Max Mugnai, fredde e siderali, e i suoni
di Gianluca Misiti, che creano un tappeto di inquietudine da paesaggio postatomico. La soluzione
può apparire essenziale e quasi scontata, ma si rivela decisamente funzionale allo statuto del
dramma: ogni scena costruita da Jarry è infatti un dipinto compiuto, autosufficiente pur nel suo
concorrere alla costruzione dell’impalcatura generale. Roberto Latini intuisce alla perfezione la
potenza di questi quadri e ne sfrutta l’indipendenza per farsi a sua volta autore, innestando brani di
testi di altra e diversa provenienza.
«Ordunque il Padre Ubu scosse la pera, sicché dagli Inglesi fu poi detto Shakespeare, e di lui, sotto
tale nome, restan molte belle tragedie scritte». Parole, queste, che Jarry pone in testa al suo
dramma, quasi a mo’ di dedica; parole che Roberto Latini fa proprie al punto da portare lo stesso
Shakespeare in scena. La potenza deflagrante dell’Ubu roi nella letteratura e nel teatro di stampo
borghese di fine Ottocento elevano Jarry al pari di Shakespeare, sommo poeta della commistione dei
generi e di un teatro libero da ogni stereotipo: che colpisce lo spettatore frontalmente, lo trascina
dentro il racconto, lo coinvolge.
Nell’Ubu roi di Latini, il portatore del messaggio shakespeariano è un burattino fortemente teatrale nel
senso appena descritto: è il Pinocchio di Carmelo Bene, di cui veste i panni lo stesso regista. Le sue
citazioni da Shakespeare (Giulio Cesare, Macbeth, Amleto, Giulietta e Romeo, La tempesta), recitate
con i toni spezzati del Pinocchio beniano, fungono da intermezzi alla rappresentazione. Non hanno
nessuna precisa funzione se non quella di creare un parallelo tra i due scrittori: sono ispirazioni
dettate al regista dall’andamento della storia principale. Con questo espediente Latini suggerisce al
suo pubblico almeno una chiave di lettura per uno spettacolo in verità assai ricco di spunti, su cui chi
guarda è costretto a riflettere. Il ruolo di Pinocchio non si esaurisce però a questo: egli vuole essere
percepito dal pubblico come lo spettatore esemplare. Lo specchietto che due delle onnipresenti figure
mascherate gli pongono davanti, gli ricorda che quello che vede in scena lo riguarda direttamente. E
riguarda parimenti tutti noi, che ci crediamo al sicuro, nascosti dal buio della sala, quando al sicuro,
invece, non siamo mai: non lo siamo da questo teatro, ma ancora meno dalla Storia che l’Ubu roi
racconta.
Come si intuisce, il simbolismo di Jarry viene disseminato da Latini lungo tutta la messinscena, che
egli contamina con i frutti delle maggiori avanguardie storiche che proprio dal simbolismo si
svilupparono. Del dadaismo recupera la pratica della giustapposizione del ready-made: non solo
Shakespeare o Bene incollati su Jarry, ma anche l’orientalismo accoppiato ai piccoli numeri dei clown.
Al surrealismo giunge per una via ancora più diretta, seguendo il suggerimento della patafisica come
«scienza delle soluzioni immaginarie». Questa, invenzione straordinaria dell’autore di Ubu, ha lo
scopo di spiegare le leggi che governano l’universo «supplementare» al nostro. Quell’universo da cui
sembrano provenire tutti i personaggi di questo Ubu roi, negativi o positivi, nessuno escluso. Si tratta
di un luogo governato dalle eccezioni piuttosto che dalle regole, nelle quali Jarry, parodiando non solo
i principi della fisica ma quelli della stessa metafisica, riconosce la realtà più autentica delle cose.
Volendo, vi si potrebbe quasi leggere un’anticipazione della legge di indeterminazione di Werner
Heisenberg.
Ci si diverte e si ride delle ridicole figure inventate da Jarry e ben replicate da tutti gli attori. Il Padre
Ubu di Savino Papparella è forse poco vigliacco, ma avido quanto serve a farne una figura
sprezzante. La Madre Ubu, incarnata da un divertentissimo Ciro Masella, è trascinante forse più del
marito, per la sua cupidigia inesauribile e per quel tocco di grottesco coraggio che la
contraddistinguono. Sebastian Barbalan colpisce soprattutto per la sua regina Rosmunda, così
ieratica anche al momento di morire di crepacuore. Convincenti Lorenzo Berti (Re Venceslao) e
Simone Perinelli (Principe Bugrelao) perfettamente impastati coi loro volti clowneschi che sembrano
usciti dalle fantasie di Glenn Brown. Decisamente surrealista il Bordure di Marco Jackson Vergani.
Ma nella bianca radura popolata dalle immagini oniriche dei protagonisti, i cui i colori adescano
continuamente lo spettatore a partecipare a una festa, sembra sparire il messaggio politico-sociale
che trapelava con forza dalle pagine di Jarry. Si ha talvolta l’impressione che la tensione estetica
soffochi l’importanza, primaria per l’autore del testo, dello specchio da mettere di fronte allo
spettatore. In verità l’appello civile alla salvaguardia delle libertà e il monito a dubitare delle
rivoluzioni solo apparenti sono affidati alle figure mascherate che abitano quasi ogni scena. Il loro
stanco ma inerme seguire le impronte del potere, il loro silenzio e la loro accondiscendenza sono
l’avvertimento più rumoroso: chi non è avversario, è complice.
doppiozero.com
12 aprile 2012
Shakespeare e la patafisica. L’Ubu re di Roberto Latini
di Andrea Pocosgnich
Bianca scatola con due timide aperture ai lati, scena simmetrica e svuotata, territorio algido della
mente, foglio bianco da riempire cominciando con una luna pastello, grande, sullo sfondo. In linea col
boccascena un oggetto lungo e nero, parallelepipedo minimale che ben presto rivela la sua funzione di
piastra da cottura disilludendo le aspettative taumaturgiche. Attorno alla piastra, accesa e collegata
alla corrente, si ritrova una comunità. Anche se in penombra i volti da subito rivelano fattezze difformi
da quelle umane, così come le conosciamo. A metà tra uomini e primati, questi esseri sembrano i
protagonisti di una distopia da Pianeta delle scimmie, una realtà altra e senza tempo. Ma non c’è
volontà mimetica alcuna, il mistero dura poco e la maschera mostra ben presto la sua natura
posticcia.
Come sempre accadrà in questo Ubu Roi, messo in scena da Roberto Latini in una coproduzione
Fortebraccio e Metastasio, l’alta speculazione si mescola con la più ironica demenzialità: le strane
creature di bianco vestite (sotto la cintola un sospensorio alla Arancia meccanica devia l’estetica
orientale) con delle specie di canne di bambù iniziano a far dondolare sulla piastra bollente salsicce
che non mangeranno mai. Il grasso sfrigola amplificato dal microfono che Latini porta in scena con sé,
feticcio tra i feticci, segno di una poetica che ha accompagnato l’artista per anni durante le sue
peregrinazioni solitarie.
Questo spettacolo racconta due mondi: quello di provenienza testuale e letterario dell’Ubu Roi scritto
nel 1896 da Alfred Jarry e il mondo del teatro secondo Roberto Latini, riverberando perciò una serie di
riferimenti (il termine citazione gli va a mio avviso stretto) cari al regista. Lo stesso personaggio che
Latini si ritaglia, in un eterno a parte, è la punta dell’iceberg di questo ragionamento. È un Pinocchio
con la catena al collo che immediatamente rimanda a Carmelo Bene, ma anche a quell’Ubu incatenato
che per Latini rappresentò un’importante tappa di alcuni anni fa. Osservatore e contraltare straziante
della vicenda, porta nell’universo patafisico dell’autore francese quel dolore di cui parallelamente si
alimenta l’altro percorso di Latini, quello che ancora una volta lo vede solo in scena - ma senza
microfono - nella rappresentazione della noosfera, ovvero la sfera della mente. C’è l’amato
Shakespeare, non solo il Macbeth che dell’Ubu Roi è il nucleo, ma anche Amleto, Giulio Cesare,
Romeo e Giulietta, La tempesta, quest’ultima torna pure con un cenno alla celebre versione di
Strehler grazie a l’utilizzo di un velo rosso che dalle quinte viene risucchiato via lasciando sul palco
solo uno scheletro nero.
Aldilà dei livelli di comprensione ai quali vuole puntare, lo spettacolo visto al Teatro India di Roma, è
prima di tutto un meccanismo teatrale a tratti infallibile per ritmo, connotazione visiva, ricerca sulla
recitazione - alimentata da decine di registri differenti - e sonorizzazione della scena, quest’ultima
affidata, come sempre accade nei lavori di Latini, alla funambolica costruzione musicale di Gianluca
Misiti. D’altronde il complesso tessuto di segni, che va necessariamente a comporre le ragioni e il
ripensamento di un percorso artistico, si scontra e si fonde con la scalata al potere di Padre Ubu, con
una scena viva e divertente - alimentata da attori e performer di altissimo livello - rappresentando
perciò proprio una di quelle soluzioni immaginarie che la Patafisica di Jarry avrebbe voluto.
Ubu Roi - Teatro India (Roma)
27 Marzo 2012
di Enrico Bernard
Tra sperimentazione e tradizione Roberto Latini ripropone una lettura del
capolavoro di Jarry che perde qualcosa sul piano del contenuto
ideologico, ma suggerisce un rapporto con la ricerca metateatrale della
drammaturgia italiana del '700 di Carlo Gozzi.
A differenza del mio antenato e omonimo Tristan
Bernard, non celeberrimo ma noto commediografo
francese di fine Ottocento, che alla prima parigina di
"Ubu Roi" nel 1896 al Teatro dell'Oeuvre si unì alle
proteste per quella "sgangherata e demenziale follia",
io - Enrico Bernard - più modestamente ma più
modernamente dichiaro il mio amore per Ubu. Ed
anche per lo spettacolo di Roberto Latini che non
esito a definire entusiasmante per la bravura sua
e del gruppo da lui diretto. Al punto che le due ore
visionarie, oniriche, spericolate e divertentissime
di un allestimento, semplice come può essere semplice
e al contempo complesso e ardito un circo equestre
che si ribalta in drammaturgia allo stato puro, riescono
persino a farmi dimenticare alcuni brani del testo di Alfred Jarry che Latini trasforma sinteticamente
in pantomime o salta a pié pari tra un salto mortale, una processione mascherata e un giro in
bicicletta.
Il piacere di questo gioco teatrale che rappresenta diversi piani, dal circo equestre al piano
nobile della drammaturgia (i polemici riferimenti shakespeariani espliciti nel testo sono giocati in
una specie di cartone animato che si umanizza solo in punto di morte, astratta sintesi simbolista), mi
prende talmente che non rimpiango, dunque, alcuni dettagli del testo che vanno a nascondersi, e
forse un po' si perdono, tra le pieghe di un rosso telo che avvolge l'ambaradam di salti mortali,
esibizioni da tragico clown e della danza di macabri scheletri, - fino alla nave che salpando dalla
Polonia naviga a vista davanti al castello shakespeariano di Elsinore, come un carrozzone di
commedianti dell'arte sul mare in tempesta della storia e della vita.
Nelle "Note di Regia" del programma di sala Roberto Latini è del resto chiaro sul "taglio" della sulla
lettura:
"Jarry ci restituisce alla “occasione teatro” superando addirittura la natura stessa del suo testo. Non
sono le parole, la struttura, la trama addirittura, la drammaturgia, ma lo spirito di libertà che
accompagna ogni scena. E' come se l'autore avesse voluto darci questa libertà creativa,
proporre Teatro e non letteratura".
Alfred Jarry viene così chiamato in ballo come testimone e complice, egli stesso, del proprio
“tradimento” (uso la parola nel senso buono di “rielaborazione”). Ciò facendo però, ovvero citando
l'autore sul banco dei testimoni a favore, Latini non tiene conto che, inversamente a quanto da lui
dichiarato, Jarry si espresse in una serie di interventi (ad esempio nell'articolo pubblicato sul "Mercure
de France", settembre 1896) parlando piuttosto della “inutilità del teatro a teatro”, e non della
letteratura teatrale, cioé del testo. Scrive Jarry:
"Vi sono due cose che bisognerebbe dare al pubblico, per fare in modo che non si senta troppo
lontano dall'opera teatrale: personaggi che pensino come lui e dei quali egli comprenda tutto,
riportando anche l'impressione di essere spiritoso perché sta ridendo a causa di battute spiritose. In
secondo luogo i soggetti e le peripezie DEBBONO ESSERE NATURALI (maiuscolo mio, ndr.), cioé
abituali, quotidiani, comuni".
Ciò detto Jarry mette all'indice "alcuni oggetti notoriamente orrendi e incomprensibili che ingombrano
la scena senza utilità, PRIMA DI TUTTO LA SCENOGRAFIA E GLI ATTORI (maiuscolo mio, ndr.)"
In questo brano Jarry pone una prima questione "letteraria", quella relativa al “naturalismo” che poi
diventa, nel processo di astrazione simbolista e surrealista, la “naturalità” dell'opera d'arte.
Il personaggio drammatico deve insomma poter esistere realmente, rappresentare l'immagine riflessa
dello spettatore comune (e pure un po' tonto): deve essere quindi credibile e rappresentare una
possibilità di immedesimazione (e catarsi).
Questo “realismo” snaturato in una sorta di soggettivismo avrà ovviamente delle conseguenze
letterarie e cinematografiche, oltre che teatrali (basti pensare a Brecht), nel '900. Zavattini e De Sica
- per altro citati da Latini per via del riferimento al viaggio sulla scopa che richiama il finale simbolista
di "Miracolo a Milano", che come si sa deriva da un romanzo dello stesso Zavattini, "Totò il buono" del
1932 - anticipano il simbolismo neorealista del Fellini de "La strada": come non vedere un filo
diretto tra le idee di Latini e queste opere fondamentali della nostra cultura teatrale,
letteraria e cinematografica?
Ma, come dicevo, Latini evoca la (presunta) volontà di Jarry di "proporre Teatro e non letteratura": se
non si tratta di un refuso, di un errore di stampa, si usa stranamente la lettera maiuscola solo per il
Teatro, come se il teatro non fosse esso stesso letteratura. E la letteratura fosse scarto inorganico,
per dirla con Padre Ubu: MERDRE! Ma il fatto è che invece Jarry afferma a chiare lettere l'esatto
contrario, cioé l'essenza letteraria del teatro:
"Deve SCRIVERE PER IL TEATRO (maiuscolo mio, ndr.), solo l'autore CHE PENSA (maiuscolo di Jarry,
ndr.) prima di tutto in forma drammatica: in seguito si può trarre un romanzo dal suo dramma, se si
vuole, perché si può raccontare un'azione; ma l'inverso non ha quasi mai una verità artistica; e se un
romanzo fosse drammatico, l'autore prima di tutto lo avrebbe concepito (e scritto) in forma di
dramma."
Quindi secondo Jarry (che ripete esattamente un
concetto espresso da Goldoni nelle "Memorie" a
proposito della “narratività” del testo teatrale) il
dramma contiene sempre, e lo presuppone, l'elemento
letterario (la parola scritta su cui insiste Jarry, cioé IL
TESTO!), mentre non sempre la letteratura è
drammatica. Al di là della disquisizione sul tema del
“testo” che il regista e drammaturgo Roberto Latini si
sente “libero” di tramutare in azione scenica, o con
essa sostituirlo, resta il fatto che di questa libertà
registica non c'è traccia in Jarry. Il quale, al contrario,
regola la messa in scena dell'opera secondo un vero e
proprio prontuario di drammaturgia, scenografia e
recitazione che segue il copione vero e proprio.
La libertà drammaturgica rivendicata da Latini a proposito del suo "Ubu Roi" produce poi
uno strano effetto: la letteratura (il testo scritto che tanto infastidisce i signori registi) che
si esilia dal teatro, rientra come i Sei personaggi di Pirandello dalla porta di servizio del
teatro stesso. Ritagliandosi un ruolo da Pinocchio astratto (ma pur sempre letterario, perché
Pinocchio è un personaggio letterario), recitante battute che più letterarie di così non si può (ad
esempio la dichiarazione amorosa che sa di letteratura andante o spicciola), per di più armato di
microfono e asta portamicrofono come un conferenziere (alla faccia dell'antiletteratura!), Roberto
Latini si muove - ed è bravissimo - proprio come un narratore che dipana i fili di una storia,
ci risiamo, letteraria.
Qualcosa non mi quadra e, andando a rileggere il testo, scopro alcune soluzioni e passaggi testuali
deviati sulle piste della pantomima, o più semplicemente compressi. In effetti in questa
"preparazione" del pasto regale del Padre Ubu manca qualche portata. Quale? Beh, il cuoco condisce
con poco peperoncino la parte sostanziale della presa di potere da parte di Ubu che, da piccolo
signorotto represso e frustato, ed anche un po' scemo, si trasforma in un dittatore pronto a scannare,
fucilare, sgozzare chiunque si opponga al suo regime fiscale molto particolare: le tasse si pagano a lui
tre volte e forse anche quattro. E circa i metodi di governo di Ubu nelle scene centrali dell'opera ne
apprendiamo di belle: provatevi a sovrapporre nell'immaginario Mario Monti e Silvio Berlusconi, per
avere un'idea di quanto sia prepotente, nel testo originale, l'attualità di Ubu!
Non che nella versione di Latini non vi siano accenni alla questione dei metodi di governo da parte di
Ubu Roi, si parla ad esempio delle tasse matrimoniali, ma la questione della vessazione fisica,
economica e morale del suo popolo è per così dire giocata sul piano delle girandole, dei salti-in-banco,
delle giravolte e capriole che fanno ridere, ma fanno perdere al capolavoro di Jarry quella pregnanza
filosofica, storica ed ideologica (e rivoluzionaria) che esso è capace di esprimere. Per questo Latini
sente l'esigenza di introdurre il suo tragico Pinocchio letterario a far da contraltare al
“tragicomico” Ubu teatrale.
Ma il fatto è che "Ubu Roi", nella sua tragicomica attualità, ha un preciso background filosofico ne
"L'unico" di Max Stirner - il filosofo posthegeliano antagonista di Marx. Stirner sostiene infatti il
diritto (fondato sulla "Filosofia del diritto" di Hegel) del piccolo borghese di impadronirsi della Sua
Proprietà (cioé di tutto quello che può) con la violenza. Nel momento in cui Ubu si trasforma in
dittatore, non fa che mettere in pratica l'assunto teorico di Stirner. E il passo da Ubu Roi a Hitler e
Mussolini è abbastanza breve, come insegna il film di Chaplin che idealmente mescola i tratti surreali
e comici di Ubu a quelli ben più tragici del Führer.
Mi sembra allora che la proposta di Roberto Latini voglia spostare l'attenzione e l'interesse dal
piano del contenuto (letterario) del testo al suo aspetto formale (teatrale), secondo una
visione che non può non farci venire in mente un'altra opera della drammaturgia italiana
del '700: "L'amore delle tre melarance" di Carlo Gozzi. A dir la verità simbolisti e surrealisti
russi si erano accorti fin dal primo '900 della modernità sperimentale del teatro di Gozzi: prova ne sia
la strabiliante opera musicata da Prokofiev. In Gozzi, infatti, l'elemento letterario e fiabesco (il
"Cunto" di Basile) si fonde con l'elemento teatrale formale, sperimentale e (ante literam)
avanguardistico del gioco delle maschere e dell'improvvisazione della Commedia all'italiana, cioé della
Commedia dell'arte.
E' per questo motivo che Jarry - conscio del suo background filosofico (Stirner) e drammaturgico
(Gozzi) ritiene, ai suoi tempi, in corso di archiviazione o superamento la pratica della
“sperimentazione”:
"Il compito dei teatri sperimentali non è esaurito - scrive il drammaturgo francese - ma, poiché
durano da qualche anno, la gente ha smesso di ritenerli pure follie e oggi sono teatri regolarmente
frequentati dalla élite. Tra qualche altro anno [...] ci si sarà avvicinati maggiormente alla verità in
arte, oppure se ne sarà scoperta un'altra, e questi teatri saranno, in ogni cattivo senso, regolari, a
meno che non si ricordino che la loro essenza non è l'essere, bensì il divenire".
Ora, la questione di cosa sia l'essenza del teatro sperimentale e cosa rappresenti il suo divenire, si
può risolvere semplicemente, anche se un po' alla buona, così: se il pubblico applaude e si diverte
siamo nel campo dell'Essere, se invece succede qualcosa di diverso e insolito, di inaspettato,
imprevisto e imprevedibile, in quello del Divenire.
L'eccellente spettacolo di Latini si pone e propone dunque come una sfida alla
drammaturgia che deve cercare - per dirla con le parole di Jarry - il suo divenire: la sua
polemica col tempo in cui viviamo.
www.persinsala.it
Rivista di Arte e Teatro
Crudeli visioni in candida sospensione
di Marco Di Nardo
26 marzo 2012
In uno spazio indistinto di suoni e rumori Roberto Latini costruisce
un’architettura di personaggi che travolge, coinvolge e spiazza lo
spettatore: al Teatro India di Roma l’opera di Alfred Jarry lascia senza fiato
Si parte dal silenzio, dalla lentezza, dal segreto di una congiura per poi
veder esplodere lo spettacolo in tutto il suo tripudio di suoni, costumi,
rumori e movimenti. L’ascesa al potere di Padre Ubu è un cammino nel
grottesco e nel paradossale; lo stesso Re al cui trono Ubu ambisce è una
sorta di buffone in grado solo di scherzare e ridere, accompagnato da un
figlio inadatto alla lotta e da una moglie nostalgicamente concentrata solo
sulle felicità passate. Nella lettura di Roberto Latini ogni personaggio si fa
caricatura di se stesso, eccessiva ed estrema, sfiorando le corde della
comicità e mettendo a nudo tutta la miseria di figure mosse solo dalla sete
di potere. Padre e Madre Ubu, triviali e ferini, sono i principali protagonisti
di questa privazione di senso messa in atto dal regista, attore in scena
nelle vesti di un ingombrante Pinocchio; impossibile non far andare più
volte il pensiero a Carmelo Bene, già impegnato nel 1963 in una
rivisitazione dell’Ubu Roi intitolata I Polacchi. Roberto Latini gioca con la
sua voce, la amplifica e la distorce attraverso l’uso di microfoni, mentre
con il suo corpo fa da contrappunto tragico alla scena, costantemente
alleggerita nella visione d’insieme dai costumi e dalle luci, a contrasto con
gli accadimenti e con il susseguirsi della storia. È una sorta di bolla atemporale quella in cui i personaggi si muovono, uno spazio vivo che
respira ed esiste, asettico e luminosissimo, foglio bianco su cui incidere
graffi di linee colorate; costumi estremi e paradossali, macchine sceniche,
teli, cornici, materassi e scope volanti, ma anche abiti talari bianchissimi e
lineari, maschere inespressive e biciclette in miniatura. L’Ubu Roi di
Roberto Latini si contraddistingue per il suo coraggio: il coraggio di osare,
costruendo su un testo mirabolante e contorto una partitura scenica, fisica
e vocale, ancora più complessa, ottenendo lo splendido risultato di elevare
a potenza la forza di una delle opere maggiori della storia del teatro. Da
vedere.
www.paneacqua.eu
La féerie patafisica di Roberto Latini
14 Febbraio 2012
di Silvia Mei e Lorenzo Gasbarri
Tutto è possibile su un foglio di carta, formato gigantografia, sul cui candore si stagliano papaline
figurine ton sur ton, come monaci tibetani in livrea bianca con lunghe canne di bambù, riuniti in uno
strano rituale che non prevede cerimonie del tè. Iconograficamente richiama le litografie e le icone
dell’artista dell’Alabama NALL, dove il tratto da grafic
novel, color ardesia su bianco puro, traccia mutanti figure
da meraviglioso neobarocco con gusto macabro fiammingo
alla Hieronymus Bosch.
Il teatro di Ubu Re (rimarcabile Savino Paparella) - una
statuina sadomaso black and white, in cilindro, maglia di
rete e pastrano di pelle sdrucito con attributi da satiro – è
per l’appunto uno spazio bianco, una scatola di carta che
aperta diventa un modellino scenico: due feritoie come
quinte quasi impercettibili, un telo rosso, seta-acrilico, che
schizza e cola come una macchia di sangue e cangia in mar
rosso - il campo di battaglia tra Polacchi e Russi.
Roberto Latini ha la capacità di rovesciare i segni con la disinvoltura di Max Ernst, costruisce set
onirici, per la dinamica delle associazioni, calate in una cornice fiabesca che rievoca il meraviglioso
medievale senza fatine salvatrici o aiutanti magici. Dal lucore abbacinante del vuoto viene a
emersione un disco solare quasi fosse il monolite di “2001 Odissea nello spazio”; un bastone diventa
una canna da pesca, l’esca è una salciccia e un tavolino da fumo su un tatami da pic-nic è invece,
blasfemo, una piastra ollare, per un barbecue tra strani conoscenti in un conclave appetitoso rotto da
canti del gallo, cinguettii edenici, sonorità da percussioni nipponiche (sono l’ambiente sonoro e gli
stacchetti musicali di Gianluca Misiti).
Rewind. Fall/Summer 2010-11. “Noosfera”, una produzione Fortebraccio Teatro, di e con Roberto
Latini: primo movimento “Lucignolo”, secondo movimento “Titanic”. In realtà due stanze di un
programma che, senza rievocazioni da centocinquantenario, parla dell’Italia - dalla parte di chi d’Italia
ne vorrebbe un’altra - recuperando Carlo Collodi (ma c’è anche, latente, ignoto, l’Edmondo De Amicis
di Oceano). È da qui che si presentificano, germogliando nell’effetto serra della produzione artistica,
gli elementi di questa nuova stagione di Roberto Latini. L’estetica fumettistica, fatta di sfondi bianchi
incasellati da lacune di buio, come scene en cloisonné tra stazioni della passione e stile nabis,
notomizza un’azione sfilacciata, un’impotenza, un’irrimediabile capacità di reazione – il megafono non
riesce a proiettare la voce perché non si ha più voce in capitolo - se non nel coatto spargimento di
una montagnola di sale grosso. É lo scenario indiziario di un osceno paese dei balocchi, di una
traversata per arrivarvi (“se il carro su cui salgono Lucignolo e Pinocchio fosse trainato da un cane,
questo si chiamerebbe Titanic”, spiega Latini), della contrazione di un morbo che inebetisce, sterilizza,
conduce allo sfinimento. Un paese delle meraviglie, un’isola che non c’è: ecco l’Italia che
impietosamente
declama
Lucignolo,
“un
paese
di
merda”.
Non c’era niente di più conseguente che il “Merdra” tuonato da Madre e Padre Ubu e lo scenario di
una Polonia di Polacchi cloni incapaci di fonare. Latini vi giunge poi alla luce della sua esplorazione
linguistica, una pirotecnia vocalica, nel 2007 di “Ubu incatenato”, ipertecnologico con avatar in video e
cablaggio a vista a mimare la follia sadica dell’autoincatenamento di Ubu. Di quelle catene rimane ora
un residuo, fetish, nel collare sadomaso di Pinocchio, figura che Roberto Latini conduce (non
interpreta) in scena come reperto beniano. È uno sguardo patemico, disincantato, un commento
raramente dotato di voce, ma che dà voce ai rumori di fondo della scena. In pinocchietti e anfibi rammemora maschere alla Gillot, e i Pierrot di Watteau– non teme di ustionarsi i piedini alla griglia
dell’ouverture e ricorda l’impiccagione della marionetta all’albero dei soldi nel modello di scheletro
annerito che porta a passeggio come un cagnolino, forse citazione colta di “Cleaning the Mirror”
dell’Abramavic.
Difficile non rintracciare echi lontani - nel japonisme di parte degli accessori, abiti e stili di
movimento, o nella scena “semplice” colorata da petali rossi e piume come fiocchi di neve dell’Hamletmaschine di Heiner Müller declinata dagli ex Magazzini Criminali (Lombardi-Tiezzi), dove il
teatro No incontra Shakespeare lungo gli interstizi di veneziane pensate come novelli screens alla
Gordon Craig. E Shakespeare per l’appunto zampilla, riaffiora
insepolto a partire dalle parole di Jarry, quasi con la forza di getto
di un geiser che si fa landscape: “Scrivo Jarry – annota Latini - e
penso si possa leggere Shakespeare. Abbiamo lavorato tenendo
questo continuo riferimento, tutti i parallelismi possibili”. È una
polluzione ininterrotta, da “Macbeth” - con una Lady (un
superlativo Ciro Masella per Madre Ubu) che fa il verso allo Smigol
de “Il Signore degli anelli” - al “Riccardo III”, fino a “Romeo e
Giulietta”, nel tableau vivant di regina Rosmunda (un metamorfico
e trasformista Sebastian Barbalan che è anche Zar Alessio in
versione kung fu) e Principe Bugrelao (Simone Perinelli). E ancora
“Giulio Cesare”, “La tempesta”, “Amleto”, quest’ultimo interpolato con un gioco irriverente di dinastie
di spettri del Re Venceslao (Lorenzo Berti). Tutto scorre fluido lungo un testo, quello di Jarry,
disponibile a innesti e a fuori cornice come la love story di due orsi bruni, troppo presi dal loro
corteggiamento per curarsi del resto.
Uno spazio di tragedia e fiaba insieme, quasi da “Sogno di mezza estate”, dove Capitan Bordure
(Marco Jackson Vergani), uno sciancato balbuziente in abiti da squadrista fascista, può volare dallo
Zar sulla scopa della Befana. E così pure Pinocchio ha diritto ad integrarsi in un teatro di marionette
quale quello di Jarry, che non ha più bisogno di un Mangiafuoco di turno.
**********************************************
Roberto Latini alle prese con il classico della modernità Ubu Roi è un successo della produzione
artistica del Teatro Metastasio di Prato. Uno spettacolo che è da consigliare allo spettatore che pur
sentendosi stanco dei teatri di tradizione, ancora è impaurito dall'astratta complessità del teatro
contemporaneo. Nell'accompagnare lo spettatore a familiarizzare con gli strumenti di questo teatro
assolve quasi ad una funzione pedagogica, eliminando lentamente la struttura del teatro di prosa
classico.
Lo spettatore più inesperto si ritrova catapultato nella contemporaneità a godere dei mezzi espressivi
che essa offre. Del resto, è Ubu Roi stesso un momento di passaggio della storia del teatro, così come
è stato interpretato e diretto da infinite produzioni e critici. Roberto Latini ha esalato le già forti
connessioni con Shakespeare, rendendole evidenti e quasi ridondanti in ogni loro passaggio, quasi a
sottolineare l'opera di collage del teatro di Alfred Jarry. Un'opera proseguita dal regista introducendo
un pinocchio incatenato, un giocoliere scappato dal teatro di Carmelo Bene e approdato con surreale
casualità sul palco, ad alimentare la natura clownesca dell'opera. Pinocchio è una figura da soluzione
immaginaria, che incarna l'essenza della patafisica, la filosofia frutto del genio di Alfred Jarry.
Ubu Roi è uno spettacolo costruito intorno all'attore, a cui sono asserviti gli altri elmenti scenici,
ridotti al bianco totale della scena e ad una illuminazione esclusivamente funzionale. E' una prova di
maestria attoriale vinta dai componenti della Fortebraccio Teatro, tra cui spicca Madre Ubu,
interpretata da Ciro Masella. Un personaggio su cui Roberto Latini ha concentrato particolare
attenzione e che assolve ad almeno due funzioni. E' una Lady Macbeth motore della storia e della
scena, che dal bianco iniziale diventa rossa, partendo dalle sue mani insanguinate per avidità
personale, fino a contaminare tutto il vestito e quindi il palco intero, nel sangue della guerra come
conseguenza globale.
Ed è un personaggio che permette a Roberto Latini di evitare di insistere più del necessario sulla
metafora politica di Ubu Roi, governante folle, che se nel passato a permesso a molti di contestare
anche le più feroci dittature, oggi finirebbe per essere una lettura interessante, ma non certo
innovativa. Ubu Roi di Roberto Latini è senza ogni dubbio uno spettacolo da consigliare, e da far
girare anche nei circuiti più ancorati alla tradizione.
Krapp's Last Post | Teatro tra le nuvole
La densa spirale shakespeariana dell’Ubu Re secondo Roberto Latini
14 Febbraio 2012
di Marco Menini
Passa attraverso Artaud, Carmelo Bene e Leo de Berardinis,
l’Ubu Re di Roberto Latini, andato in scena al Fabbricone di Prato
in prima nazionale, intrecciando, in una spirale ben equilibrata, il
testo di Alfred Jarry con squarci da Shakespeare (Macbeth,
Amleto, Giulio Cesare, La tempesta, Romeo e Giulietta) con una
regia che ben dosa tragedia e commedia, osceno e provocazione,
nell’intento di un’indagine sul dramma della condizione umana.
È uno studio attorno all’uomo, alla tragedia dell’essere e alla
responsabilità dell’essere attore, dove un Latini nei panni del
Pinocchio di Carmelo Bene, incatenato nel primo atto e libero e di
bianco vestito nel secondo, segue come testimone silenzioso, se
pur partecipe nella sua compassione, la tragedia che investe gli
avidi e sanguinari protagonisti dagli eccessivi comportamenti,
protagonisti dell’opera teatrale di Jarry.
Spettacolo denso e complesso, carico di riferimenti e omaggi, caratterizzato da “assunzioni di
responsabilità” - come spiega Latini nelle note di regia - di un modo di intendere il teatro
contemporaneo nella ricerca di sostanza più che di forma. E questa sembra essere una delle
tematiche più stringenti dell’attuale panorama italiano, dove risulta sempre più spesso essere la
seconda ad avere il sopravvento.
Ma è anche uno spettacolo dove risuona forte il timbro della poetica dell’attore e regista romano,
nell’uso della voce amplificata come fosse uno strumento, tra riferimenti a suoi lavori precedenti. Il
tutto all’interno della scena creata da Luca Baldini, algida, bianca, razionale, che sembra richiamare i
recenti lavori di Virgilio Sieni.
L’Ubu Re che ha debuttato a Prato si apre in un’atmosfera alla Stanley Kubrick di “2001: Odissea nello
spazio”, con i protagonisti di bianco vestiti che indossano una maschera da uomo/primate, intenti a
cuocere su una piastra würstel appesi a lunghe canne di bambù, a mo’ di canne da pesca. Poi si
aprono le danze e assistiamo allo svilupparsi delle efferate vicende che portano alla presa del potere
di Padre Ubu dopo l’uccisione del re Venceslao e tutto ciò che ne consegue.
Spesso la trama di Jarry viene interrotta per dare spazio a quadri evocati da testi di Shakespeare, ma
che altro non sono che uno studio, un’indagine sull’uomo, sulla tragedia, spinte centrifughe rispetto
all’azione scenica, solo apparentemente in distonia col percorso drammaturgico, ma che in sostanza
ben compensano un equilibrio di fondo in cui la regia di Latini mostra tutta la sua efficacia, ora che il
suo modo di fare teatro sembra giunto a una piena maturazione, in un ottimo equilibrio tra ironia e
tragicità.
Gli attori sono bravi, Ciro Masella è così a suo agio nei panni di Madre Ubu da risultare in certi
momenti addirittura troppo compiaciuto. Notevole anche la prova di Fabiana Gambanini.
Le evocative musiche di Gianluca Misiti, strutture portanti nell’architettura drammaturgica del
lavoro, sono anch’esse parole che divengono amplificazione emotiva della partitura gestuale degli
attori in scena.
Roberto Latini supera questo esame di maturità con talento e bravura, grazie anche al grande lavoro
di preparazione che emerge in molti particolari, creando un meccanismo che ruota quasi alla
perfezione.
Affiora un pensiero, nel fare teatro, - un atto di responsabilità - che fa di questo spettacolo un grande
lavoro nella sua complessità e forte struttura.
LA REPUBBLICA
21/03/2013
25 gennaio 2015
UBU ROI. Il Teatro dell'assurdo che assurdo non è.
di Enzo Radunanza
Anche nella stagione in corso, il Pubblico - Il Teatro di Casalecchio di Reno continua a proporre
una serie di spettacoli di qualità che, spaziando dalla prosa all’attualità, dal teatro-denuncia a quello
contemporaneo accontentano tante categorie di spettatori i quali rispondono con una partecipazione
costante ed interessata.
In scena, questa volta, UBU ROI, un’opera del 1896 di Alfred Jarry, nell’adattamento di Roberto
Latini, talentuoso attore e regista romano. Lo scorso dicembre, la sua interpretazione di Arlecchino
ne Il servitore di due padroni, gli è valsa il Premio UBU come miglior attore protagonista.
A dispetto dell’epoca in cui è stato scritto, UBU ROI è un testo straordinariamente attuale per le
tematiche affrontate, che ha segnato un punto di svolta nel teatro contemporaneo mescolando
surrealismo, ironia, provocazione, sarcasmo e apparenti esagerazioni. Per tale genere sono stati usati
termini e definizioni come “patafisica” o scienza delle soluzioni immaginarie o “Teatro
dell’assurdo” per la capacità di mascherare la cruda realtà con la burla. Nel testo di Jarry, nato come
spettacolo per marionette, si ritrovano tanti vizi umani, le lotte di potere, i legami familiari torbidi e
conflittuali, con costanti riferimenti al Macbeth di Shakespeare.
Roberto Latini in questo lavoro ha mescolato teatro e danza, introducendo personaggi e movenze che,
a tratti, ricordano l’arte circense. Alterna, sapientemente, commedia e tragedia per i vizi dell’animo
umano, rimasti immutati nei secoli. Inserisce riferimenti (o meglio degli “omaggi”) a Shakespeare,
Artaud, Leo de Berardinis e verso la fine dello spettacolo, a Carmelo Bene. Tutti questi elementi si
fondono perfettamente e creano un intrattenimento piacevole e comprensibile; non banale,
affascinante e magnetico.
Il merito, oltre che della regia, è anche delle scene di Luca Baldini, del suggestivo gioco di luci di
Max Mugnai e delle musiche di Gianluca Misiti. Gli elementi scenici sono scarni ed essenziali per
privilegiare la sostanza sulla forma.
La sorpresa e la curiosità si accendono già dalla prima scena, in cui una luce calda ed accogliente
avvolge una scenografia rigorosamente candida. Un gruppo di attori vestiti con larghe tuniche
bianche, seduti a semicerchio, appaiono intenti a cuocere della carne appesa a lunghe canne di
bambù. Non parlano ma semplicemente emettono versi e gesticolano con eloquenza. Indossano
maschere da primati che riportano alla mente Il pianeta delle scimmie di Franklin J. Schaffner o
2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
La tranquillità è spezzata dall'irruzione dei personaggi principali, buffi, eccentrici, pesantemente
truccati e dai tratti caratteriali esagerati che li rendono più simpatici. Conosciamo, quindi, Padre Ubu,
ufficiale di fiducia di Re Venceslao, ex re d'Aragona e sua moglie Madre Ubu, avida e senza scrupoli,
definita dal marito un’arpia brutta e ubriacona. La donna sovrasta e domina la coppia fino a spingere
il marito ad assassinare il re Venceslao e tutti i nobili che lo sostengono. Ma questa sete di potere
sarà contrastata dal Principe di Bugrelao, figlio di Venceslao il quale, sostenuto dalla propria madre, fa
in modo di riconquistare il regno.
Ad assistere agli eventi come spettatore esterno è qusi sempre presente un Pinocchio, interpretato
dallo stesso Roberto Latini, che racconta e commenta con la sua voce a megafono, girando in sella
ad una bicicletta bianca. Inizialmente, Pinocchio ha al collo una lunga catena che lascia volteggiare
compulsivamente come se volesse liberarsi dalle convenzioni e da un senso di oppressione. Nel
secondo atto, lo ritroviamo vestito di bianco. La catena viene sostituita da uno scheletro che,
probabilmente, sottolinea, la sanguinosa mattanza operata dagli UBI.
Il primo atto appare più vivace, movimentato ed esilarante rispetto al secondo dove le contaminazioni
con diversi autori diventano più ingombranti e si respira un’atmosfera più triste e malinconica. Gli
attori rivelano una preparazione poliedrica che si esprime con la voce e con il corpo. Anche quando il
viso è mascherato o truccato fino a offuscare qualsiasi lineamento, le loro movenze “parlano”. Appare
felice anche la scelta di far interpretare da maschi anche le figure femminili.
Visto il 21/01/2015 a Casalecchio Di Reno (BO) Teatro: Pubblico
www.ilfattoquotidiano.it
03 febbraio 2015
‘Ubu roi': gridiamo al miracolo del grande gioco
di Tommaso Cimenti
Difficilmente ho assistito per due volte allo stesso spettacolo. E’ capitato con l’“Ubu roi” di Roberto
Latini visto al suo debutto qualche stagione fa, con la produzione del Teatro Metastasio di Prato, e
che adesso ha ripreso nuova vita, dopo il Premio Ubu al regista e il festival a Bogotà dove ha avuto
repliche affollatissime. Ci sono spettacoli felici e fortunati dove tutto si incastra alla perfezione. E’
questo il caso: intuizioni registiche, attori straordinari (su tutti una Madre Ubu-Ciro Masella Signora
in rosso, cinica e affamata di potere che ce la fa assomigliare alla filippina Imelda Marcos o la
rumena Elena Ceausescu), inserti pop, scene raffinate, scelte musicali azzeccate, costumi illuminati
(di Marion D’Amburgo), cura nei dettagli, ricercatezza stilistica e concettuale, grande maturità
artistica da parte degli interpreti principali, citazioni e follia sparse come zucchero a velo in un
caleidoscopio-calembour di espressioni e facce, di specchi e rimandi, di ritorni e incroci, per un respiro
teatrale che finalmente può essere liberato.
Per il dovere di cronaca facciamo un passo indietro con un doveroso riassunto schematico sulla
vicenda legata alla produzione della piece: una gestazione difficile prima, con il contratto firmato dal
precedente direttore del Met Federico Tiezzi, accordo che l’accoppiata dei direttori Massimo
Luconi- Paolo Magelli voleva in prima istanza far saltare. Successivamente effettivamente lo Stabile
della Toscana produsse l’“Ubu” di Latini ma i problemi continuarono a persistere per quanto
riguardava la distribuzione. Infine il Met ha lasciato lo spettacolo nelle mani della compagnia
Fortebraccio Teatro per poi “ricomprarlo” in occasione delle nuove messinscene pratesi. Intanto il
gruppo sta girando per i teatri per le nuove date con un fondale che non è quello originario, quello
che, si dice, dovrebbe essere lo stesso usato per un altro spettacolo in calendario al Fabbricone di
Prato.
Allora gridammo al miracolo, e lo facciamo oggi a distanza di un tempo (tre anni) che non ha scalfito
minimamente la freschezza dell’impianto. Al suo debutto scrissi che la parte che si era ritagliato Latini
era troppo invadente, lui che dentro il testo di Alfred Jarry prendeva le sembianze di Carmelo Bene
nel suo Pinocchio con catena al collo da Melampo, cosa che oggi non risulta così distorcente o
“infastidente” anzi rilancia, raccoglie, cuce, racchiude quadri e scene con quella lucida spensieratezza,
con quella lampadina della ragione che si accende e acceca e abbaglia destando sempre viva e vigile
l’attenzione, la curiosità vivace, la gioia infantile. Un grande gioco, un grande patto nasce e cresce (e
sfugge di mano, finalmente, meravigliosamente) sulla scena (mirabile quella architettata da Luca
Baldini) e tra la scena e la platea, di fiducia e condivisione in un percorso che non ha una strada
segnata ma ne ha infinite.
Teatrale, nel senso più alto del termine. Teatrale come eversivo, teatrale come geniale, teatrale come
non terreno, quindi vicino alle nuvole, teatrale come un imbarazzo dato dal non saperlo categorizzare,
teatrale come non imbrigliabile, teatrale come eccedente qualsiasi definizione, teatrale come stupore,
teatrale come senza chiedersi “che cosa significa”, teatrale come eccitante, teatrale come rendere
l’impossibile possibile e credere all’incredibile. Così la pesca miracolosa che apre la sarabanda di
scimmie (le maschere indossate potrebbero vagamente ricordare anche il regista Peter Brook)
gorgoglianti primordiali e gutturali, che sembrano uscite da “2001 Odissea nello spazio”, ma
abbigliate e agghindate come sacerdoti se non addirittura Papi nelle loro vesti candide, in questo post
atomico limbo catastrofico dove resiste soltanto un bianco stordente e straniante in un contesto da
azzeramento bucolico e ancestrale, porta, come in un flash back, al prima, all’autodistruzione della
nostra società, alla stupidità del Male, alla violenza barbara degli uomini sui propri simili, alla guerra
fredda, alla vendetta.
Pochi tocchi di rosso (come “La fanciulla” di Vermeer) bastano a raccontare dell’odio e del sangue
corso e versato inutilmente mentre tutto attorno è un gran Carnevale istrionico jodoreskiano sopra le
righe, eccessivo, esplosivo. Il Re nel suo trono-carriola, le scarpe leopardate, le conchiglie pubiche da
“Arancia meccanica”, i continui rimandi a Shakespeare, i pon pon, i palloncini, le pellicce, i
samurai nipponici, la scopa della Befana, le corazze da Pupi siciliani, il “tesssoro” dal “Signore degli
anelli”, i nasi da clown in una gigantesca girandola che però mantiene sempre teso il filo riconoscibile
del sotto testo: “il sangue chiama sangue” come ci conferma lo scheletro annerito bruciacchiato
(sembra uno dei duemila cadaveri trucidati e poi dati alle fiamme in Nigeria dai terroristi islamici di
Boko Haram) abbracciato nella danza macabra dal “narratore” Pinocchio. Il tutto ha un sapore
biblico ed epico, che va ben oltre l’attualità. “Occhio per occhio e il mondo diventa cieco”, Gandhi.
Castello Pasquini, Castiglioncello
03 febbraio 2015
“Ubu Roi” di e con Roberto Latini
Andato in scena al Teatro Pubblico di Casalecchio di Reno (Bo)
di Amelia Di Pietro
Uno sguardo limpido e penetrante che sa catturare
lo spettatore, intrecciare testi, storie, vita, arte.
Questo è il teatro che Roberto Latini ama mettere
in scena e questo ha fatto anche con lo spettacolo
Ubu Roi di Alfred Jarry, andato in scena al
Teatro Pubblico di Casalecchio di Reno (Bo). Il
testo di Jarry si presta perfettamente all’idea di
teatro che l’attore e regista ama mettere in scena.
Un teatro che si serve della finzione come
stratagemma per raccontare, estrapolandola dalla
dimensione spazio temporale, l’umanità con i suoi
giochi di potere, la bramosia di denaro e successo e
tutta la desolazione che ne consegue.
Latini ha inserito i personaggi in una scatola bianca,
dai contorni indistinti, entro la quale si muovono in
un ambiente evanescente in cui il tempo non esiste
e lo spazio è solo un’illusione. Il concetto di tempo
si disgrega anche per la capacità del regista di
trasportare un testo scritto nel 1896 fino ad oggi,
permettendo di coglierne l’estrema attualità e ricordando come alcuni meccanismi siano ciclici e si
ripetano all’infinito, proprio come una pena nel girone dell’Inferno.
E se i personaggi ideati da Jarry erano delle marionette, Latini, per testimoniare le loro gesta si serve
di un burattino, Pinocchio, in omaggio a Carmelo Bene. È lo stesso regista a interpretare questo
personaggio, facendolo diventare un testimone attivo delle atrocità che Padre Ubu compie per
ottenere la corona di re di Polonia e per accumulare sempre più denaro. E allora, quella catena al collo
che rende prigioniero il Pinocchio di Bene, qui prende vita: si contorce, si dimena perché chi la
indossa non vuole rassegnarsi a quanto i suoi occhi sono costretti a vedere e le sue orecchie ad
ascoltare. La catena sarà sciolta nella seconda parte dello spettacolo e lascerà il posto a uno scheletro
con cui il burattino inscenerà una macabra danza e che resterà sempre in scena a testimonianza,
insieme a un tessuto rosso che svolazza a terra, dei massacri causati dalla guerra, tra Ubu Roi e lo
Zar Alexis nello specifico, e in generale come portatrice di violenza e massacri.
Ma se il ricordo al grande Carmelo è evidente, altrettanto lo è la firma dello stesso Roberto Latini, del
suo modo di vedere e fare teatro. Infatti, anche in questo caso non manca il microfono, anch’esso
testimone, non silente, di ciò che accade. La voce risuona e tocca gli animi più sordi, desidera
esprimere ciò che ha dentro sperando che, come la pietra in uno stagno, risuoni e arrivi il più lontano
possibile. Attraverso il microfono, il regista si serve delle parole di Shakespeare, mediante un collage
di citazioni (Macbeth, Giulio Cesare, Romeo e Giulietta, La Tempesta) asservite al contesto e che,
proprio per questo, non ammiccano allo spettatore più sapiente ma fanno parte di un discorso molto
più ampio.
Questo è uno spettacolo dai molteplici strati visivi e interpretativi. C’è la storia di Padre Ubu, deciso
ad ogni costo a conquistare il trono di Polonia e arricchirsi a dismisura, raccontata in modo esilarante,
con attori bravissimi in grado di mescolare provocazione, parodia, farsa, umorismo crasso e sbracato.
Ma in questo teatro dell’assurdo s’insinua la voce di Pinocchio/Latini che, con il suo microfono,
verifica, testimonia ed evidenzia ciò che accade. C’è poi la musica di Gianluca Misiti che, insieme
alla bellissima costruzione delle luci di Max Mugnai, rende possibile il continuo passaggio ai diversi
livelli di recitazione in modo agile e disinvolto. C’è infine, il concetto di sospensione che aleggia per
l’intero spettacolo, percettibile già col candore della messa in scena, ma evidenziato anche da tutti gli
altri personaggi, non protagonisti, che indossano delle maschere da primati e una tunica bianca,
divenendo anonimi, senza nessun tipo d’identità, vittime inconsapevoli e incoscienti dei soprusi subiti
da Padre Ubu.
Una costruzione perfetta, quella realizzata da Roberto Latini, capace di catturare lo spettatore fino
all’ultimo minuto, di dare freschezza e nuova vita ai grandi classici del teatro, con la consapevolezza
di dover necessariamente attingere da essi, ma con la volontà di creare poi qualcosa di diverso, di
speciale, di unico.
04 febbraio 2016
In morte di Ubu: quel grido sepolto dal dolore della farsa. Jarry
secondo Latini
di Giulio Sonno
E se Padre Ubu fosse morto? Morto davvero, morto per
sempre – cosa ne sarebbe di noi?
Che Roberto Latini sia un artista è un fatto evidente a
chiunque abbia assistito con onesto abbandono ai suoi
spettacoli, ma c'è qualcosa che lo contraddistingue dai suoi
colleghi teatranti e ne fa un artista puro: Latini non guarda
troppo al tempo in cui è immerso, né si fa mettere in scacco
dalla cultura codificata; Latini crea con la lungimiranza
di un saggio e l'innocenza di un bambino; Latini gioca
un gioco senza mai dimenticare di star giocando – e non
per questo lo fa con minore serietà.
Ma allora cosa significa domandarsi cosa ne sarebbe di noi se Padre Ubu fosse morto? Significa
domandarsi come vivremmo senza quella crudele innocenza chiamata umanità. E con il suo Ubu
Roi, Latini sembrerebbe celebrarne appunto l'impossibile funerale. Impossibile perché – purtroppo
o per fortuna – nulla muore mai davvero per sempre.
«Guardate, mi si sgancia la gogna e mi si sfilano le manette dalle mani. Finirà che mi troverò libero,
senza ornamenti, senza scorta, senza onori, e costretto a provvedere da me a tutte le mie necessità!»
[Ubu incatenato, Atto IV, 4]
Nato sui banchi di scuola del collegio di Rennes, dove circolavano storie buffonesche attorno al
malcapitato professore di fisica Hébert, l’Ubu Re è una farsa per burattini composta nel 1888-89 da
un quindicenne Alfred Jarry. Con gli anni questo personaggio buffo e grottesco, sanguigno e
maldestro, conoscerà diverse variazioni che troveranno, infine, la loro forma più matura e
filosoficamente satirica nell’Ubu incatenato del 1899 (“filosofica” perché sviluppa, a suo modo, la
celeberrima dialettica hegeliana padrone-servo), divenendo il padre putativo di tutti i patafisicidadaisti novecenteschi (si pensi a quel capolavoro di ironia antibellica che sono Le avventure del
buon soldato Sc'vèik di Hašek).
Ora, pur non avendo la complessità compositiva di un Sogno di Strindberg, l’Ubu Re è a suo modo
altrettanto irrappresentabile, perché – a meno che si ricorra ai pupi o tutto si riduca a una
goliardata amatoriale – trasferita sul corpo di attori in carne e ossa quella sua comicità
grandguignolesca diventa immediatamente drammatica. Proprio come se, invece di un cartone
animato, Peter Griffin (che, a ben guardare, è l’erede contemporaneo più brillante e compiuto di
Padre Ubu) fosse realisticamente un americano obeso ritardato che insulta ebrei, donne e disabili:
l'effetto sarebbe inquietante. Dunque, come viene tradotto sulla scena della compagnia
Fortebraccio Teatro il testo di Jarry?
Latini parrebbe intuire che ancor prima di essere un'icona o un personaggio teatralmente ricchissimo,
Padre Ubu e l'intero Ubu Re racchiudono il concentrato di una farsa molto più grande: quella
della storia. Ma qui si tocca un tasto assai scomodo per la nostra ipocrisia democratica. Già,
perché oggi come ieri la storia è segnata dall'abuso dei potenti sui più deboli: e non è certo la
morte di centinaia o migliaia di persone a trasformare questo orribile farsa viril-egotistica in una
faccenda meno ridicola e imbarazzante. Ecco, Latini accetta la farsa, accetta che portarla in
scena solleverà tante risate quante pugnalate alla bella innocenza democratica; egli accetta la
potenza e l'impotenza, ed elabora questa dinamica della tragedia ridicola sviluppandola su più
livelli (con una sensibilità e una qualità che molto spesso ricorda il Totò, principe di Danimarca di Leo
de Berardinis).
Se l’Ubu Re, infatti, è una rivisitazione umoristica del Macbeth di Shakespeare (un ufficiale che
aizzato dalla moglie assassina il suo re, gli ruba la corona, ma poi perde il senso della misura e
diventa un tiranno pazzo), Latini inserisce nella propria messa in scena un elemento apparentemente
del tutto estraneo. Interpretato da egli stesso, si tratta di un pinocchiesco deunculus ex machina
(un po’ à la Bene, un po’ à la Fellini, un po’ à la Castellucci) che con la sua catena al collo agisce da
alter ego di Padre Ubu: presagendone da un lato la prossima rovina, evocandone dall'altro
l'evoluzione drammaturgica in Ubu incatenato; al tempo stesso quest'essere amplifica, altresì, la
dimensione più culturalmente teatrale di Ubu quale personaggio chiave del passaggio alla
"modernità" novecentesca (dunque a tutti gli orrori del secolo scorso). Non solo per questo, però,
il suo spettro bianco reciterà di tanto in tanto con aria dimessa stralci di opere shakespeariane.
Immaginate un freak (Francesco Pennacchia) che vuole conquistare la corona dell'imperatore degli
stracci. Immaginate ora che la corona sia un megafono con cui poter strillare ancora più forte la
propria voce; ma immaginate anche che una volta divenuto re questo povero diavolo non sappia
assolutamente cosa mai dire (o fare) di “regale” e cominci a sparare idiozie – uccidendo –, ancor
peggio del suo spodestato predecessore (perché il potere è un morbo che rende tutti ridicoli).
Immaginate poi che a spingerlo e a manovrarlo sia una moglie avida (un Ciro Masella
magistralmente – e misuratamente – istrionico, protagonsita indiscusso della farsa), moralmente
ancora più discutibile, e che tutto sia il frutto di un miserevole vuoto. Immaginate allora che
scoppi la guerra. E che i due, alla fine, perdano tutto per ritrovarsi più miseri di prima.
Ebbene, ora provate a immaginare che uno spettro fatto di dramma puro infesti questa
carnevalata, che con la sua vivacità mortifera si inserisca tra una scena e l'altra pronunciando
monologhi fra i più gravi e toccanti della produzione shakespeariana costringendoci a ripensare
inavvertitamente che tutta questa buffonata potrebbe essere più seria e verosimile e vicina di
quanto pensiamo. Immaginate, infine, che la storia, la nostra storia, sia un larghissimo lenzuolo
rosso che sotto la finzione della scena – oltre i cicli e ricicli, oltre quella sparire e riapparire dei soliti
noti – ci sveli che sotto a tutto giace uno scheletro (capitale la costruzione scene-luci-suono di
Baldini-Mugnai-Misiti).
Ecco, ora chiedetevi chi sia quello scheletro. Pensate a cosa è morto e non è più rinato tra un
bagno di sangue e l'altro. Chiedetevi se quello scheletro fosse Padre Ubu, o la vostra innocenza, la
vostra umanità, la vostra fantasia; se il teatro fosse quel cadavere, se lì si nascondesse
l'incapacità di guardare all'arte (cioè di vivere l’inspiegabile) senza il rifugio sicuro di un
compiacimento intellettual-elitario (o qualunque sia il conformismo in cui ciascuno si rifugia). Chi è
quel morto? Ha forse ragione Maurizio Cattelan quando afferma che «nessun artista sta dicendo o
facendo qualcosa di più forte di quello che sta accadendo nel mondo»? C'è qualcosa che ci sta
sfuggendo negli ultimi anni? «Che cosa si è da noi scancellato? Quale semplice formula, che
numero, che cifra, che parto rifiutato ha fatto di noi solo un nome e un cognome?» [come scriveva
Mariangela Gualtieri nel 2004 per Paesaggio con fratello rotto del Teatro Valdoca] Quand'è che ci
siamo destituiti dal vivere, per inseguire una baracconata che sta spingendo, ultimamente,
così tanti a morire?
«Sono pronto ad accettare il comando, invaderemo le prigioni e sopprimeremo la libertà. / Urrà!
Ubbidiamo! In prigione!» [Ubu incatenato, Atto V, 1]
Forse allora non c'è da sorprendersi troppo che l'Ubu Roi di Fortebraccio Teatro (2011) abbia girato
finora così poco. Forse qualcosa è rimasto inascoltato, quel grido sensibile e discreto che Latini
sprigiona tra un silenzio e l'altro non è stato intercettato, e ora risuona ancora più duro. Ma certo è
che in barba a ogni logica stantia di produzione questo spettacolo dovrebbe (ri)cominciare a girare di
teatro in teatro, di città in città, in Italia e all’estero: i direttori artistici hanno pur una
responsabilità culturale. Che poi piacerà o meno è indifferente, ma è necessario vedere Latini
stringere a sé, sotto il sangue, quello scheletro secco e bruciato – per poi domandarci: “Chi è quel
morto? È l'artista? O sono io? O forse io ne sono il mandante?”
Perché, attraverso le parole di Prospero, una risposta in fondo ci arriva:
«Non c’è altro rimedio che il dolore del cuore e, in avvenire, una vita onesta.
Credimi
Credimi
Credimi
E tienimi.»
Letture consigliate:
• Arrostimi, ma di teatro saziami: l’Ubu Roi di Roberto Latini, di Renzo Francabandera (PAC)
• Shakespeare e la patafisica, di Andrea Pocosgnich (DoppioZero)
• Ubu Roi secondo Roberto Latini, di Carlotta Tringali (Il Tamburo di Kattrin)
• La densa spirale shakespeariana dell’Ubu Re secondo Roberto Latini, di Marco Menini (Krapp's Last
Post)
Crediti:
di Alfred Jarry
adattamento e regia Roberto Latini
musiche e suoni Gianluca Misiti
scena Luca Baldini
costumi Marion D’Amburgo
luci Max Mugnai
con Roberto Latini
e con
Francesco Pennacchia, padre Ubu
Ciro Masella, madre Ubu
Sebastian Barbalan, regina Rosmunda/ zar Alessio
Marco Jackson Vergani, capitano Bordure/ Orso
Lorenzo Berti, re Venceslao/ Spettro/ Nobili
Guido Feruglio, principe Bugrelao
Fabiana Gabanini, palotini/ Orsa/ Messaggero
direzione tecnica Max Mugnai
collaborazione tecnica Nino Del Principe
assistente alla regia Tiziano Panici
cura della produzione Federica Furlanis
promozione e comunicazione Nicole Arbelli
foto Simone Cecchetti
produzione
Fortebraccio Teatro
un progetto realizzato in collaborazione con
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
06 febbraio 2016
Ubu Roi o l’occasione del teatro. Al Vascello di Roma la pièce di
Latini
di Alessandro Morino
ROBERTO LATINI RIPORTA AL TEATRO VASCELLO DI ROMA, FINO AL 7 FEBBRAIO 2016, IL
SUO SPETTACOLO DI SUCCESSO UBU ROI, RIADATTAMENTO DEL LAVORO DI ALFRED
JARRY CHE CAMBIÒ LA STORIA DEL TEATRO OCCIDENTALE. LA NOSTRA RECENSIONE
Nonsense, ironia, grottesco, spirito giocoso e insieme tragico. Vita, morte, essenzialità. L’Assurdo. Il
Teatro.
Tutto questo è lo spettacolo Ubu Roi di Roberto Latini, in scena a Roma fino al 7 febbraio 2016
al Teatro Vascello.
Teatro o realtà, cornice o fondo di verità che si vuole, la pièce di Latini segue il gioco carnevalesco
della ‘patafisica’, quella “scienza delle soluzioni immaginarie…” nata proprio con Alfred Jarry e la sua
opera teatrale su “Padre Ubu”, rappresentata per la prima volta nel 1896 a Parigi. Considerata
anticipatrice dello stesso movimento surrealista e del teatro dell’assurdo, fu certamente un’azione di
sconvolgimento globale e innovazione per il teatro dell’epoca, mescolando insieme provocazione,
assurdo, farsa, parodia e umorismo crasso e sbracato.
Ed è sulla stessa onda che Roberto Latini ripropone con successo questo suo lavoro di teatralizzazione
unica dello spettacolo più tragicomico che la vita sembra mostrarci quotidianamente: l’uomo.
L’essere umano pare essere davvero il nodo centrale di Ubu Roi. E se per Jarry poteva essere
l’assurdo del teatro della sua epoca, per Latini verosimilmente somiglia ad un paniere esilarante e
triste allo stesso modo, di tutti quei segni caratterizzanti l’essere umano in tutte le sue sfaccettature.
Eccoci allora presentato il “nostro” Padre Ubu, “capitano dei dragoni, officiale di fiducia di re
Venceslao, decorato con l’ordine dell’aquila rossa di Polonia, ex re d’Aragona, conte di Sandomir”,
uomo più di tutti gli uomini plasmato di grettezza, meschinità, vigliaccheria, desideroso di potere e
succube al medesimo delle sue paure, come della sua dolce metà: la Madre Ubu. Parodia questa
della donna astuta, dominatrice della parola e di quel linguaggio capace di colpire il cuore stesso del
maschile. Megera alla continua ricerca di ricchezza per il solo gusto del possedere. E ancora gli altri
personaggi-marionette che identificano essenzialmente le varie sfumature della natura umana: dal re
Venceslao certo d’onnipotenza al principe Bugrelao spinto alla vita dalla sete di vendetta.
Continui i rimandi ad autori ed opere che hanno fatto la storia del teatro occidentale, daigrandi
lavori di Shakespeare (il Macbeth, Romeo e Giulietta, l’Amleto, Giulio Cesare o La
Tempesta) all’Edipo Re di Sofocle, dal Pinocchio di Carmelo Bene alla personalità di Antonin
Artaud. Non solo mero citazionismo ma, alla stregua del ribaltamento cercato da Jarry, sembrerebbe
che Latini abbia voluto tradurre alla sua maniera la stessa storia di quel teatro che ha vissuto,
esplorato, studiato: “Jarry propone una nuova convenzione, più che moderna, dentro l’assolutezza
che soltanto i classici riescono a determinare”, afferma Latini, che continua: “Abbiamo integrato Jarry
col suo proprio modello e Shakespeare con l’inventore della patafisica, li abbiamo entrambi ricondotti
al nostro tempo teatrale, al nostro sentire, al nostro modo di stare al Teatro”. Anche qui la
dimostrazione di un gioco che l’assurdo del Teatro può costantemente tentare di fare, poiché esso è lo
spettacolo più carnevalesco della vita. Un divertimento pensato, ragionato, ironico, a volte ridicolo a
volte tagliente, velenoso, amaro. Poiché Teatro è una possibilità, una occasione.
07 febbraio 2016
L’Ubu-Pinocchio di Roberto Latini
Il teatro del potere nell'era dell'eccidio dei migranti
di Vincenza Di Vita
William Shakespeare e Alfred Jarry sono i capisaldi della poetica di Roberto Latini. Non a caso l’Ubu
roi è probabilmente il culmine estetico e drammaturgico dell’attore e regista, allievo di Perla
Peragallo. Questo spettacolo (e sarebbe bello vedere anche la reazione di un pubblico francese, prima
o poi) ha debuttato nel 2012, Latini ha ricevuto peraltro il Premio Ubu, per Il servitore di due
padroni di Antonio Latella, come migliore attore nel 2014.
Latini gommato fa stretching come una marionetta umana, mossa dai fili di una ideale luce, il fascio
scenico realizzato dal sapiente gioco estetico di Max Mugnai. Lady Macbeth e sempre nuovi
personaggi tratti dai testi di Shakespeare prendono vita, animati da quello che possiamo considerare
l’Amleto italiano, ovvero Pinocchio, secondo Latini. Omaggiando Carmelo Bene, Latini è abitato dai
costumi e dalle catene che furono già in Bene la traduzione e il tradimento di Collodi. Acrobaticamente
impegnato al microfono, diviene la Lady Macbeth che pronuncia la nota battuta sul neonato a cui
schizzare via il cervello, ma anche la romantica e isterica Giulietta. L’incipit collodiano del “c’era una
volta” prometteva “un re”: viene degnamente sostituito dal burattino-Latini, che rende Pinocchio
davvero e finalmente un re, anche narratore.
Amleto è Pinocchio, la Tempesta è Calibano, Cotrone è
Pirandello, Latini è Jarry-Shakespeare in una giostra
acrobatica e danzata in cui il gatto e la volpe sono ballerini
e le risate e i clown sottolineano i momenti più
drammatici. Ritornano tematiche sviluppate in altre opere
di Fortebraccio Teatro, grazie anche alla tessitura
drammaturgica del compositore Gianluca Misiti, specchio
ed
eco
del
regista.
Papà Ubu uccide il re facendo scoppiare il fallo fittizio, tre
palloncini colorati che sono poi rinvenuti nel momento in
cui il re Venceslao muore giocosamente, spandendo tre
ciuffi rossastri dal petto come fuochi d’artificio. Molteplici e
consueti sono decervellamenti o risucchi in botole, come da testo – e d’altro canto Latini, lo
sappiamo, è un fedele “traduttore” dei testi da cui sono tratte le sue opere. I nobili divengono
sembianza di un solo attore in Latini, con capriole da saltimbanco mimate a tempo, raccogliendo
quegli stessi petali donati dall’unico attore che interpreta tutti i nobili e re Venceslao/ Lorenzo Berti,
con promessa funerea indubbiamente e costante elemento scenografico. C’è in questa esibizione delle
rose mortifere anche un omaggio alla Duse, omaggiata da Bene? Forse si tratta solo di uno sberleffo
intelligente alla bara-letto di Sarah Bernhardt, o di una compiaciuta mascherina di Latini che Ippaso ci
ricorda essere soprattutto “un’attrice” (vedi Katia Ippaso, Io sono un’attrice, Editoria&Spettacolo,
2009, già recensito da ateatro).
Suoni di ambienti esterni, uccelli, acqua e altri elementi naturali sono rievocati dal tappeto sonoro;
dentro le cornici stanno i morti e in questo caso i re, quindi coloro che rinunciano alla vita per morire
indossando una corona-megafono – qui è inevitabile pensare al Macbeth di Orson Welles. Pinocchio è
l’unico personaggio in scena a dire cose sensate, è la coscienza parlante ed è anche Lucignolo.
Pinocchio è la storia di una iniziazione e presenta diversi elementi massonici, come ben evidenzia
l’impianto scenico. Dentro la tradizione non può più rimanere neanche una piccola traccia di regalità o
cerimonia, perché il moderno ha già spazzato via tutto: così una katana viene rimpiazzata dalle
pallottole e non è più tempo di scope volanti, anche se qualcuna ancora rimane sospesa sul fondale.
L’ammonimento è: “Seppure voleste colpire le vostre spade sono ormai troppo pesanti per le vostre
forze, non potete sollevarle, non potete […] non c’è altro rimedio che il dolore nel cuore”. La citazione
corale e i riferimenti alle altre opere di Latini costituiscono qui una divertente via di perdizione per lo
spettatore. Il gioco c’è e sarebbe un peccato non stare alle sue regole.
Dopo l’annuncio della guerra, una danza circolare antioraria e un mantello rosso sulle spalle della
regina aleggiano annunciando l’inizio della catastrofe. Anche Pinocchio ha legato al suo collare una
catena che regge ormai solo il suo scheletro: a esso toccherà in sorte di essere vagliato dagli aruspici
con uno specchio, mentre è steso sul pavimento del palcoscenico creando una ombra anomala e
ossimorica per il suo opposto orientamento rispetto alla proiezione della luce.
Madre Ubu, interpretata dall’ottimo Ciro Masella, è spaventata mentre compie un sacrilego furto e su
di lei incombe il teschio decapitato di Macbeth/Padre Ubu e alter ego di
Pinocchio: all’uscita, serpeggiante da un acuto cantato su arpa, crolla
un rosso sipario e dal fondale accede Papa Ubu con uno scheletro
bianco come quello di Pinocchio ma senza testa. Il fondale rosso
ricoprirà il corpo di Pinocchio e quello della sua ombra-scheletro nero.
Ma questo fondale, che è poco più che un enorme velo di sangue, finirà
per avvolgere Papa Ubu, che ci cammina dentro calpestandolo con
presunzione: ma alla fine sarà proprio questo sudario a risucchiarlo e
ucciderlo per finta. Ubu svela quindi sotto di sé lo scheletro di
Pinocchio, mentre con gesto imitativo fa roteare una tibia o quel che
rimane del suo scheletro privo di colonna vertebrale: a reggerlo – si sa
– era solo il potere. Alla vittoria del principe Bugrelao, primo clown
della compagnia di guitti, segue il riassorbimento della benda di
sangue sollevata da una parte dalla quinta di destra.
L’omaggio di Latini al Macbeth Horror Suite di Carmelo Bene, per la
“ferita benda” e non per il braccio, mette in evidenza una profonda
evoluzione nella concezione di teatro. Se in Bene infatti assistiamo a
una consapevolezza finzionale, in Latini il reale con il suo portato
metafisico e verticale incombe sulla comicità, rendendola tragico epilogo. Non ci può essere salvezza
nel reale, anzi lo scheletro nero è sempre presente al centro del palcoscenico e al centro della vita.
La skené sacrale lascia oggi il posto ai protagonisti dell’avanspettacolo. Pinocchio in bicicletta gira in
senso antiorario per celebrare un requiem alla sua ombra scheletrica. Lo segue Papà Ubu,
percorrendo lo stesso tragitto su questa macchina del tempo a due ruote. In senso orario e con una
bici bianca, come quella sulla quale abbiamo incontrato Pinocchio nella prima parte dello spettacolo,
gli rivolgono un omaggio il gatto o la volpe, poco importa, danzando quasi volando e salutando una
farfalla con il compare (il gatto o la volpe, chissà? Perché conferire dei rigidi ruoli all’ineffabile bellezza
delle mascherine?). Il re, ricevuto il volo e dopo averlo scambiato con un battito cardiaco, stramazza
morto in un angolo del palcoscenico, sempre quello di sinistra e sempre con il capo rivolto verso il lato
di palcoscenico da cui si è eclissata la enorme benda rossa e ferita.
Al centro della scena viene collocata una bara e viene apparecchiata come per un banchetto o per un
talamo nuziale ed è inevitabile pensare a La vita cronica di Eugenio Barba per l’Odin Teatret – in
effetti ci sono anche le ali – ma anche e prima ancora di Barba, e non è un caso, il pensiero va alla
botola in cui si rifugiano tutti i personaggi di Akropolis di Jerzy Grotowski prima del crollo che si ode
nel finale a scena ormai vuota. Ancora una volta viene riprodotto il suicidio sacrificale del samurai, in
una ripetizione che svuota di significato il dolore. Tolte le maschere, i già morti si uccidono di nuovo,
ma non sarà vero fino a quando non sarà il vero samurai/Regina Rosmunda/zar Alessio/Sebastian
Barbalan a sparare pallottole ai malcapitati con la sua katana-bastone di legno.
Madre Ubu imita la Fatina con la voce, quando come una
apparizione in senso pirandelliano viene evocata per
spaventare Padre Ubu. Tuttavia ci si fa male per gioco,
battendo panni sulla gommapiuma-botola e anche bara. La
verticalità è dunque esasperata non solo da doppi esseri
con ali ma anche dall’entrata di una macchina scenica,
vero e proprio deus. Davanti a essa Pinocchio danza e
gioca con il suo scheletro, quasi fosse una bambola,
mentre alla sua sinistra un angelo spande piume bianche
da un secchio. La fisarmonica sottolinea l’ambientazione
popolare e folklorica da processione, quasi un dramma da
Maggio montano, incluse le simulazioni magiche della
pesca ai lati della rappresentazione centrale e nella scena iniziale. La musica sovrasta il vociare e i
versacci mentre il buio accoglie sul fondale l’erigersi di un immenso vascello infernale come un teatro
d’ombre allestito da un neuròspastos senza età e senza morale, tripudio di cronaca coeva che renda
memoria all’eccidio dei migranti.
08 febbraio 2016
Dis-fare il Teatro: Ubu Roi secondo Latini
Il testo di Alfred Jarry al Teatro Vascello di Roma si fonde con la sensibilità
artistica di Roberto Latini, per un acuto pastiche creativo.
di Nicole Jallin
Roberto Latini è ideatore, artefice, performer,
co-interprete di un incontro con l’Ubu Roi di
Alfred Jarry, lavoro datato 2012 e riproposto dal
4 al 7 febbraio al romano Teatro Vascello, che
espone mente e coscienza alla destabilizzazione,
al disorientamento, al coinvolgimento condiviso
dell’impatto
con
la
concreta
credibilità
dell’assurdo,
del
non
realistico,
dell’immaginario.
Una produzione di Fortebraccio Teatro con la
collaborazione del Teatro Metastasio Stabile
della Toscana, che dà forma a un’unione
curiosa,
originale,
e
anomala
con
l’opera (narrante l’impresa e la disfatta degli
Ubu alla conquista illegittima della corona di
Polonia) caposaldo del teatro dell’assurdo, composto dall’allora liceale drammaturgo francese. E Latini
non si limita a una rilettura, a un nuovo adattamento, a una personale riscrittura registica della storia,
ma l’accoglie su di sé come eredità testuale verso la quale intesse una relazione di de-strutturante
responsabilità creativa. Un’eredità abbracciata con un pastiche di sensibilità artistiche (di concezione,
di contatto, di linguaggio, di sentire) riconducibili a Shakespeare, ad Artaud, a Leo de Berardinis, a
Ionesco, a Bene, alla Socìetas.
A darne corpo, voce e movimento, un ensemble di personalità con
estremizzata vocazione al non-sense (e memorabile recitazione
dagli attori), che già per effetto di decisa contrapposizione cromatica –
di costumi, luci e scena (scarna, asettica), a cura di Marion
D’Amburgo, Max Mugnai e Luca Baldini – inneggia alle tinte di un
surrealismo bizzarro alla Dalì, e include: una caricaturale famiglia(fantoccio) reale con un Re Venceslao (Lorenzo Berti) munito di tronocarriola – ma trapuntata – e megafono per corona; una Regina
Rosmunda (Sebastian Barbalan) istrionica e premonitrice di sventure
coniugali; e un Principe Bugrelao (Guido Feruglio), quattordicenne (con
barba) con fare da tontolone e attitudine alla vendetta amletica.
i sono poi un Capitano Bordure (Marco Jackson Vergani) claudicante
nel fisico e nella parola, prima complottista poi fuggiasco e alleato di
uno Zar Alessio in veste di samurai (ancora Barbalan) dispensatore di
colpi di grazia; e una coppia di Romeo e Giulietta in versione orsi
antropomorfi (Vergani e Fabiana Gabanini). C’è Padre Ubu in cappotto
di pelle stracciato cui Francesco Pennacchia dona un cinismo grottesco
ma raffinato, una brutalità ingorda ma sottile, e una follia energica ma
assuefatta; e c’è Madre Ubu con tendenze sanguinarie proprie di una
burlesca Lady Macbeth, e con straordinaria fisionomia interpretativa di
Ciro Masella. Ci sono maschere con fattezze da primate cui spesso si
associa una mise da drughi kubrickiani, e c’è la presenza dello stesso Latini quale Pinocchio incatenato
a Carmelo Bene, che si affida al microfono per dar voce a commoventi passi del Bardo, che si aggira
anche in sella a una bici come una clownesca scheggia felliniana, che corre e crolla (tra suoni e
musiche di Gianluca Misiti), osserva, somatizza e riflette (su) Ubu Re come personaggio e artista,
teatrante e spettatore, carne umana e scheletro carbonizzato dall’assurdità di un’esistenza sociale
avida (senza redenzione) di potere, di dominio, di denaro. Come testimone di un teatro del non-
luogo e del non-tempo, di un “teatro senza spettacolo”, di un teatro (“scienza delle soluzioni
immaginarie”) consapevolmente farsesco che immerge nell’ironia la tragedia dei protagonisti, e
spalanca ai nostri occhi l’interrogativo sull’essere, sulla realtà, sull’arte: «Ormai Ubu esiste,
inevitabilmente».
09 febbraio 2016
LA RICERCA TEATRALE (FINALMENTE) AL CAPOLINEA
di Andrea Porcheddu
Uno spettro si aggira per i palcoscenici. È quello della ricerca teatrale italiana.
Sono in scena contemporaneamente – l’uno per due settimane, l’altro per troppi pochi giorni – due
spettacoli significativi della “nuova ricerca” italiana. Sto parlando di Ti regalo la mia morte,
Veronika, con la regia di Antonio Latella e Ubu Roi, diretto e interpretato Roberto Latini.
Dal momento che i due lavori sono stati già ampiamente visti, riccamente recensiti e financo premiati,
mi viene gioco facile fare altre considerazioni, tentando di non solo di tenerli assieme, ma anche – e
soprattutto – di trar profitto dalla coincidenza temporale e dalle fortuita scelta nella programmazione
del Teatro di Romae del Teatro Vascello.
Antonio Latella, in questa produzione ERT, riprende l’amato Fassbinder, accerchia – direi assedia – il
soggetto e la storia di Veronika Voss e ne estrae un mirabile gioco metateatrale (o
metacinematografico). Lo spettacolo non è pienamente riuscito, a tratti contorto e verboso ma, come
sempre nelle creazioni di Latella, è inquietante al punto da suscitare domande e prese di posizione
anche aspre.
Ti regalo la mia morte, Veronika. Regia di Antonio Latella
Al di là dell’esito scenico, dunque, pure per molti aspetti notevole, mi pare di poter dire che il regista
(con i suoi sodali) abbia ormai definitivamente abbracciato un periglioso viaggio nella
drammaturgia, destinato a allargare o speriamo inventare una scrittura scenica del nostro tempo. È
un viaggio teatrale faticoso – per chi lo fa e per chi lo riceve – quello scelto da Latella: chiede molto
allo spettatore come all’interprete. Quasi che abbia (simbolicamente) preso il testimone lasciato da
Luca Ronconi: è un esempio, non se ne vogliano i puristi ronconiani, né tantomeno i “latelliali”. Ma
quel che accumuna i due – diversissimi su mille fronti – è proprio l’ansia di saggiare scritture
diverse e di declinare, assolutamente nei margini imprescindibili dello specifico teatrale, fonti le più
diverse.
Non solo per spunto o assunto di partenza non abituale (un romanzo, una sceneggiatura, una
biografia) quanto anche per costruzione scenica che – senza dimenticare mai i codici del palcoscenico
– cerca disperatamente di approdare ad altro.
Ti regalo la mia morte, Veronika non fa eccezione: la partitura intertestuale, gli scavallamenti
semantici, le derive psicoanalitiche che si dipanano dal personaggio principale (la sempre brava
Monica Pisedducircondata dalle sue “scimmie”) sono altrettanti piani narrativi che si intrecciano, si
moltiplicano, evocano e suggeriscono allo spettatore sensazioni complesse, mai effettivamente risolte.
Ridondanti, al solito, eccessivi, eppure a tratti spiazzanti.
Monica Piseddu
E nel finale cechoviano, poi, si sugella il definitivo spostamento (o spaesamento), il superamento di
Fassbinder stesso, verso un “gioco” teatrale che si diverte a mettere assieme tutto e il contrario di
tutto.
Vien da pensare che sia stufo di se stesso, del suo gusto smaccatamente pop, di certo
compiaciuto cripticismo: Antonio Latella spinge verso altro. In questa prospettiva, penso che l’apice
l’abbia raggiunto dall’essenzialità scenica e interpretativa di un “pezzo” come Ma, ispirato alla figura
della madre di Pasolini: sospeso, dolente, rarefatto e avvolgente, tragicamente attuale.
Forse neanche Latella si rende conto (o forse sì) di quanto sta rischiando, di quanto stia provocando il
pubblico costringendolo ad andare in territori inesplorati, infidi, mai consolatori. Cerca, insomma, esiti
scenici che possano mettere in discussione anche i risultati acquisiti dalla ricerca nostrana che ha
creato una “gabbia” oramai fin troppo stretta.
E qui entra in gioco l’altro alfiere dell’avanguardia contemporanea, Roberto Latini.
Seguo il suo percorso praticamente dal debutto o addirittura da prima, non ho visto tutto, ma certo
molto. E posso affermare, sulla scia di molti recensori, che l’Ubu Re sia uno dei suoi prodotti migliori,
per complessità, acutezza di sguardo, partecipazione del gruppo (tutti bravi) e soluzioni sceniche.
Dunque: benissimo!
Siamo felici della calorosa accoglienza del pubblico e della critica entusiasta– meno
degli strani meccanismi del sistema teatrale nazionale, per cui questo lavoro è costretto a poche e
sporadiche repliche. Di Ubu ne vediamo pochi in Italia: ricordiamo volentieri quello ironicamente iperborghese diDonnellan alla Biennale di Venezia o, anni fa, la travolgente edizione romagnola
del Teatro delle Albe di Martinelli. Poi poco altro: meriterebbe dunque ogni attenzione e tanto
spazio questo realizzato da Roberto Latini.
Detto ciò, l’Ubu Roi di Latini e del suo Fortebraccio Teatro è uno spettacolo del secolo scorso. Mi
spiego.
Di fatto, mi sembra che Roberto firmi un concentrato (meglio: un precipitato) di tutta la “nostra”
ricerca. A partire dalla figura centrale, protagonista, quell’Ubu-Pinocchio-Carmelo Bene, diventato
ormai unamaschera del post-moderno e condivisa da molti (basti pensare alla recente produzione
di ArmandoPunzo). Una figura che si è fatta addirittura consolidata, strutturata, quasi pervasiva.
Non solo: oltre al nume Bene, e al divampante spirito artaudiano, lo spettacolo è pregno di
citazionismo: dal concettuale al simbolico, nell’Ubu Roi si rintracciano agilmente Leo de Berardinis e
Perla Peragallo, dal momento che il talento di Latini può vantare una sorta di “discendenza” diretta.
Poi rimandi a Castellucci, frammenti di Wilson, evocazioni di Grotowski, oggetti kantoriani,
suggerimenti da Tiezzi e molto altro…
Il tutto in una struttura drammaturgica smaccatamente nota: ancora il procedere per frammenti, per
lacerti che si alternano al testo, con invocazioni-suppliche che si incastrano nel loop o nel crescendo
musicale, in cui si insinuano le interpolazioni colte – le eterne citazioni dal canone shakespeariano:
quei tre o quattro titoli conosciuti da tutti – che contrappuntano lo strato comico. Non mancano
le maschere umane o animali, la biciclettina, i controluce, la gabbia scenica bianca abbacinante,
certi sospensori modello Arancia Meccanica…
Roberto Latini, foto di Simone Cecchetti
Elementi che ritornano, spesso e volentieri, anche in tanti altri protagonisti della nostra scena (Latella
primo fra tutti), che hanno fatto “tradizione” – come dice lo stesso Latini nelle note di sala – o
addirittura “maniera” della ricerca. Ormai conformista e autoreferenziale, la scena di ricerca parla
solo a chi sa riconoscere quei codici e quei segni. Siamo arrivati al punto di avere – come diceva
il compianto Nico Garrone – un “teatro amatoriale di ricerca” fatto da quanti ripetono stancamente
stilemi della ricerca che fu (ovviamente non è il caso degli artisti di cui stiamo scrivendo).
Insomma, mi pare che Roberto Latini si sia preso il coraggio e la responsabilità di evocare
tutti gli spettri, di mettere assieme i passati, per fare – spero – il definitivo canto del cigno di
quel mondo e di quel modo che da quaranta anni segna “l’avanguardia” soprattutto italiana.
Denunciare la “forma” dandola, reiterandola, è l’operazione più ambiziosa e certo più coraggiosa
del regista e interprete: se ne fa carico, con intelligenza e ironia, mettendo bene in fila tutti i
“santini” del bravo sperimentatore teatrale.
E non è un caso che abbia scelto Alfred Jarry e l’Ubu.
Mi piace sostenere che il Novecento, per quel che riguarda il teatro, non sia il “secolo breve”
teorizzato daHobsbwam, ma sia un secolo lungo, molto lungo che si è aperto proprio nel 1896,
quando andò in scena l’Ubu Roi a Parigi. Eccoci dunque: possiamo sperare che, con questa edizione,
si chiuda il Novecento del teatro, il secolo che va da Ubu a Ubu?
Siamo arrivati sin qui, ci dice Latini con l’eterno sorriso stralunato di Carmelo Bene.
Apologia e fine della ricerca: il traguardo è là, nel ghigno satanico di Mamma Ubu (fatta da un
Ciro Masellaen travesti, e da premio).
Allora, rispetto all’Ubu, definitivo e tombale, applaudito al Vascello; e rispetto alle sinuose
accelerazioni di Latella, si tratta di ricominciare, di andare altrove, di allargare quelle maglie – sia
della drammaturgia che della scrittura scenica: finirla di evocare lo spettro della ricerca
“com’era dov’era”, dando definitiva sepoltura al cadaverino insepolto, allo zombie cui eternamente
tocca rendere omaggio. La ricerca ha trovato quel che doveva trovare: quel che avanza sono miti,
icone stanche degli anni Sessanta-Settanta, che hanno inchiodato troppo a lungo il nostro
teatro.
13 febbraio 2016
TRA I DETRITI, VIVE L'UBU DI ROBERTO LATINI
di Ester Formato
Può sembrare assai banale trovarsi davanti ad un palcoscenico a quinte laterali leggermente oblique,
completamente bianco, mentre “ominidi” vestiti del medesimo colore si stagliano sulla parete di
fondo. La scena è come una superficie lattea sulla quale Padre Ubu (Francesco Pennacchia), Madre
Ubu (interpretata, con tanto di baffi, da Ciro Masella) e i futuri “consiglieri” stanno silenziosamente
pescando, ascoltando i suoni di una qualsiasi alba.
Non c’è nessun riferimento spazio-temporale se
non quello d’individuare, nella labilità della
pratica teatrale, un punto nel quale concentrare
l’incontro fra linguaggi ed echi che si intrecciano
sino a dar vita – seppur nel segno di una grande
raffinatezza registica ed attoriale – a un’enorme
materia grezza che va da Shakespeare a Carmelo
Bene, passando per altri esponenti del teatro di
ricerca
del
Novecento,
in
un’ottica a
posteriori della rottura che Jarry opera col teatro
sino ad allora esistito.
Come si legge nei versi che introducono il testo,
Ubu pare essere nella testa del suo ideatore
l’archetipa essenza di Shakespeare i cui echi
pulsano fra le maglie assai grottesche della
relativa drammaturgia dalla deformante lingua e che nell’adattamento di Fortebraccio Teatro sono
amplificati, tratti alla luce per mezzo di un Pinocchio (citazione di Carmelo Bene), come se si
sventrasse sostanzialmente l’opera dal suo interno.
Un Pinocchio incatenato – non a caso
impersonato dallo stesso Roberto Latini −
recita al suo microfono i versi di Lady Macbeth,
correndo subito dopo dietro la corpulenta
Madre Ubu attribuendole, con questo gesto, la
malvagità insita nella protagonista della
tragedia inglese; l’inerme e ridicolo principe
Bugrelao
(Guido
Feruglio)
giura
maldestramente vendetta agli spettri degli
antenati e del padre re Vinceslao, sulla
falsariga dei versi di Amleto, e diventa
grottescorimando al giuramento pudico e
romantico di Romeo e Giulietta, della cui morte
se ne fa parodia quando Ubu Roi “gioca” alla
guerra contro il legittimo erede. Al “burattino di
legno” ed alle sue catene è delegata la funzione
maieutica di rigettare letteralmente tracce della tradizione scespiriana e non solo.
Nel 1896 Ubu Roi si afferma nella storia del teatro come punto di rottura e di non ritorno, spada
divisoria fra ciò che si concepisce come tradizione ed avanguardia; un momento unico ed irripetibile
dal quale si origina proprio la stessa dicotomia secondo la quale abbiamo per decenni concepito il
teatro. Ma, non sono oramai le avanguardie di ricerca novecentesche esse stesse a possedere una
propria tradizione? Il fenomeno Alfred Jarry sembra dunque oggi un concetto inafferrabile, la cui
svolta eclatante e relativa forza di scandalo sono oramai opacizzate; è Ubu Roi un’opera che, messa
in scena ora, vale a dire nel nostro presente, ha esaurito il suo ruolo di rottura e diviene per noi un
classico.
L’epopea grottesca di Ubu si trasforma così
in un appuntamento nel quale passato e
futuro si incontrano; le pulsioniscavate dalle
citazioni del Bardo hanno il sapore di echi
ancestrali, riti perenni che si incasellano negli
stilemi da teatro dell’assurdo; conscio delle
distorsioni linguistiche e della natura
marionettistica
con
la
quale
Jarry
rappresenta i protagonisti, Fortebraccio
Teatro
mette
in
scena
personaggi
rigorosamente in maschera (rivendicando,
quindi, la ritualità e la natura ancestrale del
teatro stesso) dal ventre ridicolmente
rigonfio (similmente nelle farse elleniche) e,
come con Bordure (Marco Jackson Vergani)
ne disarticola le capacità verbali e motorie
rendendoli, ai nostri occhi, insieme ominidi e marziani futuristici; inoltre rievoca in chiave parodica,
nei gesti di Rosmunda (Sebastian Barbalan) il teatro di maniera o nel lontano imperatore d’oriente
quello cino-giapponese, tanto caro ai primi movimenti di avanguardia di fine Ottocento e fa di
Bugrelao − al quale Jarry attribuì cuffia e tutina da bebè – una sorta di fantoccio semi-autistico. Si
contemperano così una pluralità di forme e linguaggi che fanno del mostruoso Ubu una sorta di buco
nero dal quale il passato ed il “futuro” – cioè il teatro dopo Jarry − sono letteralmente vomitati sulla
medesima scena, nella stessa non-dimensione spazio temporale,
alla ricerca di una possibilità di espressione ad oltranza.
Sembra quasi che l’allestimento Ubu Roi firmato da Roberto
Latini si basi su una forza centrifuga entro la quale vedere il
teatro come una valanga che arreca con sé detriti che
camminano con esso, ponendo di volta in volta il limite della sua
infinita estensione, nuove colonne d’Ercole del suo linguaggio e
dell’immaginazione.
Padre Ubu resta una creatura mostruosa, un ibrido che
attraverso le figurazioni e stili “futuristici” e la sua infantile
pretesa di illimitata fantasia, ci rimanda non una mera
rappresentazione, ma un monito a (ri)vedere il teatro come
spazio immaginario, rituale che non è spettacolo ma richiamo
alla pluralità di linguaggi e forme con i quali fondare una
relazione tra chi ne condivide ancora il valore e la necessità.
A noi, quindi piace quella scena completamente bianca e vuota
perché, andando oltre la cognizione formale ed estetica,
abbiamo visto in essa un rito vagamente dionisiaco di puerile
irruenza, una visione entropica del teatro contemporaneo;
ritorniamo con la mente allo spettacolo di Roberto Latini
riflettendo sulla nostra capacità di ri-creare nuove soluzioni e
nuovi mondi possibili; sulla nostra capacità di riprovare ad
immaginare e raccontare nuove derive per gli Ubu in fuga, così
grottescamente scampati alla vendetta di Bugrelao, e di
continuare a rappresentare l’inesorabile riprodursi di questa
scalata al potere così ridicolmente violenta e banale.
Così con l’ultima battuta quasi nonsense − “Se non ci fosse la Polonia, non ci sarebbero i Polacchi” −
si allontana il vascello che trascina il protagonista in una deriva metafisica che lo lascia sempre e in
ogni caso, come il teatro stesso, in vita.