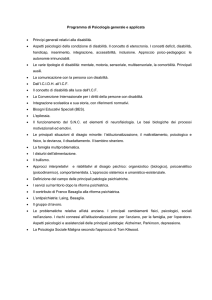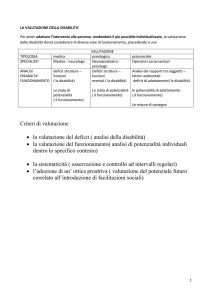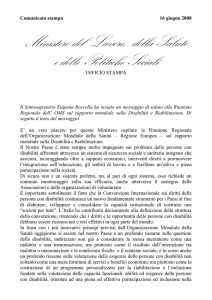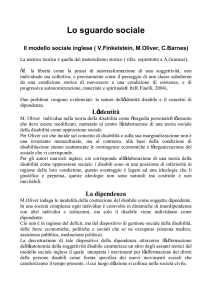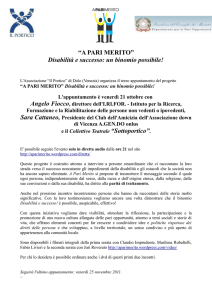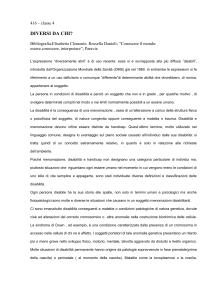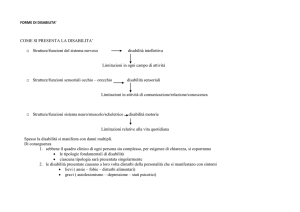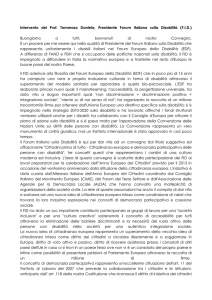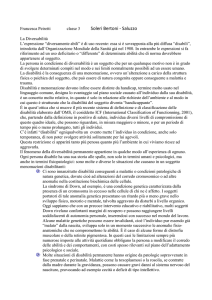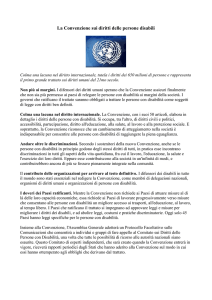Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-1-
Disabilità e cittadinanza
Nazzareno Gaspari
Parlare della disabilità dal punto di vista della cittadinanza significa riflettere su quanto e come
la nostra società sia, nei fatti oltre che nei princìpi, a misura dei diritti delle persone con
disabilità.
Questo approccio pone la disabilità in relazione non solo ai compiti delle istituzioni e degli
“addetti”, ma alla più generale responsabilità civica che ci coinvolge tutti in prima persona e in
modo diretto; inoltre ci fa cogliere il tema nella prospettiva della sua evoluzione, mettendo in
luce una dimensione essenziale del rapporto “Giovani-Disabilità” che è al centro di questo
Convegno; infine, ci permette di apprezzare la lungimiranza e la portata dell’idea che vent’anni
fa ispirò la nascita de I Nuovi Amici e che da allora alimenta l’attività dell’Associazione.
La cittadinanza in senso stretto è l’istituto giuridico che fonda il rapporto di appartenenza di
una persona ad uno Stato; più in generale, nel senso che qui ci interessa, è la partecipazione a
pieno titolo – con pienezza di diritti e in condizioni di uguaglianza - ad una comunità nelle
varie articolazioni e ai vari livelli: società, istituzioni, città, quartiere, vicinato ecc. .
L’idea di cittadinanza è ciò che connette i diritti di ciascuno con i doveri di tutti gli altri; fuori
di essa, e della sua comune consapevolezza, quei diritti restano in una sfera meramente
declamatoria, formale. Nessuno è realmente cittadino in senso pieno se i suoi con-cittadini non
lo riconoscono come tale e se non si comportano di conseguenza.
La cittadinanza non è certamente un premio da doversi meritare, come incredibilmente si sente
affermare da parte di autorevoli esponenti politici sostenitori di una visione inficiata dal
pregiudizio ideologico e dalla propaganda contro gli immigrati.
Non è neanche un’acquisizione da dare per scontata solo sulla base dei dati anagrafici.
Essa designa il sistema dei diritti e dei doveri entro cui collochiamo la nostra vita personale e
sociale, la reciprocità dei rapporti civili, etico-sociali, economici, politici.
Parlando di disabilità, essere titolari di diritti è molto diverso dall’essere portatori di bisogni.
poter partecipare è molto diverso dall’essere assistiti e tutelati.
E’ molto diverso per tutti, non solo per le persone con disabilità: cambia radicalmente il senso
e la portata dei reciproci doveri tra tutti i cittadini; i diritti si declinano infatti sul terreno della
responsabilità generale, non solo su quello della solidarietà e della spontanea generosità.
Più complessa è la definizione di disabilità: metterla in relazione alla cittadinanza ne comporta
infatti una definizione del tutto nuova e per molti versi sconvolgente.
La definizione più aggiornata e autorevole è quella contenuta nella Convenzione Internazionale
per i diritti delle persone con disabilità, approvata dalle Nazioni Unite nel 2006, ratificata dal
Parlamento italiano appena un anno fa - nel marzo 2009 - e dalla Unione Europea lo scorso
novembre: “La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con le menomazioni e le
barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società, su base di uguaglianza con gli altri”.
E’ una definizione profondamente innovativa sotto vari aspetti: stabilisce che la disabilità non è
un dato personale, ma il risultato di una interazione; dice che essa dipende non solo da come
uno è, ma da come gli altri si comportano nei suoi confronti; libera la persona dalla sua
identificazione con la disabilità ascrivendo quest’ultima alla relazione con gli altri; pone come
termine di paragone non più un’astratta “normalità”, ma la piena ed effettiva partecipazione
alla società su base di uguaglianza; afferma che quest’ultima può essere impedita, più che
dalle condizioni personali, da barriere comportamentali oltre che ambientali.
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-2-
Questa definizione di disabilità ci porta nel cuore del rapporto tra disabilità e cittadinanza:
metterle in relazione significa verificare a che punto è il lungo processo che dall’esclusione e
dalla marginalità deve portare le persone con disabilità all’inclusione, alla compiuta
realizzazione della pari dignità, all’effettiva uguaglianza dei diritti; in una parola, appunto, alla
piena cittadinanza.
La legislazione del nostro Paese a favore dei disabili è considerata tra le più avanzate.
Questo vale per quasi tutti i settori che interessano direttamente la disabilità: l’assistenza
sanitaria, l’integrazione scolastica, il collocamento mirato, la tutela giudiziaria, il sistema
integrato di interventi e servizi sociali, la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, il
sostegno alle associazioni di volontariato.
Anche sul terreno delle elaborazioni etico-culturali il nostro Paese ha avuto un ruolo di
avanguardia; la stessa Convenzione Internazionale per i diritti delle persone con disabilità è il
risultato di un lungo e complesso lavoro iniziato proprio su iniziativa dell’Italia più di
vent’anni fa.
Eppure le statistiche ci dicono che la disabilità è percepita dalla maggioranza delle persone
come una delle cause più diffuse di negazione dei diritti; in Italia è una delle tre cause di
discriminazione che nella percezione della gente va oltre il 50% ed è superiore di due punti alla
media europea. Non solo: oggi il rischio per i disabili di pagare le conseguenze della crisi
economica (in termini di perdita di posti di lavoro, riduzioni di tutele, minori sostegni al diritto
all’istruzione ecc.) è pari al 300% della media generale, il triplo (fonte: Eurobarometro,
novembre 2009).
Nel Paese dunque dove è più avanzata la legislazione di promozione e tutela dei diritti dei
disabili, la condizione di disabile è considerata tra le maggiori cause di svantaggio e di
esclusione.
C’è evidentemente qualcosa che non funziona. C’è un problema diffuso di cultura, di
mentalità, di sensibilità. C’è un’Italia a due velocità: le punte avanzate della società civile e
della politica non rappresentano tutto il Paese e non ne influenzano i comportamenti.
Se questo è vero, si rende necessaria ed urgente una forte opera di sensibilizzazione, alla quale
non a caso ci richiama il sottotitolo di questo Convegno: “sensibilizzare i giovani e la
cittadinanza all’integrazione”.
Abbiamo visto la definizione di disabilità che sta a fondamento della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità. E’ questo il primo grande accordo sui diritti umani del terzo
millennio; è il documento più autorevole (adottato da 192 Stati) ed il più avanzato, segna una
svolta epocale nel modo di affrontare i temi della disabilità.
La Convenzione si propone di “promuovere, proteggere e assicurare il pieno godimento e in
condizioni di uguaglianza, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le
persone con disabilità, promuovendo il rispetto della loro intrinseca dignità”.
Essa introduce un modo del tutto nuovo di comprendere e considerare la disabilità: abbandona
l’indirizzo tradizionale basato sulla risposta ai bisogni; pone al centro dell’attenzione la
dimensione dei diritti; sostituisce alle politiche dell’assistenza le politiche dell’inclusione;
indica nel cambiamento di atteggiamento nella società lo snodo fondamentale e necessario per
consentire alle persone con disabilità di raggiungere la piena eguaglianza.
Non rivendica nuovi diritti, non sollecita attenzioni o provvedimenti speciali.
Si prefigge qualcosa che sembrerebbe persino scontato: assicurare alle persone con disabilità il
pieno ed eguale godimento dei diritti di tutti; che scontato evidentemente non è.
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-3-
In sostanza, ci obbliga a ripensare il problema ripartendo dalla domanda fondamentale: è il
disabile un problema per la società, o è la società un problema per il disabile? La disabilità sta
dentro la persona del disabile o sta nelle sue relazioni funzionali con l’esterno?
Nella logica della Convenzione, gli interventi da promuovere a favore delle persone con
disabilità non sono tanto e solo interventi sulle e per le persone con disabilità, quanto
sull’ambiente in cui le persone vivono perché possano tutte inserirsi pienamente in esso e
realizzare il meglio di sé, come tutti.
L’approccio innovativo al tema della disabilità contenuto nella Convenzione ONU, e il
riferimento fondante in essa contenuto alla “intrinseca dignità” delle persone con disabilità, ci
porta a rileggere la nostra Costituzione Repubblicana.
E’ noto infatti che, al contrario di altre Costituzioni come quella tedesca e la cosiddetta Carta di
Nizza, la nostra Costituzione non mette espressamente la dignità della persona a fondamento
della Repubblica, anteponendole il lavoro (art.1).
Questo aspetto è stato oggetto anche recentemente di polemica da parte di autorevoli esponenti
politici. Ma è esso un limite della nostra Costituzione? Tutt’altro: mostra quanto siano stati
lungimiranti e moderni i nostri Padri Costituenti; d’altra parte non si potrebbe davvero credere
che in una Costituzione ispirata nei suoi principi fondamentali al personalismo e al solidarismo
possa essere assente il principio della dignità della persona.
Il fatto – a lungo sottovalutato e invece di grande portata – è che nella nostra Costituzione la
dignità della persona non viene affermata come principio generico e astratto, ma nella sua
dimensione più concreta e impegnativa, quella della pari dignità tra tutte le persone.
E’ la mirabile formulazione dell’art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Si noti: tutti i cittadini, prima di essere eguali davanti alla legge, hanno pari dignità sociale,
che è molto di più dell’eguaglianza formale; pari dignità e eguaglianza, poi, non riguardano
solo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, ma anche le condizioni
personali, ivi comprese ovviamente le condizioni di disabilità; infine rendere effettiva la pari
dignità e l’eguaglianza è il primo compito che la Repubblica si dà.
La dignità della persona non entra dunque nella nostra Costituzione in una prospettiva
soggettivistica, solo come attributo aprioristico della persona, ma in una prospettiva
eminentemente relazionale, sociale: è collegata col principio di eguaglianza; ha significato e
riscontro concreto nella pienezza della cittadinanza, nella vita personale intesa come capacità e
libertà di partecipazione alla vita sociale; va oltre la semplice, pur sacrosanta, ottica di “difesa”
dell’individuo per porsi come principio su cui si fondano i rapporti sociali; comporta, oltre ad
azioni passive di tutela, anche e soprattutto azioni positive di promozione dei diritti (rimuovere
gli ostacoli, rendere effettiva ecc.).
Potremmo interrogarci, ma non è questa la sede, sulle incongruenze e sulle strumentalizzazioni
storicamente seguite all’affermazione generica e astratta, ancorché solenne, della dignità della
persona umana. Ciò che interessa qui sottolineare è il fatto che la nostra Costituzione,
ponendola invece come principio e fondamento della cittadinanza, fa coincidere la sua
affermazione teorica con le implicazioni pratiche di ordine politico, sociale, economico e
culturale necessarie a renderla effettivamente rispettata ad ogni livello.
L’aver posto all’art.1 il lavoro a fondamento della Repubblica è l’altra faccia della stessa
medaglia, l’affermazione emblematica del diritto di tutti ad un inserimento attivo nella vita
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-4-
sociale, del diritto di tutti a vedere rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e
l’effettiva partecipazione…
Questo ci dice dunque la Costituzione da oltre sessant’anni: la persona non è separabile dalle
sue relazioni sociali; la sua realizzazione si sviluppa in un contesto relazionale e sociale, nella
reciprocità dei rapporti, nel riconoscimento degli altri; la dignità della persona non è separabile
dalla qualità delle sue relazioni e quindi dalla compiuta attuazione dei diritti di cittadinanza;
non basta l’osservanza delle norme a garantire la dignità; è necessaria un’assunzione di
responsabilità da parte di tutti in quanto cittadini, non solamente delle istituzioni o dei servizi
delegati o del volontariato attivo.
La dignità è indivisibile, è come l’aria: se è buona lo è per tutti, ugualmente se è malsana.
Lo stesso vale per la cittadinanza. Quello che serve, per allargare l’assunzione di responsabilità fino a
renderla comune a tutti, è una profonda e capillare opera di sensibilizzazione su questi temi.
Cambiare mentalità vuol dire anzitutto avere consapevolezza delle parole che usiamo,
soprattutto quando ci servono a identificare e definire gli altri.
Il modo in cui ci rapportiamo ai disabili e comunichiamo con loro, il modo stesso in cui li chiamiamo,
ne segna l’identità, la crescita, il futuro. Le definizioni che sottolineano la disabilità costituiscono una
specie di marchio che, aldilà delle intenzioni, svaluta ed emargina chi ne è oggetto.
Se ripensiamo ai diversi modi in cui abbiamo via via chiamato le persone con disabilità negli
ultimi decenni, proviamo un sentimento contrastante: per un verso di compiacimento per i
progressi che abbiamo fatto, ma per l’altro di vergogna per le ingiustizie che attraverso le
parole abbiamo perpetrato. Abbiamo a lungo usato parole ingiuste e generatrici di ingiustizia.
Un abisso etico e civile separa parole come anormalità, subnormalità, disadattamento, dalla
definizione della Convenzione ONU che allarga il concetto di disabilità fino a contestualizzarlo
come “il risultato dell’interazione tra le persone”.
Si pensi all’ipocrisia (di cui non ci siamo ancora del tutto accorti, neanche nei documenti
ufficiali) dell’uso di parole come handicap, originariamente indicativa nel linguaggio sportivo
di un modo per mettere alla pari competitori di diversa potenzialità e diventata nel linguaggio
comune esattamente il contrario, una qualifica per stigmatizzare la diversità dei livelli di arrivo
come di quelli di partenza; o all’uso prolungato e compiaciuto delle definizioni negative: non
vedente, non udente ecc.. Immaginiamo una società in cui tutti fossimo chiamati in base a ciò
che non siamo, che non sappiamo fare, che non possiamo fare; è inconcepibile! Eppure
abbiamo ritenuto a lungo questo criterio quello più appropriato per definire alcuni di noi, anzi
l’abbiamo considerato quello meno offensivo, meno brutale….
Certo, queste e le altre definizioni un tempo in uso vanno inquadrate storicamente; sono frutto
di precisi contesti socio-culturali e hanno segnato tappe evolutive del linguaggio a cui hanno
storicamente corrisposto modi diversi e progressivi di trattare le persone con disabilità; ma
dobbiamo superarne definitivamente i limiti e gli equivoci.
Il cuore del problema terminologico è che nessuna definizione è giusta se sposta l’attenzione
dall’interezza della persona ad una sua parte, ad un suo dettaglio. Il meccanismo non può
essere quello di “fare la persona a pezzi”, separarne le caratteristiche, prendere la peggiore, la
più discriminante, e farne la sua identità, la sua definizione.
Da sempre incasellare le persone in categorie basate su aspetti particolari della loro identità
(dal colore della pelle alla razza alla disabilità) ha costituito il modo di imprigionarle in tutto e
per sempre in uno stereotipo discriminatorio; ed è stato il presupposto culturale e sociale
dell’emarginazione, dell’esclusione, finanche della persecuzione.
Nella prospettiva dell’inclusione e della piena cittadinanza, dobbiamo usare parole non solo
rispettose, ma in grado di inserirsi in un orizzonte di senso positivo, di marcare l’identità della
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-5-
persona nella sua integralità e non in una sua parte, nelle sue potenzialità e non nei suoi
caratteri preclusivi.
Nessuno può cambiare la natura della disabilità; tutti possiamo cambiare il modo di guardarla e
di comportarci nei suoi confronti.
Il primo dato della cittadinanza è il modo in cui tra noi ci riconosciamo e ci chiamiamo.
La scelta delle parole influenza non solo il rapporto con le persone, ma anche l’identità stessa
delle persone. E’ ampiamente dimostrato che l’immagine che una persona si forma di sé è
fortemente influenzata dall’adattamento all’immagine di sé che proviene dagli altri. Trattare
una persona sottolineandone una qualità negativa e irrimediabile finisce alla lunga con
l’indurla a conformarsi pienamente ad essa, ad identificarsi con essa anche nei propri vissuti
interiori, ad isterilire senza accorgersene altre qualità positive, a pensare il proprio futuro su
quella base.
Lessi una volta la testimonianza di un operatore (purtroppo non ne ricordo il nome) il quale
raccontava di avere cominciato a porsi il problema della disabilità fin da ragazzino, quando
faceva le stesse cose del suo amico Mirko ma si chiamavano in modo diverso: lui faceva
ginnastica, Mirko faceva fisioterapia; lui faceva nuoto, Mirko faceva riabilitazione in acqua; lui
cantava e suonava, Mirko faceva musicoterapia; lui si divertiva, Mirko si curava; ma facendo
le stesse cose.
Essere consapevoli di quanto siamo attraversati da pregiudizi e stereotipi, ci permette di evitare
il rischio di rendere ingiusto il nostro modo di chiamare le persone e le cose; e di non
precludere a nessuno il suo futuro possibile.
Dobbiamo centrare le relazioni con gli altri sul riconoscimento delle persone nella loro
integralità e sulla promozione dei comuni diritti; è all’interno di questa prospettiva che la stessa
cura dei bisogni può valorizzarsi ed approdare nella compiuta realizzazione personale e sociale.
Due concetti che sintetizzano bene questa esigenza sono quello di inclusione e quello,
strettamente connesso, di partecipazione.
Nell’ottica della cittadinanza, dobbiamo parlare della disabilità assumendo il punto di vista del
noi; diventare e sentirci noi, condividere fino ad entrare in una dimensione esistenziale, etica,
sociale responsabilmente vissuta al plurale; avere la consapevolezza che la disabilità è
problema di tutti e non solo di alcuni; sapere che la presenza della diversità non solo sollecita i
nostri sentimenti e la nostra generosità ma cambia la nostra vita personale e sociale.
La prospettiva dell’inclusione segna il compimento del lungo processo storico che dal rifiuto
ha portato via via alla marginalità, alla protezione, all’inserimento, all’integrazione, in un
crescendo di giustizia che ha visto progressivamente ampliarsi la sfera dei diritti insieme
all’ambito dei “facentesi carico”: dalla famiglia, alle opere caritative, alle strutture delegate, ai
servizi sociali, alle istituzioni e oggi, nell’ottica della cittadinanza, alla responsabilità sociale
diffusa.
Sono passati appena poco più di trent’anni dallo smantellamento anche fisico di spazi e luoghi
“dedicati”, luoghi di cura e protezione ma anche di isolamento ed emarginazione (abolizione
delle classi differenziali 1977; legge “Basaglia” 1978); ma non basta abbattere muri e aprire
porte; l’approdo della cittadinanza, quindi dell’inclusione e della responsabilità sociale diffusa,
richiede l’abbattimento di barriere culturali e comportamentali.
Occorre anche un salto di qualità della politica. E' necessario sviluppare politiche e stili di
governo che inseriscano gli interventi sociali in una visione ampia di inclusione sociale,
superando definitivamente la tradizionale ispirazione compensatoria e assistenziale.
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-6-
Un utile esempio viene da quelle Amministrazioni locali che hanno iniziato a pensare e
realizzare le politiche per le persone con disabilità all’interno delle politiche generali, rivolte a
tutti i cittadini. Mantenere le politiche a favore dei disabili in capo ad un assessorato specifico,
come generalmente si fa, può essere utile ma può anche essere improprio e limitativo.
Mettersi nell’ottica delle politiche generali è un passo importante verso la realizzazione di un
welfare della responsabilità condivisa, non delegabile solo a specifiche istituzioni e servizi; ed
è un presupposto per l’inserimento effettivo di tutte le persone nel tessuto della vita sociale.
Una vera politica sociale non può collocarsi nell’orizzonte limitato delle azioni specifiche a
favore dei bisognosi, azioni irrimediabilmente settoriali ed elargitorie ancorché
opportunamente mirate; deve proiettare programmi e azioni concrete sullo sviluppo globale
della comunità, perseguire la qualità generale della vita e delle relazioni.
Per dirla con uno slogan: non basta che la città sia attenta ai disabili; lo sarà veramente e
concretamente quando vorrà essere a misura di tutti e si metterà alla prova in tutte le sue
articolazioni e manifestazioni.
E’ la via da sempre auspicata del superamento dell’assistenzialismo, del paternalismo, e anche
degli alibi e delle strumentalizzazioni.
Il disabile è un cittadino in difficoltà, certo, ma anzitutto un cittadino: con il diritto di tutti a
non essere limitato da fattori esterni nella sua vita di relazione e a non essere additato come
soggetto o oggetto di impedimenti particolari e di corrispondenti benefici particolari.
Nella Dichiarazione di Lisbona (settembre 2007) giovani disabili rappresentanti delle maggiori
associazioni europee vollero rivendicare questo diritto: “Non vogliamo simpatia; vogliamo
essere rispettati come futuri adulti che andranno a vivere e a lavorare in un ambiente normale.
(…) Dobbiamo rimuovere le barriere dentro di noi e dentro le altre persone senza disabilità.
Dobbiamo andare oltre la nostra disabilità, e il mondo ci accetterà nel miglior modo
possibile”.
Un passo utile in questa direzione è stato tentato nell’ambito dei lavori di predisposizione della
Agenda dell’Unione Europea per il 2020 (la cosiddetta “strategia post Lisbona”) in corso di
approvazione in queste settimane; l'Intergruppo sulla disabilità del Parlamento Europeo e
l'European Disability Forum hanno formalmente chiesto di inserire nella sezione dell’Agenda
riguardante la “crescita inclusiva” l’adozione di un “Patto sulla disabilità”, contenente obiettivi
concreti e misurabili oltre ad iniziative specifiche in favore dell'integrazione dei disabili in tutta
l’area UE. Il documento base predisposto dalla Commissione Europea (3 marzo 2010) sembra
tuttavia porsi in una prospettiva più limitata, non andando oltre il generico impegno ad
“elaborare e attuare programmi volti a promuovere l'innovazione sociale per le categorie più
vulnerabili (…) e a combattere la discriminazione ad esempio nei confronti dei disabili”.
Ma tutto questo discorso sulla cittadinanza, sull’uguaglianza, sui diritti e sulla partecipazione si
scontra con una obiezione molto diffusa, dai contorni capziosi, che non si può eludere: come
possiamo considerarci uguali se uguali non siamo? Non è fuorviante e alla fine ingiusto fare
finta che siamo tutti uguali quando non è vero? Cosa ci fa affermare che un disabile è uguale a
tutti gli altri?
Una risposta la dà la fede: ogni persona riceve la vita e la dignità da Dio, e questo la rende
uguale a tutti gli altri.
Un’altra risposta, sostanzialmente analoga nelle implicazioni pratiche, la dà la filosofia: ogni
persona ha dignità e diritti non in misura di ciò che è, o di ciò che sa fare, ma in quanto
persona, e come tale è uguale a tutti gli altri.
Convegno “Giovani e Disabilità” - Macerata, 10 aprile 2010
-7-
Ma c’è anche un’altra risposta: siamo tutti uguali proprio perché siamo tutti diversi, tutti
diversamente abili, tutti disabili; cambia per ognuno l’ambito e il grado delle abilità e delle
disabilità, ma tutti siamo diversamente abili.
Lo affermò con straordinaria efficacia, mostrandosi egli stesso disabile davanti al mondo,
Giovanni Paolo II: “le persone disabili svelano la radicale fragilità della condizione umana”
(8 gennaio 2004). E aggiunse tra l’altro: “riconoscendo e promovendo la loro dignità e i loro
diritti, noi riconosciamo e promoviamo la dignità e i diritti nostri, di ciascuno di noi”.
La fragilità è costitutiva della natura umana. Tutti portiamo il fardello di limiti e
inadeguatezze; tutti però portiamo anche la responsabilità di liberare noi stessi e gli altri dagli
ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione) e
“la piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza” (Convenzione
ONU).
E’ all’esercizio di questa responsabilità, alla sua qualità e alla sua ampiezza, che è legata la
speranza di una società migliore per tutti.
Circa dieci anni fa, Giuseppe Pontiggia volle intitolare il suo romanzo autobiografico sul
rapporto con il figlio disabile “Nati due volte”.
Metafora stupenda quella della ri-nascita, tanto da essere stata usata anche da Gesù nella
risposta a Nicodemo: «In verità ti dico, se uno non rinasce di nuovo (o dall’alto) non può
vedere il regno di Dio» (Giovanni 3,3).
Si nasce due volte. La prima nascita può non essere fortunata; può essere persino uno scherzo
della natura. Ma ci deve essere una seconda nascita, che non dipende dalla natura, non dipende
dalle leggi, non dipende dalle istituzioni, non dipende del tutto neanche dai ritrovati medici e
scientifici: dipende da noi, da ciascuno di noi, dalla nostra volontà e capacità di abbattere ogni
barriera culturale e comportamentale, oltre che fisica.
E’ il motivo per cui siamo qui; è il motivo per cui rendiamo omaggio e gratitudine a I Nuovi
Amici per i 20 anni e oltre della loro attività e della loro testimonianza; e per cui ripartiamo da
qui con una consapevolezza e un impegno più grandi, perché tutti – tutti – abbiamo bisogno di
superare insieme agli altri i limiti che ciascuno di noi ha e di rafforzare insieme agli altri le
risorse di umanità sulle quali ciascuno di noi può contare.
Nazzareno Gaspari