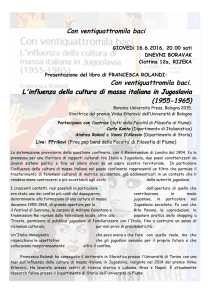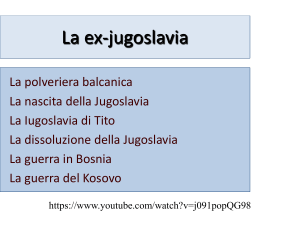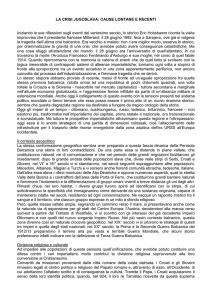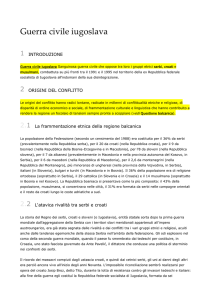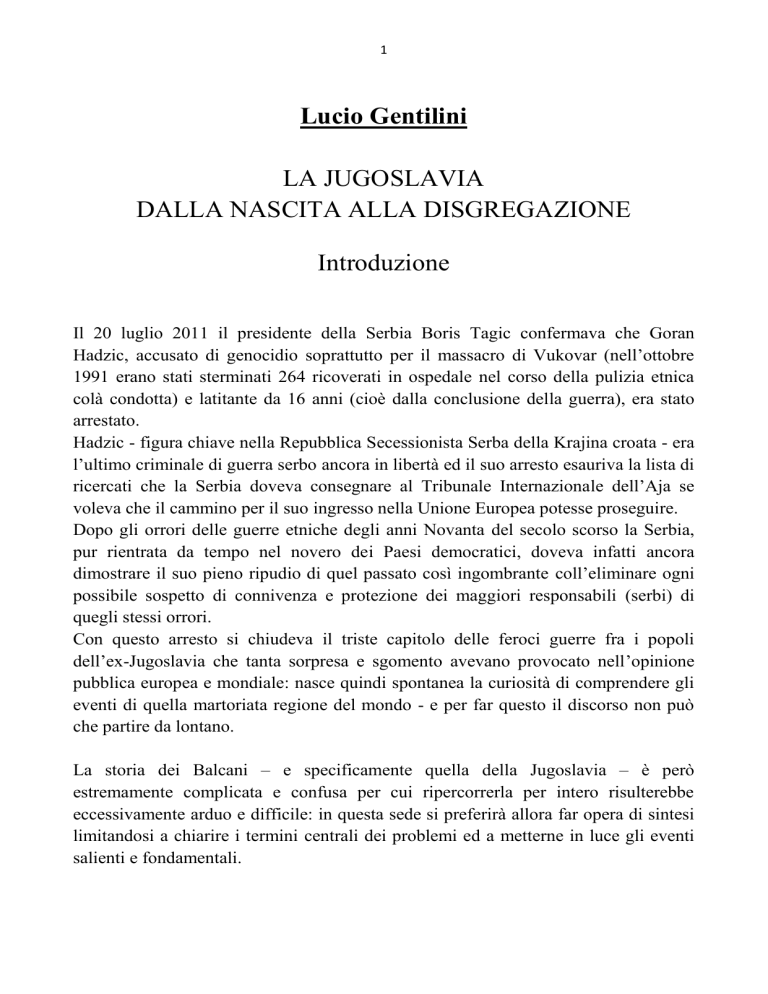
1
Lucio Gentilini
LA JUGOSLAVIA
DALLA NASCITA ALLA DISGREGAZIONE
Introduzione
Il 20 luglio 2011 il presidente della Serbia Boris Tagic confermava che Goran
Hadzic, accusato di genocidio soprattutto per il massacro di Vukovar (nell’ottobre
1991 erano stati sterminati 264 ricoverati in ospedale nel corso della pulizia etnica
colà condotta) e latitante da 16 anni (cioè dalla conclusione della guerra), era stato
arrestato.
Hadzic - figura chiave nella Repubblica Secessionista Serba della Krajina croata - era
l’ultimo criminale di guerra serbo ancora in libertà ed il suo arresto esauriva la lista di
ricercati che la Serbia doveva consegnare al Tribunale Internazionale dell’Aja se
voleva che il cammino per il suo ingresso nella Unione Europea potesse proseguire.
Dopo gli orrori delle guerre etniche degli anni Novanta del secolo scorso la Serbia,
pur rientrata da tempo nel novero dei Paesi democratici, doveva infatti ancora
dimostrare il suo pieno ripudio di quel passato così ingombrante coll’eliminare ogni
possibile sospetto di connivenza e protezione dei maggiori responsabili (serbi) di
quegli stessi orrori.
Con questo arresto si chiudeva il triste capitolo delle feroci guerre fra i popoli
dell’ex-Jugoslavia che tanta sorpresa e sgomento avevano provocato nell’opinione
pubblica europea e mondiale: nasce quindi spontanea la curiosità di comprendere gli
eventi di quella martoriata regione del mondo - e per far questo il discorso non può
che partire da lontano.
La storia dei Balcani – e specificamente quella della Jugoslavia – è però
estremamente complicata e confusa per cui ripercorrerla per intero risulterebbe
eccessivamente arduo e difficile: in questa sede si preferirà allora far opera di sintesi
limitandosi a chiarire i termini centrali dei problemi ed a metterne in luce gli eventi
salienti e fondamentali.
2
Gli Stati dell’ex-Jugoslavia nel 2011.
3
Nascita di un’idea
Il 13 agosto 1866 - sconfitto nettamente l’Impero Austriaco - il cancelliere prussiano
Otto von Bismarck con la pace di Praga otteneva la completa espulsione dell’Austria
dalla Confederazione Germanica: era una svolta molto importante nella politica
europea perchè il controllo della Germania da parte dell’Austria (pur con inevitabili
mutamenti) risaliva al Medioevo.
Il 3 ottobre 1866 – altra conseguenza della sconfitta austriaca – con la pace di Vienna
l’Impero Austriaco perdeva anche il Veneto che entrava così a far parte del Regno
d’Italia, come aveva fatto sette anni prima la Lombardia.
Nonostante Trentino e Friuli (Trento e Trieste) continuassero a far parte dell’Impero
Austriaco, era ormai finito anche il suo controllo dell’Italia: l’Impero andava dunque
ripensato e ristrutturato e per questa necessità il 21 dicembre 1867 si trasformò
nell’Impero Austro-Ungarico (o Austria-Ungheria).
L’Impero venne diviso in Cisleithania (Austria e tutta la parte ad ovest del Leitha, un
affluente del Danubio, più la Dalmazia) e Transleithania (Ungheria con tutta la parte
ad est del medesimo fiume): riconosciuti Regni indipendenti, ambedue però
rimanevano sotto lo stesso Imperatore (austriaco) – l’Ungheria soltanto per quel che
riguardava guerra, finanze ed esteri.
L’Impero aveva assunto insomma un assetto duale - e non a caso ebbe per simbolo
un’aquila bicipite.
Questa nuova sistemazione dell’Impero suscitò tuttavia opposizione e risentimento
fra gli altri popoli che lo componevano e che comprensibilmente si sentirono esclusi e
discriminati: fra questi ci furono gli sloveni, insieme ai boemi sotto l’Austria, ed i
croati, sotto l’Ungheria, i cui confini allora arrivavano fino all’Adriatico.
Fu in queste circostanze che prese vigore l’idea di unire gli Slavi del Sud – gli
Jugoslavi – in una compagine politico-amministrativa dotata delle stesse autonomie
delle altre due etnie (l’austriaca e l’ungherese) in modo da trasformare in triplice il
duplice Impero.
In questo modo esso sarebbe diventato più equilibrato e rispettoso di tutte le
nazionalità che ne componevano la struttura multietnica, multilinguistica,
multiculturale e multireligiosa, ma in realtà questo progetto era vecchio di almeno
vent’anni e risaliva al movimento ‘illirico’ dello scrittore e poeta croato Ljudevit Gaj,
mentre il vescovo (anche lui croato) Josip Juraj Strossmayer aveva sì puntato anche
lui sull’unità degli slavi del sud, ma per costruire un stato del tutto nuovo, autonomo
ed indipendente.
In ogni caso, nel clima di diffuso Panslavismo del tempo per raggiungere
quest’obiettivo gli estensori di ambedue i progetti erano disposti a passare sopra le
grandi diversità esistenti fra i popoli in questione che parlavano lingue differenti,
praticavano differenti versioni del Cristianesimo (cattolici i croati e gli sloveni,
ortodossi i serbi, i montenegrini ed i macedoni), comprendevano molti mussulmani
(sia fra i bosniaci che gli albanesi del Kosovo), avevano diversi alfabeti (croati e
4
sloveni scrivevano con caratteri latini mentre serbi, montenegrini e macedoni con
caratteri cirillici) ed avevano differenti retaggi storici: mentre infatti croati e sloveni
erano stati sudditi relativamente fedeli dell’Imperatore austriaco (l’avevano per
esempio sostenuto nel 1848-49 contro gli ungheresi quando questi si erano ribellati
proclamando la loro indipendenza) ed avevano accolto favorevolmente l’idea
‘illirica’, serbi e montenegrini invece l’avevano rifiutata, mentre ancora più
complicata era ed era stata la storia dei macedoni, divisi e contesi fra Serbia, Grecia e
Bulgaria.
I serbi cui si faceva riferimento nel progetto di unione degli slavi del sud erano quelli
che vivevano all’interno dei confini dell’Impero Austro-Ungarico (soprattutto in
Croazia ed in Bosnia), ma al di fuori di questo la Serbia esisteva ormai come entità
indipendente - seppur in dimensioni più ridotte di quelle odierne.
La Serbia in quanto tale non aveva mai fatto parte dell’Impero Asburgico:
gradualmente conquistata dai turchi e da questi dominata per oltre tre secoli, ne era
sempre stata una fiera resistente così che dal 1804 al 1815 dopo una strenua lotta era
infine riuscita a divenire autonoma - e proprio nel 1867 l’ultima guarnigione turca
aveva dovuto abbandonare definitivamente la capitale Belgrado nella quale era potuta
restare fino a quel momento.
Anche se la Serbia venne riconosciuta Principato solo nel 1878 (e Regno nel 1882),
di fatto era ormai libera ed indipendente e, anzichè mirare ad unirsi ad altri popoli
slavi, da tempo manifestava invece la sua volontà di unire tutto il suo popolo in un
unico stato – proprio come avevano voluto fare ed avevano fatto gli italiani ed i
tedeschi.
Tutti i popoli slavi dei Balcani erano comunque mescolati fra loro: così come non
tutti i serbi vivevano in Serbia, nemmeno tutti i croati in Croazia, ecc., per tacere
degli ebrei, dei tedeschi e delle mille altre minoranze.
Numerosi osservatori, studiosi, scrittori e viaggiatori stranieri (in genere inglesi) per
parte loro avevano tuttavia insistito su una presunta stretta parentela e su presunte
origini comuni dei vari popoli jugoslavi: essi avevano notato per esempio che fra la
lingua serba e quella croata le differenze – alfabeto a parte – erano minime; che
questi popoli erano stati separati a forza da altri stati ed imperi che ne avevano
spezzato l’unità originaria; che le innegabili differenze che sembravano renderli
ormai estranei fra loro erano in realtà frutto di influenze esterne che erano stati
costretti a subire e che, insomma, le difficoltà a riunirli in un unico stato non
sarebbero state insormontabili.
Il progetto di uno stato per gli slavi del sud – gli jugoslavi - era ancora sicuramente
prematuro, ma l’idea era comunque nata, sia all’interno che all’esterno: perchè essa si
potesse concretizzare si sarebbero tuttavia dovute verificare almeno due condizioni,
l’espulsione dei turchi dai Balcani ed il crollo dell’Impero Austro-Ungarico - i due
Imperi che opprimevano e dominavano gli slavi del sud.
5
L’espulsione dei turchi dai Balcani
L’espulsione dei turchi dai Balcani (meridionali) fu definitiva con la pace di Losanna
nel luglio 1923 (vedere su questo punto il capitolo relativo nel mio “La
ricomposizione etnica dell’Europa” e “ ‘Neve’ di Orhan Pamuk” ) quando alla
nuova Repubblica Turca in Europa rimase solo la Tracia orientale, ma per quel che
riguarda i territori ed i popoli che avrebbero composto la Jugoslavia l’espulsione –
senza dimenticare l’indipendenza della Grecia (1929) ed altre numerose rivolte avvenne in due momenti fondamentali: con la guerra russo-turca del 1876-78 e con la
prima guerra balcanica (1912-13).
I
Nel biennio 1875-76 i serbi che abitavano nella Bosnia-Erzegovina si ribellarono
ancora una volta ai turchi ed ottennero subito l’aiuto degli altri popoli balcanici
(serbi, montenegrini, bulgari e rumeni): la rivolta venne duramente domata con atroce
brutalità soprattutto contro i bulgari, ma la Russia, che da tempo si atteggiava a
paladina dei popoli slavi, non perse l’occasione e nell’aprile 1877 il suo esercito
invase la penisola balcanica e da lì riuscì a spingersi fino ad Istanbul.
Il sultano non potè che arrendersi e firmare la umiliante pace di Santo Stefano (marzo
1878) ma questa vittoria russa era insopportabile per Austria-Ungheria, Francia ed
Inghilterra, che minacciarono di intervenire a loro volta: il risultato di questa nuova
crisi internazionale fu il Congresso di Berlino che, voluto dall’ ‘onesto sensale’
Bismarck, si concluse il 13 giugno 1878.
Fra i tanti deliberati del Congresso quelli che interessarono la futura Jugoslavia
furono il riconoscimento dell’indipendenza della Serbia e del Montenegro, mentre la
Bosnia-Erzegovina - anche se formalmente continuava a far parte dell’Impero Turco
- venne però assegnata per trent’anni all’amministrazione dell’Austria-Ungheria (!?).
Anche questo fu insomma un capitolo di quella “Questione d’Oriente”, cioè del
problema rappresentato dalle aspirazioni indipendentistiche dei popoli balcanici e
dagli interessi divergenti delle Potenze Europee sui Balcani stessi (e non solo) che
ormai il traballante Impero Turco non riusciva più a controllare.
II
Verso la fine del secolo fu ormai evidente che l’Impero Turco non era più sostenibile:
difeso per tanto tempo dalle Potenze Europee per la sua funzione di escludere
l’accesso della Russia al Mediterraneo, ormai non era più in grado di farlo ma,
soprattutto, per Francia, Inghilterra e Russia il nuovo pericolo era ora rappresentato
dalla Germania di Guglielmo II (e dalla sua alleata Austria-Ungheria) - così la
conseguente Triplice Intesa (1907) di Francia, Inghilterra e Russia fra i suoi compiti
ebbe anche quello di fermare la spinta dell’Austria-Ungheria nei Balcani.
6
Questa spinta divenne evidente il 6 ottobre 1908 quando, scaduti i trent’anni di
amministrazione, l’Austria-Ungheria si annesse la Bosnia-Erzegovina: la Turchia il
26 febbraio 1909 dovette riconoscere l’atto compiuto, ma esso suscitò le estese
ribellioni dei serbi e dei musulmani residenti, che per essere sedate impegnarono un
terzo dell’esercito austro-ungarico.
Per la Turchia le cose non potevano ormai che peggiorare: approfittando della guerra
italo-turca per la Libia, nel 1912 Serbia, Grecia, Montenegro e Bulgaria, appoggiati
dalla (solita) Russia, l’8 ottobre attaccarono a loro volta la Turchia per strapparle la
fertile Macedonia - e ci riuscirono scacciandone nel sangue e nel massacro la
popolazione turca.
I giochi erano così compiuti: il 30 maggio 1913 col Trattato di Londra la Turchia
dovette rinunciare praticamente a tutti i suoi possedimenti in Europa, dove potè
mantenere solo la Tracia orientale – e questo confine è rimasto inalterato fino ad
oggi.
Fu questa la prima guerra balcanica, subito seguita da una (brevissima) seconda per il
possesso della multietnica Macedonia che colla pace di Bucarest (agosto 1913) venne
spartita fra Serbia e Grecia.
La grande vincitrice era la Serbia che, essendosi annesso anche il Kosovo, aveva ora
raddoppiato l’estensione del suo stato (ma ne aveva perso l’omogeneità etnica).
Elemento comune a tutti i Paesi balcanici che avevano combattuto contro i turchi era
stata la Chiesa Ortodossa, l’unica istituzione che – come aveva fatto a suo tempo la
Chiesa di Roma durante la dominazione barbarica dell’Europa occidentale – era stata
le gelosa e fedele custode del patrimonio culturale, linguistico e storico (oltrechè
religioso, s’intende) delle popolazioni slave sottomesse al Sultano.
Nel clima di acceso nazionalismo slavo si verificarono continui trasferimenti di
popolazione (soprattutto di quella turca nella sua madrepatria) ed anche pulizie
etniche, mentre le tensioni fra le Potenze Europee sui Balcani, ‘polveriera d’Europa’,
rimanevano alte.
Non fu un caso se la prima guerra mondiale scoppiò proprio qui.
Nascita della Jugoslavia
Lo svolgimento della prima guerra mondiale è fin troppo noto perchè in questa sede
abbia senso ripercorrerlo per intero e basterà dunque ricordare brevemente i principali
eventi che riguardarono direttamente i popoli e gli stati della futura Jugoslavia:
le ostilità scoppiarono il 28 luglio 1914 quando l’Austria-Ungheria dichiarò guerra
alla Serbia e gli slavi del sud si trovarono così a dover combattere su opposte
barricate: sloveni, croati ed i serbi sudditi dell’Impero, nell'esercito austro-ungarico,
mentre i serbi di Serbia ed i montenegrini, alleati dell'Intesa, si batterono contro gli
Imperi Centrali. I cittadini della futura Jugoslavia dovettero così scontrarsi anche fra
di loro per tutta la durata della guerra;
già l’11 agosto 1914 l’esercito austro-ungarico attaccò la Serbia, ma questa riuscì a
respingerlo, a sconfiggerlo ripetutamente e ad inseguirlo in Bosnia ed in Croazia;
7
il 1 novembre 1914 la Turchia entrò in guerra a fianco degli Imperi Centrali;
nel settembre 1915 anche la Bulgaria entrò nel conflitto a fianco degli Imperi Centrali
e così la Serbia, presa tra due fuochi, venne completamente invasa: con grandissima
difficoltà re, esercito e governo con una marcia epica e difficilissima riuscirono però
ad arrivare all’Adriatico dove vennero evacuati (dapprima a Corfù) dalla flotta
italiana;
più tardi, con il sostegno dei francesi, partirono al contrattacco dal fronte a Salonicco
(cuore delle operazioni dell’Intesa nei Balcani);
il 14 settembre 1918 la Bulgaria crollava definitivamente sotto l’urto franco-serbo;
nell’ottobre 1918 i serbi (coi francesi) compivano la sanguinosa ma vittoriosa
riconquista della loro terra e del loro regno;
il 3 novembre 1918 l’Austria-Ungheria era definitivamente travolta.
Per l’Europa la guerra fu un disastro terribile: nello shock dell’inspiegabile follia
annientatrice ed assassina, che aveva impazzato in quello che aveva pensato di essere
il continente più evoluto ed avanzato (oltre che civilizzatore!) del mondo, morti e
distruzioni erano arrivati a livelli impensabili.
Insieme alla Polonia (altro campo di battaglia) fu la Serbia che pagò percentualmente
il più alto tributo di sangue: almeno metà dei maschi adulti (350.000 uomini) ed un
terzo dell’intera popolazione era infatti stato ammazzato o era morto di stenti e
malattia, mentre nell’intero Paese imperversava ancora la tubercolosi.
La febbre ‘spagnola’ infierì infine sull’intero pianeta col suo incredibile carico di
morti.
In queste condizioni si aprì a Parigi il congresso di pace i cui esiti trasformarono
profondamente l’Europa: trionfò infatti il punto di vista del presidente statunitense
Wilson che portò allo sfaldamento degli antichi imperi multinazionali in favore degli
stati nazionali, ma come ogni regola anche questa ebbe le sue eccezioni – fra cui la
Jugoslavia appunto, che andò invece nella direzione diametralmente opposta.
Già durante la guerra comitati slavi e governi in esilio non avevano mai rinunciato –
pur fra mille difficoltà – a portare avanti il progetto di uno stato jugoslavo e già il 10
luglio 1917 si era giunti all'accordo in base al quale serbi, croati e sloveni alla fine
della guerra avrebbero dato vita ad uno stato democratico, parlamentare e rispettoso
delle peculiarità nazionali di ogni singolo popolo sotto la dinastia serba dei
Karageorgevic.
Il 1 dicembre 1918 venne poi ratificata la dichiarazione comune serbo-croato-slovena
in favore di uno stato unitario - al quale cinque giorni prima, il 26 novembre, anche
l’Assemblea Nazionale del Montenegro aveva chiesto di aderire.
A guerra finita i trattati di Neuilly, di Saint Germain e del Trianon sancirono così la
nascita del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni: alla Serbia, ora coi propri
confini allargati (aveva infatti incorporato come province proprie Montenegro,
Vojvodina e Bosnia-Erzegovina), unica gloriosa vincitrice della guerra ed alleata
8
delle Potenze dell’Intesa, vennero ora unite non solo Croazia, Slovenia e
Montenegro, ma anche Dalmazia e Macedonia.
I problemi di una simile unione erano evidenti: a quelli costituiti dalle differenti
lingue, alfabeti (cirillico e latino) e religioni (cattolicesimo, ortodossia e islam) si
affiancavano quelli costituiti dalle varie nazionalità e, oltretutto, dalle numerose
minoranze etniche (ungheresi, rumeni, albanesi e tedeschi) e dalle differenti eredità
culturali dovute alle diverse dominazioni subite per secoli.
Se il termine ‘balcanico’ – inteso come confuso, caotico, instabile e magari violento –
ha un senso, lo si può ritrovare in pieno in questo regno che non presentava nessun
carattere di saldezza, coesione, identità, omogeneità e di tutto ciò che può tenere
insieme ed amalgamare una società ed un organismo politico.
Viene inevitabilmente da chiedersi allora che senso ebbe e perchè fu operata una
scelta simile, fra l’altro – ripetiamolo – in netta controtendenza rispetto all’indirizzo
prevalente.
Circa le motivazioni ‘interne’, in Slovenia e Croazia si volle evidentemente operare
una scelta che permettesse di evitare un eccessivo frazionamento politico in un’area
notevolmente agitata ed instabile per la mancanza di un centro di gravità e di
orientamento - facile quindi alla penetrazione di interessi stranieri e, di conseguenza,
destinata a divenire (ancora una volta!) terreno di scontro fra Potenze esterne.
La guerra aveva poi mostrato oltre ogni ragionevole dubbio quanto era costato a
staterelli come Serbia e Montenegro essere di dimensioni ridotte e come solo un’unità
politica più grande poteva quindi garantire l’indipendenza di tutti.
Appare infine logico riconoscere che tracciare dei confini che separassero i popoli
jugoslavi sarebbe stato estremamente difficile se non impossibile data la presenza in
ogni regione di numerose e cospicue minoranze etniche - che però alle spalle avevano
stati di loro connazionali (a loro volta con numerose e cospicue minoranze etniche):
così, per esempio, c’erano serbi che vivevano in Croazia e croati che vivevano in
Serbia.
Tuttavia mentre i serbi considerarono la Jugoslavia come un allargamento del loro già
raddoppiato stato (ripetiamo che erano stati gli unici vincitori nella guerra), croati e
sloveni l’intesero come una federazione fra uguali, ma dovettero piegarsi alla
supremazia serba per la paura (per niente infondata) delle pretese italiane e austrotedesche sui loro territori.
La nascita del Regno era stata voluta però anche dalle Potenze vincitrici (tanto che le
motivazioni ‘esterne’ per Vesna Drapac furono quelle prevalenti e decisive).
Lo sbriciolamento dell’Impero Austro-Ungarico a loro giudizio rischiava infatti di
generare un vuoto ed una frammentazione politica dell’intera area balcanica che
avrebbe inevitabilmente attirato le mire italiane - e soprattutto tedesche! O russe! creando una forte instabilità e divenendo fonte di conflittualità - aggravate oltretutto
dalla dissoluzione dell’Impero Turco e dalle mire greche su tutta l’area egea.
Uno stato (alleato e protetto dall’Intesa) di media grandezza come il nuovo regno
poteva invece costituire un utile contrappeso alle spinte centrifughe ed antagonistiche
9
nella zona e contribuire così alla stabilità di cui particolarmente da parte inglese si
sentiva urgente bisogno.
La Francia aveva poi premuto per la nascita di questo nuovo stato anche per
circondare meglio la Germania con Paesi di media grandezza - Polonia,
Cecoslovacchia e, appunto, la Jugoslavia, guarda caso tutti stati multinazionali.
Comunque lo si voglia giudicare - frutto degli interessi geopolitici stranieri, delle
ambizioni serbe, del bisogno di sicurezza degli altri popoli jugoslavi o
dell’inestricabile mescolamento delle nazionalità - questo nuovo stato rimase
comunque in piedi per oltre un settantennio e le due volte che la sua unità si
frantumò (nei primi anni Quaranta e nei Novanta) ciò avvenne nell’orrore, nel sangue
e nella violenza più sfrenata – dando insomma indirettamente ragione a chi lo aveva
voluto.
La Jugoslavia dei Karageorgevic
La nascita del nuovo Regno di 12 milioni di abitanti, così composito e disomogeneo,
(38,83% di serbi, 23,77% di croati, 8,53% di sloveni, 6,05% di mussulmani
bosniaci, 4,87% di macedoni, 4,27% di tedeschi, 3,93% di ungheresi, 3,68% di
albanesi, ecc.) era avvenuta mettendo a tacere le voci nazionalistiche dei vari popoli
che per decenni avevano puntato invece sulla loro etnia come base per la costruzione
di uno stato nazionale, omogeneo e basato sulla sola loro cultura: il multietnicismo ed
il multiculturalismo – giudicati oppressivi cascami dei regimi ottocenteschi – erano
sempre stati combattuti da questi idealisti propugnatori della propria identità intesa
come unica, ma il loro progetto si scontrava colla realtà del mescolamento etnico dei
popoli che rendeva difficilissimo, anzi impossibile, tracciare confini dotati di un
senso – a meno che non si fosse fatto ricorso al trasferimento massiccio e forzato (alla
deportazione) o all’eliminazione (alla pulizia etnica) degli appartenenti agli altri
popoli.
Ma, oltre a ciò, il problema più urgente era quello della scelta della struttura da dare
al nuovo regno, se cioè questo dovesse essere una federazione di uguali o uno stato
accentrato ad inevitabile direzione serba.
Il dissidio fondamentale fu così quello tra i croati, federalisti e propugnatori della
piena parità di diritti fra le varie etnie, ed i serbi centralizzatori che intendevano
l'unificazione prevalentemente come ingrandimento della Serbia stessa.
Anche se la leadership serba non portava con sè sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita alle altre nazionalità del regno (come ad esempio aveva fatto la
Russia con le altre popolazioni del suo impero) perchè le più avanzate e ricche, anche
per la loro eredità austro-ungarica, erano Slovenia e Croazia, prevalsero comunque i
serbi e le richieste dei delegati del consiglio di Zagabria non furono accolte.
Croati e sloveni dovettero accettare il centralismo serbo anche in vista dei pericoli
che continuavano a minacciarle dagli stati vicini: le sconfitte Bulgaria ed Ungheria
10
erano infatti profondamente scontente per le pesanti perdite territoriali subite coi
trattati di pace, mentre l'Italia (soprattutto), pur vincitrice della guerra, protestava per
la sua ‘vittoria mutilata’ e reclamava maggiori compensi proprio a discapito di
Slovenia e Croazia.
Oltre a ciò, le decisioni venivano prese mentre la difficile situazione economica
postbellica dava luogo ad inevitabili forti tensioni sociali con scioperi e
manifestazioni che venivano duramente represse dal governo: nella confinante
Ungheria l’esperimento comunista di Bela Kun (durato solo tre mesi e mezzo, dal
marzo al luglio 1919, ma altamente drammatico) aveva suscitato notevoli apprensioni
ed il Partito Comunista del neonato Regno risultò la terza forza politica nelle elezioni
del 1921.
Sembrava insomma che solo uno stato forte e centralizzato potesse offrire l’ordine e
la stabilità così necessari - anche se la soluzione centralistica si identificava con le
tendenze egemoniche serbe: probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente
dato che, oltretutto, l’unico stato fino a quel momento esistito era stato quello serbo,
che i serbi erano l’etnia di gran lunga più forte e che i serbi erano gli unici ad essersi
meritati sul campo di battaglia la reputazione eroica di cui godevano - e che volentieri
facevano pesare.
Secondo il progetto presentato dal capo del governo, il serbo Pasic, il Regno dei
Serbi, dei Croati e degli Sloveni sarebbe stato una monarchia centralizzata nella quale
il governo non sarebbe stato responsabile solo verso il parlamento, ma anche verso il
re: la Costituzione del 1921 che – ispirandosi apertamente a quella serba del 1903 tracciò la struttura del regno a tre anni dalla sua nascita, ne stabilì così la struttura
centralistica e la supremazia dei serbi e delle loro istituzioni, ma fu altamente
significativo che, su 419 parlamentari, 161 rifiutarono questo fondamento stesso della
nuova costituzione, che alla fine fu approvata con soltanto 223 voti favorevoli, 35
contrari e, appunto, 161 astenuti.
Di indubbio significato fu poi il fatto che essa fu fatta entrare in vigore il 28 giugno,
il giorno di S.Vito, data-simbolo dell’identità serba perchè anniversario della storica
(per i serbi) e sempre commemorata (dai serbi) battaglia del Kosovo.
In Croazia ed in Slovenia la costituzione fu accolta con rabbia e disappunto ed il
leader croato Radic, sostenitore della tendenza autonomistico-federalistica,
abbandonò l’Assemblea Costituente stessa, seguito dai deputati comunisti e dai
rappresentanti sloveni.
Il nuovo stato si portò dentro fin da subito lo scontento di tanti sloveni e dei croati,
dei tanti bosniaci che non erano serbi, di tanti macedoni e di tante altre genti slave
passate dalla corona asburgica a quella di Pietro I Karageorgevic invece che in uno
stato federale e paritario fra le nazionalità: oltretutto, se la Jugoslavia era nata in
seguito alla prima guerra mondiale, tale memoria poteva avere valore fondante solo
per i serbi (ed i montenegrini) dato che gli altri Jugoslavi avevano combattuto sul
fronte opposto, quello degli sconfitti.
11
Radic fondò così il Partito Contadino Croato che, favorevole all’autonomismo,
continuò una vigorosa opposizione in collaborazione col più moderato Partito
Popolare (cattolico) Sloveno guidato da monsignor Korosec.
Altri minori oppositori furono i mussulmani della Bosnia guidati da Spaho ed alcuni
montenegrini per l’autonomia.
Secondo il modello francese il Paese venne diviso in 33 unità amministrative,
indifferenti alle appartenenze etniche e guidate da funzionari di nomina regia: i
confini amministrativi fra queste varie parti del regno - ad eccezione di quelli della
Slovenia - non corrispondevano a quelli storici fra i popoli (minoranze a parte); a
capo dei 33 distretti vennero poi posti - sempre ad eccezione della Slovenia funzionari serbi; le circoscrizioni elettorali vennero tracciate in modo da favorire i
serbi che così ottenevano un seggio ogni 4944 voti mentre i croati ogni 6600; infine,
con la sola e breve eccezione di uno sloveno, tutti i capi di governo e tutti i ministri
furono sempre serbi.
Ultimo corollario, nello stesso 1921 vennero infine introdotte leggi speciali per la
difesa dello Stato ed il Partito Comunista venne posto fuorilegge e costretto alla
clandestinità.
Un Paese difficile
Il neonato regno fin dalla nascita fu segnato da profonde – ed irrisolvibili? – tensioni
fra aspirazioni nazionali e politiche centralistiche, manifestatesi soprattutto fra croati
e serbi: la lotta acquistò inevitabilmente anche tinte ideologiche e culturali in quanto
esprimeva due visioni dello stato incompatibili.
La durezza e la complicazione dello scontro riproduceva quella del territorio così
aspro, sofferto, frastagliato nelle sue valli e catene montuose che accentuavano le
difficoltà dell’amalgama e dei collegamenti: la grave crisi economica postbellica e le
incertezze dell’Europa tanto segnata dalle stragi e dalle devastazioni si
ripercuotevano in un Paese i cui cittadini avevano combattuto su fronti contrapposti.
Ogni tentativo di mediazione e compromesso ebbe al massimo effetti temporanei e la
situazione non riuscì mai a trovare un punto di equilibrio che permettesse una
conduzione unitaria e condivisa dello Stato.
Il complicato ed a volte caotico – vien proprio da dire ‘balcanico’ – corso degli eventi
ebbe un andamento davvero confuso e questi furono comunque i suoi momenti
salienti:
nonostante nel 1924 Radic avesse finalmente deciso di entrare in Parlamento (la
Scupstina), nel gennaio 1925 Pasic (segretario del Partito Radicale e capo del
governo) lo fece arrestare insieme ai suoi collaboratori con l’accusa di intesa con
l’U.R.S.S.;
alle elezioni del 18 febbraio 1925 vinse il blocco governativo serbo (i radicali di
Pasic ed i democratici di Pribicevic), ma fu accusato di brogli;
12
la commissione di controllo annullò tutte le elezioni dei seguaci di Radic in base alla
legge del 1921;
i deputati di Radic proclamarono ufficialmente la loro fedeltà al sovrano e così nel
luglio 1925 Radic fu scarcerato;
il 20 novembre 1925 Radic entrò addirittura nel governo Pasic come ministro
dell’Istruzione;
nell’aprile 1926 in seguito alla rottura fra Pasic e Radic il governo cadde, ma nel
nuovo governo Uzumovic rimasero altri ministri del Partit Contadino Croato;
in ottobre Radic giunse ad un nuovo accordo con Pasic;
il 6 dicembre 1926 il governo cadde sulla politica estera: la contesa italo-jugoslava
sull’Albania era stata persa in seguito al patto italo-albanese del 27 novembre 1927;
il 10 dicembre Pasic morì;
rifare il governo si rivelò complicato e difficile finchè Uzumovic ci riuscì grazie
all’accordo con un gruppo di ex-radiciani, ma al prezzo del passaggio di Pribicevic,
ora alleato di Radic, all’opposizione;
le relazioni italo-jugoslave peggioravano sempre più finchè agli italiani di Dalmazia
fu addirittura proibito di possedere terreni e negozi;
nell’aprile 1927 il nuovo governo Vukicevic comprendeva oltre ai musulmani di
Spaho anche Radic, ma non i popolari sloveni che non accettavano l’anticlericalismo
di quest’ultimo;
dopo le elezioni dell’11 novembre 1927, vinte dal blocco governativo, i popolari
sloveni rientrarono nel governo che avevano combattuto in campagna elettorale;
lo stesso 11 novembre un accordo franco-jugoslavo controbilanciò quello italoalbanese - che il 22 novembre venne reso ulteriormente stringente (per l’Albania);
in 7 febbraio 1927 Vukicevic fu costretto alle dimissioni per contrasti all’interno
della maggioranza, ma dopo laboriose manovre ne formò un altro: il problema erano i
rapporti con l’Italia che il nuovo governo voleva migliorare con opportuni accordi,
ma che provocarono anche scontri ed incidenti anti-italiani;
il 20 giugno 1928 alla Scupstina Radic attaccò il governo e un deputato della
maggioranza sparò contro i deputati croati uccidendone due e ferendone altri fra cui
lo stesso Radic: l’opposizione abbandonò la Scupstina;
il 27 luglio 1928 il nuovo governo fu guidato da Korosec che non era serbo e con ben
otto ministri non serbi, ma l’opposizione non rientrò;
l’8 agosto Radic morì per le ferite riportate e fu sostituito da Macek, altrettanto
intransigente;
il 21 dicembre 1928 Korosec dovette dimettersi dato che lo scontro fra serbi e croati
era sempre più grave.
Nella tormentata Europa degli anni Venti il Regno era arrivato al suo decimo anno di
esistenza senza essere riuscito a risolvere i suoi problemi di fondo (quegli stessi con
cui era nato) ed il nuovo re Alessandro I – succeduto al padre nel 1921 – decise di
cambiare strada.
13
La politica estera del nuovo Regno
Prima di esaminare gli sviluppi della situazione interna, così minata dai contrasti fra
le nazionalità, è però necessario ricordare anche la politica estera del nuovo regno che
mirò al mantenimento dello status quo (cioè delle conquiste della vittoria) contro le
manovre delle nazioni sconfitte.
Per questo scopo il 14 agosto 1920 la Jugoslavia si era così alleata alla
Cecoslovacchia e quando l’anno seguente aderì anche la Romania nacque la Piccola
Intesa.
La Piccola Intesa era rivolta soprattutto contro l'Ungheria che in seguito alla sconfitta
nella prima guerra mondiale aveva dovuto cedere gran parte dei propri territori ai
nuovi stati confinanti e che pertanto puntava alla revisione del trattato di pace del
Trianon, ma mirava anche ad impedire una possibile restaurazione asburgica
nell'Europa danubiana.
Naturalmente la Piccola Intesa ebbe il sostegno della Francia, grande amica della
Jugoslavia ed interessata al mantenimento del nuovo status quo nei Balcani, e della
ricostituita Polonia, in nome del buon vicinato e del contenimento di Germania ed
Austria.
Una dittatura in più
Dopo un decennio di instabilità il 6 gennaio 1929 Alessandro I ricorse alla forza del
colpo di stato ed impose al Paese la sua dittatura: la Scupstina venne sciolta senza
che venissero indette nuove elezioni, la Costituzione del 1921 venne sospesa ed egli
assunse (provvisoriamente, disse) i poteri legislativo ed esecutivo.
Nominato un governo a lui sottoposto presieduto da un militare (il generale
Zivkovic), tutti i partiti politici vennero sciolti, la stampa venne imbavagliata e fu
istituito un severissimo tribunale speciale per la difesa dello stato: si adottarono
insomma tutte le tristi misure delle dittature, si ricorse cioè ad un vero e proprio
terrorismo di stato per procedere finalmente ad una decisa politica di
omogeneizzazione nazionale in base al principio ‘uno stato, una nazione, un re’ –
cioè alla serbizzazione del Paese.
A rimarcare che le differenze etniche fra i vari popoli non dovevano contare più ed
andavano superate, il 3 ottobre il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni divenne il Regno
di Jugoslavia ed il suo territorio venne diviso in dieci ‘banati’, cioè in dieci regioni
amministrative che - a parte quella slovena - non tenevano in alcun conto l’etnia delle
loro popolazioni e che erano guidate da un funzionario di nomina regia, il ‘bano’
appunto, in genere un militare serbo o filoserbo.
Tutti i simboli, le bandiere e gli stemmi tradizionali furono vietati e sostituiti con
quelli nuovi jugoslavi: tutto quel che ricordava le diversità nazionalità venne abolito.
Quella della dittatura era la (solita) strada che intraprende chi ritiene che solo la forza
possa riuscire a venire a capo dei problemi che si ritiene non derivino da decisioni
14
sbagliate (sulle quali si dovrebbe quindi ritornare): ed era questa una strada molto in
voga nell’Europa di allora.
Anche tralasciando i casi fin troppo noti dell’Italia fascista, dell’U.R.S.S. e della
Germania (che sarebbe diventata nazista quattro anni dopo), quello della Jugoslavia
veniva ad inserirsi nel lungo elenco dei regimi dittatoriali di estrema destra che
nell’Europa fra le due guerre resero una rarità la democrazia liberale:
il 1 marzo 1920 in Ungheria il contrammiraglio Horty era divenuto capo provvisorio
del governo e reggente con poteri pressochè assoluti - anche se la vera e propria
dittatura sarebbe stata instaurata nel 1932 da Gyula Gombos;
il 9 marzo 1923 in Bulgaria un colpo di stato militare aveva eliminato il governo di
Stambolijnski favorevole ai contadini;
il 14 maggio 1926 in Polonia il maresciallo Pilsudski aveva assunto poteri assoluti;
nel luglio 1927 in Austria Schober aveva instaurato una non troppo velata dittatura
che sarebbe poi proseguita sotto il più noto Dollfuss;
nel 1926 in Portogallo il generale Carmona aveva istituito una dittatura militare e nel
1932 Salazar l’avrebbe istituzionalizzata con una nuova costituzione civile;
nel 1933 in Estonia si sarebbe instaurata una dittatura militare;
nel 1934 la Lituania avrebbe fatto lo stesso;
il 4 agosto 1936 in Grecia Metaxas avrebbe dato vita ad una dittatura d’accordo col
re Giorgio II;
il 27 febbraio 1938 in Romania re Carlo II avrebbe assunto poteri assoluti anche per
frenare la fanatica estremista ‘Guardia di ferro’ (che avrebbe sciolto l’anno seguente);
nel 1939 in Spagna Franco avrebbe vinto la guerra civile ed imposto il suo potere
assoluto.
Naturalmente la pretesa di eliminare con la forza e con la violenza i conflitti sociali
ed etnici e di risolvere i problemi politici con la persecuzione degli oppositori, la
censura, gli arresti, la tortura, gli assassinii politici, i ‘suicidi’ in carcere, la
propaganda e tutta la (solita) lurida sequenza di misure coercitive ed oppressive non
aveva – non l’ha mai! – possibilità di vera riuscita: in queste condizioni l'opposizione
nazionalista croata non potè che crescere ed esacerbarsi.
Fin dalla fine dell'800 l’avvocato croato (ma di origini ebraiche) Josif Franz,
richiamandosi ai secolari diritti del regno croato e predicando l'odio contro i serbi,
aveva costituito un movimento visceralmente nazionalista ed i suoi successori non
avevano mai aderito all'idea dello stato federale postbellico che invece Radic, seppur
riluttante, aveva comunque accettato.
Ora, anche se la grande maggioranza dei croati restava al seguito del successore di
Radic, Macek, si formò un movimento di nazionalisti estremisti ed il loro capo, Ante
Pavelic, fuggito all’estero, cominciò ad organizzarli in Austria ed in Ungheria in un
movimento detto degli "ustascia" (ribelli).
Già nello stesso 1929 Pavelic si trasferì in Italia dove venne accolto come amico ed
alleato (seppur non troppo stimato): come in Ungheria, in Italia l’opposizione di
Pavelic venne attivamente sostenuta, dato che ambedue i Paesi erano interessati a
15
destabilizzare la Jugoslavia allo scopo di acquistare influenza ed ingrandimenti
territoriali nei Balcani.
Francia (soprattutto) ed Inghilterra manifestarono invece comprensione per le misure
che re Alessandro, già principe-guerriero ed alleato, a loro dire sarebbe stato costretto
a prendere per il bene superiore del suo Paese: in realtà alle due Potenze interessava
il mantenimento dell’integrità della Jugoslavia, necessaria per la stabilità dell’area e
per i loro interessi - e qualunque mezzo impiegato per questo scopo andava bene.
Intanto l’8 novembre 1931 Alessandro I promulgò una nuova costituzione che, fra
l’altro, vietava tutte le associazioni politiche (e sportive!) costituite su base
confessionale, etnica o regionale: il Partito Contadino Croato diventava così
legalmente impossibile.
Manifestazioni, proteste e mancanza di consenso resero tuttavia brevi e fragili i
governi della dittatura.
Pavelic potè allestire in Italia (ed in Ungheria) campi di addestramento per i suoi
fanatici volontari pronti ad “affogare i nemici (della Croazia) in fiumi di sangue": ben
presto essi poterono dedicarsi all’attività terroristica con tutta una serie di attentati,
sabotaggi ed omicidi politici - il più importante dei quali fu l’assassinio dello stesso
Alessandro I (insieme al ministro degli esteri francese Barthou) appena sbarcato a
Marsiglia in visita di stato il 9 ottobre 1934, organizzato e gestito assieme ai
macedoni dell’I.M.R.O..
A Belgrado si protestò la responsabilità di Italia e di Ungheria nell’attentato, ma a
tutt’oggi non ci sono prove decisive di un loro coinvolgimento diretto: certamente
però alla Francia che chiedeva l’estradizione di Pavelic il governo fascista oppose un
rifiuto asserendo che si era trattato di un delitto politico e non di un atto
semplicemente criminale.
Ad Alessandro succedette il figlio Pietro di soli 11 anni e di fatto il potere passò ad
un Consiglio di Reggenza presieduto da Paolo, fratello di Alessandro.
Paolo cercò di correre ai ripari: sotto il suo governo, più moderato e conciliante, le
restrizioni vennero allentate, la Scupstina della dittatura fu sciolta e nelle elezioni del
5 maggio 1936 il blocco governativo ottenne il 62% dei voti e quello
dell’opposizione di Macek il 35%.
Un ulteriore passo fu compiuto nell’agosto 1939 quando il capo del governo Dragisa
Cvetkovic strinse un patto con i croati a cui venne concessa una forte autonomia
mentre i confini del loro banato (comprendente ora circa il 30% dell’intero Paese)
furono ridisegnati in senso più rispettoso della loro etnia – ma era ormai troppo tardi
e la seconda guerra mondiale scoppiava solo pochi giorni dopo.
La politica estera jugoslava degli anni Trenta
L’ascesa in Germania di Hitler il 30 gennaio 1933 ebbe inevitabili effetti e ricadute
anche sulla politica estera jugoslava e balcanica: di fronte alle evidenti intenzioni di
rivincita e di espansione del Terzo Reich la Piccola Intesa già nel 1933 rinsaldò i suoi
16
legami e divenne ‘un’organizzazione internazionale unificata con personalità propria’
dotata di un Consiglio permanente e di un Segretariato con sede stabile a Ginevra.
Non ancora soddisfatte, il 9 febbraio 1934 Grecia, Turchia, Jugoslavia e Romania
strinsero fra loro un accordo noto come Intesa Balcanica o anche come Patto
balcanico: l'accordo – caldeggiato questa volta dall’Inghilterra - mirava a far fronte
comune sia contro le mire sulla regione di Germania e Italia che contro il
revisionismo dei trattati di pace da parte delle loro protette Bulgaria ed Ungheria:
prevedeva infatti la non-belligeranza tra i quattro stati, l'inviolabilità delle loro
frontiere, il coordinamento della loro politica estera e l'aiuto reciproco in caso di
aggressione da parte di uno stato non aderente al Patto.
Nonostante però la Piccola Intesa rimanesse in vigore fino al 1939 ed il Patto
Balcanico addirittura fino al 1940, l’attivismo, la forza crescente e la pressione del
Terzo Reich li vanificarono molto prima: gli anni Trenta videro infatti non solo lo
sviluppo ed il velocissimo rafforzamento della Germania, ma anche la sua marcia
trionfale nell’Europa orientale e balcanica (e la progressiva esclusione dell’Italia) - e
la ricerca di accordi con essa da parte degli Stati di quell’area:
già nel 1936 Jugoslavia e Romania operavano una politica di riavvicinamento al
Terzo Reich;
il primo ministro jugoslavo Stojadinovic il 24 gennaio 1937 concluse con la Bulgaria
un patto di ‘pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua’;
aprì poi all’Italia e si impegnò per una politica di amicizia culminata il 25 marzo
1937 con la firma a Belgrado (fu il ministro italiano degli esteri Ciano a spostarsi) di
un accordo della durata di cinque anni sul rispetto delle frontiere comuni e sulla
soluzione pacifica di ogni divergenza;
subito seguì anche il riavvicinamento alla Germania ed il 7 giugno 1937 a Belgrado
(anche in questo caso fu il ministro degli esteri tedesco Neurath a spostarsi)
Stojadinovic disse di voler andare ‘d’accordo con i suoi amici’ e parlò di identità di
punti di vista, ma in realtà con la Germania si trattava di qualcosa di più di relazioni
di amicizia: dal 1929 al 1939, in dieci anni, le importazioni jugoslave dalla Germania
erano salite infatti dal 16% al 39% e le esportazioni dal 9% al 42% - e queste sono
cifre di uno stato-cliente;
gli accordi di Monaco del settembre-ottobre 1938 diedero intanto via libera a Hitler
per l’annessione della regione dei Sudeti in Cecoslovacchia;
di fronte alla continua imbelle acquiescenza di Francia ed Inghilterra, nel marzo 1939
la Germania occupò l’intera Boemia scorporando la Slovacchia che sotto la direzione
di monsignor Tiso divenne un suo stato protetto;
cercando affannosamente di far la sua parte e la sua figura, l’Italia il 7 aprile 1939
occupò l’Albania.
La guerra era ormai imminente e sarebbe scoppiata (in Europa) il 1 settembre 1939
con l’invasione tedesca della Polonia.
17
La Jugoslavia nella seconda guerra mondiale
Anche lo svolgimento della seconda guerra mondiale è fin troppo noto perchè in
questa sede abbia senso ripercorrerlo per intero e basterà dunque ricordare i principali
eventi che riguardarono direttamente la Jugoslavia.
Al principio del marzo 1941 la Bulgaria aderì al Patto Tripartito (Germania – Italia –
Giappone) ed il 25 dello stesso mese vi aderì anche la Jugoslavia del reggente
principe Paolo e del primo ministro Dragisa Zvetkovic che aveva sostituito Milan
Stojadinovic e la sua prudente politica di neutralità ed equilibrio fra le parti: le
vicende belliche sembravano essere a favore dell’Asse, ma il Consiglio della Corona
era diviso.
Sloveni e croati ritenevano infatti che l’adesione al Patto fosse stato un passo
necessario per evitare che le truppe tedesche invadessero il Paese ormai circondato
da alleati di Hitler, ma la maggior parte dei serbi voleva invece resistere.
Come si vede, all’interno della Jugoslavia si riproponevano ancora una volta le
divisioni fra chi nella prima guerra mondiale aveva combattuto a fianco i tedeschi e
chi contro.
La soluzione della crisi fu però fulminea: già il 26 marzo un colpo di stato promosso
da ufficiali vicini all’Inghilterra e capeggiati dal generale Dusan Simovic rovesciò il
governo di Zvetkovic e la reggenza: sostenuto da un entusiastico appoggio popolare
(serbo), il diciassettenne re Pietro II, dichiarato maggiorenne, ordinò la mobilitazione
generale e pochi giorni dopo la Jugoslavia firmava un trattato di amicizia e di nonaggressione con l’U.R.S.S., la tradizionale alleata e sostenitrice degli slavi dei
Balcani fin dai tempi degli zar.
Con ciò la Jugoslavia era entrata di fatto in guerra.
La risposta tedesca fu infatti altrettanto immediata: il 6 aprile partì infatti la loro
operazione ‘Castigo’ cui si associarono subito anche Italia, Ungheria e Bulgaria.
Massicci bombardamenti su Belgrado (17mila morti!) e sulle altre principali città si
accompagnarono alla facile invasione della Jugoslavia: l’esercito nazionale si
dimostrò incapace di resistere - anche per la defezione dei croati che, insieme alla
loro Chiesa Cattolica, accolsero entusiasticamente le truppe dell’Asse – così re e
governo non poterono far altro che riparare a Londra.
Nello stesso giorno le truppe tedesche (con l’operazione ‘Marita’) arrivarono in aiuto
a quelle italiane anche in Grecia: dopo che il 18 aprile l’esercito jugoslavo aveva
dovuto arrendersi, il 26 anche quello greco dovette capitolare e in pochi giorni tutta
la penisola balcanica venne occupata, smembrata e spartita.
Mentre la Grecia veniva posta sotto occupazione prevalentemente italiana, per la
Jugoslavia cominciò un periodo terribile:
la Slovenia fu divisa fra Germania (il nord) ed Italia (che formò la provincia di
Lubiana);
il Montenegro fu formalmente ricostituito e posto sotto protettorato italiano;
18
la Serbia - persi tutti i territori periferici che aveva inglobato nel trentennio
precedente in favore di Ungheria, Bulgaria ed Albania italiana (che si annesse
l’agognato Kosovo) e ridotta quindi ai confini antecedenti le guerre balcaniche rimase sotto il controllo totale della Germania che impose il governo
collaborazionista (serbo) del generale Milan Nedic;
la Macedonia jugoslava fu ceduta alla Bulgaria (che già si era impossessata di quella
greca);
alla Croazia venne riconosciuta la sospirata sovranità, proclamata già il 10 aprile in
una Zagabria occupata da truppe tedesche da un esponente degli ustascia, Slavko
Kvaternik, visto che Ante Pavelic, il poglavnik, cioè il duce, si trovava ancora in
Italia: anche in questo caso tuttavia non si trattava di tutto il il territorio storico della
Croazia visto che, anche se essa inglobò la Bosnia-Erzegovina, perse però una buona
parte della Dalmazia a favore dell’Italia. Nè finì qui perchè i due Stati non solo
stipularono accordi su un'unione doganale e monetaria, ma stabilirono anche l'ascesa
sul trono di Croazia di un principe di casa Savoia, Aimone d'Aosta duca di Spoleto
(che tuttavia molto prudentemente e realisticamente non mise mai piede nel ‘suo’
regno).
Italia, Ungheria, Bulgaria e Romania ottennero ognuna territori jugoslavi e videro
così soddisfatte richieste avanzate a volte fin dai tempi di Versailles: il Terzo Reich
mirava insomma a favorire le aspirazioni frustrate dei suoi alleati scontenti in modo
da poter contare sul loro appoggio e fedeltà e sulla loro accettazione delle inevitabili
restrizioni dovute alla guerra.
Fu questo soprattutto il caso dell’Italia - che nei patetici vaneggiamenti di Mussolini
avrebbe dovuto imporre un ‘nuovo ordine mediterraneo’ - dal Nordafrica all’Egeo ed
all’Adriatico - fatto di stati sottomessi o satelliti al suo volere ed ai suoi interessi.
Una complicata occupazione
Nella Serbia di dimensioni ridotte ed occupata dai tedeschi vennero prese tutte le
misure criminali che anche tutti gli altri Paesi invasi dovettero purtroppo sopportare
e naturalmente le prime vittime furono gli ebrei: fin da subito, cioè dal 30 maggio
1941, quei poveretti furono sottoposti ad allontanamenti, confische, lavoro forzato,
discriminazioni di ogni genere, ‘arianizzazione’ dei loro beni (cioè la loro confisca a
favore di tedeschi), erano loro gli ostaggi preferiti da fucilare come rappresaglia per
la guerriglia partigiana dei cetnici, ecc. ecc. ... finchè si procedette al loro sterminio
vero e proprio, portato avanti con efficienza ed alacrità tanto che già nell’agosto 1942
il rapporto di Turner, uno dei massimi responsabili dell’operazione, poteva
concludere così: “Serbia, unico paese dove questione Ebrei e questione Zingari
risolte” (Hilberg pag. 690).
Nella Croazia alleata e collaborazionista (la N.H.D. di Pavelic) l’odio etnico e
politico si scatenò improvviso, immotivato, cieco e violentissimo, sorprendendo gli
italiani (e gli stessi tedeschi!) per la sua forsennata intensità: solo tre settimane dopo
19
la nascita del nuovo stato il governo croato varò leggi contro gli ebrei che, totalmente
discriminati e perseguitati, potevano risiedere solo nei quartieri-ghetto
opportunamente approntati per loro e dovevano portare la stella di David sul braccio
per essere immediatamente riconoscibili.
Queste misure erano evidentemente solo propedeutiche al vero e proprio genocidio
finale: per ebrei (e zingari) dopo un’orribile deportazione, anticamera della loro
soppressione nei campi di sterminio presto allestiti, la morte era cosa certa – e con
una gran varietà di sistemi, come malattie, tifo, fame, torture, fucilazioni,
annegamenti, accoltellamenti, colpi di martello in testa, ecc..
(Solo nelle zone controllata dagli italiani i disgraziati poterono trovare sollievo,
protezione e rifugio (come d’altra parte in Grecia e in Francia) e questa è una pagina piuttosto sconosciuta della nostra storia - che ci fa onore perchè le pressioni tedesche
e croate perchè abbandonassimo questo atteggiamento furono ripetute ed insistenti.)
Immediatamente dopo quella degli ebrei (e degli zingari) fu la volta dei serbi di
Croazia (circa 2 milioni su una popolazione complessiva di circa 6 milioni di
persone) e, dato il numero e la forza dei serbi e l’oppressione da loro esercitata sui
croati quand’erano tutti insieme nella Jugoslavia, era chiaro che erano proprio i serbi
il vero bersaglio delle persecuzioni del regime degli ustascia.
La linea da seguire nei loro confronti fu chiara fin dall’inizio ed uno dei motti
preferiti da Pavelic era: “Un terzo dei Serbi deve diventare cattolico, un terzo deve
abbandonare il paese, un terzo deve morire!”, così convertirsi al cattolicesimo fu per
molti serbi (che dovevano portare una ‘P’ sul braccio in quanto ‘pravoslavac’, cioè
ortodosso) l’unico modo di salvarsi la vita mentre più di 700mila (ma le cifre sono
molto incerte) vennero ferocemente massacrati ed i loro corpi (il solito problema
dello smaltimento dei cadaveri!) gettati in mare, nei fiumi, nelle foibe o anche nelle
chiese ortodosse chiamate con scherno “Case del Signore”.
Le torture perpetrate ai danni dei serbi consistevano nello strappare loro gli occhi,
nell’amputar loro le orecchie e il naso, nel seppellirli o crocifiggerli vivi: alle donne
dopo lo stupro venivano tagliate via le mammelle.
Curzio Malaparte nel suo “Kaputt” racconta che sul finire dell’estate 1941 trovandosi
nello studio di Pavelic insieme al Ministro d’Italia, Raffaele Casertano, scambiò il
contenuto di un paniere di vimini sulla scrivania per frutti di mare, ma quando chiese
se erano ostriche della Dalmazia, Pavelic “sorridendo, con quel suo sorriso buono e
stanco” rispose di no: “E’ un regalo dei miei fedeli ustascia: sono venti chili di occhi
umani”. (pag. 296)
Per i serbi fu organizzato insomma un vasto piano di eliminazione che prevedeva il
massacro di una parte di essi e la deportazione dei sopravvissuti o la loro forzata
conversione al cattolicesimo. E fu strage, strage che non solo non trovava alcun
fondamento nelle operazioni belliche o in esigenze (per così dire) di ordine interno,
ma che era dettata solo dall’irrazionalità dell’odio etnico e del fanatismo sanguinario
di chi si inebriava col sogno della purezza razziale: la gravità dell’evento è
testimoniata dal fatto che avvenne nel caos e nell’improvvisazione, tanto che le cifre
20
relative all'eccidio sono ancora piuttosto incerte (la Ljubisic parla comunque di
750mila serbi, 50mila ebrei e 25mila zingari eliminati).
Il regime di Pavelic fu istituzionalmente cattolico all’insegna della ‘Bibbia e della
Bomba’: il poglavnic era considerato dal Primate della Chiesa cattolica croata,
Aloizij Stepinac (beatificato fra l’altro da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1998)
‘un croato devoto’ e nel 1943 da papa Pio XII ‘un cattolico praticante’.
E praticante e devoto lo era sicuramente: spesso ufficialmente in compagnia di
prelati, aveva una cappella privata nel suo palazzo ed il suo confessore era sempre
con
lui.
Innumerevoli religiosi erano ustascia mentre molti vescovi e sacerdoti erano
addirittura membri del parlamento croato stesso.
(A onor del vero, Vesna Drapac informa che dieci anni dopo la sua beatificazione, nel
2008, alcuni storici avrebbero scoperto che in verità l’entusiasmo di Stepinac per gli
ustascia si era affievolito già alla fine del 1941 e che egli in seguito avrebbe
protestato contro e rifiutato il regime razzista.)
Non stupisce comunque che la maggior parte delle chiese serbo-ortodosse in Croazia
vennero depredate, adibite a magazzini, gabinetti pubblici e stalle: nè che molti
religiosi ortodossi vennero assassinati e trucidati, come il pope Branko
Dobrosavljevic, al quale furono strappati la barba ed i capelli, sollevata la pelle ed
strappati gli occhi, mentre il suo figlioletto veniva fatto letteralmente a pezzi dinanzi
a lui.
Eppure i circa 500mila mussulmani vennero considerati da Pavelic di "purissimo
sangue croato" (ed effettivamente ciò che li distingueva era solo la loro religione),
non vennero perseguitati in quanto tali e venne permessa addirittura la costruzione di
una moschea a Zagabria.
Quella che fin da subito gli ustascia intrapresero fu insomma una spietata e feroce
‘rivoluzione razziale’, non religiosa.
Eppure tutto questo orrore che stupì persino i tedeschi (!) andò scemando nel tempo
anche per la fondamentale inefficienza del regime di Pavelic il cui movimento non
godette mai, nè tantomeno ebbe allo scoppio della guerra, un appoggio di massa: i
croati si erano infatti sempre riconosciuti soprattutto nel Partito Contadino, pacifista e
contrario ad assumersi ogni ruolo di collaborazione con le forze occupanti.
Non ci fu mai una rivoluzione o una presa del potere autonoma da parte di
Pavelic e del suo movimento, una marcia per la conquista dello stato basata sulle
proprie forze: il regime degli ustascia potè affermarsi e reggersi solo grazie alle
truppe tedesche ed italiane che erano intervenute nel Paese nè fu mai in grado di
sostenersi da solo – e ciò getta, se possibile, ulteriore discredito sulla loro stolida e
furiosa bestialità.
Come se non bastassero quelle degli ustascia e dei tedeschi, le persecuzioni contro i
serbi vennero perpetrate anche dagli ungheresi della Vojvodina (la regione a
maggioranza serba nel nord della Serbia, da questa acquisita dopo la prima guerra
mondiale ed ora ripresa dall’Ungheria), dai musulmani nella Bosnia-Erzegovina e
dagli albanesi nel Kosovo.
21
Il calvario del popolo serbo si compiva dunque in tutta la ex-Jugoslavia: vent’anni
dopo i traumi della prima guerra mondiale esso era ora sottoposto ad una nuova e
dolorosissima prova e gli effetti, così traumatici sulla coscienza e sull'identità serba,
avrebbero purtroppo fruttificato negli anni successivi e continuato ad influenzare i
comportamenti politici di quel popolo così provato.
Un'immensa ondata di profughi si riversò verso quanto rimaneva della Serbia ma ci
fu anche chi si diede alla macchia organizzandosi in bande armate per resistere alla
spaventosa aggressione: intorno agli ufficiali dell'esercito che erano riusciti a sottrarsi
alla cattura si raccolsero poi i soldati decisi a continuare a resistere.
La resistenza di Mihailovic
Se la Resistenza fu un fenomeno generale dell’Europa occupata dai nazifascisti, fu
però nell’ex-Jugoslavia che nacque.
E nacque immediatamente: bande di cetnici - così si erano chiamati in passato i ribelli
ai turchi - si costituirono infatti fin dallo stesso aprile 1941 in alcune aree serbe e
montenegrine: i cetnici si lasciarono crescere barba e capelli, la loro bandiera al
centro aveva un teschio e si posero sotto la guida del colonnello Mihailovic,
pluridecorato eroe di guerra che era stato onnipresente sul fronte di Salonicco, e di
Kosta Pecanac.
Ancora una volta si trattò di un movimento impetuoso e appassionato, fortemente
motivato dalla fedeltà alla tradizione, alla dinastia ed ai miti della propria storia e che
arrivò a contare quasi 350mila uomini, cioè ebbe le dimensioni di un vero e proprio
esercito.
I cetnici e le truppe di Mihailovic erano serbi e la loro lotta ed la loro azione erano
intese come movimento nazionale serbo per il ripristino della Jugoslavia
serbocentrica e dominata dai serbi.
La strategia di Mihailovic si basava sulla convinzione che, come era avvenuto nella
prima guerra mondiale, la Serbia sarebbe stata liberata dalla vittoriosa avanzata degli
Alleati occidentali: scopo della resistenza doveva dunque essere tener duro ed essere
pronti ad agire in modo decisivo al momento opportuno – esattamente come nel
1918.
Non va poi dimenticato che la maggioranza dei serbi di Serbia riteneva che una
politica attendista fosse preferibile ad incauti tentativi rivoluzionari che avrebbero
condotto ad ulteriori feroci rappresaglie da parte delle forze di occupazione ed alla
distruzione incontrollata del territorio.
Per quanto a prima vista strano e difficile da credere, per molti serbi (e sicuramente
per i cetnici) il principale pericolo per la Jugoslavia e per loro stessi non era costituito
tanto dai tedeschi, dagli italiani, dai bulgari e dagli ungheresi, ma piuttosto proprio
dagli altri jugoslavi, cioè dai croati, dai musulmani della Bosnia e perfino dagli
albanesi.
22
In fondo il ragionamento era semplice: si poteva sopravvivere sopportando gli
stranieri occupanti ed attendendo la fine della guerra, quando si sperava questi
sarebbero stati sconfitti (da altri ovviamente): ma il nemico ‘interno’- jugoslavo voleva invece l’eliminazione di ogni minoranza etnica (serba) sul suo territorio e la
voleva subito, durante e dopo la guerra; con quello non c’era possibilità di accordo e
non si sarebbe fermato mai!
Quello ‘interno’ era dunque il nemico principale, quello da temere veramente.
Alla luce di queste considerazioni appare dunque più che comprensibile che
Mihailovic abbia finito per raggiungere un accordo informale con il regime di Nedic
giustificandolo con la necessità di salvaguardare la Serbia dal rischio delle distruttive
ed inutili rappresaglie tedesche e, soprattutto, dalle pulizie etniche antiserbe (ad opera
soprattutto dei croati).
Ben presto la politica temporeggiatrice adottata da Mihailovic si tradusse in una
debole resistenza (quando giudicata inevitabile) ed addirittura nella collaborazione
colle forze di occupazione italiane e perfino tedesche, collaborazione che si sommò
facilmente allo scontro interetnico in corso ed arrivò a macchiarsi di eccidi e stragi di
croati e mussulmani – tanto che si parlò anche di genocidio ai loro danni.
I cetnici insomma, che pure resistevano all’occupazione nazifascista, erano però
nazionalisti e fieramente anticomunisti; essi volevano una Grande Serbia etnicamente
pura e per tutta la durata della guerra (dal 1941al 1945) esercitarono anch’essi una
politica basata sul terrore etnico: fin dal 1941 Mihajlovic ordinò il genocidio dei
croati e dei musulmani in Serbia, Montenegro e Bosnia - cioè là dove la popolazione
serba era maggioritaria - esattamente come facevano gli ustascia e le milizie
musulmane (istituite dagli ustascia) nei confronti dei serbi di Bosnia e di Croazia.
Tuttavia questa impostazione data alla resistenza da parte di Mihailovic conveniva
anche ai tedeschi: da una parte evitava loro un serio conflitto con la guerriglia cetnica
e dall’altra essi si rendevano ben conto che, per quanto fossero avversari di
Mihailovic, l'unione delle forze di quest’ultimo con quelle di Nedic isolava il Partito
Comunista in Serbia.
Con Tito, segretario del Partito Comunista e leader dell’altra forza partigiana,
Mihailovic aveva tentato invero di negoziare la possibilità di unire le proprie forze,
ma a causa della profonda differenza tra i loro obiettivi (e quindi delle tattiche da
seguire) il tentativo non aveva avuto successo e tra i due schieramenti era nata invece
una fiera ostilità.
Come si vedrà nel prossimo paragrafo infatti, oltre al fatto che Tito era uno
stalinista e Mihailovic uno strenuo anticomunista, Tito era perdipiù a favore di una
repubblica federale fra popoli uguali nei diritti, mentre Mihailovic era invece
monarchico, panserbo nè nascondeva il proprio progetto di pulizia etnica nei territori
della futura Grande Serbia - che avrebbero dovuto includere anche la BosniaErzegovina ed una buona parte della Croazia.
E fu così che il terrore cetnico dopo il 1942 si abbattè (ampiamente ricambiato) anche
sulla popolazione che aiutava l'Esercito di Liberazione Popolare comunista e le
formazioni partigiane di Tito.
23
Nella ex-Jugoslavia si era scatenata insomma la furia sanguinaria dell’hobbesiano
‘bellum omnium contra omnes’: i combattenti non si dividevano solo fra occupanti e
resistenti, ma anche all’interno degli occupati, dei collaborazionisti, degli
appartenenti alle diverse etnie ed alle diverse religioni in un’orgia di sangue ed in un
caos terribile in cui la popolazione civile pagava prezzi allucinanti.
La strategia di Mihailovic finì per comportare inevitabilmente notevoli conseguenze
negative per il suo movimento perchè la collaborazione coi nazifascisti lo screditò
agli occhi degli inglesi, evidentemente interessati a fornire il proprio appoggio a chi
combatteva senza esitazione i tedeschi come facevano con decisione i partigiani
comunisti di Tito (e le forze che combattevano con loro), ai vertici dei quali si
trovavano uomini di diverse estrazioni sociali e di diverse nazionalità - senza
problemi dovuti a queste particolarità.
Fu così inevitabile che, scelto Tito come loro interlocutore, gli Alleati alla fine del
1943 sospesero gli aiuti ai cetnici di Mihailovic e li trasferirono ai partigiani
comunisti di Tito.
La perdita del sostegno della Gran Bretagna fu un duro colpo per i cetnici e per
converso l'appoggio militare e politico dell’Inghilterra costituì un elemento molto
importante della vittoria finale di Tito.
La resistenza di Tito
Ben diversa fu l’impostazione data da Tito (acronimo per Taina Internazionalisca
Terroristica Organizacia) alla resistenza da lui diretta.
Nato in Croazia il 7 maggio 1892, Josip Broz, settimo dei quindici figli di un fabbro
croato e di una madre slovena, pastore durante l’infanzia, a quindici anni aveva
studiato alla scuola serale, ma la svolta della sua vita era avvenuta quando, soldato
dell’Impero austro-ungarico, era caduto prigioniero di guerra dei russi nel 1915:
convertito al bolscevismo e guardia rossa dopo l’Ottobre, aveva sposato una
moscovita ed era stato uno dei fondatori del Partito Comunista Croato.
Rientrato nel 1920 in Jugoslavia, era stato arrestato ed aveva passato sei anni in
carcere: esule in U.R.S.S., organizzatore dell’invio di volontari jugoslavi in Spagna,
nel 1937 gli era stato affidato da Dimitrov (presidente del Komintern) il compito di
riorganizzare il confuso e sbandato Partito Comunista Jugoslavo: con mano ferrea
(una sua costante) aveva proceduto ad una feroce epurazione ed era riuscito a
trasformarlo in un organismo forte, coeso ed altamente disciplinato.
A capo del P.C.J., l’unica formazione che, per quanto ancora poco numerosa, era
però presente in tutte le regioni dello smembrato stato jugoslavo, Tito aveva
accettato completamente l’internazionalismo comunista e la svolta che Stalin aveva
imposto alla politica estera dell’U.R.S.S. nel 1936 con l’apertura di Fronti Popolari
che dovevano includere ogni oppositore del nazifascismo.
La reazione sua e del Partito all’invasione nazifascista fu fulminea: deciso a
combattere senza tregua, con tutti i mezzi e a tutti i costi, il 15 aprile, il giorno stesso
in cui l’esercito jugoslavo capitolava, Tito invitò il popolo “a non disperare della
24
vittoria finale anche se in questo momento soccombe di fronte a un nemico superiore
di numero”: la lezione della rivoluzione russa e la fede potente ed incrollabile nella
fine imminente del capitalismo (e della sua guerra) vivevano in lui con la ferma
convinzione propria dei comunisti.
Il 28 aprile a Lubiana si formò il primo gruppo – interetnico! – di resistenza, il 1
maggio Tito chiamò il popolo a raccolta ed il 4 luglio, divenuto comandante generale,
lanciò nel Paese la mobilitazione generale.
Tito progettava una Jugoslavia postbellica unita ma federale e con tutte le nazionalità
poste su uno stesso piano di parità: con questa strategia si proponeva di uscire dal
vortice dell’odio interetnico e dalla maledizione delle divisioni nazionali e di formare
nell’immediato un fronte unito contro il nazifascismo e le potenze occupanti.
Tito divenne così capo di un'ampia coalizione al cui interno le differenti etnie non
contavano – nè dovevano contare – nulla: tutte erano poste sullo stesso piano.
Chiunque professasse un'ideologia antifascista era accettato in condizioni di parità ed
indipendentemente dalla propria nazionalità.
Seguirono Tito quegli sloveni il cui Paese era stato frazionato dal Terzo Reich e
dall'Italia fascista e che temevano per la loro stessa sopravvivenza nazionale; quei
croati provenienti dalle regioni meridionali annesse all'Italia e quelli che, richiamati
in servizio nell'esercito regolare croato, insieme ai loro ufficiali si unirono invece, in
gran numero con armi ed equipaggiamenti, intorno a lui; quei mussulmani della
Bosnia che, nonostante le offerte di collaborazione di Pavelic - per il quale essi erano
il "fior fiore della nazione croata" – e che a Zagabria aveva fatto erigere perfino una
moschea, avevano constatato la natura autoritaria del suo regime e credevano alla
promessa di Tito che garantiva la futura autonomia della Bosnia-Erzegovina; quegli
altri croati e mussulmani in fuga questa volta dalle atrocità compiute dai cetnici nei
loro confronti; quei macedoni che erano delusi dal regime della Bulgaria (cui erano
stati annessi) e che credevano invece alla promessa di Tito sull’autonomia anche
della Macedonia dopo la guerra; quegli albanesi del Kosovo che magari auspicavano
di poter riunire la loro terra all’Albania vera e propria - allora sotto occupazione
italiana; infine tanti serbi di Croazia e della Bosnia-Erzegovina minacciati di
sterminio da parte del regime ustascia.
Tito si trovò contro tutti gli anticomunisti; tutti quei nazionalisti che si
identificavano solo nella loro etnia che pretendevano dovesse diventare omogenea e
‘pura’ da ogni contaminazione; i collaborazionisti; gli ustascia di Ante Pavelic; i
domobranci (‘difensori della patria’, volontari nazisti) sloveni; quei serbi di Croazia
che, in fuga dal regime di Pavelic, si unirono alle milizie cetniche; infine i cetnici di
Mihailovic, passati ormai dalla parte degli anticomunisti e dei nazionalisti che
combattevano contro Tito e divenuti così una delle forze in campo che dilaniavano la
martoriata Jugoslavia.
Gli eserciti invasori ed occupanti spezzando il regno jugoslavo avevano permesso
all’odio interetnico ed alla violenza nazionalista di scatenarsi in un’orgia di sangue:
in un caos davvero ‘balcanico’ gli schieramenti si accavallavano spesso senza
costrutto in un’orgia di violenza raccapricciante.
25
Qualsiasi elenco delle atrocità commesse da ognuna delle tante parti in lotta sarebbe
incompleto: ognuna di esse ha morti da rivendicare, stragi da ricordare, vendette da
giustificare, orrori da denunciare, colpevoli da additare ... ma la verità è che gli
innocenti e le vittime erano dappertutto, così come le responsabilità.
Anche in Jugoslavia si pagava insomma lo scotto di un assetto europeo costruito
davvero male a Versailles; sicuramente nessuno aveva allora tenuto conto (e tutti
avevano sottovalutato) delle grosse difficoltà che la Jugoslavia avrebbe incontrato,
ecc. ecc., ... tutto vero e tutto giusto, ma tutto ciò non può nemmeno lontanamente
spiegare (figurarsi giustificare) il folle carnaio in cui fanatismi e vere e proprie follie
collettive trasformarono la Jugoslavia.
Certamente anche Tito ed il suo movimento resistenziale praticarono la violenza
indiscriminata di chi non dà alcun valore alla sofferenza umana: per esempio, egli
non si asteneva dal colpire i tedeschi, anche se la rappresaglia era di cento morti per
ogni tedesco ucciso e di cinquanta per ogni ferito - ed anzi riteneva che questo
avrebbe spinto ancor più la popolazione ad opporsi (!).
Eppure va riconosciuto che la sua azione – portata avanti con mano ferrea - era
l’unica fornita di una logica e di una riflessione politica dotata di senso e di realismo.
Nelle zone liberate subito si insediava il regime partigiano come base per ulteriori
operazioni: nessun compromesso era giudicato possibile con i collaborazionisti nè
c’era alcuno spazio per gli esitanti: la decisione rude ed aspra propria delle genti di
queste montagne impervie e difficili si impose rigorosa fin dall’inizio – ma, d’altra
parte, questa è sempre stata una caratteristica dei popoli dei Balcani.
A costo di ingenti sacrifici, di molto sangue e di spietati combattimenti, le zone
liberate cominciarono a moltiplicarsi: Mosca – diffidente nei confronti della
indipendenza (giudicata eccessiva) di Tito e scarsamente interessata alla Jugoslavia
(che giudicava appartenere alla sfera d’influenza inglese) – non mandava aiuti, ma i
partigiani di Tito potevano supplire a ciò con l’ingente bottino delle armi strappate
agli italiani (e non solo dopo l’8 settembre 1943, quando, comunicata la resa
incondizionata dell’Italia, l’esercitò italiano si squagliò più velocemente della neve al
Sole).
Per conseguire un ordine ed un coordinamento sempre maggiori nelle zone liberate e
nella guerriglia partigiana, verso la fine del 1942 venne costituito l’A.V.N.O.J. (il
Consiglio Antifascista di Liberazione Nazionale della Jugoslavia) nel quale non
sedevano solo comunisti - anche se essi erano in forte maggioranza.
Data la situazione, fu inevitabile che nei primi mesi del 1943 gli Alleati togliessero il
loro supporto ai cetnici, accusati di collaborare con l'Asse, e scegliessero Tito come
l’alleato da sostenere – e questa decisione fu ratificata ufficialmente alla Conferenza
di Teheran (dal 28 novembre al 10 dicembre 1943).
Ciò significò aiuti (prima da parte degli statunitensi dopo la resa dell’Italia nel
settembre 1943 e poi soprattutto della Gran Bretagna) ed isolamento di tutti i suoi
avversari, mentre il re ed il governo in esilio a Londra avevano ormai scarsa voce in
capitolo.
26
Il 16 giugno 1944 fu comunque firmato sull'isola di Lissa (in Croazia) un accordo tra
Tito e il governo monarchico in esilio, noti come Accordi Tito-Subasic o Trattato di
Lissa: in esso si chiamavano tutti gli sloveni, i serbi ed i croati ad aderire alla lotta
partigiana di Tito i cui guerriglieri furono riconosciuti dal governo reale per quello
che erano di fatto e senza bisogno di ratifiche, l'esercito regolare della Jugoslavia.
Mihailović e molti cetnici si opposero agli accordi, così, su pressione di Churchill, il
29 agosto re Pietro II destituì Mihailović dalla carica di comandante in capo
dell’esercito (lo era dal gennaio 1942) ed il 12 settembre mise Tito al suo posto.
Nel settembre 1944 Tito incontrò Churchill in Italia e in ottobre (per la prima volta)
Stalin a Mosca.
Gli Alleati rinunciarono allo sbarco vagheggiato da Churchill nell’alto Adriatico ed
alla conseguente invasione dei Balcani (in funzione antisovietica) in favore di uno
nell’alto Tirreno francese (a Tolone e a Marsiglia): gli jugoslavi ebbero così mano
libera e a metà settembre le formazioni di Tito avevano raggiunto il controllo di
quasi tutto il loro territorio nazionale.
Intanto il 9 settembre 1944 l’Armata Rossa era entrata in Bulgaria ed il 28 Tito
autorizzò un ‘temporaneo ingresso delle truppe sovietiche in territorio jugoslavo’:
anche se Belgrado fu liberata il 18 ottobre da forze congiunte, la Jugoslavia si era
però liberata da sola, essendo stata disposta a pagare costi terribili per questo
risultato.
Tito, indipendente ed abituato a far di testa sua, ne era ben consapevole, voleva che
ciò fosse chiaro a tutti e si sarebbe comportato sempre di conseguenza: già in
novembre le truppe sovietiche abbandonavano infatti il territorio jugoslavo (!).
La resa dei conti
Coloro che avevano combattuto coi tedeschi (e cogli italiani) e che spesso avevano
commesso atrocità inenarrabili spesso tentarono la fuga verso occidente con le loro
famiglie al seguito e macchiandosi di delitti e distruzioni terribili di tutti e di tutto ciò
che trovavano sul cammino della loro fuga disperata.
Fu così che i resti del famigerato Gruppo E del generale Lohr che dalla Grecia
stavano risalendo i Balcani raccogliendo esercito croato, reparti ungheresi,
nazionalisti sloveni, monarchici serbi, formazioni albanesi, cosacche e montenegrine
insieme a connazionali e famigliari (donne e bambini compresi), ormai arrivati alla
Drava vennero rimandati indietro dagli inglesi e, finiti così nelle mani dei titini,
furono ferocemente trucidati in massa;
anche gli ustascia croati e domobranci sloveni che erano riusciti ad arrivare in Austria
(fra Bleiburg e Loibach) con l’intenzione di arrendersi agli inglesi furono parimenti
consegnati ai partigiani jugoslavi (così come prescrivevano gli accordi di Yalta):
nonostante le disperate suppliche e migliaia di suicidi, 300mila (!) ustascia vennero
trasportati su vagoni piombati di nuovo in patria dove, consegnati alle truppe di Tito,
27
più di 100mila vennero eliminati subito ed altre migliaia (quante?) morirono di stenti
durante la ‘marcia della morte’ verso i campi di lavoro;
anche i domobranci sloveni furono consegnati dagli inglesi ai titini e le vittime
dell’immediato massacro furono più di 12mila (su un totale di 13mila ai tempi
dell’occupazione);
naturalmente insieme a questi gruppi maggiori altre migliaia di collaborazionisti delle
varie altre nazionalità jugoslave fecero la stessa fine;
a guerra finita, nel maggio 1945 gli inglesi consegnarono ai partigiani jugoslavi anche
tre reggimenti serbi e 11mila ausiliari sloveni che avevano combattuto contro Tito:
tutti vennero messi a morte;
anche 80mila soldati e 30mila civili croati, consegnati ai titini, vennero sterminati.
Impressiona che - pur nella indescrivibile fornace sanguinaria jugoslava - queste
stragi non abbiano lasciato praticamente segno: Pirjevec in “Le guerre jugoslave” non
ne fa alcuna menzione; La Perna in “Pola – Istria - Fiume 1943-1945” dedica a questi
massacri un accenno in una frettolosa nota a piè di pagina (86); e ne “L’esodo”
Petacco conclude che “di questo immane sterminio avvenuto in tempo di pace ... il
Maresciallo Alexander non fa alcun cenno nelle sue memorie.” (pag. 121)
A guerra finita i cetnici erano comunque ancora numerosi: alcuni si unirono alle forze
tedesche per non arrendersi ai sovietici ed ai partigiani di Tito, ma molti (ben
206mila!), anche per evitare le rappresaglie contro i collaborazionisti, si unirono ai
titini vincitori, sia individualmente che in intere unità.
Tra il 21 novembre 1944 ed il 15 gennaio 1945 Tito offrì ulteriori amnistie di cui
beneficiarono, appunto, soprattutto i cetnici.
Mihailovic con i pochi fedelissimi rimasti tentò di fuggire in Austria, ma, intercettato
e catturato dall’O.Z.N.A. (la polizia politica comunista), nel luglio 1946 fu processato
con l’accusa di tradimento e giustiziato: gli Alleati lo lasciarono al suo destino per
non guastare i rapporti con Tito.
Secondo un copione seguito da molti criminali nazisti, Pavelic dopo aver guidato fino
all'ultimo le sue truppe riuscì a fuggire dapprima in Austria, quindi a Roma e poi in
Argentina: seriamente ferito colà in un attentato, finirà i suoi giorni nella Spagna di
Franco nel 1959.
La Chiesa di Roma, Pio XII ed il suo Segretario di Stato cardinal Montini furono - e
sono - fortemente sospettati di averne favorito la fuga attraverso i monasteri ed il ‘rat
channel’ (il canale dei topi), la sezione vaticana della famosa organizzazione
‘O.D.E.S.S.A.’ che, creata dopo la fine della guerra da Otto Skorzeny, si incaricò di
mettere in salvo i criminali nazisti ed i loro alleati.
Nel 1946 - per ripulire definitivamente il Paese dagli indesiderabili - dei 500mila
tedeschi che ancora ci vivevano 290mila furono scacciati (ed andarono ad
aggiungersi ai milioni e milioni che un po’ da tutta Europa ne stavano condividendo
il destino) e 130mila furono uccisi o deportati.
Nel chiudere definitivamente i conti e nel ripulire per bene il Paese non si andò certo
per il sottile – ed ora lo si poteva interamente ricostruire secondo il nuovo progetto.
28
La Jugoslavia di Tito
Feito giudica la Jugoslavia “prodotto inatteso della seconda guerra mondiale” (pag.
47) ed ha ragione: gli jugoslavi si erano mossi da soli ed in modo autonomo facendo
nascere uno stato nuovo e non previsto dalle Potenze Europee; avevano trovato un
diverso modo di stare ancora insieme; dal basso e dalla lotta durissima si era forgiata
una nuova classe dirigente di sperimentatissima affidabilità.
I prezzi pagati erano stati comunque altissimi: i morti erano stati 1.700mila (fra cui
l’80% degli ebrei), cioè più di un decimo della popolazione totale - quattro volte
quelli dell’Italia, che però ne aveva due volte e mezzo gli abitanti.
Anche in questo caso, come dopo il primo conflitto mondiale, la guerra era stata un
orrendo bagno di sangue, ma quelle genti così dure erano capaci anche di pagare
prezzi simili per la loro indipendenza e libertà.
Il nuovo stato che fondarono con tanti sacrifici si sarebbe sempre mosso in modo
autonomo ed originale.
Tito - divenuto fin dal novembre 1943 il Maresciallo Tito - aveva sempre concepito
la sua azione come volta al mantenimento della Jugoslavia entro i suoi confini
antebellici (anzi, ad ampliarli a spese dell’Italia): ben conscio tuttavia della
complessa situazione interna, fatta di popoli diversi che avevano combattuto
crudelmente fra di loro e le cui aspirazioni autonomistiche, quando non
indipendentistiche, erano sempre state – e lo erano ancora – molto forti, capiva bene
che l’unica soluzione possibile non poteva che essere quella di una federazione;
infine, comunista convinto, per lui la nuova Jugoslavia doveva essere trasformata in
uno stato socialista.
In una parola, era favorevole al modello sovietico.
Dal 29 novembre al 4 dicembre 1943 alla seconda riunione dell’A.V.N.O.J. tenutasi a
Jaice (in Bosnia-Erzegovina) era stata così fondata la Democrazia Federale di
Jugoslavia.
A guerra finita Tito su pressione delle Potenze vincitrici (e di Stalin - che a tutti i
costi non voleva che i rapporti con loro si guastassero) dovette giungere ad un
accordo col governo regio in esilio a Londra ed adattarsi nel marzo 1945 ad un
governo di coalizione con un rappresentante di quest’ultimo, tal Subasic: era tuttavia
chiaro chi controllava davvero il Paese e chi aveva dalla sua la forza dell’esercito,
insomma chi aveva il potere e comandava.
Chi aveva forgiato nel sangue e nella durissima lotta non prendeva – ma come
avrebbe potuto? – nemmeno in considerazione l’idea di spartire il governo con chi era
stato in esilio e/o al sicuro, nè di stabilire insieme a questa gente il tipo di stato che la
Jugoslavia sarebbe dovuta diventare: così già nell’agosto Pietro II fu spinto a rompere
le relazioni con Belgrado e nell’ottobre Subasic dovette dimettersi.
Le elezioni dell’11 novembre seguente per l’Assemblea Costituente vennero tenute
su una sola lista (governativa) in cui alcuni partiti allineati facevano da corona ai
comunisti: durante la campagna elettorale erano riemerse le vecchie divisioni
29
nazionalistiche, religiose e particolaristiche, ma i partigiani avevano reagito con
violenza ponendo fine senza tanti riguardi (diciamo così) alla possibilità stessa di
prendere in seria considerazione queste posizioni.
Nonostante ci fosse stato anche chi per questo aveva invitato gli elettori ad astenersi,
in realtà votò l’88,6% degli oltre 8 milioni di elettori e più del 90% dei voti andò al
Fronte Popolare dei partigiani.
Il 31 gennaio 1946 dall’Assemblea eletta per questo scopo venne così varata la
nuova Costituzione che sancì la nascita della Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia, una federazione che comprendeva sei repubbliche dotate di una propria
autonomia, Montenegro, Macedonia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e
Serbia: tuttavia, nonostante le stragi e le pulizie etniche del periodo di guerra, solo la
Slovenia poteva contare su una popolazione etnicamente omogenea e, insomma, la
maledizione delle minoranze e delle nazionalità mescolate rimaneva ancora.
I comunisti non avevano intenzione di ripetere l’errore di re Alessandro che aveva
immaginato una Jugoslavia unitaria che in realtà non era mai esistita: la vecchia
Jugoslavia serbocentrica sembrava comunque finita anche perchè la Serbia perdeva
Montenegro e Macedonia, mentre Vojvodina (a nord) e Kosovo (a sud), due delle
sue province, pur continuando a farne parte, venivano però proclamate autonome.
Quanto la Serbia aveva guadagnato con guerre ed immensi sacrifici (ed aveva perso
con l’occupazione nazifascista) continuava ad essere perso e si sarebbe detto che Tito
aveva voluto una Serbia debole per avere una Jugoslavia forte.
Sulle sponde dell’Adriatico si riproponeva insomma un’U.R.S.S. in piccolo e, anche
se il suo primo presidente fu un certo Ivan Ribar, il potere era sicuramente
concentrato nelle mani del Maresciallo Tito, seppur ufficialmente solo primo ministro
(nel 1953 Tito sarebbe stato infine eletto presidente e lo sarebbe rimasto fino alla
morte).
Sul fronte estero questa nuova Jugoslavia così unita, rivoluzionaria e dinamica, apriva
scenari nuovi ed imprevisti e presentava una notevole spinta espansionistica in tre
direzioni:
per quanto riguardava l’Italia nord-orientale, vedere il mio “Pulizia etnica
antitaliana”;
per quanto riguardava la multietnica, contesa e divisa Macedonia, la Jugoslavia
(grazie all’appoggio sovietico) potè annettersi la parte bulgara, ma dopo complicate
vicende non potè fare altrettanto con la parte greca (nonostante partigiani slavi vi
avessero combattuto) - e ciò provocò due esodi dei macedoni slavi dalla Macedonia
greca verso la Macedonia slava;
per quanto riguardava l’Albania, essa seguì tutte le orme della Jugoslavia e ne
sembrava un’appendice, ma nel 1948 la situazione sarebbe completamente mutata.
30
I primi passi
La Jugoslavia dal punto di vista politico era un Paese con una struttura di potere
sicuramente chiara e stabile: sotto la mano ferma di Tito governavano i comunisti che
avevano gloriosamente combattuto una durissima guerra di liberazione: Tito
procedette rapidamente ad una decisa epurazione che servì a serrare ancora di più i
ranghi mentre sul versante economico venne operata una nazionalizzazione radicale
che già nel 1946 aveva posto nelle mani dello stato l’intero settore industriale.
Tuttavia l’economia jugoslava era debole ed arretrata e le devastazioni ed i morti
della lunga guerra l’avevano ovviamente grandemente peggiorata: come dappertutto
in Europa era ora il tempo di ricostruire – compito certo non facile, dato che la
Jugoslavia mancava allora di tutto (crediti, tecnici, infrastrutture, perfino operai
qualificati), oltre al fatto che essa allora era ancora interamente legata all’U.R.S.S.
(ed ai suoi interessi).
Nonostante le condizioni davvero difficili, per il mondo comunista (almeno in linea
teorica) il problema era però di facile soluzione: il comunismo ha infatti sempre
creduto solo nell’economia pianificata, cioè gestita dall’alto, e la pianificazione è
possibile solo se l’economia stessa è stata nazionalizzata, cioè se i mezzi di
produzione appartengono allo stato e non ai privati.
E’ questo insomma il noto capovolgimento dell’economia (capitalistica) di mercato
che, a partire dall’U.R.S.S., tutti i Paesi comunisti hanno sempre praticato.
E non basta: nell’ambito di questa pianificazione – come già aveva fatto Stalin in
U.R.S.S. – la posizione preminente spetta poi all’industria ‘pesante’ - base della
produzione bellica e della stessa industria ‘leggera’.
Ora, la Jugoslavia possedeva le materie prime necessarie, ma mancava di
attrezzature, manodopera qualificata e crediti, tutte cose che poteva trovare solo
grazie all’aiuto ed alla collaborazione con l’estero.
Come sempre, l’U.R.S.S. era disposta a fornire strumenti e sostegno per la
meccanizzazione dell’agricoltura, ma non a sostenere lo sviluppo di un’industria
(soprattutto degli armamenti) jugoslava: si trattava insomma del (solito) tentativo di
operare la (solita) divisione internazionale del lavoro che avrebbe lasciato l’U.R.S.S.
l’unica potenza industriale del campo socialista – cioè la sua potenza dominatrice.
Tito ed il suo stato maggiore non avrebbero mai potuto accettare quest’impostazione
che li avrebbe resi strutturalmente subalterni e reagirono con una mobilitazione
nazionale paragonabile a quella con cui avevano chiamato il popolo alla resistenza:
alla mancanza di attrezzature e di esperienza si oppose l’ottimismo, l’orgoglio, lo
sforzo volontario della gioventù, l’entusiasmo popolare – si seguì cioè il copione già
adottato in U.R.S.S. ai tempi della super-industrializzazione staliniana.
Ancora una volta nulla di nuovo insomma, se non l’esplicita volontà di non dipendere
da nessuno, cioè dall’U.R.S.S. – e per un comunista dei tempi di Stalin era
impossibile trovare un’eresia più grossa.
31
Emarginati ed allontanati i prudenti, gli incerti e gli accondiscendenti, il 26 aprile
1947 Tito presentò all’Assemblea il piano quinquennale (anche qui, nessuna
deviazione rispetto alla prassi comunista) insistendo sull’indipendenza della
Jugoslavia anche in questo campo – e questa non era assolutamente retorica!
Il piano voleva trasportare un popolo di pastori e di contadini nella piena civiltà
industriale ed evidenziava tutta la determinazione della leadership jugoslava - ed
anche la sua ambizione: in questa sede non è il caso di ripercorrere interamente il
piano stesso e per averne un’idea basterà ricordare alcuni dei suoi obiettivi principali.
Il 98% della produzione di metalli (la Jugoslavia era ricca di miniere) era in mani
straniere, come del resto il 50% di tutta l’economia nazionale: si sarebbe allora
dovuto passare da questa condizione semicoloniale a quella di potenza industriale; in
cinque anni la produzione metallurgica sarebbe dovuta aumentare sette volte; quella
dei materiali da costruzione otto volte; quella dell’industria chimica nove volte;
quella di corrente elettrica quattro volte; quella del coke e del carbone tre volte;
quella dell’acciaio tre volte; si sarebbe dovuto raddoppiare il numero degli operai e
moltiplicare quello dei diplomati e dei laureati.
Aspetto importante del piano era che esso si articolava anche repubblica per
repubblica e teneva conto delle specificità e del grado di sviluppo di ognuna in modo
da essere calzante ed appropriato alla loro realtà economica diversificata – la
Jugoslavia evidentemente era federale anche in economia.
L’energia e lo spirito d’iniziativa con cui il piano partì si accompagnarono alle misure
volte a punire come tradimenti le esitazioni e gli scoraggiamenti ed a quelle che
proteggevano la segretezza con cui si doveva procedere (in modo da non dare appigli
di conoscenza al nemico).
Certamente le difficoltà non mancarono e l’entusiasmo dovette fare i conti con la
realtà della mancanza di macchine e la insufficienza dell’agricoltura a fornire il
surplus necessario all’esportazione in modo da poterle comprare all’estero, mentre la
formazione di quadri tecnici e di operai specializzati procedeva anch’essa più lenta e
difficile del previsto.
Fu in questo quadro che si inserì il cosiddetto ‘contro-esodo rosso’ di italiani: se
ovviare alla partenza forzata degli italiani delle regioni giulie (l’esodo, appunto) era
stato facile nelle campagne, non così fu invece nei cantieri navali (soprattutto) e nelle
fabbriche.
Per rimediare alla mancanza di tecnici e di operai specializzati i comunisti italiani ed
i comunisti jugoslavi nel più rigoroso segreto raggiunsero l’accordo per cui fin dal
1947 lavoratori qualificati (e politicamente fidati) italiani furono trasferiti
clandestinamente in Istria ed in Dalmazia (ma anche nelle regioni dell’interno) con le
famiglie al seguito.
L’operazione venne condotta di nascosto e senza che la stampa se ne accorgesse (!).
Come dice bene con amara ironia Petacco ne ‘L’esodo’, questi italiani avevano il
compito di “insegnare agli jugoslavi come far funzionare i nostri cantieri di cui si
erano impadroniti”. (pag. 172)
32
In terra jugoslava si riformava quindi una piccola comunità di italiani con le loro
scuole ed i loro servizi: essi erano tutti militanti del P.C.I. altamente selezionati dal
punto di vista ideologico e politico perchè si trattava di costruire la nuova Jugoslavia
comunista: certamente nessuno li aveva costretti, anche se la propaganda del Partito
Comunista della Regione Giulia era stata molto insistente: visto che in Italia la
rivoluzione non c’era stata, tecnici ed operai specializzati – comunisti, s’intende erano caldamente invitati ad andare a vivere in un Paese dal socialismo realizzato e lì
lavorare per il suo successo - quindi per la causa del comunismo mondiale.
Un aspetto però illustra in modo lampante il carattere così gelosamente nazionalistico
(!) e sospettoso della nuova Jugoslavia: nonostante gli italiani del contro-esodo
fossero di sperimentatissima fede comunista, anche se erano stati richiesti di recarsi
nel Paese dalle sue autorità che avevano un così grande bisogno di loro, anche se
erano venuti per lavorare con abnegazione e disciplina, nonostante stessero
dimostrando di essere disposti a sacrifici notevolissimi (la Jugoslavia era davvero in
condizioni pessime), ebbene, nessuno di loro potè entrare a far parte del P.C.J. – alla
faccia dell’internazionalismo proletario e della fratellanza dei popoli nella lotta
comune per il successo della causa comune.
La rottura con Stalin
Nell’autunno 1947 all’interno del movimento comunista internazionale la Jugoslavia
godeva di grande prestigio: Tito ed il P.C.J. avevano infatti fin dall’immediato
dopoguerra assunto tutto il potere e proceduto sulla strada della riorganizzazione del
Paese da soli e seguendo con decisione la via socialista - senza porsi il problema di
contenere e di limitare le misure adottate allo scopo di mantenere buoni rapporti con i
non-comunisti dell’interno e coll’Occidente all’estero.
Essi avevano cioè anticipato quella rottura fra le Potenze vincitrici della guerra che
ormai si era verificata e che ora imponeva anche a Stalin di serrare i ranghi e di
stringere definitivamente la presa su tutti gli Stati socialisti: non era stato quindi un
caso che Belgrado era stata scelta come sede dell’importante e sensibile Ufficio
d’Informazione (il Kominform, parziale sostituto della Komintern, già sciolta da
Stalin nel 1943 per favorire la sua alleanza con l’Occidente).
Era dalla fine della guerra che Stalin si stava muovendo con la sua consueta capacità
manovriera per organizzare e dominare compiutamente gli stati dell’Europa centrale
che già controllava (chi più chi meno) fortemente: non è qui il luogo di ripercorrere –
nemmeno per sommi capi – il complicato, spietato e spesso sotterraneo gioco politico
che si svolse per realizzare in tutta la sua gravità il disegno imperiale di dividere
l’Europa in due e di assoggettare completamente la sua metà orientale, basterà così
ricordare che il colpo comunista di Praga (nel Paese più ‘occidentale’ fra quelli nella
sfera sovietica) del febbraio 1948 e le elezioni italiane del 18 aprile 1948 mostrarono
al di là di ogni possibile dubbio che l’Europa era stata definitivamente segata in due
33
(dall’U.R.S.S. e dagli U.S.A.) e che soprattutto a Est la sua libertà di manovra era
divenuta pressochè nulla.
Anche la Jugoslavia stava finendo fra i Paesi ‘a sovranità limitata’ (come li si sarebbe
detti anni dopo) e se voleva evitare di fare questa fine Tito doveva agire subito – e
così fece.
Fu così che quando nella seconda metà di giugno 1948 in Romania si riunì il
Kominform (l’istituzione nata per imporre a tutti i comunisti l’obbedienza a Mosca)
gli jugoslavi non vi parteciparono ed il 28 giugno da Praga (sede certamente non
scelta a caso) venne data ufficialmente la notizia di tale rottura – perchè un gesto del
genere significava rottura davvero profonda – che colse il mondo incredulo.
La notizia del rifiuto della Jugoslavia di aderire all’organizzazione di tutti i partiti
comunisti del mondo rese ufficiale e definitivo lo scontro in atto, ma ovviamente da
tempo i rapporti fra U.R.S.S. e Jugoslavia si erano tesi in misura crescente – almeno
fin da quando (come si è già visto) quest’ultima aveva voluto definire in modo
autonomo il suo primo piano quinquennale per raggiungere l’autosufficienza in
campo economico.
Le schermaglie erano state continue: estremamente sintomatico era poi il fatto che
mentre Mosca si rivolgeva al ‘comunista’ Tito (per ricordargli che la fedeltà alla
causa del comunismo da lei diretta veniva prima di tutto), quest’ultimo parlava
invece di ‘rapporti fra stati’ (per sottolineare che invece qui si trattava
dell’indipendenza della Jugoslavia).
Lo spirito d’indipendenza di Tito e la sua volontà di non farsi condizionare avevano
già portato alla decisione di Mosca del 18 marzo precedente di ritirare tutti i
consiglieri e gli istruttori militari sovietici dalla Jugoslavia.
Il Comitato Centrale del P.C.J. del 13 aprile era stato categorico nel respingere le
accuse sovietiche di allontanamento dalla difesa della causa socialista e quei suoi
membri disposti al compromesso vi erano stati isolati: ciò era essenziale perchè
Mosca faceva di tutto per scardinare la politica di Tito dall’interno (come aveva
sempre fatto dappertutto) e per avere così una direzione jugoslava a lei fedele: non a
caso la scomunica del 28 giugno invitò infatti “le forze sane del Partito comunista
jugoslavo a imporre una nuova linea politica alla direzione”.
La Jugoslavia poteva permettersi di insistere sulla sua autonomia perchè si era
liberata da sola ed aveva quindi l’esperienza, l’autorevolezza e la capacità stessa per
poter continuare sul suo cammino senza doversi sottomettere a nessuno, ma il
precipitare della ‘guerra fredda’ richiedeva invece che l’U.R.S.S. potesse disporre a
proprio piacimento di tutto il ‘campo socialista’.
Tutti i mezzi vennero usati per ricondurre la Jugoslavia all’ordine: infiltrazioni nel
partito, nell’esercito e nello stato di elementi fedeli a Mosca; spionaggio per
disarticolare la catena di comando e le strutture stesse dello stato jugoslavo;
propaganda e lusinghe; minacce sempre più esplicite.
Non stupisce che ci furono molti militanti e dirigenti jugoslavi che vollero rimanere
sinceramente leali verso Mosca nè lo stesso Tito avrebbe voluto rompere col Paeseguida del comunismo di cui aveva cercato l’appoggio tanto necessario (per es. su
34
Trieste), ma ai suoi occhi tutto ciò sarebbe dovuto avvenire su una base di parità fra
le parti, fra alleati, fra compagni, fra stati, e non nell’ambito di un inaccettabile
rapporto di subordinazione.
Tutti gli altri Paesi e partiti comunisti (italiano e francese compresi) rimasero dalla
parte dei sovietici e fecero più o meno diplomaticamente pressioni sugli jugoslavi
perchè accettassero di sottomettersi, o di adeguarsi, o insomma di rientrare
fedelmente nei ranghi - e questo atteggiamento era più che comprensibile: uscire
dalla sfera sovietica per un partito comunista (o per un militante) era uscire dal
proprio mondo fatto di fedeltà incrollabile alla causa che da Mosca Stalin difendeva e
diffondeva nella storia e nel mondo.
Allontanarsi o, peggio, rompere con l’U.R.S.S. significava dunque condannarsi
all’isolamento ed all’impotenza, tradire una fede vissuta con incrollabile sicurezza - e
di altri Luteri nella Chiesa comunista non si vedeva l’ombra.
Gli effetti della rottura furono gravi e misero il Paese in serio pericolo: la Jugoslavia
del 1948 si ritrovò ad essere un Paese isolato e circondato da nemici, mentre le sue
condizioni interne (economiche) erano a dir poco estremamente precarie.
Gli aiuti dai Paesi socialisti (soprattutto dalla Cecoslovacchia) su cui si era fatto tanto
affidamento cessarono immediatamente ed i confini con essi divennero vere barriere
da vigilare con attenzione anzichè semplici demarcazioni fra stati amici ed alleati.
Se la rottura con Stalin ebbe echi un po’ in tutto il pianeta, certamente molto più forti
furono le sue ripercussioni nel mondo comunista: l’U.R.S.S. infatti per evitare che un
capo così fidato e prestigioso come Tito potesse trovare emulatori aumentò la sua
presa ed i suoi controlli su tutti i partiti comunisti rafforzando (come se ce ne fosse
stato bisogno!) il suo dominio su di loro e quindi sui loro Paesi:
l’Albania era molto legata alla Jugoslavia in tutti i settori e dipendeva largamente da
essa: il suo amico più sincero era il giovane ministro degli Interni Xoxe, ma subito
dopo la rottura il capo del partito Enver Hoxha riuscì ad emarginarlo
progressivamente ed a sconfiggerlo schierando così anche l’Albania contro l’eretica
Jugoslavia. L’ironia fu che egli usò gli stessi argomenti che Tito aveva usato contro
Stalin, e cioè rivendicò l’autonomia e l’indipendenza del suo Paese contro la
Jugoslavia troppo ‘protettrice’;
anche in Bulgaria Tito poteva contare numerosi amici, ma aveva anche nemici che
rimasero fedeli a Mosca e che sotto la guida di Cervenkov anche qui riuscirono a
prevalere emarginando, silurando ed eliminando l’ala cosiddetta ‘nazionalista’ del
partito;
in Ungheria la forte minoranza jugoslava volle restare fedele alla madrepatria e
dovette così rinunciare alla tolleranza goduta fino a quel momento.
Questa progressiva trasformazione dei partiti comunisti in caste sottoposte e soggette
ad una disciplina militare esterna li avrebbe separati sempre di più dalle loro società
di appartenenza – e nel 1989 la loro fine così patetica e ridicola avrebbe messo fine
ad un grottesco ed insensato accanimento terapeutico.
35
Titoismo e Cominformismo
Per resistere all’isolamento della Jugoslavia la dittatura del Partito sul Paese ed
all’interno del Partito stesso non potè che accentuarsi e fu in queste condizioni che
venne accelerata la collettivizzazione delle terre: si doveva dimostrare che la base
sociale della Jugoslavia non era costituita di kulaki ed inoltre ciò serviva al
rafforzamento del dominio e del controllo da parte del Partito sull’intera società.
Per resistere allo scontro nella Jugoslavia partì inevitabilmente una caccia alle streghe
con l’accusa di ‘cominformismo’ rivolta a quei comunisti che volevano rimanere
fedeli a Mosca, mentre dall’altra parte, nel ‘campo socialista’, per chiunque fosse
sospettato di volere una maggiore autonomia o soltanto ricucire con Belgrado
l’accusa – gravissima - era di ‘titoismo’.
Dunque altre difficoltà, altre lotte, altre persecuzioni (almeno 1600 arresti conosciuti,
2572 ‘rieducati’, lager come quello sull’isola di Goli Otok, sorvegliati speciali, ecc.),
altre sofferenze ed emigrazioni si sommarono alle precedenti, ma in questo modo
Tito evitava anche un altro grande pericolo (di cui pure l’U.R.S.S. lo avvertiva
minacciosa) e cioè che, usciti da un campo, non si poteva che finire nell’altro (quello
occidentale e capitalista) o comunque esserne strumentalizzati e ricattati.
Tito voleva invece salvare la capra della sua indipendenza e i cavoli del far rimanere
la Jugoslavia un Paese socialista.
Il mondo comunista è sempre stato un mondo di persecuzioni e di eliminazione degli
avversari (veri o presunti) e le polizie politiche, potentissime e feroci, hanno sempre
avuto molto lavoro da svolgere: camere di tortura, lager, eliminazioni, censure e
propaganda sono sempre state la regola ma, naturalmente, a diverse intensità a
seconda dei casi e delle situazioni: ora l’intensità delle repressioni crebbe e, fra gli
altri, ne fecero le spese anche quegli italiani del ‘contro-esodo rosso’ che, tutti di
provata fede stalinista, furono sospettati di complottare contro Tito al soldo
dell’U.R.S.S. e così anche su di loro cadde pesante la mannaia degli imprigionamenti,
delle torture, del lager.
Caratteristica del mondo comunista è sempre stata anche la consegna del silenzio:
tutte le persecuzioni – questa compresa – operate ai danni di comunisti da parte di
altri comunisti dovevano essere condotte nel silenzio (anche delle vittime!) durante
(ed anche dopo!) la persecuzione stessa (!) per motivi di immagine e di propaganda e
per non danneggiare la causa socialista rivelando all’avversario i contrasti interni che
egli avrebbe potuto usare nella sua azione e nella sua propaganda.
Dunque anche menzogna, calunnia e silenzio si aggiunsero nell’orrore dell’aumento
dell’oppressione.
Infine, la battaglia era anche eminentemente ideologica: all’accusa di
‘deviazionismo’, cioè di allontanarsi dalla retta via del marxismo-leninismo, Tito
ebbe buon gioco nel ribattere che quest’ultimo non era un dogma immutabile, ma una
prassi da adattare alle circostanze nell’azione creatrice rivoluzionaria.
36
Chi conosce anche superficialmente la mentalità comunista, fatta di convinzioni
saldissime e di fede indiscussa, si può rendere conto facilmente di quanta
spregiudicatezza ebbero bisogno gli jugoslavi per rimanere decisi sulla loro strada
che li isolava completamente da tutti quelli con cui avevano sperato, combattuto tanto
e condiviso la costruzione del comunismo internazionale.
Socialismo ed autogestione
Quando si consumò lo strappo con l’U.R.S.S. la Jugoslavia non era certo in buone
condizioni economiche: il primo piano quinquennale - entusiasmo e propaganda a
parte - stava attraversando le grandi difficoltà che una gestione burocratica e
centralizzata dell’industria in un Paese arretrato e semidistrutto non poteva non
incontrare, mentre la collettivizzazione della terra aveva esasperato i contadini ed i
raccolti erano deludenti.
La cessazione dell’aiuto sovietico e del collegamento economico coi Paesi socialisti
coi loro sbocchi commerciali costituì poi un’aggravante molto seria nella congiuntura
economica jugoslava: era legittimo chiedersi addirittura quale sarebbe stato ora il
destino della Jugoslavia - ma gli jugoslavi seppero reagire.
Essi, che avevano incolpato i sovietici di avere instaurato una dittatura burocratica
nella quale il potere era concentrato nelle mani di una casta ristretta, vollero
procedere invece nella direzione opposta, cioè verso il decentramento: gran parte dei
poteri centrali vennero così trasferiti agli organi regionali e periferici e ciò, oltretutto,
serviva anche ad andare incontro all’eterogeneità della società e delle popolazioni
della Repubblica Federale.
Non fu un caso che il nome del partito dal 1952 divenne Lega dei Comunisti, proprio
a sottolineare che era un’alleanza ed un’unione e non un monolite diretto
burocraticamente dall’alto.
A livello politico-amministrativo nei comuni le collettività si sarebbero autogovernate
eleggendo – dal basso! - comitati popolari locali.
A livello economico il decentramento interruppe addirittura la collettivizzazione
forzata delle terre e si preferì cercare di ottenere l’adesione spontanea dei contadini
ad entrare nelle cooperative di produzione con l’esempio del loro buon
funzionamento (!).
Ancora più importante, la gestione delle aziende stesse venne trasferita ai relativi
consigli operai dotati addirittura di personalità giuridica e di autonomia anche nei
rapporti coi Paesi esteri da cui ed in cui ora potevano liberamente importare ed
esportare (!).
Venne affermato esplicitamente che la direzione centralizzata dell’economia non
riusciva a garantire lo sviluppo – semmai dal centro si doveva orientare e coordinare
– e che il lavoratore non doveva essere oppresso dai controlli ma motivato
dall’interesse (!).
37
In ogni settore il consiglio operaio divenne di fatto un consiglio d’amministrazione
che decideva investimenti, approvava bilanci, salari, distribuzione degli utili, ecc., in
un regime di libera concorrenza: l’operaio era direttamente interessato al successo
dell’azienda nella quale lavorava e che a rotazione entrava a dirigere: se l’azienda in
cui era impiegato produceva utili anche lui ne avrebbe goduto, se aveva perdite anche
lui ne avrebbe sofferto (!).
Nel mondo comunista questa ‘economia socialista di mercato’ era un’assoluta novità,
mentre dal punto di vista ideologico affermare che il potere doveva andare agli operai
ed ai lavoratori e non ai burocrati del partito era un’aperta eresia.
La Jugoslavia divenne un ‘regime di assemblee’ nel quale (almeno in teoria) tutto
poteva essere discusso e criticato – tranne i fondamenti del regime stesso.
Il riformismo jugoslavo si sviluppò fra il 1950 ed il 1955 e contemplò anche un
ridimensionamento dei poteri della polizia segreta, chiamata ora U.D.B.A., il
permesso agli artigiani di riaprire le loro botteghe e lo scioglimento dei 4/5 delle
fattorie collettive di stato: si realizzò insomma una sorta di N.E.P. e di bucharinismo
che, se lasciarono comunque che il Paese rimanesse comunista e fosse guidato
esclusivamente dai comunisti secondo la (solita) logica totalitaria, tuttavia esso fu
anche il più libero e vivibile del ‘campo socialista’ del quale pretendeva ancora di far
parte.
Nacquero tuttavia tutta una serie di problemi nuovi, dovuti questa volta ad un eccesso
di spinte centrifughe, di iniziative scollegate fra loro, di scarso coordinamento e
quindi di instabilità: per esempio poteva non esserci sufficiente energia elettrica per
tutte le industrie che erano state aperte, i capitali stranieri non erano affluiti come
sperato, la corsa ai consumi, seppur pienamente comprensibile, era eccessiva, i
consigli di fabbrica stabilivano salari troppo alti, i comitati potevano arrogarsi poteri
eccessivi, ecc..
Nonostante autogestione e decentramento, i partiti che avevano diritto di esistere
erano solo la Lega dei Comunisti e l’ (affine e subalterna) Alleanza Socialista del
Popolo Lavoratore: in queste condizioni era molto dubbio che potesse svilupparsi
davvero la promessa democrazia, così quando Milovan Gilas (numero tre del partito
dopo Tito e Kardelj) provò a proporre che la Lega venisse sciolta per permettere il
libero dibattito, venne dimissionato, espulso e condannato a 18 mesi con la
condizionale (nel mondo comunista questa era comunque una bazzecola).
Gilas tornò all’attacco nel 1956 e le sue critiche furono decisive nel mettere in luce la
contraddizione del sistema jugoslavo: secondo lui anche se il frazionamento
economico e politico nelle aziende e nei comuni poteva dare l’impressione di vaste
autonomie decisionali, in realtà il dibattito generale sugli obiettivi dell’intera nazione
rimaneva nelle mani del vertice dello stato. La libertà di poter decidere solo sulle
piccole questioni - e non su quelle di fondo! – esprimeva così l’impossibilità della
pretesa di poter conciliare il regime a partito unico con la democrazia.
Erano critiche fondate che renderanno Gilas famoso anche all’estero e che erano
ineludibili: la Jugoslavia era sì il più libero degli stati socialisti, ma questi per loro
natura non erano liberi!
38
Gilas propugnò così il multipartitismo e Kardelj (il numero due del regime) gli
rispose seccamente che ciò era fuori discussione.
Tito tirò dritto sulla strada intrapresa e nel 1965 introdusse ulteriori riforme, come la
riduzione progressiva dell’intervento Stato in economia, il compenso secondo il
lavoro e, insomma, una serie di misure volte a favorire l’economia di mercato che
liberalizzarono ulteriormente l’economia del Paese.
Desta una certa impressione vedere quanto profondamente gli jugoslavi erano
convinti della correttezza della strada intrapresa e con quanta lucidità si rendevano
conto di aver rovesciato i criteri dell’economia di ogni altro Paese comunista e cioè la
statalizzazione di ogni attività produttiva e di ogni servizio e la direzione
centralizzata nelle mani dello stato dell’intero sistema economico: ecco per esempio
come si esprimeva Tito di fronte al Comitato Centrale della Lega nel 1969: “Noi
rifiutiamo lo statalismo perchè si è dimostrato incapace di risolvere le contraddizioni
sociali e i problemi di un efficace sviluppo, e perchè inaccettabile dal punto di vista
dello sviluppo di rapporti sociali umani e socialisti.” (pag. 81) Qui ciò che si rifiutava
era semplicemente l’intero sistema comunista concretamente esistente!
Inevitabilmente però tutto questo decentramento accentuò differenze e sperequazioni
e, favorendo le regioni più sviluppate e più capaci di competere, cioè Slovenia e
Croazia, cioè le regioni (ex-asburgiche) geograficamente più vicine all’Europa
capitalistica, aumentava anche la forza delle spinte autonomiste o addirittura
separatiste.
Tutto il senso della via jugoslava al socialismo stava nella convinzione che il sistema
socialista era il migliore, che conveniva ai lavoratori e che quindi avesse in se stesso
la forza di affermarsi e rafforzarsi se solo lo si lasciava libero di procedere: lo slogan
di Tito era “sostituzione del metodo di comando con il metodo della partecipazione”
ma, ad ogni buon conto, era duramente vietato metterlo in discussione!
Anche in Jugoslavia, come in tutti i Paesi socialisti, una insopportabile e gonfia
retorica celebrava infine le vittorie continuamente conseguite ed i traguardi
continuamente raggiunti e superati: qui comunque la ricostruzione post-bellica operò
davvero miglioramenti significativi che si fusero col passaggio – tipico di ogni Paese
socialista – da un’economia in mano al capitale straniero e sostanzialmente agricola
ad una autonoma ed industriale.
La politica estera della nuova Jugoslavia
Fu giocoforza che la Jugoslavia cercasse ed ottenesse facilmente sostanziosi ed
essenziali finanziamenti e più stretti rapporti economici con l’Occidente:
l’Occidente infatti non poteva che gioire e favorire l’uscita dal blocco sovietico di un
Paese che per la sua posizione geografica impediva all’U.R.S.S. l’accesso
all’Adriatico (ed al Mediterraneo) e costituiva inoltre un utilissimo cuscinetto.
39
Tuttavia anche in questa occasione Tito riuscì a mantenersi libero e ad evitare di
passare dalla soggezione ad una superpotenza al controllo dell’altra: seppe invece
uscire dalla strettoia fra Est ed Ovest con originalità ed innovazione.
Di fronte alla spaccatura del Pianeta in due blocchi contrapposti ed iperarmati la
Jugoslavia infatti evitò accuratamente di schierarsi o, meglio, aderì al movimento dei
cosiddetti ‘non-allineati’ di cui fu anzi una fondatrice insieme all’Egitto di Nasser e,
soprattutto, all’India di Nehru.
Scopo dei non-allineati, movimento che dal 1954-55 (quando fu fondato) avrebbe
evitato, appunto, di schierarsi in uno dei due blocchi, fu fare invece opera di
conciliazione fra i due ed offrire una sponda a tanti Paesi che si stavano liberando dal
giogo coloniale ed avevano bisogno di una collocazione internazionale.
Soprattutto, però, i non-allineati fondavano tutta la loro azione sul riconoscimento
dell’indipendenza e dell’autonomia di ogni popolo e Paese che doveva esistere
sempre su un piano di parità con tutti gli altri: musica per le orecchie di Tito che
ripetè sempre (come nel 1969) “Rifiuteremo in modo categorico qualsiasi limitazione
all’indipendenza e alla sovranità, qualunque siano i motivi e gli argomenti con i quali
si tentasse di giustificarla”.
Corollario di questa politica estera era quella della difesa che Tito chiamò ‘difesa
popolare globale’: egli pensò che per la Jugoslavia non sarebbe mai stato possibile nè
desiderabile avere una forza militare aggressiva ed adatta all’invasione di altri Paesi e
così, forte dell’esperienza della resistenza nella seconda guerra mondiale, volle
organizzare la politica del popolo in armi.
Doveva essere cioè approntata un’organizzazione militare che, radicata nel territorio
e forte di milioni di combattenti, avrebbe dovuto rendere impossibile ad un eventuale
invasore di portare avanti la sua opera: anche una grande potenza si sarebbe dovuta
trovare impantanata in un territorio aspro e difficile, montuoso e frastagliato, in cui la
popolazione armata ed organizzata non le avrebbe dato tregua.
Nel 1969 Tito affermò che “si creano condizioni migliori per mobilitare e preparare il
nostro paese in modo da poter opporre l’intera nostra popolazione, armata e
organizzata, a qualsiasi potenziale aggressore e in qualsiasi eventuale guerra.”
Quindi all’esercito popolare si aggiunsero anche la milizia territoriale ed altre forme
di forza militare organizzata: ciò implicò un addestramento militare generalizzato
all’intera società mentre, last but not least, le organizzazioni di spionaggio e di
controspionaggio dovevano assicurare le indispensabili segretezza e sicurezza
interne: inutile dire che questo significò una sorveglianza ed un controllo molto stretti
da parte della polizia segreta sulla società – in Jugoslavia si rafforzarono così i
sistemi dello stato assoluto.
Comunque invadere la Jugoslavia o, meglio, riuscire a portare a compimento
un’invasione, sarebbe dovuto risultare impossibile.
40
La riabilitazione di Tito
La notte fra il 24 ed il 25 febbraio 1956 nella seduta segreta e finale del XX
Congresso del P.C.U.S. il nuovo segretario del P.C.U.S. e leader sovietico Krushev
denunciò (alcuni de)i crimini di Stalin stupendo e sconvolgendo tutto il mondo
comunista (e non): una delle conseguenze di questo cambiamento di rotta fu poi lo
scioglimento del Kominform il 17 aprile 1956.
Il 26 maggio 1956 Krushev atterrò a Belgrado e si incontrò pubblicamente con Tito
abbracciandolo e baciandolo sulla bocca: i sette anni di isolamento e condanna (per
non dire altro) erano finiti e la spiegazione della svolta così repentina fu che i
documenti ritrovati dopo la morte di Stalin (5 marzo 1953) e di Berija (capo del
N.K.V.D., la terribile polizia segreta sovietica, fatto eliminare dallo stesso Krushev il
23 dicembre 1953) avevano svelato che la rottura era stata frutto di un imbroglio e di
una congiura costruiti dai (soliti) ‘nemici del popolo’ (sic) per dividere ed indebolire
il campo socialista.
Tutti i comunisti, kominformisti o titoisti che fossero, dovettero accettare questa
versione e chi sapeva doveva tacere – compresi coloro che avevano patito nei lager:
come sempre in quel mondo incredibile, il silenzio non era tanto imposto, quanto
autoimposto per ‘non danneggiare la causa’.
Non ci si può davvero stancare di rimarcare quanto tutti d’un pezzo erano questi
comunisti, ma bisogna anche chiedersi cos’era successo davvero.
Era successo che l’U.R.S.S. aveva fatto male i suoi calcoli e che la Jugoslavia,
sostenuta (soprattutto economicamente) dall’Occidente, aveva resistito: inoltre il
nuovo corso che la nuova dirigenza sovietica voleva intraprendere implicava
l’abbandono di tante scelte e direttive di Stalin sia in politica interna che estera - dove
ora si puntava ad avere rapporti ‘distesi’ con l’Occidente.
La ‘guerra fredda’, che aveva avuto il suo momento culminante nella guerra di Corea,
era giunta ad un punto di stallo e di equilibrio (grazie anche alla parità
dell’armamento nucleare) e non poteva continuare al ritmo di prima.
Così la riappacificazione con la Jugoslavia era funzionale all’appianamento di tante
diffidenze ed inoltre forniva credibilità alle aperture che ora venivano prospettate.
Dopo sette anni di insulti, condanne e di (la solita) forsennata propaganda nella quale
nulla era stato risparmiato per demonizzare Tito e la sua ‘cricca fascista’, era arrivata
la rettifica: era stato tutto una trappola ordita da alcuni ed un equivoco ed un errore in
buona fede da parte di altri.
Naturalmente tutti si dovettero acconciare al ‘contrordine compagni’ di guareschiana
memoria e spesso la cosa fu imbarazzante, ma nel mondo comunista la verità e la
propaganda di stato erano capaci di ben altro – e la disinvoltura con cui i nemici
diventavano amici e viceversa era del resto già stata ben illustrata da Orwell nel suo
“1984”.
Un particolare degno di nota è che l’anno precedente, quando Krushev si era
consultato cogli altri leader socialisti in merito allo scontro con la Jugoslavia, era
41
stato Mao ad esprimere i dubbi più seri sull’affidabilità di Tito come comunista – e
ciò anche per una certa rivalità fra i due Paesi (!): tutti due si erano liberati da soli
durante la guerra, ma gli jugoslavi si atteggiavano ad indiscussi maestri di guerriglia
e ciò irritava i permalosi cinesi; gli jugoslavi inoltre in quanto autorevoli non-allineati
sembravano insidiare le posizioni cinesi in India, Birmania ed Egitto (!).
Naturalmente alla riappacificazione si era opposto anche ciò che era rimasto della
vecchia guardia staliniana (soprattutto Molotov), ma Krushev aveva tirato dritto,
incolpando di tutto Berija ed il suo vice Abakumov (ma non Stalin!) e riconoscendo
infine che il P.C.J. era rimasto marxista-leninista, seppur in una forma originale.
Così diceva la dirigenza sovietica quindi così era stato.
Nonostante le inevitabili schermaglie ed i consueti distinguo, quel che era successo
era tuttavia chiarissimo: Tito aveva vinto - ancora una volta aveva gestito la
situazione come aveva voluto riuscendo a coniugare socialismo ed indipendenza.
Tuttavia il volto autentico del regime jugoslavo lo si potè cogliere con maggior
precisione proprio nello stesso 1956 in occasione della rivolta ungherese e della sua
violenta repressione da parte dei sovietici: inizialmente Tito aveva giudicato la prima
fase della sollevazione ungherese un autentico movimento popolare ed era stato dalla
parte di Imre Nagy (il segretario del partito che aveva voluto liberalizzare ed aprire il
suo Paese), ma quando quest’ultimo si spinse verso il multipartitismo e sembrò
volersi avviare verso la democrazia (borghese) – alla Milovan Gilas per intenderci –
allora Tito ritirò il suo appoggio ed anzi sostenne l’intervento dei carri armati
sovietici del 4 novembre 1956 che per ‘salvare il socialismo’ soffocarono nel sangue
la tentata rivoluzione ungherese.
Tito era insomma per aperture ed indipendenza, ma all’interno del sistema
comunista sul quale non era disposto a transigere: poteva essere il comunista più
avanzato, ma sicuramente rimaneva comunista.
Seguire la rotta tracciata
Tito aveva vinto su tutti i fronti e finchè visse la Jugoslavia seguì la rotta da lui
tracciata: certamente innumerevoli furono gli scarti, gli episodi notevoli, i momenti
difficili e quelli belli, i successi e le difficoltà, ecc. ecc., ma ormai il Paese non
avrebbe indietreggiato rispetto all’autogestione socialista all’interno e ad una politica
di equilibrio e di non-allineamento all’estero.
Nella Lega dei comunisti si affrontavano due tendenze, quella dei conservatori (più
rigidi nel volere un maggior controllo centralizzato) ed all’opposto quella dei liberali
favorevoli al decentramento: a complicare il problema c’era il fatto che questi ultimi
provenivano in genere dalle regioni più ricche (Slovenia e Croazia) e che, viceversa, i
primi erano invece prevalentemente serbi e montenegrini.
Tito dovette barcamenarsi fra le due fazioni ed alla metà degli anni Sessanta optò per
i liberali: egli – così come Stalin con Berija e Mao con Lin Biao - nel 1966 aveva
scelto come suo successore (aveva ormai 74 anni) Rankovic, il serbo fondatore della
42
polizia segreta U.D.B.A., ma così si era approfondita anche la lotta coi liberali che,
fra l’altro, nel 1965 erano riusciti a varare ulteriori riforme per sviluppare e far
avanzare l’economia socialista di mercato jugoslava.
Lo scontro si risolse l’anno seguente quando si scoprì che Rankovic aveva messo in
piedi un’organizzazione segreta che aveva spiato perfino Tito: Rankovic fu
processato ed allontanato definitivamente dal partito, i suoi collaboratori condannati
ma amnistiati, l’U.D.B.A. perse la sua libertà di manovra e fu sottoposta al controllo
del governo e del comitato centrale, ma per rabbonire i serbi che avevano visto in
tutto questo un colpo inferto a loro da sloveni e croati, furono ancora serbi i nuovi
dirigenti del servizio.
Le tensioni fra le nazionalità rimanevano insomma vive e preoccupanti: nel 1970
esplose la ‘Primavera croata’, una serie di veementi proteste per il mancato
riconoscimento del croato come lingua originale - sgarbo che aveva rinnovato la
frustrazione dei croati che si sentirono ulteriormente discriminati ed eterodiretti.
Essi risposero colla celebrazione e coll’esaltazione dei grandi uomini croati, della
cultura e della civiltà croate, ma questa ventata di orgoglio nazionale suscitò contro di
loro l’accusa di separatismo, di nazionalismo e di nostalgie ustascia.
La ‘Primavera croata’ mostrò insomma quanto il fuoco nazionalista ed
indipendentista covasse ancora sotto la cenere e la repressione seguì immancabile e
pesante: il pendolo politico questa volta si spostò (seppur con accortezza) dalla parte
dei conservatori e, come sempre in questi casi nei Paesi socialisti, un’intera fetta della
classe dirigente venne a sua volta allontanata dal potere.
Le questioni nazionali continuavano ad esistere e si manifestavano in tutte le
controversie, tuttavia (forse anche per questa sua eterogeneità!) la Jugoslavia fu
sicuramente il Paese comunista più aperto (in tutti i sensi) al resto del mondo; cercò
sempre di rimanere amica – ma libera – dei Paesi comunisti senza mai sbilanciarsi in
modo eccessivo quando questi (soprattutto U.R.S.S. e Cina) litigavano fra loro;
sfruttò al massimo la sua posizione politica e geografica per accattivarsi le simpatie
dell’Occidente (un Paese indipendente sull’Adriatico era un utilissimo cuscinetto fra i
due blocchi – e soprattutto per l’Italia che così non doveva confinare con quello
sovietico); l’arrivo di capitali occidentali le permise uno sviluppo economico più che
accettabile per un Paese comunista; autorevole membro fondatore dei non-allineati
poteva svolgere infine funzioni di raccordo e conciliazione nelle dispute
internazionali.
Alla fine del 1961 la scelta definitiva dell’Albania di Enver Hoxha in favore della
Cina e la rottura irrimediabile (ed inspiegabile) con Mosca (le cui modalità esulano
dagli scopi di questo saggio) ne decretò per un trentennio la chiusura totale ed il
bizzarro e tragico isolamento: ciò fu però di notevole vantaggio per la Jugoslavia che
a sud non ebbe più il problema della pressione del blocco sovietico e, soprattutto,
escluse definitivamente la possibilità per la flotta dell’U.R.S.S. di accedere
direttamente all’Adriatico.
43
Quest’ultimo era sempre stato un obiettivo delle Potenze europee fin dai tempi degli
zar, come ora lo era della N.A.T.O., ma per la Jugoslavia significava la sicurezza
delle coste – incalcolabile dunque la sua benefica importanza.
Non si può comunque mai dimenticare che con tutte le sue aperture la Jugoslavia
rimaneva un Paese a partito unico ed aveva un regime dittatoriale nel quale i confini
del lecito e dell’illecito erano insindacabilmente tracciati dall’alto; che le aspirazioni
nazionali quando non rimanevano all’interno delle autonomie concesse erano vietate
e represse; e che la scelta socialista non poteva essere nemmeno oggetto di
discussione.
Censura, polizia segreta e sistema totalitario erano meno pesanti che nel resto del
mondo comunista, ma rimanevano comunque un pilastro fondamentale dell’intera
costruzione comunista del Paese.
Infine, la figura del Maresciallo Tito svettava inarrivabile su tutto e su tutti: padre
della patria e dittatore, i suoi meriti erano giudicati eccezionali, la sua parola
definitiva, la sua guida indiscutibile ed il suo potere assoluto.
Finchè Tito visse la Jugoslavia proseguì come lui aveva voluto e continuava a volere.
Già: finchè visse.
La Jugoslavia senza Tito
Dopo una lunga agonia e tenuto artificialmente in vita finchè fu proprio possibile,
Tito morì a ottantotto anni il 4 maggio 1980, in un momento in cui l’economia del
Paese stava dando preoccupanti segni di crisi e di cedimento con un debito estero che
superava i 15 miliardi di dollari ed un costante aumento dell'inflazione e della
disoccupazione.
Sei anni prima, nel 1974, Tito aveva fatto approvare una nuova costituzione che
ribadiva la struttura federale della Jugoslavia ed anzi l’ampliava col riconoscimento
del diritto alla secessione da parte di ognuna delle sei repubbliche (ma non delle due
regioni autonome), del sistema della presidenza collegiale (dei rappresentanti delle
varie nazionalità) e della rotazione annuale della carica del reggente ‘primus inter
pares’ in base all’appartenenza etnica: tuttavia senza la sua presenza era venuto a
mancare il collante necessario a tenere insieme la Repubblica.
Il federalismo non bastava più nè esistevano rimedi efficaci e duraturi al
nazionalismo dei vari popoli jugoslavi che – acuito dalla difficile situazione
economica e dagli inevitabili programmi di austerità - cominciava a riemergere più
impetuoso che mai.
Nel marzo 1981 il Kosovo si ribellò un’altra volta o, meglio, si ribellarono gli
albanesi del Kosovo, cioè il 90% dei suoi 1.800mila abitanti: non potevano nè
volevano più sopportare di essere sottomessi alla esigua minoranza serba
(praticamente i restanti 180mila abitanti) e ritenevano che questo stato di cose
derivasse dal loro non essere di ceppo slavo - e dal loro essere musulmani dal punto
di vista religioso; chiedevano infine di divenire la settima repubblica.
44
Mentre ovviamente gli albanesi di Albania spalleggiavano i propri ‘connazionali’ ed i
serbi di Serbia i loro, l’immancabile risposta dello Stato fu la (solita e prevedibile)
accusa di controrivoluzione e la (solita e prevedibile) dura repressione.
A causa della sua irrequietezza nel 1983 fu poi la volta della Bosnia-Erzegovina a
subire misure repressive – preventive si direbbe – anche queste sollecitate dai
(1.300mila) serbi di quella repubblica spalleggiati da quelli (6.200mila) della Serbia,
mai soddisfatti e sempre in pena.
Naturalmente il nazionalismo e le rivendicazioni di indipendenza che più facevano
paura per la tenuta della ormai fragile federazione erano quelli della Croazia, nella
quale la minoranza etnica più consistente era ancora una volta quella serba (600mila
abitanti).
La lunga onda della storia dell’identità nazionale dei popoli balcanici riemergeva
insomma indomabile nonostante la loro complessa mescolanza ed anzi addirittura
aggravata da essa: in queste terre martoriate infatti non si agitava solo il problema
dell’indipendenza, ma anche quello terribile della pulizia etnica per far sì che il
popolo, ogni popolo, fosse puro dalla contaminazione con chi non gli apparteneva ed
interamente raccolto nella sua terra – terra sua e di nessun altro.
Il nazionalismo serbo non era certo meno sentito degli altri, ma aveva trovato modo
di manifestarsi in un modo diverso perchè fin dalla costituzione del Regno di
Jugoslavia erano stati i serbi a costituirne la spina dorsale e a dirigerlo, tanto che esso
potè essere vissuto addirittura come un allargamento del regno di Serbia stesso (e per
molti aspetti lo era stato).
Nella Jugoslavia di Tito i serbi avevano perso territori e centralità, ma nondimeno
erano stati pur sempre fondamentalmente loro – date le loro tradizioni, le loro
capacità ed il loro numero – a costituire la base ed i vertici dell’esercito, così
prestigioso ed importante nel mantenimento della Repubblica Federale; erano stati
loro a costituire l’ala conservatrice, centralista ed ortodossa della Lega non solo
perchè la loro economia era meno sviluppata di quella slovena e croata, ma anche e
soprattutto perchè così avrebbero potuto continuare ad esercitare il peso decisivo
nella vita dell’intera Jugoslavia; infine, sparsi in tante repubbliche (Croazia, Bosnia e
Kosovo) solo in uno stato centralizzato potevano continuare ad esserne protagonisti
anzichè scomode ed emarginate minoranze.
Ora tutto questo minacciava di crollare così come era crollato il Regno di Jugoslavia e questa volta non ci sarebbe stato un nuovo stato unitario in cui i serbi stessi
avrebbero potuto continuare ad esercitare il loro ruolo preminente, ma una
frantumazione che li avrebbe resi un piccolo stato con tanti suoi cittadini all’estero
divenuti improvvisamente minoranze etniche: non stupisce quindi che essi si
adoperarono in tutti i modi per preservare l’esistenza della Jugoslavia sempre più
minacciata di sgretolamento.
Per chiarire ancora meglio la situazione può essere utile ricordare i dati del
censimento del 1991: dei 24 milioni di abitanti dell’intera Jugoslavia i serbi erano
allora il 36%, i croati il 20%, gli albanesi (praticamente tutti in Kosovo) il 15%, i
mussulmani (in Bosnia-Erzegovina) il 10%, gli sloveni (tutti in Slovenia) l’8%, i
45
macedoni (tutti in Macedonia) il 6%, i montenegrini (tutti in Montenegro) il 2%, gli
ungheresi (nella provincia della Vojvodina) il 2% mentre coloro che si dichiararono
Jugoslavi erano il 3%: infine, solo serbi e croati avevano ‘connazionali’ fuori delle
loro repubbliche.
Memorandum e nazionalismo serbo
Nessun popolo balcanico era immune dal nazionalismo, che in queste terre possedeva
una forza ed una passionalità – ed una mancanza di scrupoli – enormi: esso invece era
stato ormai superato e dimenticato nel resto d’Europa che così non capì la gravità
della tempesta che stava arrivando terribile - nè la Jugoslavia ebbe un Gorbaciov che
l’accompagnasse in modo pacifico e razionale verso il destino del suo inevitabile
disfacimento.
Ogni passo verso il soddisfacimento del desiderio di autonomia o di indipendenza
dell’uno significava una minaccia ed un pericolo per l’altro la cui reazione ne
generava un’altra uguale e contraria - e questo progressivo avvitamento della
situazione su se stessa rendeva sempre più nemici fra loro i popoli della federazione.
Fu così che, in occasione di un’aspra disputa fra sloveni e serbi, il 24 ottobre 1986
venne pubblicato a Belgrado il Memorandum dell'Accademia Serba delle Scienze e
delle Arti (noto anche come ‘Memorandum S.A.N.U’) che, steso da un gruppo di
suoi membri (serbi), ebbe un’eco grandissima nel Paese.
Esso denunciava una campagna antiserba sia all’interno che all’esterno della
repubblica, ne metteva a fuoco le radici storiche, formulava i principi del
nazionalismo serbo e riproponeva la rinascita della ‘Grande Serbia’ come giusta e
doverosa.
Gli argomenti addotti erano rivelatori di uno stato d’animo molto particolare e di
sentimenti dolorosi e profondi che da sempre si agitavano nelle fibre più riposte di
questo popolo così rude ed esaltato.
Innanzitutto il Memorandum affermava che i serbi si erano sempre sacrificati per gli
altri ma non avevano mai avuto i riconoscimenti che si sarebbero meritati – tesi che
va presa molto sul serio.
Per quanto possa sembrare incredibile, il ricordo della gravissima sconfitta subita
nella battaglia del Campo dei merli (in Kosovo, per i serbi terra sacra e focolare del
loro popolo) il 28 giugno 1389 contro i turchi era ancora vivissimo nella psiche dei
serbi che, sterminati in massa, sostenevano però che con questo sacrificio avevano
bloccato l’avanzata dei turchi stessi: dovendo sopportare tutto il peso della loro
occupazione, essi avevano inoltre fatto da schermo protettivo antiturco al resto
d’Europa.
Indomiti e ribelli ad ogni giogo, i serbi si erano ribellati al dominio ottomano e
all’inizio dell’Ottocento - primi fra tutti - avevano potuto costituire già uno stato
praticamente indipendente.
46
Ora che si sentivano stretti ancora fra i musulmani - quelli albanesi a sud e quelli
bosniaci a nord - venivano riportate in auge le memorie della gloriosa lotta secolare
contro gli infedeli turchi con una partecipazione emotiva straordinaria.
Anche durante la prima guerra mondiale i serbi avevano dovuto affrontare prove
durissime (mentre sloveni e croati avevano combattuto contro di loro inquadrati
nell’esercito austro-ungarico): solo loro alla fine del conflitto avevano potuto sedersi
al tavolo dei vincitori salvando l’onore slavo ed infine solo intorno alla Serbia la
Jugoslavia aveva potuto unirsi e nascere.
Durante la seconda guerra mondiale erano stati ancora una volta i serbi che avevano
dovuto sopportare il peso della durissima occupazione tedesca e della campagna di
sterminio portata avanti dai croati di Pavelic contro di loro.
Erano riflessioni come queste che dilagavano fra i serbi e, insieme ad esse, la rabbia e
l’umiliazione di aver perso tanti territori e di essere stati abbassati al livello degli altri
popoli nella Jugoslavia socialista di Tito.
Il Memorandum parlava addirittura di un genocidio strisciante che da secoli sarebbe
continuato ad essere perpetrato ai loro danni ed al quale era ora di porre fine.
I serbi si sentivano incompresi e vittime della storia (“I serbi sanno vincere le guerre,
ma perdono la pace”) - e bisogna rendersi conto di quanto pericolosi sono questi
sentimenti quando trovano sfogo pubblico e libera diffusione; quanto violenta ed
inconsulta può essere la reazione di un popolo che si sente frustrato e trattato tanto
ingiustamente da essere minacciato addirittura di sparizione come soggetto attivo
della storia; quanto infine è grave rifiutarsi di ascoltarlo e limitarsi ad accusarlo.
In ogni caso, al di là di ogni considerazione di opportunità politica, è difficile e forse
impossibile stabilire con giustizia ed imparzialità quanto di vero ci poteva essere
nelle recriminazioni dei serbi - che effettivamente erano un popolo che aveva
grandemente patito e subito vessazioni anche terribili in tutto il corso tragico della
sua storia: non sembra condivisibile insomma chiamare il loro doloroso sentirsi
sottovalutati ed incompresi “dilagante e paranoico vittimismo” come fa ad esempio
(lo sloveno) Pirjevec.
Quelle che sembrano invece ben più facili da giudicare sono le soluzioni che
venivano proposte: il Memorandum infatti chiedeva decisamente “l’instaurazione
della piena integrità nazionale e culturale serba, a prescindere dalla Repubblica o
dalla Provincia in cui vive” ed il ritorno della Vojvodina e del Kosovo sotto la piena
autorità di Belgrado, l’annullamento cioè del loro status di province autonome.
In altri termini, là dove vivevano serbi, quella era terra serba, indipendentemente
dalla presenza di abitanti di altre nazionalità (sia che fossero in maggioranza o in
minoranza) che in realtà finivano per essere considerati una sorta di residenti abusivi:
si ripeteva che "la Serbia è là dove c'è un serbo” ed il significato di questa sorta di
slogan risulta più chiaro se si invertono i termini dell’equazione e cioè se si dice che
dove c’è un serbo, quella è Serbia.
Quel rispetto e quella giustizia che i serbi chiedevano per sè li negavano però agli
altri; quel diritto e quella attenzione che reclamavano per la propria identità non
venivano però riconosciuti a quella degli altri.
47
Ciò è indubbiamente inaccettabile, ma nondimeno veniva diffuso a piene mani e, quel
che è peggio, cercava e trovava fondamento in quel sostrato di frustrazione, paura e
desiderio di rivincita che un popolo tanto bellicoso, impavido ed altrettanto
orgoglioso, soffriva tanto acutamente.
Alla Serbia così inasprita mancava ormai solo un leader capace di interpretare la sua
rabbia, che apparisse in grado di incanalarne le sue straboccanti energie, una figura in
cui potesse riconoscersi e sentirsi capita, una guida cui potersi affidare.
Nei momenti critici questi personaggi compaiono sempre e la Serbia trovò il suo in
Slobodan Milosevic.
Slobodan Milosevic
Nato nel 1941, con entrambi i genitori morti suicidi (il padre nel 1962 e la madre
dieci anni dopo), marito di Mirjana Markovic appartenente ad un’influente famiglia
serba, eletto nel 1986 Presidente della Lega dei Comunisti Serbi, la vera svolta nella
sua vita politica avvenne l’anno seguente quando il Presidente della Serbia Ivan
Stambolic (oppositore del Memorandum e sostenitore della Repubblica Federale) lo
inviò nel turbolento Kosovo perchè vi risolvesse la sempre più grave tensione fra la
minoranza serba e la grande maggioranza albanese.
Egli si schierò subito ed apertamente dalla parte dei serbi che lamentavano un
trattamento discriminatorio nei loro confronti da parte delle autorità ormai costituite
esclusivamente da albanesi: facendo riferimento alle aggressioni di cui i serbi
dichiaravano di essere vittime, in un discorso che sarebbe diventato famosissimo
dichiarò loro che “nessuno vi picchierà più!” - e da questo momento la sua carriera
sarebbe proceduta velocissima.
Milosevic si presentò immediatamente alla Jugoslavia intera come il difensore della
sua unità ma, soprattutto, come l’alfiere della causa serba – dato che per lui le due
cose procedevano insieme: la Jugoslavia poteva rimanere unita e forte solo sotto la
guida dei serbi ed i serbi potevano essere un popolo rispettato, potente ed influente,
solo in una Jugoslavia da loro diretta e nelle cui repubbliche e province non fossero
mai avvertiti come minoranza.
Milosevic interpretò, rappresentò ed allo stesso tempo fomentò i sentimenti più
profondi dell'opinione pubblica serba, si propose come il campione della sua causa, il
convinto partecipe delle sue doglianze e la guida della sua riscossa ed affermazione.
Il suo successo fu enorme: spazzò via l’intera classe dirigente serba che accusò di
incapacità, di immobilismo e di mancato riconoscimento della causa serba ed il 14
dicembre 1987 costrinse lo stesso Stambolic alle dimissioni (ed il suo successore,
Petar Gracanin, non ebbe mai alcun ruolo effettivo).
In brevissimo tempo Milosevic era divenuto il ‘vozd’, il duce, il capo carismatico del
suo popolo, osannato e celebrato nelle sempre più imponenti manifestazioni che i
serbi, scalpitanti e pieni di ardore, sempre più spesso tenevano.
48
Il passaggio dal comunismo al nazionalismo più acceso può sembrare stupefacente
solo a prima vista: era quest’ultimo la linfa che da secoli e secoli scorreva nelle vene
dei popoli balcanici e (soprattutto ma non solo) per i serbi era poi l’unica politica che
potesse tenerli insieme dato che tanti di loro vivevano fuori dai confini della Serbia
vera e propria.
Era ovviamente scontato l’appoggio – importantissimo - dell’Armata Popolare
(l’esercito), la forgiatrice della Repubblica Federale stessa, e quello dei nazionalisti di
nuova e di vecchia data, ma allo stesso modo e per gli stessi motivi non può stupire
nemmeno il sostegno e l’alleanza offerti a Milosevic dalla Chiesa Ortodossa, che,
dopo aver incarnato per secoli l’anima e l’identità dei serbi oppressi dal giogo turco,
era ora desiderosa anche di riguadagnare il terreno perduto sotto il comunismo.
Esempio tangibile di questo riavvicinamento e di questo ricompattamento dello stato
e della società serbi è sicuramente il tempio di San Sava a Belgrado.
San Sava, fratello del primo re di Serbia, Stefano, era stato il fondatore della Chiesa
Ortodossa serba quando aveva optato per l’ortodossia anziché per il cattolicesimo e,
nominato nel 1219 a Nicea dall’imperatore bizantino Teodoro, era divenuto il primo
arcivescovo (ortodosso ed indipendente dalla Chiesa bulgara) di Serbia.
Morto nel 1233, la collinetta su cui era stato sepolto era divenuta meta di venerazione
e di pellegrinaggi finchè i turchi nel 1594 avevano dato alle fiamme la chiesa ed il
cadavere del santo, le cui ceneri erano state disperse nel terreno circostante.
Dopo l’indipendenza, nel 1895 era stata decisa la ricostruzione della chiesa, ma per le
dure vicende belliche e per il travaglio sopportato dalla Serbia nei decenni seguenti i
lavori poterono cominciare solo nel 1985 – e l’impulso finale e decisivo fu dato
proprio da Milosevic nella sua convinta azione di rifondazione della Serbia.
(Oggi solo la parte esterna del tempio di San Sava – la più grande chiesa ortodossa al
mondo – è stato terminato, ma essa è già stata consacrata ed è aperta a funzioni
particolari.)
Forte di tanti appoggi, innanzitutto Milosevic volle sistemare le cose all’interno della
Serbia stessa e così, per riportare sotto l’autorità di Belgrado le due province
autonome, nell'ottobre 1988 costrinse alle dimissioni il governo della Vojvodina ed il
28 marzo 1989, incurante delle (duramente represse) proteste degli albanesi, annullò
lo status di Provincia autonoma del Kosovo.
Ai comportamenti concreti si accompagnavano quelli simbolici – non meno
importanti nel clima di frenetico proliferare di sentimenti patriottici: il 28 giugno
1989, nel seicentesimo anniversario della battaglia di Kosovo (la famosa battaglia
del Campo dei merli tra serbi e turchi, ancora sentitissima e piena di echi nell’animo
serbo) Milosevic la celebrò sul posto davanti a centinaia di migliaia di serbi che vi
erano convenuti: egli esaltò la nazione serba e l'unità multietnica jugoslava, ma non
nominò nemmeno gli albanesi.
Il 19 novembre 1989 a Belgrado una delle (tante) manifestazioni del nazionalismo
serbo raggiunse il milione di manifestanti.
49
Fin da quando si era impadronito del partito Milosevic era stato l’unico vero
detentore del potere in Serbia e le cose non cambiarono quindi quando ne divenne
anche ufficialmente il Presidente nel maggio 1989 - per essere poi rieletto alla stessa
carica il 6 dicembre dello stesso anno.
Tutti i popoli della Jugoslavia erano nazionalisti, ma del tutto particolare era la
fondamentale caratteristica del nazionalismo serbo: mentre in tutta la Jugoslavia i
nazionalisti volevano separarsi dalla Jugoslavia stessa, i nazionalisti serbi tutto
al contrario volevano invece tenerla unita perchè pensavano che solo così
avrebbero potuto controllarla e sentirsi padroni e sicuri ovunque entro i suoi confini:
per i 2 milioni di serbi che vivevano fuori della Serbia una disintegrazione della
Jugoslavia sarebbe stata una catastrofe terribile che volevano quindi evitare in ogni
modo.
Tutto al contrario di quanto aveva pensato Tito, una forte Serbia era giudicata la
garanzia di una forte Jugoslavia – e viceversa! - accadde così che ogni volta che un
popolo della Jugoslavia volle separarsene si trovò contro non solo coloro che la
volevano ancora unita, ma soprattutto i serbi che non erano tanto i difensori della sua
unità, quanto di se stessi in essa.
Fu questo il senso delle guerre che negli anni Novanta del secolo scorso disgregarono
nel sangue la Jugoslavia.
L’indipendenza della Slovenia
Dopo che uno dopo l’altro tutti i Paesi dell’Europa centro-orientale si erano liberati
del dominio dell’U.R.S.S. fu la volta della stessa U.R.S.S. a disgregarsi e ciò, fra
l’altro, comportò a sua volta la fine della Jugoslavia federale e multietnica.
Senza l’U.R.S.S. infatti la Jugoslavia perdeva una delle ragioni stesse della sua
esistenza: col blocco dell’Est crollato e la ‘guerra fredda’ finita non c’era più bisogno
di uno stato-cuscinetto fra i blocchi ed i generosi finanziamenti dell’Occidente di cui
la Jugoslavia aveva potuto sempre godere (e che avevano mascherato le reali
difficoltà della sua economia) ora non avevano più motivo di essere continuati - ed
infatti cominciarono a rarefarsi.
Come se ciò non bastasse, ora nel continente si aprivano nuovi giochi geostrategici o,
meglio, riapparvero vecchie tensioni: Francia ed Inghilterra cominciarono infatti a
temere che la Germania appena riunificata avrebbe inevitabilmente premuto per una
decisiva presenza e penetrazione nell’area centro-orientale e balcanica e, pensando
come un tempo che una Jugoslavia amica avrebbe costituito un utile freno a ciò, ne
sostennero ancora l’unità – ma era una battaglia persa perchè senza più l’U.R.S.S. le
tensioni fra le varie nazionalità interne al Paese ora potevano manifestarsi più
apertamente, oltretutto in una situazione economica in continuo peggioramento.
La Jugoslavia aveva ormai i giorni contati e la Slovenia - non a caso la repubblica più
ricca (il suo reddito pro-capite nel 1960 era stato tre volte quello del povero Kosovo e
nel 1970 cinque) - fu la prima a separarsene e a divenire uno stato indipendente.
50
Già nel 1988 (durante la ‘Primavera slovena’) le proteste in quella repubblica erano
state particolarmente accese: esse erano state occasionate dal modo in cui era stato
condotto un processo a quattro giornalisti, ma il vero motivo era che l’opinione
pubblica slovena non sopportava più il nazionalismo ed il militarismo serbo, come si
vide chiaramente nel gennaio 1990 al quattordicesimo (ed ultimo) congresso della
Lega dei Comunisti Jugoslavi, quando la distanza tra serbi e sloveni risultò tanto
incolmabile che Milan Kucan ritirò la delegazione slovena che guidava.
Non potendo continuare a viaggiare a due velocità – per di più in una difficile
situazione economica - di fatto la Jugoslavia aveva cessato di esistere e subito anche
la delegazione croata abbandonò l’ormai inutile assemblea.
Nello stesso mese la tardiva ed irrimandabile introduzione del multipartitismo non
fece che aumentare differenze e conflitti e da quel momento gli eventi cominciarono
a precipitare e non si fermarono più.
In Slovenia alle elezioni vinse la coalizione liberalcattolica ‘Demos’ e gli excomunisti passarono all’opposizione, ma Kucan restò Presidente della Repubblica; il
23 dicembre 1990 un referendum si pronunciò a favore sull'indipendenza o, meglio,
sulla sovranità slovena in una nuova confederazione (comunque tutta da discutere).
Il 25 giugno 1991 infine i Parlamenti di Slovenia e di Croazia proclamarono
l’indipendenza dei loro Paesi, ma se il secondo si era limitato ad una dichiarazione
di principio, il primo passò invece subito ai fatti concreti cominciando a prendere
diretto possesso delle sue frontiere che ora venivano intese come confini fra stati.
Nonostante la Costituzione del 1974 prevedesse che una repubblica potesse optare
per la sua indipendenza, lo stesso giorno della proclamazione il Parlamento jugoslavo
di Belgrado (privo ormai dei suoi membri sloveni e croati) la dichiarò invece
illegittima: era guerra – in Europa la prima dal 1945– in previsione della quale lo
Stato Maggiore jugoslavo aveva già elaborato (in tutta fretta) il piano ‘Baluardo’.
Non si può che restare stupiti ed ammirati dal coraggio che gli sloveni (ed i croati)
dimostrarono nel pretendere e nel reclamare i loro diritti: essi avevano contro il resto
della federazione, sicuramente la Serbia, il suo Paese più forte, buona parte
dell’Armata popolare e l’intera diplomazia internazionale.
L’Occidente non voleva turbamenti dell’ordine in generale e per decenni si era
abituato a guardare alla Jugoslavia come ad un utile cuscinetto ed ammortizzatore
delle tensioni con l’Est; Francia ed Inghilterra ora la consideravano un freno alle
(supposte) ambizioni tedesche; mentre l’U.R.S.S., da sempre sostenitrice dei serbi e
anch’essa sull’orlo del disfacimento, non aveva certo piacere di assistere all’esempio
di uno smembramento analogo a quello che lei stessa temeva.
Sembrava quindi che per la Slovenia non ci fossero davvero speranze quando il 26 a
Belgrado venne dato l’ordine di circondarla e di invaderla.
Invece la Difesa territoriale slovena, opportunamente rafforzata ed organizzata dal
giovane e brillante Ministro della Difesa Jansa, insieme alle altre forze dell’ordine
seppe incredibilmente resistere all’Armata Popolare Jugoslava che si dimostrò
incapace di agire in modo opportuno e di coordinare le sue forze, mentre le diserzioni
si moltiplicavano.
51
Alla prova dei fatti le cose andarono ben diversamente da quanto era stato previsto:
l’U.R.S.S. non osò muoversi per timore di ripercussioni politiche che avrebbero
potuto rivelarsi esiziali per il suo fragilissimo equilibrio interno; gli U.S.A. erano
impegnati in Kuwait e non vedevano quale interesse ci potesse essere per loro in
quegli eventi così lontani e marginali; la Comunità Europea da sola non seppe andare
al di là delle missioni diplomatiche, delle esortazioni, delle riunioni, delle
consultazioni, insomma delle chiacchere, salvo proclamare l’embargo sulle armi –
cioè favorire l’Armata Popolare che le aveva già; e a Belgrado non si potè che
prendere atto che la Slovenia era etnicamente compatta, lontana e ben decisa a non
mollare.
Di fronte alla fermezza della Slovenia già il 3 luglio l’Armata Popolare cominciò il
ritiro delle sue truppe e già il giorno seguente tutti i confini erano in mani slovene.
I militari non-sloveni di stanza nel Paese dovettero abbandonarlo con moglie figli - e
per molti questo fallimento costituì un trauma terribile che riapriva vecchie ferite mai
rimarginate.
Gli sloveni avevano fatto tutto da soli ed il conflitto, chiamato "guerra dei dieci
giorni”, secondo Lubiana era costato solo 74 morti e 280 feriti.
Gli sloveni furono appoggiati dal Vaticano, dall'Austria e soprattutto dalla Germania,
che probabilmente stava rivalutando la sua vecchia politica di ingerenza nei Balcani.
Il riconoscimento ufficiale del nuovo Paese (insieme a quello della Croazia) sarebbe
arrivato il 15 gennaio 1992 e l’ammissione all’O.N.U. il 22 maggio successivo.
La strana indipendenza della Croazia
Anche in Croazia nel biennio 1989-90 il disgregamento crescente della Jugoslavia e
l’impossibilità della Lega dei Comunisti di fronteggiarlo avevano portato a tutta una
serie di manifestazioni e di proteste ed al sorgere di nuove formazioni politiche:
anche qui nelle elezioni tenute dal 22 aprile al 7 maggio 1990 i comunisti avevano
perso il potere e si era affermata vincitrice l’Unione Democratica Croata (H.D.Z.) di
Franjo Tudjman.
Mentre in Slovenia erano tuttavia saliti al governo i liberal-cattolici, in Croazia
l’Unione era invece una formazione sicuramente nazionalista.
Tudjman era stato un combattente partigiano ed era diventato addirittura un generale
di Tito: tuttavia – divenuto storico di professione – si era però presto convertito alla
fede nazionalista e per questo aveva dovuto scontare lunghi anni di carcere dopo la
repressione della ‘Primavera croata’ del 1970.
La Croazia nel 1991 contava 4.760mila abitanti di cui i croati erano 3.713mila, cioè il
78% ed i serbi circa 600mila, cioè il 12%, concentrati essenzialmente in Slavonia (a
nord-est) e in Krajina (a ridosso del confine settentrionale della Bosnia-Erzegovina, a
sud del quale c’era la Krajina bosniaca): giunto al potere, Tudjman non perse tempo e
volle subito affermare la totale appartenenza della Croazia ai croati colpendo
decisamente la consistente minoranza serba.
52
Nella nuova costituzione croata del dicembre 1990 l’etnia serba non venne più
riconosciuta (ovviamente) come una delle nazioni costituenti la Repubblica Federale
(da cui la Croazia usciva) ed in un colpo solo essa diveniva una semplice minoranza
etnica.
I serbi, abituati a considerarsi cittadini jugoslavi (e dunque a pieno titolo anche in
Croazia) ed anch’essi fortemente compresi della loro nazionalità (che addirittura
sentivano e volevano egemone nella Repubblica Federale), si scoprirono ora cittadini
di serie B, colpiti oltretutto da una lunga serie di discriminazioni e di licenziamenti.
I serbi di Croazia si convinsero di essere diventati improvvisamente dei dominati e di
essere ormai trattati come tali - loro che erano stati e volevano rimanere i signori
della Jugoslavia!
A rendere la situazione ancora più esplosiva, nel tripudio nazionalista croato veniva
ora riesumata tutta la simbologia del loro Stato indipendente degli anni Quaranta e si
procedeva ad una chiara ed aperta rivalutazione degli ustascia e di Ante Pavelic: ad
alimentare la profonda frustrazione dei serbi di Croazia riapparivano insomma intatti
e carichi di minacciose premonizioni i ricordi ancora traumatizzanti e vivissimi dello
scontro atroce e del genocidio da loro subito durante la seconda guerra mondiale.
Per avere un’idea della profondità e della drammaticità dei sentimenti in gioco può
essere utile ricordare che il generale serbo Vlagoje Adzic, Capo di Stato Maggiore
dell’Armata Popolare (l’esercito) Jugoslava dal 21 settembre 1989 all’8 maggio 1992,
aveva undici anni quando nel 1944 il suo villaggio natale in Bosnia venne assalito e
raso al suolo dagli ustascia: in quest’occasione egli perse tutti i suoi quarantasei
parenti fra cui otto fratelli fucilati e la madre sgozzata davanti ai suoi occhi.
Ora che i simboli ustascia venivano riproposti quasi immutati in un clima di acceso
nazionalismo croato la reazione serba non si fece certo attendere.
Nell'estate del 1990 Milosevic si adoperò per la nascita in Krajina – regione a
maggioranza serba – di una Provincia Autonoma Serba che il 2 settembre con un
referendum si autoproclamò autonoma (ed a favore di una possibile futura
congiunzione con la Serbia).
Dopo il referendum del 19 marzo, il 25 giugno 1991 la Croazia (con la Slovenia)
dichiarò la propria indipendenza e la secessione dalla Jugoslavia - e la Krajina
(serba) il 28 settembre 1991 rispose proclamandosi a sua volta indipendente.
Il governo croato aveva già giudicato il referendum nella Krajina una ribellione e,
dato che la Serbia l’aveva incoraggiata, armata, protetta e ormai la considerava parte
di sè, ciò significò guerra - guerra che si aggiunse e si sommò a quella per
l'indipendenza croata.
Dunque la Croazia combatteva sia per la propria indipendenza che per l’intangibilità
dei suoi confini (e quindi per mantenere il possesso della Krajina) e la Serbia (in
realtà ufficialmente la Jugoslavia) tutto al contrario combatteva per mantenere la
Croazia nella Repubblica Federale e per scorporarle però la Krajina (e la Slavonia) a
proprio vantaggio.
53
Come si vede, la complicazione etnica agiva in pieno nel rendere confusa e
complessa – davvero ‘balcanica’ – una situazione in cui torti e ragioni erano
inestricabilmente connessi.
Questa volta insomma le cose non potevano filar lisce come in Slovenia, Paese
etnicamente compatto e collocato ai margini della Jugoslavia: lo affermò subito a
chiare lettere lo stesso Milosevic quando dichiarò che la Croazia non poteva essere
lasciata andar via - oltretutto con la sua consistente minoranza serba!
Il progetto di una Grande Serbia comprendente tutti i territori abitati (anche solo
parzialmente) da serbi procedeva in aperta rotta di collisione con quello del
nazionalismo croato.
La propaganda non conobbe limiti nelle reciproche accuse di illegalità, aggressione e
genocidio perchè ognuna delle due parti denunciava le mire oppressive e criminali
dell’altra, ricordava le brutalità della seconda guerra mondiale e non ammetteva
repliche alla sua volontà: un compromesso non era possibile perchè ne mancavano
tutte le condizioni.
La comunità internazionale era dalla parte della Jugoslavia, cioè della Serbia, visto
che voleva preservare l’equilibrio strategico che la Federazione rappresentava mentre
paventava inoltre che un disfacimento della Jugoslavia avrebbe preluso a quello ben
più temibile dell’U.R.S.S. che, per parte sua, continuava nel suo tradizionale
appoggio (anche con rifornimento di armi) ai serbi - che ora erano oltremodo utili
anche come esempio ad uso interno per il mantenimento del moribondo stato federale
sovietico.
Il piano serbo del generale Kadijevic era semplice: d’intesa con la popolazione locale
serba suscitare insurrezioni nelle regioni abitate (anche solo in parte!) da lei,
provocare dunque la reazione croata (ustascia!) e quindi intervenire con l’Armata
Popolare in difesa dei fratelli serbi in pericolo - annettendo così alla madrepatria le
terre dove essi vivevano (il 62% della Croazia, dove però i serbi non arrivavano al
20% della popolazione).
I primi incidenti si verificarono il 29 giugno nella Slavonia orientale, il 2 settembre fu
la milizia della Krajina (la ‘marticevci’) ad attaccare e la sollevazione dilagò presto in
altre otto regioni.
Come previsto, l’Armata Popolare corse in aiuto dei ribelli serbi insieme a forze
paramilitari (locali e non) facilmente composte di elementi criminali che, spesso
ubriachi e drogati, si diedero a violenze di ogni genere infierendo brutalmente sulla
popolazione delle altre etnie (non solo croata) e spingendola ad abbandonare le
proprie case in preda al terrore.
Anche banditismo e delinquenza agivano sotto la bandiera del patriottismo e della
costruzione della agognata Grande Serbia.
La Croazia non era pronta a sostenere un urto del genere e Tudjman preferì non
reagire sperando nella diplomazia estera, ma il Paese era isolato anche a livello
internazionale, dove poteva contare sulla sola Germania, il cui ministro degli esteri
Genscher non riuscì però a convincere i suoi colleghi europei a riconoscere la Croazia
(e la Slovenia) – mossa che avrebbe fatto risultare invasori i serbi.
54
Ancora una volta erano ricordi risalenti alla seconda guerra mondiale che facevano
temere il ritorno in forze della presenza tedesca nei Balcani - con annesso sostegno
croato (ustascia o non).
Naturalmente i giochi della diplomazia internazionale con tutti i loro calcoli, mosse e
contromosse, furono ben più complicati mentre la guerra procedeva sempre più grave
colla moltiplicazione di zone sotto completo controllo serbo e col suo triste strascico
di violenze sui civili e di popolazioni disperate in fuga.
Anche fra i croati comparvero unità paramilitari fra le quali spiccò l’Associazione di
Difesa Croata: queste, che spesso indossavano la nera uniforme ustascia, a loro volta
si abbandonarono alle (solite) famigerate atrocità sulla popolazione civile delle altre
etnie, e soprattutto su quella serba.
Ognuna delle due parti in lotta accusava – a ragione! – l’altra; tutte due praticavano la
pulizia etnica; tutte due parevano non rendersi conto che facevano quel che
rimproveravano all’altra; ambedue giudicavano che le minoranze etniche proprie in
terra altrui erano vittime e che quelle nel proprio stato un corpo estraneo di cui in un
modo o nell’altro bisognava liberarsi.
La svolta nelle operazioni belliche fu la resistenza all’attacco serbo (il 24 agosto) di
Vukovar, porto fluviale sul Danubio al confine serbo-croato (in Slavonia), che giunse
del tutto inattesa e costrinse i serbi all’assedio: il 14 settembre Tudjman ordinò
finalmente il blocco delle caserme dell’Armata Popolare (cosa che gli sloveni
avevano imposto fin da subito) ma ormai la Guardia Nazionale Croata procedeva di
sua iniziativa e le assaltò impadronendosi dei loro depositi di armi.
Il 5 ottobre lo stato maggiore dell’Armata Popolare vedendo che il suo ultimatum
affinchè le caserme venissero liberate non aveva avuto esito riprese l’offensiva in
grande stile (anche contro le città dalmate) e l’aviazione riuscì a bombardare
addirittura il palazzo presidenziale a Zagabria.
Intanto il 24 ottobre la Regione Autonoma Serba di Slavonia e quella di Krajina
(compresa la Krajina bosniaca!) dichiaravano la loro volontà di unione con la Serbia
stessa in nome dell’autodeterminazione dei popoli (che evidentemente non valeva per
gli albanesi del Kosovo e per i musulmani del Sangiaccato).
Il 18 novembre cadeva finalmente Vukovar, rilevante vittoria serba pagata a
carissimo prezzo dai suoi eroici difensori e dalla sua sfortunata popolazione, ma
anche vittoria di Pirro e inizio della decadenza degli invasori serbi - che pure
sembravano sul punto di sconfiggere definitivamente la Croazia.
Il fatto era che l’Armata Popolare non poteva più reggere il ritmo della guerra e
sopportare gli sforzi cui era sottoposta: era ormai un esercito serbo e ciò significava
anche che il numero delle diserzioni (fra i coscritti delle altre etnie) cresceva, come
quello dei renitenti alla leva (anche fra i serbi!) - anche perchè da parte di tanti
militari non si capiva il senso e lo scopo di una guerra così violenta e fratricida.
Più in generale, il popolo serbo stesso non aveva le risorse necessarie per un’impresa
come la costruzione della Grande Serbia nè un sufficiente numero di persone per
popolarla; nessuno aveva previsto poi che le forze armate croate sarebbero riuscite a
55
resistere ed a contrattaccare – e intanto dalla Slavonia cominciavano ad arrivare
colonne di profughi serbi.
Come se tutto ciò non bastasse, la Serbia stava perdendo il sostegno internazionale: di
fronte anche agli efferati eccidi al di fuori di ogni convenzione di guerra, il senato
U.S.A. si pronunciò per il riconoscimento di Croazia (e di Slovenia), mentre le
pressioni tedesche in Europa facevano guadagnare ulteriore terreno alla loro causa.
Certamente anche la Croazia, nonostante fosse riuscita a costruirsi un esercito che
stava contrattaccando vittoriosamente, pativa gravi e gravissimi disagi, tali che non
poteva garantire sul suo successo finale.
I tempi erano insomma maturi per una tregua: il Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. il
27 novembre votò all’unanimità la Risoluzione 721 per un cessate il fuoco, l’invio
dei Caschi blu nelle zone di guerra per garantirlo, e incaricò lo statunitense Cyrus
Vance di studiare un piano di pace.
Già a fine anno Vance presentò il suo Piano che fondamentalmente congelava la
situazione, fermava (per la quindicesima volta!) i combattimenti e prevedeva una
serie di misure per tenere in equilibrio le due etnie nelle zone della Croazia occupate
dai serbi.
Genscher riuscì intanto a forzare i tempi e finalmente il 16 dicembre la U.E. si
impegnò a riconoscere entro il 15 gennaio 1992 qualsiasi delle repubbliche exjugoslave ne avesse fatto richiesta entro il 23 dicembre: il 19 la Germania – ansiosa di
affermarsi come uno stato ormai emancipato – procedette per conto suo al doppio
riconoscimento, il Vaticano la seguì il 13 gennaio 1992 e due giorni dopo l’Europa
intera stessa.
Anche la Croazia aveva raggiunto dunque l’obiettivo che si era prefissato ma a parte i
costi terribili – oltre 20mila morti, 600mila profughi, ingenti e dolorosissime
devastazioni – la sua era una ben strana indipendenza con oltre 1/3 del suo territorio
ancora in mano ai suoi nemici mortali serbi.
Purtroppo era evidente che soltanto una nuova guerra avrebbe potuto stabilire confini
definitivi e sovranità certe.
L’indipendenza della Macedonia
Sull’onda degli avvenimenti in Slovenia ed in Croazia, l’8 settembre 1991 in
Macedonia (su poco più di 2 milioni di abitanti il 65% era macedone, il 21%
albanese e il 5% turco) si tenne un referendum nel quale un'amplissima maggioranza
(oltre il 95,5%) votò a favore dell'indipendenza dalla Jugoslavia e così il 18
novembre 1991 anche la Macedonia proclamò a sua volta l’indipendenza e
presentò anch’essa alla U.E. la richiesta di riconoscimento: tuttavia, nonostante il
Paese avesse tutti i requisiti necessari, la U.E. preferì per il momento rimandare
l’accettazione della sua richiesta a causa dell’opposizione della Grecia che temeva il
contagio dell’irredentismo nella sua Macedonia interna.
56
Per lo stesso motivo la questione fu lasciata nuovamente in sospeso anche dopo che il
27 febbraio 1992 la Turchia (unica a farlo) la riconobbe come nuovo stato.
In ogni caso era chiaro che il riconoscimento era solo una questione di tempo:
oltretutto, come la Slovenia a nord, anche la Macedonia a sud era tutto sommato in
una posizione marginale e non certamente vitale per gli interessi serbi.
Era insomma un altro pezzo di Jugoslavia che di fatto se ne andava per la sua strada
ed era la vecchia Jugoslavia stessa che aveva cessato di esistere: dopo che anche la
Bosnia-Erzegovina proclamò la sua indipendenza, il 27 aprile 1992 Serbia e
Montenegro (rimasti ormai soli) decisero di unirsi in una nuova (e ben ridotta)
Repubblica Federale di Jugoslavia – che dichiararono, fra l’altro, erede della
Jugoslavia precedente.
A metà dicembre 1993 la Comunità Europea, passando sopra le decise proteste della
Grecia, si decise infine al riconoscimento ufficiale della Macedonia, seguita dagli
U.S.A. (impegnati intanto in un rinnovato tentativo di risolvere la questione bosniaca)
il 9 febbraio 1994.
Orrore e caos in Bosnia-Erzegovina
Gli eventi che per anni travolsero in modo terribile ed indescrivibile la BosniaErzegovina fecero impallidire quelli che si erano verificati in Slovenia ed in Croazia
per almeno due motivi: innanzitutto per la loro atrocità che raggiunse livelli
inimmaginabili e che lasciò incredula e sbalordita l’opinione pubblica europea (e
mondiale), ma anche per la loro ossessionante complicazione che solo uno studioso
così meticoloso e preciso come Pirjevec è stato in grado di ricostruire in dettaglio.
In questa sede quel che preme però è comprenderli nelle loro cause, nella loro
dinamica fondamentale e nelle loro conclusioni, in modo che ne possa emergere un
quadro comprensibile.
I
Innanzitutto va chiarito il problema fondamentale di questa terra martoriata e cioè la
triplice composizione di questa Jugoslavia in piccolo: nel 1991 su una popolazione di
4.365mila abitanti i serbi (ortodossi) costituivano il 31%, i croati il 17%, i
mussulmani il 44% e gli ‘jugoslavi’ ed altre minoranze l’8%.
Come si vede, ad una divisione di tipo etnico se ne aggiungeva una di tipo religioso
ma ciò non cambiava il fatto che qui il problema non era che un gruppo dominante
trovava difficile la convivenza con uno o con altri gruppi minoritari, ma che non
esisteva una vera maggioranza perchè i mussulmani avevano solo quella relativa nè
avevano alle spalle uno stato - come invece gli altri due popoli – fuori della BosniaErzegovina.
I serbi di Bosnia erano perlopiù concentrati nella Krajina bosniaca (a nord della
repubblica, dall’altra parte del confine con la Krajina croata), a sud (a ridosso del
Montenegro) e nei suoi territori orientali (a ridosso del confine con la Serbia stessa); i
57
croati si trovavano a est del confine con la Dalmazia meridionale (croata), sul confine
nord-orientale con la Croazia stessa ed in alcune zone del centro; i mussulmani erano
più presenti su tutto il resto dello stato: la popolazione di tutti i territori rimaneva
comunque mista, anche se a maggioranze variabili.
Sia i serbi della Serbia che i croati della Croazia consideravano fratelli quelli della
Bosnia-Erzegovina e, se in una Repubblica Federale tutti (più o meno convintamente)
erano jugoslavi, col suo disfacimento e col riemergere del nazionalismo – e quanto
sentito! - esplose drammatico il problema che la loro convivenza diventava tutt’in
una volta difficilissima se non impossibile.
II
Sul finire degli anni Ottanta i serbi di Bosnia (e di Croazia) cominciarono a stringere
sempre più i rapporti con la Serbia stessa ed a riceverne armi: fu poi durante la
guerra d’indipendenza croata che, partita da nord, dalla Krajina croata, il 12
settembre 1991 si verificò la prima incursione serba nella Bosnia-Erzegovina.
Quattro giorni dopo venne proclamata una “Regione Autonoma (serba ovviamente)
della Krajina bosniaca”, seguita subito da altre quattro.
Il 9 gennaio 1992 l’autoproclamata Assemblea del Popolo Serbo (di Bosnia) unì tutte
le cinque regioni autonome serbe in un’unica Repubblica Serba della BosniaErzegovina con capitale Pale ed il cui presidente divenne il (montenegrino)
Radovan Karadzic.
Il mussulmano Alija Izetbegovic, presidente della Bosnia-Erzegovina, continuò a
difenderne l’unità col suo multiculturalismo e col suo multietnicismo ma, dato che i
suoi correligionari erano in maggioranza relativa, era facile accusarlo di mirare
all’egemonia dell’intera repubblica.
Fin dai tempi della rottura di Tito con Stalin la Bosnia-Erzegovina era stata
considerata il ridotto in cui l’esercito jugoslavo si sarebbe dovuto ritirare in caso di
invasione e così vi era stanziata più della metà delle forze armate dell’intera
Jugoslavia: a queste se ne aggiunsero presto altre (come quelle ritirate dalla
Macedonia) e, oltretutto, da Belgrado si iniziò anche a distribuire armi ai civili serbi
bosniaci.
III
Mentre nella Krajina croata e nella Slavonia (croata) i serbi procedevano al loro
rafforzamento (e ad una strisciante pulizia etnica), il governo bosniaco, nel tentativo
di bloccare il separatismo dei ‘suoi’ serbi, il 29 febbraio ed il 1 marzo 1992 fece
svolgere un referendum sull’indipendenza (dalla Jugoslavia) della Bosnia-Erzegovina
stessa, una, multiculturale e multireligiosa, al quale tuttavia parteciparono soltanto gli
elettori mussulmani e croati (meno dei 2/3 degli aventi diritto): quelli serbi non
risposero all’appello, ne boicottarono anzi attivamente le operazioni nelle zone sotto
il loro controllo e non ne riconobbero infine l’esito - favorevole alla secessione.
58
Anche qui dunque lo scontro si complicava: il governo (e i mussulmani) voleva la
Bosnia-Erzegovina indipendente e coi suoi confini intatti; i serbi si battevano per il
suo mantenimento all’interno della Jugoslavia e per il distacco però delle zone in cui
erano presenti loro; ed i croati, già in guerra coi serbi per l’indipendenza della
Croazia, parteggiavano per i mussulmani, ma avevano anch’essi mire su parti della
Bosnia-Erzegovina.
Il 3 marzo 1992 l’indipendenza della Bosnia-Erzegovina fu ugualmente
proclamata e cominciarono subito gli scontri colla Jugoslavia - in pratica con la
Serbia.
Il 27 marzo 1992 i deputati serbi vararono la carta costituzionale della Repubblica
Serba della Bosnia-Erzegovina e Karadzic diede avvio alla guerra per
l’indipendenza (e per l’unione con la Serbia).
Le due guerre si sovrapponevano e si confondevano fra loro in un caos davvero
‘balcanico’ che ben presto sarebbe sfociato in aperto orrore.
IV
I serbi paventavano ora un ritorno dell’unione croato-mussulmana (come ai tempi
degli ustascia), così alle loro truppe ‘regolari’ bosniache ed a quelle dell’esercito
ufficialmente ‘jugoslavo’, ma ormai di fatto serbo, si affiancarono gruppi di
paramilitari serbi feroci e criminali, come le ‘Tigri’ di Arkan, le ‘Aquile bianche’ di
Bokan, i cetnici di Seselj, ecc., assetati di violenza, di bottino e fanaticamente
nazionalisti.
Nel miscuglio di etnie che caratterizzava la Bosnia-Erzegovina non era possibile
tracciare confini se non scacciando le popolazioni indesiderate dai territori che si
volevano puri da altre genti e la pulizia etnica procedette così spietata ed inesorabile
in un crescendo di terrore e nella confusione generale.
Mussulmani e croati non erano in grado di opporre una sufficiente resistenza militare.
Da Belgrado Milosevic sosteneva la lotta e spesso la guidava, dato che il suo
obiettivo era semplice e chiaro – la costruzione della Grande Serbia, da ottenersi
annettendo (oltre a parti della Croazia) anche parti della Bosnia-Erzegovina (e
lasciando pure che un’altra parte venisse magari annessa alla Croazia e che ai
mussulmani venisse lasciato il resto).
In una confusione babelica - anzi ‘balcanica’ - di mosse e contromosse, di tentativi e
svolte, per anni la violenza non fece che crescere selvaggia e sfrenata: l’opinione
pubblica mondiale assistette incredula a massacri e distruzioni inenarrabili (con
addirittura bambini gettati vivi nei forni o nelle macchine tritatrici), ad un ritorno dei
peggiori incubi della seconda guerra mondiale e dei suoi simboli, agitati ed esibiti
con orgoglio dai protagonisti della strage senza fine.
Ben presto la stessa capitale Sarajevo venne cinta da assedio e divisa da un fronte di
46 km. che correva per il centro della città stessa: per anni ed anni sarebbe stata
continuamente bombardata e ridotta in condizioni miserabili.
59
Questa città dalla popolazione fino ad allora così multietnica (49% mussulmana, 30%
serba, 7% croata, una presenza significativa di Ebrei ed un 11% di ‘jugoslavi’) ed un
tempo fiorente crocevia di popoli e culture, divenne ora il simbolo e l’emblema della
tragedia cui l’Europa ed il mondo assistevano senza riuscire a decidersi su cosa fare.
In meno di un mese e mezzo le forze armate serbe (regolari e non) occuparono il 60%
della Bosnia-Erzegovina spargendo ovunque arrivavano il terrore dei massacri, delle
razzie, delle distruzioni e della pulizia etnica: lo scopo evidente era purificare e
sgombrare dalle nazionalità non-serbe i territori che sarebbero così potuti diventare
parte integrante della Grande Serbia.
Per la prima volta nella storia lo stupro sistematico (delle donne mussulmane)
divenne una vera e propria arma di guerra: la donna, stuprata ripetutamente finchè
non rimaneva incinta, veniva poi rimandata dalla sua gente perchè ne minasse
ulteriormente il morale e ne disgregasse la compattezza interna: queste povere vittime
oltre alla pena (molto dolorosa data anche la loro mentalità) per la terribile esperienza
vissuta venivano spesso rifiutate dalle loro stesse famiglie, si sentivano colpevoli e
macchiate per sempre, portavano in grembo la prova vivente dell’irridente potenza
dell’odiato aggressore: gli innocenti che mettevano al mondo erano spesso solo un
ulteriore elemento di insopportabile disturbo.
Almeno 20mila poverette subirono questa sorte e addirittura i servizi segreti serbi
diffusero sul mercato pornografico americano videocassette in cui erano state riprese
violenze, stupri e torture cui le disgraziate erano state sottoposte.
V
La diplomazia internazionale cominciò a prodursi in un caotico ed inconcludente
balletto fatto di infinite riunioni, proclami, risoluzioni, proposte, inviti, sostegni
contrapposti alle fazioni in lotta, divisioni più o meno sotterranee, calcoli, incontri,
speranze ... e quant’altro mente umana poteva concepire per confondere le acque,
evitare di risolvere il problema e parlar chiaro.
Certamente fu stabilito il blocco commerciale con la Jugoslavia (leggi Serbia); fu
varato l’embargo delle armi (che danneggiò enormemente chi l’esercito non l’aveva,
cioè i mussulmani); il 6 aprile 1992 la Comunità Europea riconobbe la BosniaErzegovina e subito dopo anche gli U.S.A. - nell’inutile tentativo di dissuadere i serbi
a voler distruggere uno stato ormai accettato dalla comunità internazionale; i russi
ebbero un andamento molto incerto ed oscillante perchè il presidente Eltsin aveva un
gran bisogno dell’Occidente, ma anche grossi problemi coi mussulmani di casa sua e,
soprattutto, con l’opposizione rosso-nera dei nazionalisti di Zirinovskij che, nostalgici
dell’impero, lo rimproveravano di non sostenere i fratelli serbi.
Le truppe dell’O.N.U. (l’UNPROFOR) che furono inviate sul campo ebbero il solito
mandato di assistere la popolazione senza poter intervenire in sua difesa (per non
intromettersi in questioni interne dell’ex-Jugoslavia): ciò significava che dovevano
lasciar fare ai violenti tutto quel che essi volevano e che per portare gli aiuti umanitari
60
alle popolazioni straziate dovevano chiedere il permesso di passare ai loro carnefici e,
soprattutto, lasciare a questi ultimi gran parte dei beni trasportati.
E’ questo l’inevitabile destino di tutte le missioni umanitarie che si prefiggono di
alleviare gli effetti senza intervenire sulle cause: spesso essi prolungano le sofferenze
rifornendo sia gli aggressori che le vittime di cibo, medicinali e quant’altro serve alla
sopravvivenza - ed alla continuazione della guerra!
VI
Tuttavia la tragedia bosniaca non era solo un effetto dell’aggressione serba:
inevitabilmente anche i croati non poterono che essere subito coinvolti, ma la loro
partecipazione fu complessa e contraddittoria.
Se infatti da una parte essi erano orientati ad allearsi coi mussulmani contro i Serbi
perchè anche loro si sentivano minacciati da questi ultimi, allo stesso tempo però
coltivavano anche progetti analoghi a quelli stessi serbi, cioè miravano anch’essi alla
secessione delle aree della Bosnia-Erzegovina in cui erano più consistentemente
presenti – previa la loro ‘purificazione’ da elementi estranei – ed alla loro annessione
alla Grande Croazia.
L’esempio serbo venne insomma seguito subito anche dalla Croazia – che, oltretutto,
al tempo degli ustascia aveva compreso anche la Bosnia-Erzegovina! – e fin dal
marzo 1991 Tudjman e Milosevic - mentre si combattevano in Croazia! - si
consultavano però anche per la spartizione della Bosnia-Erzegovina (!).
Tudjman così da una parte cercava di frenare i serbi d’accordo coi mussulmani, ma
dall’altra appoggiava però il leader secessionista dei croati bosniaci Boban contro i
mussulmani stessi (!).
Naturalmente, anche in questo caso il turbine di accordi e controaccordi, incontri,
intese, cambiamenti, scontri e tregue, ecc., si dispiegò in tutta la sua indecifrabile
tortuosità – ma questo non può certo stupire nè possono farlo gli altissimi prezzi
pagati dalle popolazioni civili in vite umane, distruzioni e pulizie etniche subite.
Anche i croati si comportarono come i serbi quando cominciarono a conquistare
territori e città, anche loro – spesso con divise e simboli ustascia – infierirono sulla
popolazione mussulmana (e serba) che perseguitarono, su cui commisero atrocità e
che espulsero nelle loro campagne di pulizia etnica.
Al di là dei loro dissidi Milosevic e Tudjman si stavano accordando per la
costruzione di una Grande Serbia e di una Grande Croazia ai danni dei mussulmani
cui pensavano di riservare gli avanzi di quanto da loro spartito: inutile aggiungere che
le ipotesi di divisione, sia quelle fatte dai diretti protagonisti che quelle immaginate a
livello internazionale, furono numerose.
Per parte loro i mussulmani andavano rafforzandosi sempre più anche per l’arrivo
nelle loro fila di combattenti stranieri: non avevano alle spalle uno stato, ma erano
pur sempre dieci volte più numerosi dei croati e non furono da meno come
combattenti e come occupanti.
61
La Bosnia-Erzegovina era sempre più una bolgia infernale in cui si inserì a pennello
la nomina del generale Ratko Mladic - noto come il ‘macellaio di Knin’ - a
comandante in capo dell’Esercito serbo della Bosnia (ufficialmente costituito di soli
bosniaci, dato che le truppe della Serbia si erano ufficialmente ritirate dal conflitto).
VII
A partire dall’agosto 1992 sulla stampa europea cominciarono a comparire articoli e
reportages sul sistema concentrazionario serbo - in Bosnia ma anche nella Serbia
stessa e nel Montenegro – e sui lager che facevano la loro triste ricomparsa da un
passato che si pensava fosse ormai stato chiuso per sempre: le cifre poi erano
altissime - almeno 400mila persone erano state rinchiuse nei 94 lager della sola
Bosnia (!).
Naturalmente nonostante il clamore in Occidente ed all’O.N.U., a parte il solito mare
di chiacchere e a parte i soliti aiuti umanitari, non si fece nulla di concreto per
fermare questo scempio.
I genocidi potevano insomma proseguire praticamente indisturbati mentre le pulizie
etniche moltiplicavano le colonne di profughi disperati che nessuno ormai sapeva
dove sistemare: i 2/3 della Bosnia-Erzegovina erano stati ormai conquistati dai serbi
che ne scacciavano la popolazione non-serba, mentre le truppe dell’UNPROFOR
venivano aumentate di numero ma non potevano intervenire (se non per difendere se
stesse).
Era ovvio però che gli aggrediti reagissero, così il contrabbando di armi fiorì e dai
Paesi islamici cominciarono ad arrivare combattenti spesso fanatizzati: la guerra da
etnica diventava in misura crescente anche religiosa e da parte serba era vissuta
addirittura come un proseguimento di quella che dal Trecento al primo Novecento era
stata combattuta contro i turchi – e (se possibile) s’incancreniva ancora di più.
Fanno fede di ciò anche le sconsiderate distruzioni di opere dal profondo significato
storico ed artistico, come quella del ponte sulla Neretva a Mostar (nella Bosnia sudoccidentale), che, risalente ai tempi di Solimano il Magnifico (XVI secolo), era
simbolo di unione fra le etnie e i popoli: proprio per questo nel novembre 1993 venne
demolito a cannonate dai serbi.
IX
All’inizio del 1993 Milosevic si rese conto che la Serbia era ridotta in condizioni
economiche gravissime (inflazione a 2.000.000%, 80% della popolazione sotto la
soglia di povertà, oltre mezzo milione di profughi, e via di seguito), che le sanzioni
ne bloccavano i rifornimenti, che la passione nazionalista non bastava più e che,
insomma, il Paese non poteva più continuare a sostenere un così prolungato sforzo
bellico: visto che il 27% della Croazia ed il 70% della Bosnia-Erzegovina erano in
mani serbe, era arrivato il momento di raccogliere i frutti di queste conquiste e di
renderle – almeno in buona parte – stabili ed accettate.
62
Con un radicale cambiamento di politica, Milosevic divenne insomma uomo di
‘pace’, cioè disposto alla trattativa per mantenere il mantenibile.
Il vozd venne per questo sicuramente apprezzato dalla comunità internazionale, ma
solo da questa perchè i serbi di Bosnia vollero invece continuare la guerra (e
rifiutarono così tutte le proposte di pace elaborate dalla diplomazia internazionale)
come anche i mussulmani ed i croati, che nel frattempo erano riusciti a rafforzarsi
(i primi grazie agli aiuti ed agli arrivi dai Paesi islamici mentre i secondi erano ormai
un esercito moderno e ben equipaggiato) e pensavano quindi di poter avere ormai la
loro riscossa.
Tutti insomma volevano continuare la guerra tranne Milosevic (!) che, comunque,
non poteva far mancare il suo appoggio ai suoi fratelli d’oltre confine mentre cercava
inutilmente di convincerli ad una trattativa seria e sincera.
X
Data l’assoluta gravità della situazione, il 25 maggio 1993 l’O.N.U. con la
Risoluzione 827 istituiva un Tribunale Speciale per processare i responsabili delle
violazioni dei diritti dell’uomo nell’ex-Jugoslavia a partire dal 1991 e nominava suo
primo presidente l’italiano Antonio Cassese.
Era questa la prima corte per crimini di guerra costituita in Europa dalla seconda
guerra mondiale: essa sarebbe stata chiamata a giudicare i crimini avvenuti nei
quattro conflitti nell’ex-Jugoslavia: in Croazia (1991-95), in Bosnia-Erzegovina
(1992-95), in Kosovo (1998-99) e in Macedonia (2001).
La corte poteva processare solamente persone singole, quindi nessuno Stato, partito
politico od organizzazione ricadeva sotto la sua giurisdizione: la pena massima che
poteva comminare era l'ergastolo.
XI
Mentre l’opinione pubblica internazionale era sempre più sbigottita (l’‘effetto CNN’
era tale che negli U.S.A. l’impatto emotivo della guerra di Bosnia era superiore
perfino a quello del Vietnam!) e l’Amministrazione Clinton si rendeva conto
dell’impressione di impotenza che stava dando, un primo deciso passo verso la
soluzione del conflitto venne offerto nel febbraio 1994 dal riavvicinamento croatomussulmano basato sul riconoscimento dell’intangibilità delle frontiere della BosniaErzegovina e sulla pacifica convivenza delle due parti.
Ammesso che Tudjman fosse sincero, era questa una svolta davvero importante se
si pensa che la guerra era costata ai croati oltre 10mila morti e l’evacuazione della
metà degli 880mila croati abitanti i territori caduti in mano ai mussulmani: era la
rinuncia agli accordi di spartizione più volte immaginati con Milosevic che ora non
poteva più contare su nessuno, governava un Paese ormai al collasso e non riusciva a
convincere i serbi bosniaci che continuavano imperterriti la guerra e rifiutavano uno
dopo l’altro i piani di pace che venivano loro proposti: le cifre della pulizia etnica da
63
loro operata erano impressionanti, come per esempio quelle della Bosnia
settentrionale dove nella regione di Banja Luka il 90% dei 1.730mila abitanti era
stato eliminato o spinto via.
Era con questi serbi che bisognava fare i conti se si voleva concludere la guerra in
Bosnia-Erzegovina, ma essi non seppero mai rimanere entro limiti accettabili.
Mentre Sarajevo - assediata per più tempo della stessa Leningrado durante la
seconda guerra mondiale – conosceva una recrudescenza nei bombardamenti, nella
seconda metà di luglio 1995 fu Srebrenica a conoscere l’ennesimo inaccettabile
orrore: occupata dalle truppe di Mladic, tutti i suoi abitanti maschi mussulmani dai 17
ai 60 anni (accuratamente separati dal resto della popolazione) vennero massacrati in
una carneficina pianificata che durò otto giorni in un clima di entusiasmo e baldoria.
I caschi blu olandesi non mossero un dito per proteggere le 7-8000 persone che
vennero trucidate sotto i loro occhi: a Belgrado poi si festeggiò la vittoria e la presa
della città - dalla quale i serbi erano stati cacciati tre anni prima.
(Nel febbraio 2007 il Tribunale dell’Aja avrebbe poi definito ufficialmente genocidio
quello che era avvenuto a Srebrenica, ma avrebbe assolto da ogni responsabilità il
governo di Belgrado).
Tuttavia l’eccidio di Srebrenica fu un vero boomerang per i serbi perchè per la sua
gravità scandalizzò enormemente l’opinione pubblica mondiale e di conseguenza
spinse la comunità internazionale (cioè gli U.S.A.) ad intervenire in modo finalmente
efficace e definitivo.
XII
Il 10 agosto 1995 O.N.U. e N.A T.O. (cioè gli U.S.A.) si accordarono per fermare i
serbi con raids aerei mirati su obiettivi ben precisi; Tudjman e Izedbegovic
annunciarono intanto la stretta cooperazione dei loro eserciti, dato che riconoscevano
che l’attacco serbo alla Croazia e quello parimenti serbo alla Bosnia-Erzegovina
facevano parte di un unico piano (la Grande Serbia) di aggressione: si era giunti alla
stretta finale ed i serbi furono costretti ad arruolare sedicenni e donne per reggere allo
sforzo sempre più sproporzionato per le loro forze.
Il 30 agosto 1995 l’operazione “Deliberate Force” (la decima operata dalla
N.A.T.O., ma la prima veramente decisa e massiccia) costrinse i serbi a cessare
l’assedio di Sarajevo, ma non ancora la guerra, e così i bombardamenti continuarono
e le truppe croate e mussulmane ripresero l’offensiva finchè tutti non si convinsero
della assoluta necessità di sedersi tutti attorno al tavolo di pace.
I colloqui di pace iniziarono a Dayton il 1 novembre 1995 e si conclusero il 21: si
stabilì che la Bosnia-Erzegovina sarebbe rimasta uno stato unitario ma articolato in
due parti, una Federazione Croato-Mussulmana (il 51% del territorio a sud, ovest e
centro) ed una Repubblica Serba (il 49% a est e nord); le due entità sarebbero state
dotate di poteri autonomi in vasti settori, ma anche inserite in una cornice statale
unitaria; alla Presidenza collegiale del Paese (come nella Jugoslavia del dopo Tito)
sarebbero seduti, a turno ogni otto mesi, un serbo, un croato e un musulmano; i
64
profughi avrebbero potuto far ritorno alle loro case e tutti i cittadini dello stato
avrebbero goduto degli stessi diritti fra cui la piena libertà di movimento.
La Bosnia-Erzegovina di Dayton
Le sanzioni economiche e commerciali vennero naturalmente annullate e la comunità
internazionale assicurò aiuti e truppe per garantire l’esecuzione delle operazioni di
pace, l’assistenza alla popolazione e la ricostruzione del Paese ridotto in condizioni
pietose.
Infine, anche la Repubblica Federale di Jugoslavia (in pratica Serbia e
Montenegro) venne ufficialmente riconosciuta: dopo quello della Grande
Croazia, anche il progetto della Grande Serbia era definitivamente tramontato.
La divisione delle due entità non aveva – nè avrebbe - potuto tener conto della
divisione etnica antecedente alla guerra: gli spostamenti delle popolazioni e gli
sconvolgimenti del territorio erano stati troppo devastanti perchè la situazione
precedente alla guerra potesse essere ripristinata così com’era stata.
Si era combattuto ferocemente per tre anni, erano morte dalle 200mila alle 250mila
persone (circa 1/18 della popolazione), 50mila erano state quelle torturate, 2.200mila
(circa metà della popolazione) quelle che avevano dovuto abbandonare (forzosamente
o no) le proprie case, 20mila erano state le donne sistematicamente stuprate, 715
campi di concentramento erano stati aperti, Germania e Serbia avevano accolto
ognuna 330mila rifugiati (più quelli fuggiti in Canada) ... per raggiungere un risultato
come questo, un risultato che persone dotate di semplice raziocinio avrebbero potuto
benissimo conseguire con trattative rispettose e pacifiche.
Oggi il ponte di Mostar è stato ricostruito e restaurato insieme agli edifici circostanti
e la città è ancora una volta riunita, ma sul suo ingresso una targa sormontata dalla
coda di una granata dice molto eloquentemente ‘Remember 93’.
La Croazia interamente croata
Le complicazioni e gli sviluppi nell’ultimo anno della guerra in Bosnia-Erzegovina
finirono inevitabilmente per incrociarsi e sommarsi a quelli relativi alla presenza
serba in terra croata – e furono risolti tutti insieme.
65
Quando la Croazia aveva proclamato (e ottenuto) la sua indipendenza aveva parti del
suo territorio (nelle due Slavonie ed in Krajina) che i serbi avevano occupato e che
nei loro disegni avrebbero dovuto entrare a far parte della Grande Serbia – secondo il
principio che là dove c’erano (anche) serbi quella era Serbia, e viceversa.
L’indipendenza della Croazia era stata dunque imperfetta ed incompleta.
Ma cogli animi accesi di furioso nazionalismo bellico, quando in Bosnia-Erzegovina
guerra e pulizie etniche si moltiplicavano e croati (e mussulmani) erano alla riscossa,
una questione così grave non poteva più perdurare nè si poteva trovare una soluzione
alla guerra nella Bosnia-Erzegovina senza risolvere anche questa, perchè tutte due
erano figlie della stessa madre, il progetto appunto della Grande Serbia.
Ecco allora che contatti, proposte, piani, colloqui e quant’altro le insonni diplomazie
venivano elaborando a getto continuo riguardò anche la Croazia occupata e la
sistemazione dei serbi nei suoi territori, ma i serbi (soprattutto quelli di Croazia) li
rifiutavano tutti.
Gli U.S.A. tuttavia erano ormai dalla parte dei croati (e dei mussulmani) che
oltretutto in Bosnia-Erzegovina armavano, nella convinzione che solo un
riequilibrio delle forze in campo avrebbe permesso il sospirato ristabilimento della
pace.
Il 1 maggio 1995 con l’operazione “Fulmine” l’esercito croato, rinforzato e ben
ristrutturato, invase la (sua) Slavonia occidentale e (al solito) se la prese anche con la
popolazione civile serba (in buona parte composta però da nuovi venuti) che espulse
con una pulizia etnica ora di segno inverso: le masse di fuggiaschi serbi che non si
diressero verso la Krajina o la Bosnia, ma che tentarono l’ingresso in Serbia vennero
però respinte (!) e spedite nella Slavonia orientale.
Per ritorsione, la pulizia etnica dei serbi ai danni della popolazione croata e
mussulmana nella Krajina bosniaca si aggravò.
In tutto ciò (al solito) caschi blu, come le stelle, stettero a guardare.
Mentre le reciproche pulizie etniche si incrociavano, le forze armate serbe erano però
profondamente logorate e lo sforzo che si erano assunte risultava del tutto eccessivo
per le possibilità di un popolo stretto oltretutto nella morsa delle sanzioni
economiche.
Il 4 agosto 1995 con l’operazione “Tempesta” le forze croate invasero e
riconquistarono la Krajina croata senza che nè l’esercito della Serbia nè quello della
Krajina bosniaca potessero intervenire: la popolazione serba (conscia delle sue colpe
e dopo anni di esasperata propaganda) fu atterrita dall’arrivo, dalle distruzioni e dal
comportamento degli ‘ustascia’ che, spesso ubriachi o drogati, si abbandonarono alle
(solite) nefandezze (come giocare a calcio usando teste mozze di serbi al posto del
pallone) - e fuggì in massa.
Il Tribunale Penale Internazionale dell’Aia per queste atrocità incriminò diversi
militari croati tra cui il loro comandante, il generale Ante Gotovina (poi processato e
condannato nel marzo 2008).
L’esercito croato favorì il rapidissimo esodo e lasciò passare il fiume di disperati che
contava oltre 200mila persone senza più nulla al mondo: assetate però di vendetta e di
66
volontà di ritorsione, queste si avventarono a loro volta sui croati e sugli ungheresi
della Vojvodina che espulsero dai loro villaggi dati alle fiamme; altri si riversarono
nella Krajina bosniaca espellendone ulteriormente mussulmani e croati; altri ancora
vennero indirizzati in Kosovo dal governo stesso di Belgrado.
Insomma (al solito) una pulizia etnica ne generava un’altra in una (solita) spirale
crescente d’odio e di violenza mentre i serbi cercavano di ricompattarsi in un
territorio (in genere la Bosnia) meno esteso e più difendibile.
Nel clima di entusiasmo croato e nell’esaltazione di Tudjman non mancarono
richiami alla vittoriosa marcia antiserba della Wehrmacht ed ai loro alleati ustascia
nel 1941 che ora sembrava ripetersi con la stessa soddisfazione di allora.
Ormai ai serbi – diminuiti di oltre la metà - rimaneva comunque davvero ben poco in
terra croata.
I contemporanei rovesci serbi in Bosnia e la ferma insistenza degli U.S.A. nel voler
chiudere una volta per tutte la questione balcanica costrinsero finalmente anche i
nazionalisti serbi più riottosi al tavolo delle trattative di Dayton dove anche questione
dei serbi in Croazia fu risolta: il 12 novembre 1995 in base all’ “accordo di Erdut”
quest’ultima rientrava in possesso di tutti i suoi territori, ma garantiva tutti i diritti
alla popolazione serba che ci viveva, compreso quello di restare dove si era sistemata.
Erano stati necessari una guerra feroce, crudelissime pulizie etniche, atrocità di ogni
genere, sofferenze inenarrabili, anni di follia e di dolore assoluto, decine e decine di
migliaia di morti, devastazioni e distruzioni, per arrivare ad una conclusione
semplicemente ovvia e che persone di buon senso avrebbero potuto raggiungere in un
pomeriggio di pacata discussione intorno a un tavolo.
Apocalisse in Kosovo
Davorka Ljubisic è sicuramente convincente quando sostiene che la pubblicistica
occidentale (e Pirjevec) ha demonizzato i serbi, che praticamente di essi ha
considerato solo le colpe trascurando di capire loro ed i torti da loro subiti e senza
aver saputo riconoscere compiutamente anche le colpe e responsabilità degli altri
attori della tragedia jugoslava - e questo avvertimento va tenuto bene in mente
quando si affronta la (si spera) ultima tragedia della dissoluzione della Jugoslavia,
quella del Kosovo.
I
A Dayton si era persa l’occasione di trovare una soluzione stabile anche alla
situazione del Kosovo e così la calma (apparente) che per qualche tempo fece seguito
a quegli accordi fu solo una tregua che precedette l’ulteriore dramma.
Per quanto possa sembrare strano, Milosevic, nonostante tutte le sconfitte subite dalla
Serbia e la devastante crisi economica del suo Paese, riuscì a mantenersi al potere
anche perchè – ancor più stranamente – all’estero godeva di appoggio e stima: egli si
67
era guadagnato la fama di uomo di pace e la credibilità di essere l’unico interlocutore
serio nel caos balcanico.
Effettivamente, in nome di un certo realismo e della volontà di concretizzare il
miglior risultato possibile quando (data anche l’opposizione della comunità
internazionale, un tempo amica) la situazione si era fatta troppo difficile per poter
garantire il successo totale, il vozd aveva saputo distinguersi da un Karadzic e da un
Mladic e dalla insensata intransigenza loro e dei serbi di Bosnia e di Croazia: egli era
riuscito a presentarsi come il perno di ogni soluzione equilibrata nell’intera area
balcanica ed a far dimenticare (a chi non chiedeva altro) il suo nazionalismo e tutto il
suo attivismo per la costruzione della Grande Serbia.
Tuttavia la resa finale dei conti non c’era ancora stata: sarebbe arrivata infine nel
Kosovo.
II
Il problema del Kosovo era semplice: su una popolazione totale di quasi 2 milioni di
abitanti i serbi erano il 10% circa mentre gli altri 1.700mila erano albanesi, quasi tutti
di religione mussulmana e con un tasso di crescita demografica talmente alto che si
calcolava che nel nuovo millennio sarebbero diventati 2.600mila.
Eppure il Kosovo era una provincia della Serbia cui nel 1989 era stata tolta anche
l’autonomia: da allora sulla provincia si era abbattuta tutta una serie di atti e di leggi
volti a discriminare la componente albanese a vantaggio della risicata minoranza
serba mentre l’oppressione poliziesca ai danni degli albanesi era tale che Pirjevec
parla di un “governo di stampo coloniale”.
Come se non bastasse, dai serbi (tutti) il Kosovo era considerato la culla della loro
nazione: là si sorgevano i monasteri e le chiese ortodosse in cui si era formata la loro
cultura e civiltà e là si trovava il Campo dei merli in cui il 28 giugno 1389 i serbi
stessi erano stati sterminati in massa dai turchi nella storica battaglia che, se aveva
segnato la vittoria definitiva di questi ultimi, ne aveva però comportato anche
l’arresto - tanto che i serbi da allora sostengono di essersi dovuti sacrificare per la
salvezza dell’intera Europa.
Ora questa terra sacra era popolata in grande maggioranza da stranieri – che, data la
loro preponderanza numerica spesso erano intolleranti a loro volta verso i serbi - e
per giunta della stessa religione, l’Islam, dei nemici ed oppressori storici dei serbi
stessi: infine, qui non c’entrava nemmeno il progetto della Grande Serbia perchè il
Kosovo era già Serbia.
Per i serbi si trattava insomma di essere padroni in casa propria e proprio in Kosovo
Milosevic si era fatto notare agli inizi della sua scalata al potere quando aveva
assicurato protezione ai serbi locali che allora si sentivano oppressi e discriminati.
Consistenti nuclei di albanesi erano poi presenti in anche in Montenegro, in
Macedonia ed in Grecia e ciò – se possibile – complicava ancora più la situazione
perchè rischiava di esportare la destabilizzazione kosovara anche in questi Paesi.
68
Mentre l’Albania nel 1991 si era liberata dell’insensato comunismo isolazionista di
Enver Hoxha, ma versava in condizioni miserabili e non aveva alcuna possibilità di
intervenire, almeno 500mila erano però gli emigrati albanesi nel mondo – e questi
costituirono una forte base per il finanziamento dei movimenti in Kosovo.
Come si vede, gli ingredienti per uno scontro all’ultimo sangue c’erano tutti.
III
Di fronte al continuo inasprimento, anche con misure d’emergenza, della crescente
serbizzazione della provincia molti kosovari di etnia albanese scelsero (favoriti dalla
autorità serbe) la strada dell’emigrazione, ma quelli che restarono iniziarono la loro
marcia per l’indipendenza:
il 2 luglio 1990 i deputati albanesi proclamarono l’indipendenza del Kosovo
(ufficialmente però ancora nell’ambito della Repubblica Federale);
il 13 settembre 1990 decisero (segretamente) di diventare indipendenti dalla Serbia;
dal 26 al 30 settembre 1991, spinti poi dall’esempio sloveno e croato, indissero un
referendum segreto (ma al quale partecipò oltre l’87% degli aventi diritto!) che sancì
la separazione dalla Jugoslavia;
il 19 ottobre 1991 il parlamento del Kosovo ne proclamò l’indipendenza ed il suo
presidente Ibrahim Rugova istituì un governo in esilio;
il 24 maggio 1992 la Lega Democratica del Kosovo di Rugova stravinse le elezioni
(clandestine).
Rugova, pacifista convinto, portava avanti la sua azione con mezzi assolutamente
non-violenti come l’astensione, la non-partecipazione e la resistenza passiva, ma ciò
permetteva a Milosevic di poter concentrare i suoi sforzi su Croazia e BosniaErzegovina nonchè di accaparrarsi tutti i deputati alle elezioni (cui partecipavano solo
i serbi): infine, per la comunità internazionale in Kosovo la situazione era tranquilla.
Dopo Dayton l’Unione Europea aveva riconosciuto infatti la Repubblica Federale di
Jugoslavia così com’era, ignorando il Kosovo coi suoi problemi e lasciandolo
insomma nelle mani di Milosevic e dei kosovari serbi.
La condizione dei kosovari albanesi non potè che peggiorare.
IV
Nel 1996 dal fallimento della strategia di Rugova nacque il Movimento di liberazione
nazionale, l’Uck, deciso a ricorrere alla lotta armata come all’unico strumento per
raggiungere non tanto l’indipendenza del Kosovo, quanto la formazione di una
Grande Albania che riunisse tutti gli albanesi sparsi in tanti stati: non a caso il loro
simbolo era l’aquila bicipite nera su sfondo rosso, la bandiera cioè dell’Albania.
Cominciò così la serie di attentati e di incidenti armati cui rispose la repressione
sempre più dura del regime serbo in un crescendo (se possibile) di odio e di ferocia
fra le due etnie: anche qui la terribile maledizione dei Balcani si aggravava in modo
ormai irreparabile.
69
La sequenza degli eventi fu la (solita) tristissima serie di massacri, di ritorsioni, di
accuse reciproche, di brutalità rinfacciate e quant’altro, mentre la comunità
internazionale – presa infine coscienza del problema – cominciò col suo (solito)
balletto di incontri, memorandum, proposte di accordo, riunioni, giochi e giochini
diplomatici, sotterfugi, divisioni, calcoli, inviti, missioni, osservatori, ultimatum
(ovviamente disattesi) e dichiarazioni: intanto i serbi cominciavano a loro volta a
fuggire dal Kosovo, l’Uck si guadagnava l’appellativo di terrorista (dato che
oltretutto se la prendeva anche con le altre minoranze etniche) e la repressione
governativa s’incattiviva anche – e soprattutto – sulla popolazione civile, l’eterna
vittima.
Mentre il Kosovo ormai bruciava in un clima di violenza sempre più indiscriminata,
nel luglio 1997 Milosevic veniva intanto rieletto presidente della Repubblica Serba.
La situazione precipitava con l’Uck che liberava zone crescenti della provincia da cui
spazzava via ogni oppositore e Milosevic che era costretto ad accogliere nel suo
governo ancora una volta il Partito radicale di Seseli che puntava all’espulsione
forzata degli albanesi dal Kosovo ed al loro rimpiazzo con gli esuli serbi dalla
Krajina e dalla Bosnia.
I risultati di questa nuova strategia si videro presto nel luglio 1998, quando l’Armata
Popolare entrò in forze in Kosovo e l’Uck passò di sconfitta in sconfitta e di ritirata in
ritirata, seguito da turbe di civili in fuga di fronte all’avanzata dei soldati serbi: nel
Kosovo non si riusciva più nemmeno a seppellire i cadaveri.
V
Di fronte alla catastrofe umanitaria che si andava profilando ed alle masse di profughi
che rischiavano di riversarsi nei Paesi limitrofi e di creare una situazione di caos
ingovernabile in tutta la regione, l’Europa non potè che accodarsi
all’Amministrazione Clinton che con la sua battagliera Segretaria di Stato Madeleine
Albright spingeva la N.A.T.O. ad agire prima che fosse troppo tardi bypassando
l’O.N.U. - nel cui Consiglio di sicurezza sicuramente qualcuno (Russia, Cina)
avrebbe posto il veto.
Il progetto statunitense era comunque ben più ambizioso ed andava al di là del
problema del Kosovo: per l’Amministrazione Clinton infatti l’intervento in Kosovo
avrebbe dovuto porre anche le basi per trasformare la N.A.T.O. stessa da ‘alleanza
militare con basi politiche’ in ‘alleanza politica con basi militari’, cioè ridefinirne
il ruolo facendone lo strumento per portare avanti le iniziative statunitensi nel mondo:
un intervento in un Paese al di fuori dell’Alleanza stessa giustificato con motivazioni
umanitarie sarebbe stato una perfetta applicazione del nuovo principio secondo cui
quel che gli U.S.A. volevano, dovevano ottenere grazie alla schiacciante potenza
militare di cui disponevano ed ai loro alleati sempre più disposti a seguirli docilmente
- con l’ approvazione dell’ O.N.U. o senza; quanto alla Russia, essa poteva protestare
(a parole) quanto voleva, tanto era troppo dipendente dagli aiuti occidentali per poter
pretendere di opporsi sul serio.
70
Intanto la situazione sul campo andava peggiorando e le immagini strazianti degli
effetti delle efferatezze compiute facevano il giro del mondo: gli U.S.A. avevano
cominciato intanto ad armare e ad addestrare gli uomini dell’Uck, ma Belgrado non
arretrava di un millimetro convinta (probabilmente a ragione) che con un terzo delle
sue forze armate in Kosovo avrebbe potuto spazzar via l’Uck in poco tempo se gli
U.S.A. avessero smesso di sostenerli.
E i massacri, le devastazioni e le pulizie etniche continuavano sempre più intense.
Alla fine gli ultimi indugi furono superati: anche l’Italia appoggiò l’intervento
N.A.T.O. mettendole a disposizione le basi sul suo territorio.
(Per la prima volta era Presidente del Consiglio in Italia un ex-comunista, Massimo
D’Alema, evidentemente desideroso di dimostrare la sua fedeltà all’ex-nemico dei
tempi della ‘guerra fredda’).
VI
Nella convinzione che in pochi giorni Milosevic si sarebbe arreso dopo una resistenza
di facciata, l’8 marzo 1999 partì il primo raid aereo N.A.T.O. che coinvolse non
solo le installazioni militari in Kosovo, ma anche quelle in Serbia ed in Vojvodina:
era tassativo non usare mai la parola ‘guerra’ – si trattava di una missione umanitaria!
-, nè avere mai caduti dalla propria parte (i piloti dovevano volare ad almeno 5mila
metri di altezza per evitare di essere intercettati dalla contraerea serba e squadre
speciali erano sempre pronte a recuperare quelli che fossero stati abbattuti).
La reazione serba fu però tutt’altra da quella che ci si era aspettato: subito il governo
serbo proclamò infatti lo stato di guerra, ma, soprattutto, il 25 marzo affermò che gli
albanesi del Kosovo avevano iniziato un attacco generalizzato contro le forze serbe
nella provincia e partì al ‘contrattacco’, dando cioè il via alla pulizia etnica totale
della popolazione kosovara albanese.
Era lo showdown finale, la resa dei conti finale, la soluzione definitiva del problema:
il Kosovo doveva essere liberato dalla presenza degli albanesi e restituito alla sua
origine serba: nella radicalità della guerra aperta ed unica solutrice di tutti i problemi
parlarono solo le armi, la violenza e la totale mancanza di scrupoli.
‘Quando il gioco si fa duro giocano i duri’ verrebbe da dire ed in effetti fu così:
certamente di fronte alla resistenza serba ed alla drammatica aggressione totale e
pianificata, alla sequela di atrocità senza fine da parte di militari e paramilitari serbi
sulla popolazione civile kosovara albanese, nel campo degli assalitori occidentali ci
furono i soliti distinguo e le solite resistenze (segnatamente di Italia e di Russia) ma,
al solito, furono solo (le solite) parole e prese di posizione senza conseguenze
pratiche di alcun tipo.
Non si può insomma non notare che mentre da una parte c’era chi era pronto a
sopportare ogni sacrificio, a morire e ad uccidere, dall’altra stava invece chi
sottoponeva un intero Paese, incomparabilmente più debole ed alla fame, ad intensi e
continui bombardamenti (segnatamente quelli su Belgrado) ma non voleva (nè
poteva!) perdere nemmeno un uomo mentre usava solo termini politicamente corretti
71
come ‘missioni umanitarie’, ‘aiuti’, ‘pace’, ecc., ed ogni sorta di ipocrita espressione
per mascherare all’opinione pubblica quel che era evidentemente una guerra di
aggressione di cui venivano taciute molte vere motivazioni.
Seppur la campagna serba di odio e di violenza era assolutamente indifendibile,
questa disparità di comportamenti non può però essere taciuta e l’affettazione
‘buonista’ dell’Occidente risultava davvero insopportabile: e mentre in Serbia la
propaganda patriottica ed esaltatrice dell’eroismo serbo continuava martellante, la
N.A.T.O. sotto la diretta direzione del presidente Clinton non potè far altro che
infittire i suoi bombardamenti dall’alto dei cieli.
In gioco ora c’erano la credibilità stessa dell’Alleanza Atlantica ed il ruolo degli
U.S.A. negli affari europei (e mondiali), due obiettivi irrinunciabili per l’unica
superpotenza rimasta dopo il crollo dell’U.R.S.S..
VII
Come se tutto ciò non bastasse, la pulizia etnica serba stava funzionando in modo
eccellente: poco o nulla potè il tentativo di resistenza dell’Uck contro l’esodo in
massa di folle disperate e terrorizzate che, prive di tutto, si riversarono sui confini di
Albania, Macedonia e Montenegro creando un ingorgo di proporzioni bibliche e
preparando una apocalittica catastrofe umanitaria: l’opinione pubblica occidentale
assisteva incredula e sbigottita alle immagini di sterminati carnai puzzolenti di turbe
di disgraziati accampati privi di tutto in vere e proprie fogne a cielo aperto.
L’Albania con oltre 260mila profughi, la Macedonia con 250mila, il Montenegro con
una cifra oscillante fra i 35 ed i 70mila stavano scoppiando ed i governi occidentali e
le organizzazioni umanitarie dovettero impegnarsi a fondo per impedire la catastrofe
definitiva.
Mentre i bombardamenti si infittivano e sembravano non aver più fine, era sempre
più evidente che ogni previsione ed assicurazione dei governi dei Paesi della
N.A.T.O. era stata smentita: al solito, le polemiche inutili ed impotenti si
moltiplicavano senza sortire effetto alcuno.
Come sostiene la Ljubivic, nella ex-Jugoslavia non c’erano buoni contro cattivi (nulla
nei Balcani è semplice) ed anche l’Uck in un folle circuito di vendette e rappresaglie
a non finire si macchiò – e non da adesso – di crimini efferati ai danni dei serbi: il suo
estremismo la rese invisa allo stesso Rugova che temeva che il Kosovo in mano loro
sarebbe diventato una ‘Cuba europea’ ed un covo di criminali.
La Serbia di Milosevic resisteva, e più resisteva più si infittivano e si aggravavano i
raids aerei che si susseguivano ormai per tutte le ore del giorno aumentando in
parallelo anche il tipo degli obiettivi, senza risparmio alcuno per quelli civili: il
crescendo propagandistico da ambedue le parti sembrava rendere irraggiungibile la
fine dello scempio.
72
VIII
Nonostante le condizioni dei suoi cittadini fossero terribili e proibitive, la Serbia
resisteva e da parte statunitense (i cui alleati erano sempre più riottosi a continuare i
bombardamenti) ci si rese finalmente conto che ottenerne la resa senza condizioni
non era possibile e ci si decise alla trattativa: nonostante il 27 maggio 1999 il
Tribunale dell’Aja avesse emesso un mandato di comparizione contro Milosevic
(contro un capo di stato!), la diplomazia continuò a lavorare imperterrita anche con
lui finchè il 9 giugno il sospirato accordo fu raggiunto sul campo e venne ratificato
dal Consiglio di Sicurezza il giorno seguente con la risoluzione 1244.
Esso prevedeva la cessazione dei combattimenti, il ritiro dal Kosovo di tutte le forze
militari e paramilitari serbe, la smilitarizzazione dell’Uck, il governo provvisorio
della provincia da parte dell’O.N.U. (e non della N.A.T.O.!) e l’integrità della
Repubblica federale jugoslava – Kosovo compreso.
Per questo i bombardamenti (fino a 300 al giorno!) di 1.200 aerei di 13 Paesi erano
continuati per ben 79 giorni ed avevano pesantemente devastato una Serbia che pure
già da prima versava in condizioni seriamente critiche.
IX
Nonostante un’altra ennesima guerra avesse tanto piagato il suo Paese, Milosevic
parlò ai suoi concittadini di vittoria – ed effettivamente dal suo punto di vista non
aveva tutti i torti: la Serbia era riuscita a mantenere intatti i suoi confini e nel resistere
ad un’offensiva così massiccia e dotata di una superiorità di mezzi tanto schiacciante
aveva dato prova di una grinta e di una determinazione a dir poco sorprendenti; in
tutto il conflitto erano morti solo 462 soldati e 114 poliziotti (e 500 civili, per la
verità); l’Armata popolare usciva dallo scontro sostanzialmente intatta (!) dato che
era stata concepita fin dai tempi di Tito perchè fosse in grado di nascondersi,
proteggersi, riposizionarsi ed ingannare il nemico, nemico che si era affidato solo alla
sua indiscussa superiorità nei cieli senza volersi mai esporre e correre il rischio di
combattere per davvero sul campo.
I 47mila soldati serbi si ritirarono dal Kosovo in ordine e coll’equipaggiamento
praticamente intatto (!) suscitando l’ammirazione dei suoi stessi increduli nemici.
Anche la N.A.T.O. cantò vittoria – aveva perso due aerei e nessun uomo – ma in
realtà era l’Europa che usciva umiliata, incapace com’era stata di risolvere un
problema così squisitamente europeo ed avendo dovuto ricorrere (al solito) agli
statunitensi, la cui superiorità tecnologica si era oltretutto rivelata semplicemente
incomparabile con la loro.
Le vittime kosovare erano state superiori a quelle di tutte le guerre del decennio
precedente, ma di ciò nessuno sembrò curarsi.
73
X
In realtà Milosevic aveva sperato di poter conservare – con l’aiuto dei russi - il nord
del Kosovo (dove, fra l’altro, si trovavano i luoghi più significativi della storia e
civiltà serbe ed erano presenti i serbi stessi), ma oltre al fatto che l’appoggio russo era
di facciata o poco più, dietro le truppe internazionali venute a prendere il posto di
quelle serbe si mossero centinaia di migliaia di profughi albanesi che a fiumi
tornavano alle loro case in un poderoso controesodo: fu ora la volta dei serbi
(almeno 165mila) e dei rom (70mila) a dover fuggire nel caos e nel terrore delle
vendette cui l’Uck non aveva alcuna intenzione di rinunciare.
Gli accordi di pace su questo punto (la convivenza pacifica dei due popoli) non
vennero mai attuati ma questo, data la profondità degli odi implacabili fra le due
etnie, non era semplicemente possibile.
Il Kosovo era diventato albanese e ciò in qualche modo chiarì e semplificò
comunque la situazione – e nei Balcani questo non è poco.
Il Montenegro fra due fuochi
Il Montenegro – che di una popolazione complessiva di 600mila abitanti aveva il
62% di montenegrini, il 15% di mussulmani, il 9,5% di serbi, il 6,6% di albanesi ed il
4,5% di jugoslavi – era sempre rimasto al fianco della Serbia cui permetteva
l’importantissimo sbocco al mare e con cui aveva fondato la Repubblica Federale di
Jugoslavia nel 1992, ma anche questo legame cominciò a vacillare a causa sia delle
allora crescenti tensioni in Kosovo (cui la Serbia non voleva in alcun modo
rinunciare) sia per il richiamo dell’Occidente, così carico di promesse.
Nell’ottobre 1997 vinse così le elezioni presidenziali Milo Djukanovic, fortemente
critico nei confronti della politica di Milosevic;
nel maggio 1998 il suo Partito Democratico dei Socialisti – alleato anche degli
albanesi! – vinse quelle per il parlamento, che subito richiamò in patria i suoi soldati
impegnati in Kosovo;
nel marzo 1999, quando ormai l’attacco della N.A.T.O. contro la Serbia si profilava
sicuro, il governo montenegrino se ne dissociò però apertamente e vietò che il suo
territorio venisse usato per questo scopo;
quando la guerra stava ormai divampando Djukanovic, in netto dissenso con
Milosevic, chiuse le sue frontiere con la Serbia, ma questo non risparmiò le
installazioni del suo Paese dall’essere anch’esse bombardate dalla N.AT.O. (!), nè
questo fu l’unico prezzo pagato, dato che anche il Montenegro dovette ricevere masse
di sfollati kosovari albanesi che ne attraversavano terrorizzati i confini (dai 35 ai
70mila).
74
Ultimi bagliori di guerra: Macedonia
La Macedonia era arrivata all’indipendenza in modo pacifico e gli ex-comunisti
(autorinominatisi ‘socialdemocratici’) che l’avevano trasformata in una repubblica
presidenziale erano riusciti a tenerla fuori da ogni conflitto ed anzi avevano saputo
profittare dello stato di guerra soprattutto in Kosovo per favorire massicciamente il
contrabbando (un’attività da sempre largamente praticata nei Balcani) aggirando
facilmente l’embargo deciso dall’O.N.U..
Seppure in pace, la Macedonia non era però un Paese senza problemi, che anzi
andavano dalle mancate riforme in campo economico alla corruzione ed alla
dilagante criminalità organizzata, ma, soprattutto, riguardavano l’eterna conflittualità
balcanica fra le diverse etnie.
Gli albanesi di Macedonia (concentrati a nord-ovest lungo i confini coll’Albania e col
Kosovo) chiedevano infatti maggiore attenzione e rispetto per i diritti loro e della loro
cultura, che avvertivano entrambi discriminati: la guerra nel Kosovo non potè poi che
far precipitare la situazione anche in Macedonia.
Negli anni di tensione crescente e poi di guerra aperta in Kosovo, il contrabbando di
armi (e di droga, di tabacco, di cioccolata e perfino di ‘schiave bianche’) da parte
degli albanesi macedoni in favore dei ‘connazionali’ kosovari fiorì permettendo così
una grande disponibilità di armi (e di denaro) anche nella Macedonia stessa.
Nel momento più drammatico del conflitto 250mila albanesi kosovari varcarono il
confine con la Macedonia nella quale inevitabilmente vennero così stabilite anche
basi e centri di raccolta per combattenti da inviare in Kosovo: e ciò non potè non
portare anche alla formazione di milizie locali ed al rafforzamento delle bande più o
meno criminali già presenti sul territorio.
In realtà il governo aveva cercato di corre ai ripari sia chiedendo di entrare nella
N.A.TO. nel 1996, che cercando di riorganizzare e rendere efficienti grazie ad essa le
proprie forze armate dal 1998, ma corruzione e scollegamento fra le iniziative
avevano reso di fatto impraticabile ogni buon proposito ed esse rimasero così
disorganizzate, mal gestite e scoordinate.
Tensioni etniche interne, crimine organizzato e guerra etnica ai confini costituivano
una miscela pronta ad esplodere al minimo incidente.
Le prime azioni da parte degli albanesi in Macedonia avvennero nel tardo 2000 e nel
primo 2001 soprattutto lungo il confine macedone con il Kosovo ormai amministrato
dall’O.N.U.: come gli albanesi in Kosovo nel 1997 e nel 1998, anche quelli macedoni
prendevano ‘pacificamente’ possesso di villaggi dai quali la popolazione nonalbanese veniva invitata ad andarsene.
Nel gennaio-febbraio 2001 cominciarono gli scontri armati contro le autorità
legittime.
Questi scontri vennero rivendicati da un sedicente Esercito di Liberazione Nazionale
(NLA), ma il governo macedone sostenne che i combattenti erano invece infiltrati
75
dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (KLA) e sulle prime non reagì, convinto che
quel che stava succedendo non era diretto contro la Macedonia (e dalle tangenti).
In realtà anche se nessuno dei due partiti etnici albanesi lo sosteneva il NLA era
macedone ed il Kosovo era il suo porto franco dove poteva trovare mezzi, protezione
e rifugio in caso di necessità.
In quel momento in Macedonia erano presenti numerosi contingenti N.A.T.O. sotto la
supervisione dell’O.N.U., ma tutti questi rimasero rigorosamente inattivi e neutrali di
fronte alle incursioni del NLA nè contrastarono le infiltrazioni dei guerriglieri dal
Kosovo.
La spiegazione di questo comportamento è tuttavia semplice: innanzitutto, queste
truppe erano impegnate ad impedire che la guerra in Kosovo si estendesse e
contagiasse i Paesi circostanti, quindi non volevano assolutamente soffiare sul fuoco
delle tensioni in un Paese confinante; in secondo luogo, dovevano garantire la più
completa imparzialità (soprattutto in un conflitto che non le riguardava); in terzo
luogo, le truppe N.A.T.O. erano contro la Serbia in difesa degli albanesi del Kosovo e
sarebbe stato strano e controproducente se contemporaneamente si fossero mossi
contro gli albanesi (confinanti) della Macedonia; infine, un buon numero di alti
ufficiali macedoni era dalla parte della Serbia ed avverso alla N.A.T.O. ed alla sua
presenza sul territorio macedone, per cui non sembrava opportuno inasprire
ulteriormente i rapporti.
Gli scontri in Macedonia così si infittirono e la controffensiva dell’esercito e delle
forze paramilitari non riuscì a debellare i suoi ribelli albanesi: la U.E. e la N.A.T.O.
dovettero così risolversi ad intervenire per bloccare questa ennesima escalation di un
conflitto che (al solito) rischiava di rimettere in moto tensioni e rivendicazioni
nell’intera area.
Dopo l’ennesimo intervento dell’Occidente, nel giugno 2001 fu così giocoforza
giungere alla cessazione del fuoco ed all’accordo di Ocrida in base al quale il
governo macedone garantiva una maggiore decentralizzazione amministrativa, il
riconoscimento dei diritti dei cittadini di etnia albanese (inclusa l’accettazione
dell'albanese come lingua co-ufficiale e l’aumento della partecipazione degli
albanesi nelle istituzioni governative, nella polizia e nell'esercito); e da parte albanese
si abbandonò la richiesta di separazione e si riconobbe pienamente la legittimità dello
Stato macedone.
Infine, fu stabilito che il NLA sarebbe stato disarmato e che le sue armi sarebbero
state consegnate alla N.A.T.O.: fu questa l’ 'operazione ‘Essential Harvest’ che
cominciò il 27 agosto, durò un mese e si concluse senza problemi.
La positiva e tutto sommato rapida conclusione della vicenda (che tuttavia ebbe
ancora qualche strascico fino a novembre) fu possibile anche perchè i morti erano
stati solo alcune decine (da entrambe le parti), ma si era trattato pur sempre di guerra:
l’eloquente conferma di ciò è che nell'agosto 2001 i profughi erano ben 170mila, solo
74mila dei quali interni, e che nel gennaio 2004 ce n’erano ancora 2.600.
76
‘Balcanizzazione esterna’ dei Balcani
Di fronte alle crudeltà raccapriccianti ed alle atrocità senza fine del nazionalismo e
dell’odio interetnico che caratterizzarono la terribile dissoluzione della Jugoslavia
degli anni Novanta del secolo scorso non ci si può non chiedere perchè avvennero,
che senso ebbero, perchè tanto odio sfrenato, tanto fanatismo, tanta esaltazione nel
massacro e nella pulizia etnica: in genere la risposta che venne data dall’Occidente
sbigottito fu che il regime comunista di Tito in qualche modo aveva congelato
tensioni nazionalistiche di antica data che quando finalmente furono libere di
esprimersi lo fecero con tutta la carica furiosa accumulata nei decenni in cui erano
state soffocate.
Ecco spiegato, fra l’altro, anche tutto il risorgere di simboli e di atteggiamenti propri
della seconda guerra mondiale: il titoismo era riuscito a sconfiggerli ed a metterli a
tacere, ma non a farli sparire, riuscendo cioè a rimandare soltanto il momento del loro
sfogo che fu così tanto più terribile quanto più aveva dovuto attendere.
La seconda guerra mondiale, pur con tutto il suo orrore e tutte le sue stragi, aveva
insomma paradossalmente espresso ciò che gli jugoslavi, queste genti così aspre e
dure, avevano veramente nell’animo, ma non era riuscita a saldare i conti degli odi
etnici una volta per tutte: questi ultimi riesplosero appena poterono smentendo
l’illusione di chi pensava che fossero ormai solo un tragico ricordo di un tempo
fortunatamente ormai passato e sepolto.
Il fatto che i confini politici non coincidessero – nè ciò era mai stato possibile dato il
mescolamento di genti di nazionalità diverse – con quelli etnici rese la convivenza
impossibile una volta che non c’era più il regime comunista ad imporla ed a
garantirla.
Questa la ‘spiegazione’ corrente, ma Davorka Ljubisic (“A Politics of Sorrow”) la
contesta con forza - e la sua analisi merita di essere presa in seria considerazione.
La Ljubisic esalta e rimpiange la Jugoslavia di Tito di cui apprezza il piano di parità
su cui tutte le nazionalità erano state poste, in cui non c’erano maggioranze e
minoranze ma solo jugoslavi, in cui i matrimoni ‘misti’ crescevano di numero in uno
spirito di accettazione e tolleranza: secondo lei il Paese era rispettato nel mondo, la
fiorente economia arrivava a livelli quasi occidentali ed i servizi sociali erano
avanzati e garantiti a tutti.
Come fu allora possibile che tutto ciò crollasse così in fretta ed in modo tanto
violento?
La sua risposta è netta: la ‘Balcanizzazione interna’, cioè il nazionalismo etnico e
violento (innegabile), è stata messa in moto da una ‘Balcanizzazione esterna’, cioè
dagli interessi e dalle manovre di Potenze straniere mosse dalla volontà di una
ricolonizzazione dei Balcani attraverso la sperimentatissima politica del ‘divide et
impera’: i Balcani vennero insomma balcanizzati, cioè resi violenti, confusi ed
invivibili, dall’esterno!
77
Posto che essa riconosce senz’altro che “il nazionalismo è stata una condizione
necessaria ma non sufficiente per la distruzione della Jugoslavia”, i punti essenziali
della sua analisi sono comunque i seguenti:
1) I territori che nel XX secolo sarebbero diventati Jugoslavia storicamente erano
sempre stati divisi ed attraversati dai confini delle Grandi Potenze (da quelli fra
l’Impero Romano e quello Bizantino a quelli fra l’Impero Austro-Ungarico e
quello Turco) che divennero anche religiosi e culturali: i suoi popoli avevano
dovuto sempre resistere e combattere per la loro libertà ed indipendenza - che
arrivò solo nel XX secolo;
2) gli odi etnici furono un dato recente nella loro storia e risalgono al secolo
scorso, al momento dell’invasione nazifascista ed alla nuova divisione (ancora
una volta dall’esterno!) del Paese, unificato solo un ventennio prima;
3) dopo la morte di Tito ed il crollo dell’U.R.S.S. i Balcani tornarono ad essere un
punto strategico fra Nord e Sud e fra Est ed Ovest (e per il passaggio del
petrolio del Caspio) e la Jugoslavia non fu più quel (utile e comodo) cuscinetto
fra i due blocchi, com’era stata al tempo della ‘guerra fredda’;
4) nell’ambito della politica per estendere la presenza della N.A.T.O. fino ai
confini della Russia, l’interesse occidentale (soprattutto di U.S.A. e di
Germania) era stato così quello di frantumare la Jugoslavia e di poterne quindi
controllare i frammenti;
5) il ricorso ai prestiti del F.M.I. e della Banca Mondiale in seguito alla crisi
economica degli anni Ottanta (dopo la morte di Tito) avevano sottoposto il
Paese alle (solite) dure restrizioni di bilancio imposte da tali organismi
internazionali, longa manus di interessi stranieri (segnatamente di U.S.A. e di
Germania): le conseguenti privatizzazioni, la distruzione dello stato sociale e
di tanti servizi (soprattutto in seguito alla ‘shock terapy’ del 1990 ed alla
perdita di controllo sulla propria Banca Centrale da parte del governo
jugoslavo) si erano sommati alla disoccupazione crescente ed avevano portato
ad un’inevitabile esacerbamento degli animi ed alla conseguente riaccensione
delle rivalità interne;
6) “la nazione conquistò lo stato”: in Jugoslavia si diede cioè rilievo decisivo
all’appartenenza etnica delle persone e non al loro status giuridico;
7) il punto di non-ritorno fu il frettoloso riconoscimento da parte della Germania
(e del Vaticano!) dell’indipendenza di Slovenia e Croazia a confini inalterati,
senza nessuna considerazione per coloro che all’interno di essi (segnatamente
in quelli della Croazia) improvvisamente diventavano minoranze interne e
discriminate: ciò valse soprattutto per i serbi che si erano considerati (ed erano
stati) i dominatori dell’intera Jugoslavia al tempo della sua esistenza e che
ricordavano ancora il feroce genocidio perpetrato nei loro confronti dagli
ustascia - cui ora i croati si ispiravano! -;
8) nelle feroci guerre interetniche le prime vittime furono non solo le minoranze,
ma coloro che si sentivano e si definivano ‘jugoslavi’, visto che tale nazionalità
non esisteva più e che essi dunque non avevano più alcun luogo dove vivere;
78
9) il progetto di questa ‘balcanizzazione esterna’ nel Nuovo Ordine Mondiale
(con la sua ideologia del ‘libero mercato’) di Bush senior è perfettamente
riuscito ed ora i nuovi staterelli sono controllati da U.S.A. e da U.E.: non è
esagerato parlare di una vera e propria ricolonizzazione.
L’analisi della Ljubisic merita sicuramente di essere presa sul serio perchè coglie un
punto nevralgico del nostro tempo post-‘guerra fredda’ - e cioè mette in luce il
dominio sempre più massiccio esercitato su stati e nazioni dal potere finanziario
internazionale, senza volto e per questo tanto più pericoloso.
Proprio in questo autunno 2011 in Italia è evidente come prestiti ed aiuti
internazionali coll’imporre tutta una serie di misure per il risanamento dei bilanci
siano in grado di definire l’intera vita economica di un Paese e finanche i suoi
rapporti sociali interni.
La perdita di sovranità e di autonomia – cioè di libertà – risulta chiara nel momento
in cui l’organizzazione produttiva di un Paese deve innanzitutto rispondere
all’imperativo di pagare le rate del debito sottoscritto: il creditore – estero! – finisce
inevitabilmente per condizionare (o addirittura assumere il controllo) le scelte del
governo debitore, mentre fette di ricchezza nazionale passano sistematicamente in
mani straniere.
E’ ovviamente vero che nessuno (apparentemente) costringe un Paese a chiedere aiuti
e ad indebitarsi, ma, a parte che in certe condizioni (come durante la transizione da un
regime ad un altro) ciò può risultare inevitabile, i prestiti ed i finanziamenti arrivano
ormai sempre dagli stessi organismi internazionali (come F.M.I., B.C.E., Banca
Mondiale, ecc.) che dunque gestiscono una rete impressionante – planetaria – di
rapporti economici con una moltitudine di Paesi: non sembra quindi esagerato parlare
a questo proposito di una regia internazionale del credito (quindi dell’economia) e
della gestione sempre più eterodiretta di tante parti della ricchezza nazionale di tanti
Paesi.
Chi controlla questi organismi senza volto ha insomma un potere enorme: secondo la
Ljubisic dietro di essi ci sarebbero gli U.S.A. (e nel caso dei Balcani anche la
Germania) guidati ed ispirati dalla dottrina di Bush senior del ‘Nuovo Ordine
Mondiale’: la Jugoslavia secondo lei sarebbe finita nel mirino di questa politica che
puntava a smembrarla per meglio dominarla - appunto secondo l’immortale regola
del ‘divide et impera’.
La Ljubisic, sinceramente legata al ricordo idilliaco della Jugoslavia di Tito, non
dimostra nè documenta troppo le sue affermazioni, ma esse risultano ugualmente
convincenti, anche se a loro volta esagerate ed unilaterali.
Quando essa analizza la storia della Jugoslavia e tenta di ridimensionare la
convinzione occidentale che nei Balcani gli odi interetnici erano costitutivi dello
spirito stesso dei suoi popoli e mostra invece che il nazionalismo etnico è un
elemento recente risalente al secolo scorso, dimentica infatti che prima del 1919 la
Jugoslavia non esisteva!
79
I popoli che entrarono a farne parte provenivano da imperi – multinazionali! - diversi
ed i rapporti fra loro erano stati quindi fra stranieri ed erano stati sottomessi a
stranieri per così dire ‘terzi’, cioè austriaci o turchi: anche se spesso si erano
combattuti nelle guerre fra i loro stati di appartenenza, sentimenti di odio etnico in
tali condizioni non potevano nascere!
Accettando quel che la Ljubisic sostiene, e cioè che essi nacquero e si scatenarono
solo dopo che potenze straniere (nazifascismo prima, U.S.A. e Germania poi) li
accesero intervenendo nel Paese, il problema dell’incredibile intensità del
nazionalismo e della feroce bestialità degli odi interetnici nei Balcani rimane irrisolto
e non viene spiegato (sempre ammesso che sia possibile farlo): il ruolo degli
interventi stranieri è innegabile, ma come avrebbero mai potuto scatenare una furia
simile a quella nell’ex-Jugoslavia se non avesse trovato tanto odio già esistente in
essa?
In definitiva la Ljubisic aggiunge un elemento prezioso alla comprensione della
disgregazione della Jugoslavia, ma ne esagera il peso – per tacere di una certa sua
vena se non proprio assolutoria almeno giustificatrice nei confronti di chi si macchiò
di crimini orrendi che a volte essa sembra inserire fra le vittime anzichè fra i
carnefici.
Certamente ogni ricostruzione rimane legittima anche perchè dello spappolamento
della Jugoslavia - così recente! - si può fare il racconto, ma ciò non significa
(ancora) comprenderlo.
Pax americana nei Balcani
Nonostante il fugace ritorno di fiamma in Macedonia, col definitivo intervento
statunitense nel Kosovo terminava il decennio di guerre spaventose e crudeli
combattute in un clima di frenetico odio reciproco per avere stati etnicamente
omogenei - e si può dire che in qualche misura questo risultato è stato almeno
parzialmente raggiunto, visto che le minoranze etniche dei vari Paesi sono più ridotte
di quanto non fossero nel 1991.
Nel 2005 l’U.N.H.C.R., l’agenzia dell’O.N.U. per i rifugiati, calcolò che circa
2.500mila persone avevano potuto far ritorno alle loro case; che 620mila si erano
definitivamente stabilite oltreoceano, ma che altre si erano stabilite nello stato dove
erano maggioranza; per altre ancora il ritorno stesso era a dir poco problematico,
soprattutto per i serbi del Kosovo, impossibilitati a tornare a vivere nelle loro case.
Per altre ancora la vita si era spenta: non sapevano dove tornare avendo perso tutto ed
essendo rimaste sole ed indifese al mondo – profughe e rifugiate per sempre.
Un oceano di dolore e sofferenza aveva spazzato i Balcani, l’Europa aveva mostrato
quanto era imbelle e gli U.S.A. avevano preso in mano la situazione: certamente
avevano così voluto affermare i loro interessi e le loro strategie, ma chi preferisce lo
scannatoio etnico si faccia avanti e lo dica con chiarezza (se ne ha il coraggio).
80
Oltre all’incapace Europa l’altra grande assente dalla vicenda era stata la Russia di
Eltsin: prostrata economicamente, oberata dai debiti e costretta a ricorrere agli aiuti
internazionali (cioè largamente agli U.S.A.), militarmente impacciata e
disorganizzata, essa non potè intervenire efficacemente dalla parte dei serbi, i suoi
protetti e alleati di sempre, né offrire un contraltare all’intervento degli U.S.A., in
pratica i soli veri dominatori e decisori.
La lezione è durissima da accettare, ma i fatti parlano troppo chiaro per potersi
permettere il lusso ed il vezzo intellettuale di dubitarne.
Epilogo
Dopo che i giochi di guerra furono finalmente chiusi ecco lo stato dell’ex-Jugoslavia
nell’autunno 2011.
La Slovenia, lo stato più sviluppato dell’intera area, è entrata nell'Unione Europea il
1 maggio 2004 e dal 1 gennaio 2007 ha adottato l'euro.
Dopo che il 15 gennaio 1998 la Croazia aveva ripreso possesso dell’ultimo lembo di
terra ancora in mani serbe, l’11 dicembre 1999 Franjo Tudjman morì e fu così
possibile l’instaurazione di un regime democratico.
Il Tribunale dell’Aja ha riconosciuto post mortem Tudjman principale responsabile
delle stragi e delle deportazioni di civili serbi dalla Croazia nel 1995: già in
precedenza dichiarato criminale di guerra, non fu però mai direttamente processato
finché ancora in vita.
La Croazia ha presentato la domanda di adesione all'Unione Europea il 21 febbraio
2003 e la Commissione Europea il 18 giugno 2004 ha deliberato di farla diventare
Paese candidato ufficiale: essa dovrebbe così entrare nell'Unione Europea il 1 luglio
2013.
In Serbia dopo che aveva accettato la pace in Kosovo Slobodan Milosevic non
serviva più, così gli U.S.A., che avevano trattato con lui fino al giorno prima, ora
misero una taglia di 5 milioni di dollari sulla sua testa (e su quella degli uomini della
sua cerchia).
In patria i sacrifici imposti alla popolazione, l’isolamento internazionale del Paese e
tutte le guerre perse fecero sì che alle elezioni presidenziali del 24 settembre 2000 si
affermasse il suo avversario Vojislav Kostunica, fondatore e leader del Partito
Democratico di Serbia, ma gli intoppi (ed i sospetti di brogli) posti dal regime ed il
rifiuto di Milosevic di accettare l’esito spinsero la popolazione a manifestazioni e
proteste sempre più accese che culminarono il 5 ottobre con la ‘rivoluzione del
bulldozer’ (usato per attaccare la sede della radiotelevisione): due giorni dopo
Milosevic dovette finalmente cedere e rassegnare le dimissioni e Kostunica potè
entrare in carica.
81
Ormai caduto dal potere, il 31 marzo 2001 Milosevic venne arrestato per abuso di
ufficio, corruzione, omicidi, stragi, concussioni ed altro ancora: tuttavia in patria non
fu mai processato perchè il 28 giugno 2001, prima che scadessero i 90 giorni
dell’arresto preventivo, venne consegnato al Tribunale dell’Aja che da tempo lo
richiedeva.
Nonostante rifiutasse di riconoscerne la legittimità, Milosevic, definito il ‘macellaio
dei Balcani’, si difese – da solo - con vigore negando ogni addebito per tutti i 66 capi
di imputazione e protestando di aver sempre agito per il bene e la salvezza del popolo
serbo: venne trovato morto per un attacco di cuore nella sua cella la mattina dell'11
marzo 2006, ma ci furono forti sospetti che in realtà fosse stato eliminato per mezzo
di farmaci.
Pochi giorni prima nello stesso carcere dell’Aja si era suicidato l’ex-leader dei serbi
della Krajina croata, Milan Babić, che pure aveva patteggiato una condanna a soli 13
anni: queste morti, come anche il suicidio del serbo di Croazia Slavko Dokmanović
sempre nel carcere dell'Aia nel 1998, gettano una luce ancor più sinistra sui terribili
eventi di cui furono i tragici protagonisti.
Nel 2002 il parlamento federale di Belgrado operò una ristrutturazione della
Repubblica Federale Jugoslava che attenuò i legami fra Serbia e Montenegro: il 4
febbraio 2003 nacque così l’Unione degli Stati di Serbia e Montenegro che tuttavia
ebbe vita breve: in seguito al referendum del 21 maggio 2006 il Montenegro ha
dichiarato la propria indipendenza il 3 giugno 2006 (come, ovviamente, ha dovuto
fare la Serbia stessa due giorni dopo).
Il 17 dicembre 2005 il Consiglio Europeo ha conferito alla Macedonia lo status di
Paese candidato a divenire membro dell'U.E..
In base alle Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. il
Kosovo, posto sotto il protettorato della N.A.T.O., era stato dotato anche di un
governo e di un parlamento provvisori.
Mentre l'etnia albanese era ormai prevalente in quasi tutto il Paese la violenza non si
placava del tutto: vari pogrom albanesi si verificarono nei confronti dei pochi serbi
rimasti, come quello del marzo 2004, quando le uccisioni continuarono per cinque
giorni, moltissime case serbe furono sgombrate a forza dai loro abitanti e numerose
chiese e monasteri cristiani risalenti soprattutto al medioevo furono seriamente
danneggiati (oltre 60 tra chiese e monasteri erano stati distrutti nei cinque anni
precedenti).
I negoziati per lo status finale del Kosovo non conclusero mai nulla perchè i serbi
(seppur ridotti a sole 110mila unità) non volevano perdere la sovranità sulla provincia
mentre gli albanesi ne chiedevano al contrario l’indipendenza.
Nelle elezioni del 17 novembre 2007 è prevalso il Partito Democratico (Pdk) dell'ex
capo guerrigliero dell'Uck Hashim Thaci, che ha subito costituito un governo
albanesofono di grande coalizione per gestire il processo verso la piena
82
indipendenza che il Kosovo ha infine proclamato il 18 febbraio 2008: tale
proclamazione, sostenuta nel Consiglio di Sicurezza dagli U.S.A., dalla Francia e
dall’Inghilterra e osteggiata però dalla Russia e dalla Cina, è stata a tutt’oggi
riconosciuta da 85 Paesi (fra cui l’Italia), ma non ancora dall’O.N.U..
Il fatto che l’arteria centrale della capitale Pristina sia stata chiamata ‘Bill Clinton
boulevard’ è eloquentissimo riconoscimento a chi ha permesso e voluto la nascita di
questo nuovo stato.
Nel dicembre 2007 la Bosnia-Erzegovina ha sottoscritto l'accordo di Stabilizzazione
e Associazione (ha cioè firmato per presa visione del contenuto del documento) con
l’Unione Europea, fase preliminare alla presentazione della candidatura per
diventarne membro.
Conclusione
Nel dicembre 2009 la Serbia ha presentato domanda di adesione alla U.E. e il 27
ottobre 2010 la domanda è stata presa favorevolmente in considerazione: mentre i
rapporti amichevoli moltiplicano i loro benefici effetti, sono state così precisate le
condizioni in fatto di democrazia interna e di requisiti economici cui (come ogni
nuovo Paese richiedente) dovrà ottemperare.
Alla Serbia però è stato anche chiesto, anzi imposto, di consegnare gli ultimi due (dei
46, Karadzic compreso) ricercati da Tribunale dell’Aja, Ratko Mladic e Goran
Hadzic, latitanti da troppi anni e quindi sicuramente ancora coperti e protetti.
Il 26 maggio 2011 Mladic, imputato di genocidio (soprattutto per quello di
Srebrenica), complicità in genocidio, sterminio, deportazione e persecuzione, è stato
così arrestato, vecchio e malato, in un villaggetto 80 km. a nord di Belgrado:
trasferito all’Aja ha protestato anche lui di aver ‘solo difeso i serbi’.
Come ricordato nell’introduzione, Hadzic ne ha seguito la sorte nemmeno due mesi
dopo.
Verrebbe quindi da dire che questa lunga, tragica e terribile storia delle interminabili
guerre dei Balcani si è finalmente conclusa e può essere consegnata al capace
archivio del passato ... e tuttavia in tanto dolore e sgomento c’è ancora un aspetto che
non riesce a trovare la sua collocazione definitiva, un conto che forse ancora non
torna – quello dei serbi.
I serbi, questo popolo così fiero, audace e cavalleresco (‘Gallant Serbia’ dicevano con
termine intraducibile gli inglesi), che per primi si sono liberati dei turchi; che, unici
nei Balcani, sono risultati vincitori nella prima guerra mondiale a costo di perdite
spaventose; intorno ai quali si è costruita l’intera Jugoslavia; che nella seconda guerra
mondiale hanno sofferto più di tutti nei Balcani ad opera dei nazifascisti e dei loro
alleati ustascia; questo popolo - che vive ancora così acutamente il ricordo della
battaglia del Campo dei merli in Kosovo del 28 giugno 1389 (!) - nel momento in cui
la Jugoslavia si dissolveva si è visto crollare (ancora una volta!) il mondo addosso, si
83
è sentito (ancora una volta!) minacciato, si è sentito (ancora una volta!) sulle spalle
tutto il peso dell’incomprensione e della solitudine.
Che bisogno c’era da parte del Vaticano, della Germania, dell’Occidente, di
precipitarsi a riconoscere Slovenia e Croazia con quei confini, senza un accenno alla
minoranza serba che vi si sentiva intrappolata?
Perchè l’Occidente e l’Europa sono sempre state dalla parte degli altri (mentre la
Russia balbettava impotente)?
Perchè, come dice amaramente la (slovena) Ljubisic si vedono solo le violenze
commesse dai serbi e mai quelle da loro patite, come i 78 giorni (anziché i
preventivati 7) del bombardamento di Belgrado al tempo della guerra del Kosovo?
Certamente queste considerazioni non possono assolutamente essere utilizzate per
coprire o giustificare anche solo in parte le colpe gravissime dei serbi, il loro essere
passati sicuramente dalla parte del torto: non ci sono alibi o attenuanti per quel
decennio di pulizia etnica e di sterminio pianificato - anche se oggi i profughi sono
quasi tutti serbi rifugiati in Serbia.
I serbi sono stati sconfitti e chiedono di entrare in Europa – che è un po’ come
quando nel Medioevo i barbari si cristianizzavano decidendo con ciò di cambiare
vita, di diventare stanziali e di accettare le regole che la Chiesa imponeva loro – ma
vien da chiedersi se ne sono davvero convinti e, soprattutto, se hanno ottenuto
giustizia.
L’Europa sembra la soluzione di ogni problema: se si vuol entrare in Europa – e
come è possibile restarne fuori condannandosi all’isolamento ed all’abbandono? – si
devono accettare precise regole per la soluzione pacifica e negoziata di ogni
problema, si entra in un sistema economico molto avanzato capace di offrire
importanti sostegni e grandi opportunità, ci si integra con oltre mezzo miliardo di
persone che vivono in continua osmosi, ognuno deve accettare (ed è accettato da)
tutti gli altri, si vive in pace circondati solo da alleati e amici fra i quali ci si muove
liberamente.
Per la Ljubivic queste sono poco più che chiacchere e per lei in realtà in Europa si
subisce il diktat di interessi enormi che impongono il controllo di ogni area, di ogni
punto strategico (quale sono i Balcani): in guerre suscitate e manovrate dall’esterno
l’Europa senza i bombardieri statunitensi non sarebbe stata capace di far nulla nè di
risolvere alcunchè. La Ljubivic ritiene che in realtà si stanno spogliando i popoli
balcanici (segnatamente il serbo) della loro individualità e della loro importanza e che
l’Occidente (gli U.S.A.) li ha fatti combattere fra loro per dominarli ed inserirli nel
proprio ordine economico-strategico.
Anche secondo la Drapac
la storia dell’intera Jugoslavia è sempre stata
transnazionale, cioè è sempre stata (fin dalla sua nascita!) manovrata e gestita
dall’esterno e l’approdo in Europa sarebbe così la conclusione di un percorso
immaginato e gestito da Potenze straniere per controllare ed inserire nel loro dominio
anche i popoli balcanici.
Ci sarà sicuramente del vero in queste analisi e una sorta di nuovo pensiero unico si
sta davvero diffondendo nell’intero Continente, tuttavia i Balcani hanno potuto
84
risollevarsi dallo stato di assoluta prostrazione in cui le guerre li avevano ridotti solo
grazie agli U.S.A. ed all’Europa.
Oggi possono guardare al futuro con fiducia ed in pace: dopo quel che hanno passato
questo deve sembrargli un sogno dal quale bisogna sperare di non svegliarsi mai.
Sottomarina autunno 2011
85
Bibliografia
La Biblioteca di Repubblica: “La Storia” - De Agostini, Novara 2004.
Luigi Salvatorelli: “Storia del ‘900” – Oscar Mondadori, Verona 1971.
“Storia d’Italia nel periodo fascista” – Oscar Mondadori,
Verona 1970.
Wolf Giusti: “Il Panslavismo” – Bonacci editore, Roma 1993.
Misha Glenny: “Balkans” – Viking Penguin, New York 2000.
Vesna Drapac: “Constructing Yugoslavia – A Transnational History”
- Palgrave Macmillan, Great Britain 2010.
Giuseppe Boffa: “Storia dell’Unione Sovietica” - Mondadori, Verona 1979.
William L. Shirer: “Storia del Terzo Reich” - Einaudi, Torino 1969.
Raul Hilberg: “La distruzione degli Ebrei d’Europa” – Einaudi, Martellago
(VE) 1970.
Curzio Malaparte: “Kaputt” – Adelphi, Milano 2009.
Davide Rodogno: “Il nuovo ordine mediterraneo” – Bollati Boringhieri,
Torino 2003.
Antonio Gambino: “Storia del dopoguerra – dalla liberazione al potere
DC” – Laterza, Bari 1975.
Marta Verginella: “Il confine degli altri” – Donzelli, Pomezia 2008.
Costantino Di Sante: “Italiani senza onore” – Ombre corte, Verona 2005.
Arrigo Petacco: “L’esodo” - Mondadori, Cles (TN) 1999.
Gaetano La Perna: “Pola, Istria, Fiume 1943 – 1945” – Mursia, Milano
1999.
Marco Pirina: “Dalle foibe … all’esodo 1943 – 1956” – Silentes loquimur
Pordenone 1996”.
Francois Feito: “Storia delle democrazie popolari” - Bompiani, Milano 1977.
U. Alfassio Grimaldi: “Il socialismo in Europa” – Garzanti, Milano 1957.
Giampaolo Pansa: “Prigionieri del silenzio” – Sperling & Kupfer, Cles 2004.
Ivo Andric: “Il ponte sulla Drina” – Oscar Mondadori, Cles (TN) 1995.
Jozip Broz Tito: “Socialismo jugoslavo” – Editori Riuniti, Roma 1969.
Edizioni del GAZZETTINO: “Slovenia e Croazia – fuga dal passato” –
Venezia 1991.
Joze Pirjevec: “Le guerre jugoslave 1991-1999” – Einaudi, Torino 2002.
Davorka Ljubisic: “A Politics of Sorrow” – Black Rose Books, Montrèal 2004.
Numerosi saggi e servizi di AA.VV. da giornali, riviste e Internet.
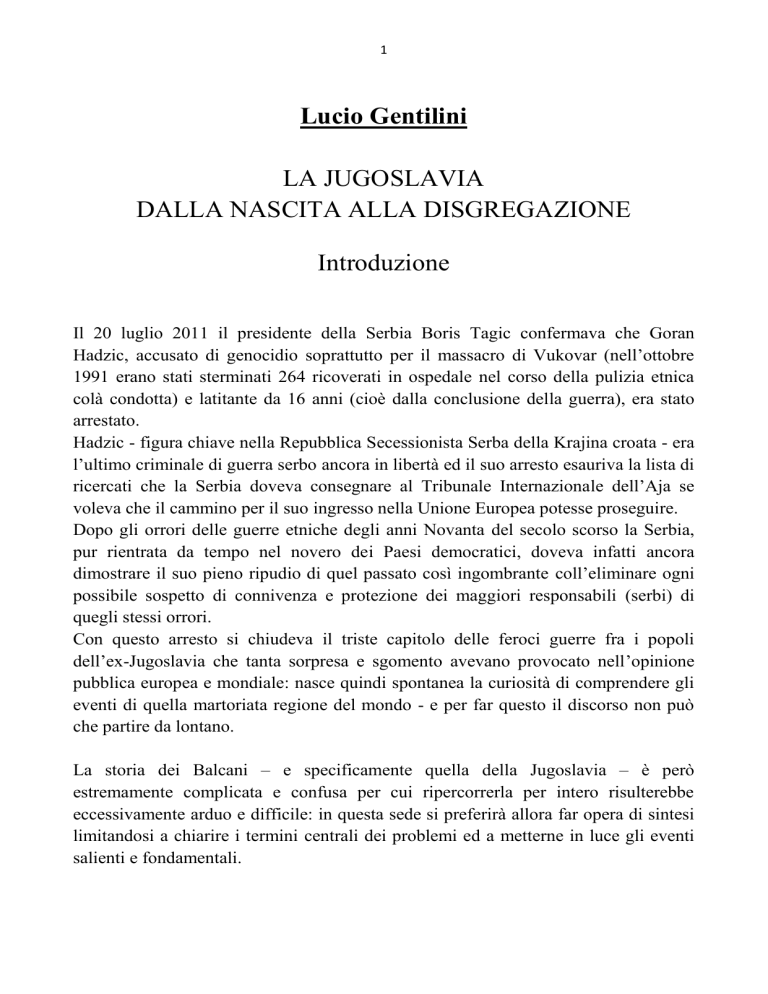
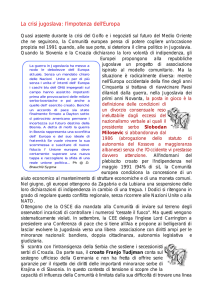

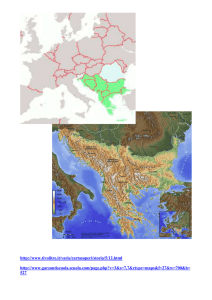

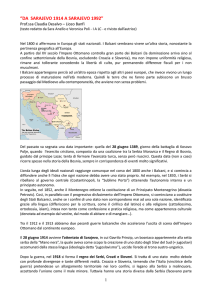
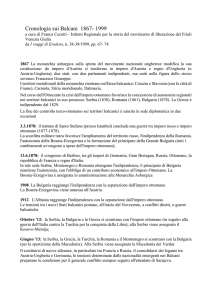
![(Microsoft PowerPoint - ex-jugoslavia [modalit\340 compatibilit\340])](http://s1.studylibit.com/store/data/001320611_1-7ee84abf992ab22f3b60e5ebbffaf648-300x300.png)