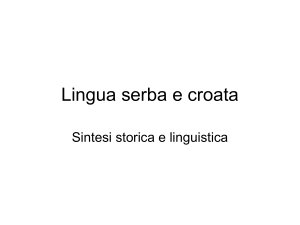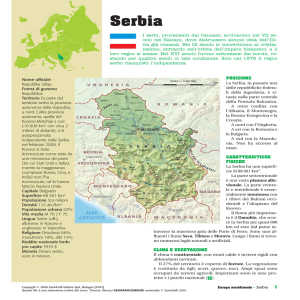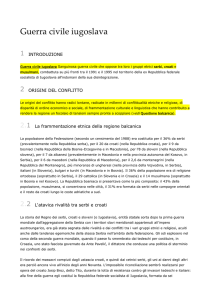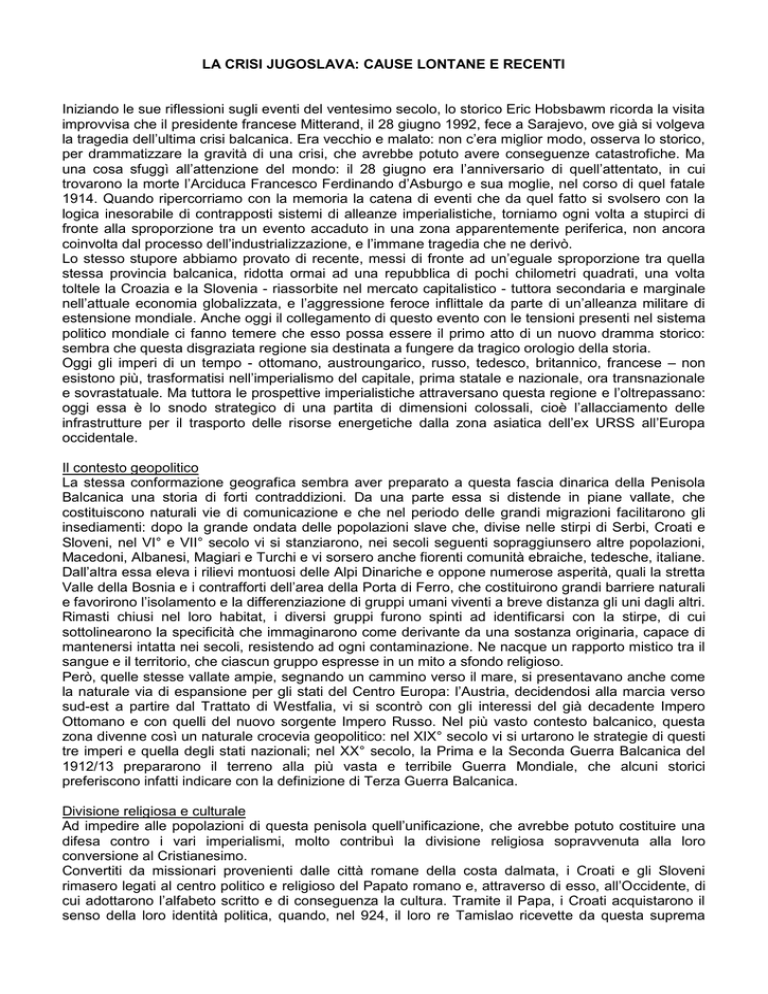
LA CRISI JUGOSLAVA: CAUSE LONTANE E RECENTI
Iniziando le sue riflessioni sugli eventi del ventesimo secolo, lo storico Eric Hobsbawm ricorda la visita
improvvisa che il presidente francese Mitterand, il 28 giugno 1992, fece a Sarajevo, ove già si volgeva
la tragedia dell’ultima crisi balcanica. Era vecchio e malato: non c’era miglior modo, osserva lo storico,
per drammatizzare la gravità di una crisi, che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche. Ma
una cosa sfuggì all’attenzione del mondo: il 28 giugno era l’anniversario di quell’attentato, in cui
trovarono la morte l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo e sua moglie, nel corso di quel fatale
1914. Quando ripercorriamo con la memoria la catena di eventi che da quel fatto si svolsero con la
logica inesorabile di contrapposti sistemi di alleanze imperialistiche, torniamo ogni volta a stupirci di
fronte alla sproporzione tra un evento accaduto in una zona apparentemente periferica, non ancora
coinvolta dal processo dell’industrializzazione, e l’immane tragedia che ne derivò.
Lo stesso stupore abbiamo provato di recente, messi di fronte ad un’eguale sproporzione tra quella
stessa provincia balcanica, ridotta ormai ad una repubblica di pochi chilometri quadrati, una volta
toltele la Croazia e la Slovenia - riassorbite nel mercato capitalistico - tuttora secondaria e marginale
nell’attuale economia globalizzata, e l’aggressione feroce inflittale da parte di un’alleanza militare di
estensione mondiale. Anche oggi il collegamento di questo evento con le tensioni presenti nel sistema
politico mondiale ci fanno temere che esso possa essere il primo atto di un nuovo dramma storico:
sembra che questa disgraziata regione sia destinata a fungere da tragico orologio della storia.
Oggi gli imperi di un tempo - ottomano, austroungarico, russo, tedesco, britannico, francese – non
esistono più, trasformatisi nell’imperialismo del capitale, prima statale e nazionale, ora transnazionale
e sovrastatuale. Ma tuttora le prospettive imperialistiche attraversano questa regione e l’oltrepassano:
oggi essa è lo snodo strategico di una partita di dimensioni colossali, cioè l’allacciamento delle
infrastrutture per il trasporto delle risorse energetiche dalla zona asiatica dell’ex URSS all’Europa
occidentale.
Il contesto geopolitico
La stessa conformazione geografica sembra aver preparato a questa fascia dinarica della Penisola
Balcanica una storia di forti contraddizioni. Da una parte essa si distende in piane vallate, che
costituiscono naturali vie di comunicazione e che nel periodo delle grandi migrazioni facilitarono gli
insediamenti: dopo la grande ondata delle popolazioni slave che, divise nelle stirpi di Serbi, Croati e
Sloveni, nel VI° e VII° secolo vi si stanziarono, nei secoli seguenti sopraggiunsero altre popolazioni,
Macedoni, Albanesi, Magiari e Turchi e vi sorsero anche fiorenti comunità ebraiche, tedesche, italiane.
Dall’altra essa eleva i rilievi montuosi delle Alpi Dinariche e oppone numerose asperità, quali la stretta
Valle della Bosnia e i contrafforti dell’area della Porta di Ferro, che costituirono grandi barriere naturali
e favorirono l’isolamento e la differenziazione di gruppi umani viventi a breve distanza gli uni dagli altri.
Rimasti chiusi nel loro habitat, i diversi gruppi furono spinti ad identificarsi con la stirpe, di cui
sottolinearono la specificità che immaginarono come derivante da una sostanza originaria, capace di
mantenersi intatta nei secoli, resistendo ad ogni contaminazione. Ne nacque un rapporto mistico tra il
sangue e il territorio, che ciascun gruppo espresse in un mito a sfondo religioso.
Però, quelle stesse vallate ampie, segnando un cammino verso il mare, si presentavano anche come
la naturale via di espansione per gli stati del Centro Europa: l’Austria, decidendosi alla marcia verso
sud-est a partire dal Trattato di Westfalia, vi si scontrò con gli interessi del già decadente Impero
Ottomano e con quelli del nuovo sorgente Impero Russo. Nel più vasto contesto balcanico, questa
zona divenne così un naturale crocevia geopolitico: nel XIX° secolo vi si urtarono le strategie di questi
tre imperi e quella degli stati nazionali; nel XX° secolo, la Prima e la Seconda Guerra Balcanica del
1912/13 prepararono il terreno alla più vasta e terribile Guerra Mondiale, che alcuni storici
preferiscono infatti indicare con la definizione di Terza Guerra Balcanica.
Divisione religiosa e culturale
Ad impedire alle popolazioni di questa penisola quell’unificazione, che avrebbe potuto costituire una
difesa contro i vari imperialismi, molto contribuì la divisione religiosa sopravvenuta alla loro
conversione al Cristianesimo.
Convertiti da missionari provenienti dalle città romane della costa dalmata, i Croati e gli Sloveni
rimasero legati al centro politico e religioso del Papato romano e, attraverso di esso, all’Occidente, di
cui adottarono l’alfabeto scritto e di conseguenza la cultura. Tramite il Papa, i Croati acquistarono il
senso della loro identità politica, quando, nel 924, il loro re Tamislao ricevette da questa suprema
2
autorità religiosa dell’Occidente una corona, come riconoscimento di sovranità e di indipendenza dal
Sacro Romano Impero ed accettò il compito di fare, del Regno di Croazia, l’antemurale contro la
nuova ondata di barbari pagani, che si erano stanziati nelle grandi pianure della Pannonia. Questa
identità politica essi difesero attraverso i secoli, riuscendo a conservare inalterate le leggi della loro
tradizione: anche dopo che, convertitisi gli Ungari al cristianesimo nella tradizione cattolico-romana,
nel 1102, per un gioco di alleanze matrimoniali, la corona di Crazia passò al re di Ungheria (che
mantenne il titolo di re di Croazia fino al 1918) e nel 1526 entrarono a far parte, assieme all’Ungheria,
dei domini personali degli Asburgo. Questa sottomissione, se da una parte tolse loro l’indipendenza
politica, dall’altra mantenne la loro cultura nell’ambito di quella occidentale: la letteratura croata, che,
fiorita nel XVI° secolo, conferì dignità letteraria al dialetto stokavo-ikavo da essi parlato, nacque sotto
la diretta influenza di quella italiana rinascimentale.
Anche la cultura degli Sloveni fu di marca occidentale: dopo un periodo iniziale, in cui furono governati
successivamente da Bavari, Franchi, Magiari, in epoca feudale furono organizzati in signorie, rette da
principi tedeschi. A poco a poco furono così assorbiti nel dominio austriaco, sicché la loro storia
coincise con quella dell’Austria, a cui, salvo la parentesi napoleonica, rimasero legati e fedeli fino al
1918.
I Serbi invece, convertiti da missionari legati a Costantinopoli, da cui ricevettero l’alfabeto cirillico,
rimasero nell’ambito del mondo bizantino e ne seguirono le sorti, riconoscendo, dopo lo scisma,
l’autorità del patriarca di Costantinopoli. La loro unificazione politica si realizzò solo nel XIII° secolo ad
opera di Stevan Nemanja, uno dei tanti capi locali su cui si era retta la loro organizzazione, rimasta
fino ad allora tribale. Contemporaneamente si realizzò la loro unità spirituale, sulla base di un
misticismo di tipo orientale, diffuso dal figlio di Nemanja, Ratsko (che poi sarà venerato come santo
col nome di Sava), il quale, educato presso i monasteri del Monte Athos, fondò a sua volta nella
Serbia meridionale e nel Kosovo quei tipici monasteri che, isolati nella campagna e fortificati,
divennero centri religiosi ed insieme fondamento dei legami sociali delle popolazioni circostanti.
L’Imperatore di Bisanzio, concedendo nel 1219 l’autocefalia alla chiesa ortodossa serba, riconobbe la
specificità della loro religione. Nel secolo successivo, la decadenza dell’Impero di Bisanzio permise al
Regno di Serbia di espandersi fino alle porte del Peloponneso, sicché, alla metà del Trecento, ridotto
l’impero bizantino alla sola Costantinopoli, la Serbia diventò il grande regno dei Balcani.
Tra i due grandi regni slavi medievali furono scarsi i contatti, perché fra di essi si frapponeva la
Bosnia, che, divenuto nel 1102 Banato indipendente, ove si radunarono i fuggiaschi di varia
provenienza, divenne poi possesso dell’Ungheria nel 1250 ed infine dominio dei Turchi.
L’espansione serba urtò invece contro quella dell’Impero Ottomano. Lo scontro avvenne il 28 giugno
1389 nella famosa battaglia di Kosovo Polje, in cui l’esercito serbo, guidato dal duca Lazàr,
nonostante la sua enorme inferiorità numerica, accettò battaglia contro quello turco. La tremenda
sconfitta riportata, in cui morì il duca Lazàr, determinò la dominazione turca sulla Serbia per circa
mezzo millennio. Ma nell’immaginario serbo la sconfitta si sublimò: i Serbi vi videro il segno della loro
missione, che li destinava a combattere in difesa della cristianità. Il duca Lazàr venne santificato e i
vari episodi della battaglia dettero origine ad una grande epopea, degna della Chanson de Roland,
come ebbe a dire Nicolò Tommaseo. Tramandatasi oralmente nei villaggi contadini mediante cantari
popolari, l’epopea produsse personaggi che esaltavano l’onore, l’eroismo, il valore del sacrificio, la
dedizione al popolo e numerose figure femminili, segnate dal lutto e dalla sofferenza. Fenomeno unico
nella storia dei popoli, i Serbi legarono la loro identità ad una sconfitta e su di essa forgiarono il loro
nazionalismo. Narra John Reed: “Ogni contadino serbo, da soldato, sa per che cosa combatte;
quando era bambino, la madre lo salutava dicendogli: ‘Salve, piccolo vendicatore di Kosovo”1.
Questa mistica fedeltà alle memorie patrie fece sì che i Turchi contassero tra i serbi il minor numero di
conversioni, mentre grande messe di convertiti essi trassero dalla Bosnia, ove nessuna tradizione
faceva da argine: i mussulmani oggi presenti in Bosnia sono gli eredi degli slavi islamizzati.
Come la Bosnia, anche la Krajna Vojna ebbe origine mista: contro l’espansione turca, gli Asburgo,
sovrani dell’Austria, Ungheria, Boemia, Slovenia, Croazia, costruirono, nell’area croato-ungherese, un
sistema di difesa mediante una serie di fortezze e con la militarizzazione delle regioni di confine. Nel
1578 istituirono la Regione della Krajna Vojna, come antemurale della cristianità contro l’Islam, e vi
concessero l’esenzione dalle tasse a chi avesse accettato di diventare contadino-soldato. Vi si
rifugiarono tutti coloro che si ribellavano al dominio turco, sicché, vicino agli originari villaggi croati, si
formarono villaggi ungheresi e serbi. I serbi vi affluirono a ondate dopo il fallimento dei vari tentativi
insurrezionali contro la dominazione turca, particolarmente numerosi dopo l’insurrezione del 1690,
quando il patriarca serbo li incoraggiò egli stesso ad emigrare. Fu allora che, nelle terre abbandonate
1
In: S. Bianchini, La questione jugoslava, Giunti
3
dai serbi, i Turchi insediarono serbi islamizzati e soprattutto albanesi anch’essi islamizzati (in Albania,
l’occupazione turca, dopo la resistenza guidata da Scanderberg, aveva prodotto una massiccia
conversione); sì che, prima degli ultimi tragici avvenimenti, il Kosovo, sacro alla memoria serba, era
abitato in grande maggioranza da albanesi.
A queste vicende tormentate rimase estranea la Dalmazia che, difesa strenuamente dalla Repubblica
di Venezia, nel 1797, con il trattato di Campoformio, andò a far parte, con Venezia, dell’Impero
Asburgico.
La storia tormentò dunque le popolazioni di questa regione, mescolando qua e là le stirpi a macchia di
leopardo; e poiché nessuna frontiera geografica distingueva le une dalle altre, le minoranze vissero in
un perenne stato di irredentismo, viste dalla stirpe dominante come un costante pericolo per la propria
compattezza etnica. Perciò il principio di nazionalità, che nel XIX secolo fu il riferimento ideale di quel
vasto movimento indicato come ‘Risorgimento dei popoli’, non venne accettato da queste popolazioni
secondo il concetto di personalità politica, bensì come unità di stirpe, di lingua e di territorio, secondo
l’interpretazione romantica partita da Herder e poi raccolta dallo Sturm und Drang. Il recupero
letterario delle antiche tradizioni, prodotto anch’esso per l’influsso del Romanticismo, conferendo
dignità ai miti popolari, determinò quel legame tra politica e mito che fu di grande impatto emotivo e a
sua volta causa di nuovi potenziali conflitti. Tra la gioventù colta della Serbia e della Bosnia, la
pubblicazione del poema Il serto della montagna, che si ispirava al ciclo del Kosovo, diffuse i miti del
tirannicidio e del martirio, che a loro volta ispirarono la rivoluzione bosniaca del 1875 e anche quella
congiura che organizzò l’eccidio del 28 giugno 1914. Lo studente serbo non aveva scelto a caso il
giorno dell’attentato. Esso era stato preparato con cura dai congiurati, come sanguinosa
commemorazione di quella tragedia antica su cui si era forgiato il nazionalismo dei serbi.
Movimenti verso l’unificazione
Questa storia tormentata degli Slavi del sud, a determinare la quale confluirono la struttura fisicogeografica del territorio, l’originaria differenza delle stirpi che vi si stanziarono, i vari antagonismi
imperialistici, fecero sì che qui più che altrove pesassero le conseguenze della varietà e complessità
degli insediamenti: come testimonia la variegata composizione etnica e religiosa dell’Jugoslavia del
1990.
Tuttavia l’istituzione della Jugoslavia nel 1918 non fu un fenomeno artificiale. Essa nacque dalla
volontà dei vincitori di umiliare lo stato sconfitto, come è nella logica di tutte le guerre: si volle ridurre
l’Austria a proporzioni insignificanti e precluderle ogni possibilità di revanscismo, chiudendola entro i
suoi nuovi confini ristretti, mediante la creazione di due stati: la Cecoslovacchia e l’Jugoslavia,
appunto. Ma già le varie regioni della penisola erano state percorse, durante il secolo XIX, da
movimenti tendenti all’unificazione: sia per la diffusione di un più ampio concetto di nazionalità, che,
superando il misticismo barbarico del legame sangue-suolo, faceva ora appello a valori comuni,
elaborati e difesi nel corso dei secoli – il Cristianesimo, anche se nelle due opzioni, cattolica e
ortodossa – sia, soprattutto, per la necessità di un mercato più vasto e articolato, che il nuovo modo di
produzione capitalistico imponeva e verso cui le regioni occidentalizzate si andavano avviando.
Si era manifestato il movimento dell’Illirismo, che, prendendo il nome dalle Province Illiriche istituite da
Napoleone – riunenti Slovenia, Dalmazia e parte della Croazia – voleva alludere ai caratteri comuni
delle varie stirpi, precedenti la loro divisione in province ostili: nel 1848 il termine venne sostituito con
quello più significativo di Jugoslavismo e l’aggettivo ‘jugoslavo’ venne adottato da alcuni partiti e circoli
culturali.
Il movimento si rafforzò con una iniziativa filologica che, negli anni ’40, portò alla pubblicazione di una
grammatica, elaborata sulla base di un dialetto comune ai Serbi, ai Croati e agli Sloveni e usato come
medium linguistico per la determinazione della lingua letteraria, che venne chiamata serbo-croato.
In questo stesso lasso di tempo i serbi, soggetti all’Impero Ottomano, insorgevano periodicamente;
l’insurrezione più violenta, guidata dapprima da Karageorgevic, poi da Milos Ovrenovic, nel 1830
condusse l’Impero Ottomano a riconoscere la Serbia come principato autonomo, sotto la guida
dell’Obrenovic. Nel 1878, con il Congresso di Berlino, la Serbia ottiene l’indipendenza.
Ostilità dell’Austria contro la Serbia
Il prestigio politico e militare di uno stato indipendente, dotato di un esercito, rafforzò l’idea della
formazione di un unico stato degli Slavi del sud: “una delle più diffuse riviste serbe di questo periodo si
intitolava Pjemont, con chiaro riferimento al ruolo esercitato dal Piemonte nell’ambito dell’unificazione
italiana” 2.
2
In: S. Bianchini, Op. cit.
4
Ciò determinò come conseguenza la profonda ostilità della duplice monarchia austroungarica e
dell’Impero Tedesco contro la Serbia, che faceva ostacolo alla loro espansione verso est e verso sud.
Lo sbocco al mare era infatti condizione necessaria alla neonata Serbia affinché potesse costituirsi
come stato economicamente indipendente, in un’epoca in cui la seconda rivoluzione industriale e la
formazione della rete strutturata del mercato mondiale stavano trasformando completamente il modo
di produzione e il sistema economico. Questa nazione slavo-ortodossa infastidiva in particolare
l’Austria, anche per l’attrazione crescente che essa esercitava sui popoli slavi ancora dominati dal
vecchio impero in disfacimento. Per cautelarsi e impedirne l’espansione verso l’Adriatico, l’Austria,
nello stesso Congresso di Berlino da cui nasceva la Serbia indipendente, si fece assegnare
l’amministrazione della Bosnia-Erzegovina – che nel 1908 occupò.
Perciò, fin dalla sua nascita a nazione indipendente, cioè dal 1878, la Serbia fu alleata delle potenze
antitedesche, la Francia e la Russia. Con la partecipazione alle due successive guerre balcaniche,
con cui le popolazioni balcaniche ancora sottomesse all’Impero Ottomano cercavano di liberarsi dal
secolare dominio, la Serbia mirava all’agognato sbocco al mare, cercandolo nell’Egeo, dato che
l’Adriatico le era precluso. Ma, ancora una volta, si scontrò con l’opposizione decisa dell’Austria ed
anche con quella dell’Italia, ache, entrata anch’essa nella logica imperialistica, mirava ad ottenere il
controllo del territorio albanese. Dal conflitto nacque infatti, nel 1913, l’Albania, formalmente
indipendente, di fatto una specie di protettorato italiano.
La tragedia che prende il via da Sarajevo era dunque già tutta annunciata: se da una parte l’eccidio
rappresentò l’atto estremo del nazionalismo serbo contro l’Austria, dall’altra non era un episodio
secondario nella politica internazionale e non a caso il conflitto generale che ne derivò prese il via da
questa, che era la zona per eccellenza dei conflitti interimperialistici: lo scopo della guerra dei due
Imperi Centrali su questo fronte era la liquidazione della Serbia, in stretto accordo col Vaticano, che vi
vedeva una crociata a favore del cattolicesimo (e a favore dell’alto clero, negli stati cattolici
largamente dotato); per l’Italia era l’acquisto della Dalmazia e ciò appunto determinò il suo
cambiamento di fronte.
L’unificazione
Nel corso del conflitto, diventarono dominanti, tra le popolazioni della penisola, l’idea e il movimento
dello Jugoslavismo, che, nel giugno del ’17 condusse alla Dichiarazione di Corfù: con essa, Serbi,
Croati e Sloveni si proponevano di costituire, al termine del conflitto, un nuovo stato democratico e
parlamentare, sotto la dinastia Karageorgevic (che, nel 1903, con un colpo di stato, si erano sostituiti
alla dinastia degli Obrenovic).
Fu posta così la prima pietra dello stato unitario, che venne proclamato il 1 dicembre 1918 – prima
della Conferenza di Pace di Versailles – col nome di Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L’atto era stato
preceduto da un voto favorevole all’unione da parte della Dieta di Zagabria e da una dichiarazione di
annessione del Montenegro alla Serbia.
La volontà di resistenza alle oppressioni straniere era stato il nuovo cemento dell’unificazione, la
sconfitta degli Imperi Centrali ne aveva permesso la realizzazione.
Arretratezza materiale e culturale
Ora bisognava che il progetto jugoslavo si realizzasse in una formazione politica capace di soddisfare
i bisogni materiali e culturali di tutte le comunità che costituivano il nuovo stato. Esso scontava una
posizione di partenza di grande arretratezza, sia economica che culturale. Il movimento verso l’unità
aveva avuto carattere urbano, promosso dai ceti medi e intellettuali; i contadini, che costituivano la
stragrande maggioranza della popolazione, l’avevano ignorato: sotto tutte le dominazioni, serba,
croata, turca, asburgica, essi erano vissuti immobilmente, scandendo la vita sui ritmi del loro lavoro,
su cui i movimenti politici agivano solo da disturbo, poiché portavano con sé disordini e guerre e
insieme carestie e pestilenze. Sottoposti al servaggio feudale, che nei paesi asburgici venne abolito
solo nel 1848, o gravati da contratti d’affitto pesantissimi, essi avevano mantenuto identiche, per più di
un millennio, le tecniche agricole e le organizzazioni sociali di base: le comunità familiari allargate a
carattere patriarcale e la comunità di villaggio che organizzava il lavoro comune.
Le condizioni naturali erano inclementi: il territorio, segnato profondamente dall’erosione carsica,
rendeva improduttiva l’agricoltura, che pur rimaneva l’attività predominante.
L’industria vi rivestiva un ruolo marginale. Era un’industria a basso valore aggiunto, spesso legata
all’agricoltura, e a bassa concentrazione. Poche le industrie moderne e tutte frutto di investimenti
stranieri, da cui restavano controllate; per giunta, situate in Croazia e Slovenia, erano dislocate
rispetto al centro politico di Belgrado.
5
L’Jugoslavia tra le due guerre
Però il nuovo stato multietnico aveva grandi potenzialità di progresso: l’aver messo in comune le
risorse materiali e quelle umane, gli apriva la possibilità di uno sviluppo sottratto al predominio del
capitale straniero e costituiva la base per ricomporre le specifiche connotazioni di ogni gruppo, sulla
base di un reciproco riconoscimento dei diritti di ciascuno. Per realizzare questo suo compito, il paese
avrebbe avuto bisogno di una pace durevole e di un’organizzazione democratica e federativa, che
permettesse alle varie nazionalità di conservare la propria identità, in modo che l’unificazione politica
raggiunta agisse da impulso verso un’integrazione culturale, considerata come meta e non imposta
d’autorità.
Invece, il nuovo stato negava in partenza l’identità ad altri popoli che non fossero Serbi, Croati,
Sloveni, cioè ai Macedoni, Montenegrini, Bosniaci, Albanesi eccetera, che venivano indicati
complessivamente con la definizione di minoranze.
La monarchia Karageorgevic, di tradizione ortodossa, autoritaria, appoggiantesi ad una corte
filoserba, instaurò un’organizzazione fortemente centralizzata, divisa in trentatré ‘bunovine’, cioè
regioni, che ignoravano i confini etnici e, secondo il modello francese, venivano chiamate con il nome
dei fiumi. I Croati persero così quell’autonomia che erano riusciti a conservare anche nella secolare
unione col Regno d’Ungheria e, successivamente, con la sottomissione agli Asburgo: esserne privati
da parte di quella Jugoslavia, alla cui istituzione avevano contribuito, rappresentò per essi una forte
delusione. Il malcontento delle minoranze, già emarginate all’interno delle singole province, ne risultò
anch’esso esacerbato.
Sulla concezione di nazione che si riconoscesse in una comune identità, prevalse ancora una volta il
principio delle differenze e la vita politica rimase segnata dalle nazionalità. Nell’immaginario del
paese, esse si identificarono con i partiti politici: il sistema dei partiti derivava da quello delle
nazionalità. Il Partito Comunista stesso, in clandestinità dal 1921, era lacerato dalla questione delle
nazionalità.
Perciò, l’iniziale divario dell’Jugoslavia rispetto agli altri paesi europei non venne colmato:
l’insufficiente riforma agraria che lasciò sopravvivere i vasti latifondi esistenti soprattutto nei territori già
soggetti agli Asburgo, l’industria non concorrenziale, capace di mantenersi solo grazie ad un forte
protezionismo, la mancanza di infrastrutture, conservarono al paese un carattere essenzialmente
rurale (nel ’31, lavorava tuttora nelle campagne il 76,5% degli abitanti) e mantennero la maggior parte
della popolazione in una condizione di arretratezza e di miseria, che aumentarono notevolmente in
seguito alla crisi del ’29. L’attività sindacale veniva fortemente limitata e le proteste sociali duramente
represse. Nello stesso anno ’29, il re, favorendo un colpo di stato militare, instaurò una dittatura
centralizzata, per cui la vita politica si fece sempre più tesa: in Croazia, l’opposizione di destra, da un
suo centro illegale di Vienna, dette vita al movimento degli Ustascia, sotto la guida di Ante Pavelic.
Intanto, sul giovane regno, già si appuntavano le mire imperialistiche contemporaneamente dell’Italia
e della Germania. Mussolini, mirando a costituire l’Impero Italiano dei Balcani, iniziò la sua
penetrazione in Albania e in Dalmazia, finanziando e promuovendo l’addestramento l’addestramento
degli Ustascia, per i quali allestì anche una rete di campi in Italia. Da questa situazione maturò
l’assassinio del re Alessandro, che avvenne a Marsiglia nel 1934, per opera degli Ustascia, aiutati
dalle autorità italiane.
Contemporaneamente, l’ascesa al potere di Hitler, che inserì subito l’Jugoslavia nel suo orizzonte
strategico, portò ad una progressiva penetrazione nel paese delle Germania, che si sostituiva così
all’Austria nella tradizionale via d’espansione verso l’Adriatico. L’Anschluss le aprì la via dell’Europa
centrale, ma anche quella dei Balcani e dell’Adriatico.
Quando l’Italia, nel 1939, occupò l’Albania, l’accerchiamento dell’Jugoslavia fu completo.
La guerra e l’occupazione italo-tedesca
Allo scoppio del grande conflitto, l’Jugoslavia proclamò la neutralità. Ma dopo la disfatta francese, le
forti pressioni della Germania, costituenti altrettante minacce, indussero il reggente Paolo a firmare, il
25 marzo 1941, l’adesione al Patto Tripartito. Ma, ricordando l’antica fierezza, quest’atto apparve alla
popolazione un tradimento: nelle città dell’Jugoslavia si produssero manifestazioni spontanee di
protesta a cui prese parte anche il Partito Comunista che, riorganizzato dal suo nuovo segretario,
Josip Broz, cioè Tito, cominciò ad assumere una parte importante nella vita del Paese. Si gridava:
“Piuttosto la guerra del patto, piuttosto la tomba della schiavitù”. Un colpo di stato militare abbatté la
monarchia ed instaurò un governo militare.
6
Ma Hitler, dopo un violento bombardamento su Belgrado, ordinò l’occupazione del paese, che il 6
aprile 1941 venne invaso contemporaneamente dalla Germania e dall’Italia, entrando gli eserciti
dall’Austria, dall’Istria, dalla Bulgaria e dall’Albania. La Croazia si proclamò indipendente e il 17 aprile
il governo jugoslavo firmò l’atto di resa senza condizioni.
Quando cessarono le ostilità, l’Jugoslavia aveva già fatto la sua rivoluzione. Fin dal 1942, mentre
infuriava la lotta contro i tedeschi e gli italiani, rappresentanti eletti di tutte le nazionalità, confessioni,
religioni, partiti, gruppi, avevano costituito un Consiglio Antifascista di Liberazione Nazionale
Jugoslavo (AVNOJ) sotto la guida di Tito, il quale divenne l’organismo dirigente della lotta di
liberazione nazionale. Esso decise di organizzare il paese su basi federative, riunendo con eguali
diritti i popoli di Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, e votò con
questo intendimento la prima costituzione rivoluzionaria: si trattava di una risposta progressiva
multietnica, sia al genocidio perpetrato dallo stato indipendente croato di Ante Pavelic, sia
all’orientamento grandeserbo dei Cetnici, sostenuto dal re. L’AVNOJ saldava la guerra patriottica di
liberazione del suolo nazionale, che trovava alimento nell’antico, tradizionale panslavismo e che
aveva provocato un’insurrezione spontanea dalla Serbia a Lubjana, con il rifiuto di una monarchia
centralizzata e dittatoriale, che già la popolazione aveva condannato come traditrice, e con la lotta di
classe contro il latifondo e i privilegi della classe dominante. A questo dovette l’unanime consenso
che, per la prima volta nella sua storia, unificò tutto il paese: nelle elezioni dell’11 novembre 1945, la
lista del Fronte Popolare riscosse il 90,48%.
Però, il progetto di questo nuovo stato prevedeva un territorio ancora troppo angusto rispetto al nodo
intricato dei nazionalismi, che si erano accumulati nei secoli. Da un lato, ogni repubblica racchiudeva
ancora nei suoi confini alcune minoranze, che venivano separate dagli stati d’origine, a volte vicini,
con ciò aprendo il problema del rapporto con i vicini, che turbò l'equilibrio del sistema. Dall'altro, come
progetto jugoslavo, cioè raggruppamento degli Slavi del sud, costituiva di per sé una sopraffazione nei
riguardi degli albanesi del Kosovo. Questa popolazione, che non era di stirpe slava, costituiva tuttora
la maggioranza in quella provincia ove si era costruito il primo regno serbo meridionale, e che
rappresentava il luogo sacro alla memoria storica dei serbi. A sciogliere questo groviglio di problemi
sarebbe stata adeguata una federazione, o confederazione socialista dei Balcani, estesa all’Albania,
la quale avrebbe potuto riunire in un’unica formazione politica tante stirpi rimaste separate nei secoli
da frontiere storiche. Ad essa Tito aveva infatti pensato già nel 1944, ma soprattutto vi pensò nel
1946/47, sostenendo attivamente i comunisti greci impegnati nella guerra civile. Ma vi si opposero da
una parte l’Inghilterra, dall’altra fortemente Stalin, perché temeva che questo ampio stato potesse
sfuggire al controllo del Kremlino. La nuova costituzione, varata agli inizi del ’48, istituì la Repubblica
Popolare e Federativa di Jugoslavia. Essa prevedeva sei repubbliche e due regioni autonome, il
Kosovo e la Vojvodina, costituite nell’ambito della Repubblica serba.
La guerra aveva lasciato il paese disastrato e dissanguato per le enormi perdite umane e solo gli aiuti
dell’UNRRA (l’organizzazione di soccorso americano) lo salvarono dalla fame: l’aiuto puntava
naturalmente a facilitare la dissidenza del nuovo stato nei confronti dell’URSS, al fine di poter pesare
sulla sua politica estera.
Le prime riforme
Il primo governo postbellico fu di coalizione, in cui però i membri dell’AVNOJ avevano la
maggioranza. Esso mise subito mano alle riforme, e fin dall’agosto del ’45 varò la riforma agraria, che
eliminò il latifondo, riducendo il limite massimo di ogni appezzamento ad un’area che andava da 25 a
35 ettari di terreno coltivabile. I maggiori espropri avvennero nelle ex province asburgiche di Croazia e
di Slovenia, ove gli enti ecclesiastici possedevano enormi proprietà. Le terre espropriate vennero
distribuite ai contadini vittime della guerra. Si operò contemporaneamente la nazionalizzazione dei
principali settori industriali, minerario dell’energia elettrica, dell’industria pesante, del commercio, e si
fece una riforma monetaria.
Le riforme rivoluzionarie
Dopo le elezioni del novembre ’45, il nuovo governo, costituito dal fronte popolare, adottò una
costituzione ricalcata su quella sovietica. Nel 1947 entrò in vigore un piano quinquennale, anch’esso
imitante il modello sovietico, sia nel privilegiare l’industria in generale e quella pesante in particolare,
sia nella forma della sua applicazione, mediante giornate ‘volontarie’ di lavoro, gruppi di lavoro
‘d’assalto’, impegni collettivi a superare gli obiettivi del piano.
In campo agricolo, si iniziò la collettivizzazione, che incontrò notevoli resistenze da parte dei contadini.
Era difficile realizzare la completa collettivizzazione delle terre secondo il modello sovietico, in un
7
paese di cui il mondo contadino era la spina dorsale e aveva fornito all’esercito partigiano la maggior
parte dei militanti ed in cui lo stesso Partito Comunista era costituito in gran parte da gente
proveniente dalle campagne.
Perciò, sino al giugno ’48 – cioè fino all’espulsione dell’Jugoslavia dal Cominform – l’applicazione del
modello sovietico procedette in modo duttile e graduale, anche perché si temeva che una forte
pressione sul mondo contadino potesse mettere in pericolo, per reazione, l’approvvigionamento delle
città. Ma, appunto nel giugno del ’48, il Cominform accusò il Partito Comunista Jugoslavo di essere
venuto a patti con i kulaki e con questa accusa lo espulse; anche se la vera causa della rottura va
cercata nell’ambito della politica estera, cioè nella dichiarata volontà di Tito di riservarsi in questo
campo un’autonomia d’azione: di fronte alle novità che la guerra fredda stava portando nello
scacchiere europeo, Tito, pur accettando il primato dell’URSS nel conflitto tra i due blocchi e nella lotta
antiimperialistica, intendeva potersi muovere autonomamente. Gli accordi intercorsi nel ’48 con il
leader bulgaro Dimitrov per il progetto di una federazione balcanica “senza chiedere l’autorizzazione a
nessuno “, come scrisse la Pravda, apparve agli occhi di Stalin una vera e propria eresia.
All’espulsione seguì un totale isolamento del paese, sia politico che economico, a causa del blocco
economico che Stalin gli impose; fu probabilmente la speranza in una composizione del conflitto che
indusse i dirigenti jugoslavi ad intensificare, dopo il ’48, la collettivizzazione. Essa avvenne mediante
la creazione di fattorie cooperative “Zadrugas”, che, dal ’48 al ’50, andarono progressivamente
aumentando di numero. Non fu evitato il dissenso dei contadini, molti dei quali occultarono i prodotti.
Si manifestarono anche episodi, sia pur limitati, di rivolta armata.
L’autogestione: 1950/1965
Ma proprio la rottura con l’Unione Sovietica spinse i dirigenti jugoslavi ad elaborare un’organizzazione
politica originale che, rispetto al modello sovietico, divenne una deviazione duratura: per il periodo di
transizione, essi concepirono un modello che, come dice Kardely, che ne fu il principale ideatore,
mirava a instaurare “legami economici diretti fra i lavoratori nel lavoro associato e il loro lavoro
accumulato socializzato”. “Nei rapporti socialisti di autogoverno non si interrompe il legame economico
e politico del lavoratore con il suo lavoro accumulato socializzato. Insieme agli altri lavoratori, egli
controlla anche questa parte dei frutti del suo lavoro, ed anzi ne dispone, mentre i risultati della
gestione del lavoro accumulato nel processo della riproduzione sociale appartengono solidarmente a
tutti i lavoratori” 3.
Il nuovo modello si basava sul principio del decentramento e mirava ad eliminare il capitalismo di stato
– etichetta dispregiativa con cui veniva indicato il regime sovietico – e la burocrazia che ne derivava.
Questa ‘via jugoslava al socialismo’, che intendeva associare in maniera permanente le masse
all’edificazione al socialismo, veniva indicata come il modello del vero socialismo ed identificata con la
visione marxiana dell’estinzione dello stato.
Esso cominciò a prender forma a partire dal 1950, dopo il fallimento del piano quinquennale.
Sul piano amministrativo, venne rivalutata l’esperienza dei Comitati di lLiberazione Popolare, che,
durante la guerra, avevano sostituito l’amministrazione locale con la partecipazione diretta dell’intera
popolazione. Perciò il decentramento si realizzò trasferendo ad organi autonomi le attribuzioni dello
stato, il quale si riservava soltanto gli affari esteri, le forze armate, la polizia di stato. Organismi
autonomi eletti a suffragio universale in ciascuna repubblica federata e comitati popolari di circondario
e di comune prendevano le decisioni e controllavano l’amministrazione propriamente detta. Il potere
centrale, ridotto al minimo, si limitava a verificare la legalità dei loro atti, senza sindacarne
l’opportunità e senza diritto di darne un assenso preventivo.
Ma la parte più originale della riforma investì l’organizzazione della produzione, ove si elaborò quel
modello che venne definito di autogestione. Le cooperative agricole divennero libere di elaborare il
proprio statuto e si organizzarono in tre forme distinte: il contadino manteneva la proprietà della terra e
la lavorava pagando un prezzo di locazione, o, partecipando al lavoro comune, riceveva una porzione
delle entrate, che venivano suddivise. In entrambi i casi il contadino, restando proprietario, poteva
ritirarsi dal lavoro organizzato e, in quel caso, gli veniva concessa una proprietà individuale di dieci
ettari: questo limite era stato posto per evitare la riapparizione dei kulaki. L’11% delle fattorie realizzò
invece una completa socializzazione, che non prevedeva la possibilità del contadino di ritirarsi dal
lavoro collettivo.
La gestione delle imprese si basava su tre principi, indicati come le tre A: autogestione,
autofinanziamento, autonomia contabile. Il primo principio stabiliva che la gestione dell’impresa fosse
affidata a consigli operai, eletti dal personale, ai quali spettava di designare un Comitato di gestione;
3
In: E. Kardely, Le vie della democrazia nella società socialista, Editori Riuniti
8
Più imprese formavano un “Gruppo economico superiore”, la cui direzione, nominata dallo stato,
nominava a sua volta i direttori delle singole imprese. Il Consiglio operaio e il Comitato di gestione si
occupavano della protezione del lavoro, dell’applicazione del piano, del bilancio consultivo. Un
Comitato nazionale elaborava il Piano-quadro, che fissava le grandi linee di sviluppo, in base alle quali
i Comitati di gestione e di gruppo elaboravano liberamente il piano per la loro unità economica.
Il secondo principio impegnava l’impresa a gestire i suoi profitti in base al calcolo dei costi, per coprire
le spese con i ricavi, e il terzo lo obbligava a stabilire una contabilità finanziaria. I profitti venivano poi
ripartiti tra i comuni (imposta fondiaria), la repubblica federata (imposta sui profitti) e il collettivo
operaio, che assegnava al personale un complemento di salario in rapporto ai profitti. Lo stato perciò
non partecipava né alla determinazione dei salari né alla sorveglianza sulla realizzazione del piano.
Questo sistema permetteva alla moneta e ai prezzi di svolgere una funzione più attiva, rispetto a
quella svolta nella pianificazione burocratica accentrata, in quanto essi esercitavano un’influenza
sulle decisioni, Tuttavia, la legge del valore non fungeva da regolatrice, poiché il modello stabiliva un
equilibrio tra il piano e il mercato: il mercato interveniva nell’organizzazione della produzione, ma non
ne era il regolatore, costituiva piuttosto il mezzo per realizzare il piano, il quale orientava gli
investimenti in base a criteri socioeconomici.
La Costituzione del ’53 sancì le riforme e, contemporaneamente, modificò la Costituzione del ’46 in un
punto essenziale, simbolicamente molto significativo: la trasformazione, non solo nominale, del Partito
comunista in Lega dei comunisti e del Fronte popolare in Alleanza socialista. Poteva sembrare un
ritorno a Marx, richiamato nella nuova denominazione assunta; in realtà era un ribadire la propria
posizione contro il centralismo e un prender le distanze dalla concezione leninista del partito. Si
giustificava questa posizione dicendo che, con la progressiva estinzione dello stato, anche il partito
avrebbe dovuto estinguersi, per trasformarsi in uno strumento pedagogico, destinato ad esercitare sui
cittadini un’azione di orientamento comunista.
Il titoismo
Si costituisce così il ‘titoismo’, che si realizza progressivamente negli anni fra il ’53 e il ’61, basato su
due elementi: questo modello interno di ‘socialismo autogestionario’ e la politica estera che fu detta
del non allineamento, nel senso che rifiutava una collocazione esclusiva in uno dei due blocchi.
Nel ’53 l’Jugoslavia aderì a un patto balcanico con la Grecia e la Turchia che indirettamente
rappresentò un’adesione alla NATO, dato che ad essa aderivano gli altri due membri. Ciò fruttò a Tito
l’appoggio dell’imperialismo occidentale, politico e militare, ma, soprattutto, economico.
Contemporaneamente, la morte di Stalin, nel ’53, favorì la riconciliazione con l’URSS. Permasero
tuttavia, tra i due paesi, diffidenze e malintesi, determinati dalla differente interpretazione data alla
“Dichiarazione di Belgrado” che, in occasione della visita di riconciliazione, fu firmata da Krusciov il
2/6/1955: sembrava di potervi leggere che l’URSS ammettesse la possibilità di forme diverse di
sviluppo socialista, ma i sovietici lo negavano. Durante la crisi ungherese del ’56, Tito tenne un
atteggiamento ambiguo, condannando dapprima l’intervento sovietico, accettandolo poi in nome della
necessità di salvare ad ogni costo il socialismo. Ma la sua condanna decisa del comportamento degli
occidentali durante la crisi di Suez lo riconfermò nel campo socialista, anche se non vi aderì mai
formalmente.
Contraddizioni e degenerazione del sistema
Il socialismo autogestionario, se giudicato sul piano formale, sembrava veramente una via progressiva
verso il comunismo, cioè non semplicemente verso un modello di giustizia distributiva, ma verso una
società in cui i “produttori associati”, secondo l’espressione marxiana, gestissero direttamente i
prodotti del proprio lavoro.
Ma l’aspetto giuridico non è quello essenziale: i diritti di cui gli individui godono in un determinato
ambito sociale derivano dai reali rapporti che si instaurano fra di essi, in seguito ai quali diritti
riconosciuti formalmente possono concretamente essere aggirati. Pur essendo scaturita da una
sincera volontà rivoluzionaria e sostenuta da un’effettiva rivoluzione dal basso, l’autogestione poteva
essere il mezzo con cui una risorta categoria privilegiata cercasse di mantenere il proprio potere o
aspirasse a posizioni di prestigio,
restaurando una gerarchia e facendo emergere nuove stratificazioni. Questo infatti avvenne, poiché
l’autogestione non era stata realizzata in maniera sostanziale: esisteva un piano nazionale, che
determinava le scelte e fissava dall’alto le linee di sviluppo, esistevano metodi indiretti per regolare
l’autogestione a livello locale: i prezzi, di cui alcuni erano fissati dal centro, le banche, che
concedevano i crediti per gli investimenti, anch’essi fissati dal centro, e che diventavano tramite tra il
9
piano e le unità di base, infine il sistema fiscale. Quest’ultimo era il principale strumento di
eguagliamento, poiché, mediante un’imposta progressiva sul reddito delle imprese, serviva a
riequilibrare le differenze determinate da una distribuzione determinata secondo gli esiti del mercato e,
di conseguenza, a ridurre gli squilibri tra le varie aziende e le varie regioni. Ma questo modo di
regolazione, sia pur fatto con strumenti economici – come venivano chiamati – anziché con gli ordini
amministrativi di cui si serviva la pianificazione burocratica, rendeva puramente formale
l’autogestione.
C’era infatti nel sistema una contraddizione immanente, che poneva necessariamente in contrasto il
profitto, realizzato in base agli esiti del mercato, e la logica redistributiva del piano, ispirata a criteri di
giustizia sociale. Si diceva agli operai: “Aumentate la vostra produttività locale e i vostri redditi
cresceranno”; ma sul reddito dell’azienda gravava l’imposta progressiva, che appariva ai lavoratori
una spoliazione ed un tradimento del principio socialista “a ciascuno secondo il suo lavoro”.
Ciò accadeva perché il controllo sociale sfuggiva agli operai. Una vera autogestione avrebbe dovuto,
partendo dal basso, arrivare fino al piano-quadro, in modo che i lavoratori potessero autonomamente
definire le priorità di produzione e i criteri distributivi. Questo avrebbe permesso di democratizzare la
pianificazione anche tra le repubbliche, poiché le scelte degli investimenti e della distribuzione
sarebbero derivate dal riconoscimento della loro necessità e da una conseguente solidarietà,
consapevolmente accettata. Ma i rapporti sociali non si erano modificati in modo tale da trasformare il
lavoro in attività creative; in altre parole, non era stato avviato il deperimento del lavoro salariato,
quindi alienato, ciò che rappresenta l’unico test per misurare il processo verso il comunismo.
Perciò il sistema degenerò: gli organismi di rappresentanza vennero sempre più spesso convocati
solo per ratificare quello che già aveva deciso il cosiddetto ‘quintetto’, cioè il direttore, i presidenti
rispettivamente del consiglio operaio e del comitato di gestione, il segretario del sindacato e quello
della Lega. La distribuzione venne progressivamente compiuta dalle imprese in base alla logica del
mercato.
Ne furono testimoni gli scioperi, che cominciarono a manifestarsi: il primo ufficialmente registrato fu
organizzato nel 1957 da parte dei minatori della Slovenia, svantaggiati dal sistema dei prezzi, poiché il
prezzo del carbone veniva fissato dal centro. Già da quell’epoca il sistema jugoslavo stava scivolando
verso una società di mercato, nel senso che lo sviluppo delle forze produttive era ormai incrementato
dal mercato: si attenuavano gli aspetti redistributivi del piano e si rafforzava l’autogestione a livello
locale, si lasciava all’impresa la libertà di amministrare il proprio ‘reddito netto’ (detratte le spese e le
tasse) ed anche i redditi personali. Come logica conseguenza, le repubbliche più ricche cercavano di
sottrarsi a quelle che venivano chiamate “ingerenze centrali”, sentite ormai come arbitrarie.
La riforma del ’65: il socialismo di mercato
Nel 1965 il socialismo di mercato venne assunto esplicitamente come obiettivo. Il IX Congresso
affermò la necessità di orientare la riforma verso una piena affermazione di forme più evolute e più
libere della produzione. Non ci si limitava più a criticare l’eccessivo accentramento della produzione, si
rovesciava addirittura il rapporto del piano con il mercato, secondo un modello liberista. Si voleva
restituire coerenza i criteri della legge del valore. Perciò la ‘economia’, considerata quasi come un
soggetto al di sopra delle classi, veniva contrapposta allo stato, ora inteso come nemico, per cui,
affermavano i dirigenti, la gestione delle risorse doveva essere restituita di diritto all’economia, che, se
fosse stata spoliticizzata, l’avrebbe condotta secondo criteri oggettivi. I criteri oggettivi che venivano
invocati erano quelli del mercato mondiale, con i prezzi da esso imposti: le imprese, che non fossero
state in grado di reggere alla concorrenza con una normale protezione doganale, avrebbero dovuto
riorganizzarsi o chiudere.
La riforma non si svolse bruscamente: fu preceduta da misure che vennero inserite gradualmente nel
sistema. Nel 1963 furono soppressi i fondi sociali di investimento, le cui risorse vennero trasferite alle
banche, che avrebbero dovuto gestirle secondo criteri economici. Non si trattò solo dei fondi per le
imprese: venne trasferito alle banche anche il Fondo Generale di Investimento, sicché il piano ne
risultò smantellato: poiché gli investimenti si realizzavano, di conseguenza, solo attraverso il sistema
bancario, esso si trasformò in un semplice indirizzo. Si realizzò così un decentramento
dell’accumulazione verso le attività produttive e il settore bancario. Contemporaneamente fu
alleggerita la fiscalità, cioè furono soppresse o diminuite le varie imposte che gravavano sulle
imprese: completamente abolito fu il contributo sul reddito che le imprese dovevano alla comunità,
mentre fu aumentata la quota di valore aggiunto che veniva lasciata alla responsabilità delle imprese:
da una media del 47% nel 1963, essa salì ad una media del 58% nella seconda metà degli anni ’60.
10
La gestione passava dai consigli operai alle strutture imprenditoriali della società, indebolendo perciò i
fini sociali ed etici dell’autogestione.
La riforma del sistema bancario
L’aspetto più importante della riforma del ‘65 fu la trasformazione del sistema bancario. Le banche
erano state fino ad allora istituzioni destinate a gestire fondi sociali sotto il controllo di “Collettivi
sociopolitici”, cioè organismi statali, e secondo le direttive del Piano. Ora vennero distinte per
specializzazioni: banche d’affari per investire a lungo termine e banche per il credito al consumo ed
acquistarono maggiore autonomia rispetto alle scelte centrali. Vennero inoltre stimolate a fondersi, per
cui, non più limitate ad agire all’interno della repubblica federata, acquistarono il diritto di allargarsi
sull’intero territorio. Potevano essere istituite dalle imprese, o da sole o insieme a un Collettivo
Sociopolitico che avesse almeno venticinque membri, il quale però non poteva possedere più del 20%
del capitale; un organo statale da solo non poteva fondare se non una banca di risparmio. La
direzione era costituita dall’Assemblea generale, nella quale i membri fondatori avevano diritto di voto
in proporzione ai fondi investiti; gli impiegati non avevano alcun diritto di controllo sulla politica
creditizia della loro banca, nemmeno attraverso il loro consiglio operaio.
Ma l’innovazione principale fu l’istituzione di un fondo creditizio che raccoglieva le risorse della banca,
costituite dagli apporti dei soci fondatori e dagli interessi che la banca percepiva sui crediti: si trattava,
in pratica, di un fondo di appartenenza della banca, che questa cercava di sfruttare a proprio
piacimento. La legge sulle banche e il credito, del 1965, consentiva così per la prima volta ad
un’impresa di percepire un reddito risultante da un investimento di un’altra impresa, cioè derivante dal
lavoro altrui.
La riforma ebbe logicamente una ricaduta sul commercio e sui prezzi. Si ridussero le tariffe
protezionistiche, si svalutò il dinaro, si adeguarono i prezzi interni a quelli del mercato mondiale. Ciò
determinò un forte aumento dei prezzi ed un processo inflazionistico, che divenne la causa
fondamentale della crisi economica del sistema. Nel 1970, i due terzi dei beni avevano prezzi liberi e
le imprese, liberate dagli obblighi previsti dal piano, entrarono in concorrenza tra di loro e con il
mercato mondiale, mentre la distribuzione dei redditi avveniva ormai decisamente secondo gli esiti del
mercato. Contemporaneamente le imprese conquistarono il diritto di negoziare direttamente i crediti
esteri.
Si modificarono anche i rapporti con l’estero, concedendo libertà di circolazione e di emigrazione e
aprendo ai capitali stranieri. Si autorizzò l’istituzione di joint-ventures, con una limitazione, secondo la
quale almeno il 51% dei capitali doveva essere jugoslavo.
Conseguenze sociali della riforma del ‘65
Ma si pose allora il problema dello statuto dei lavoratori che vi si impiegavano, e si dichiarò che essi
non dovevano avere diritti diversi da quelli degli altri lavoratori, per cui si dovevano applicare anche ad
essi i criteri dell’autogestione: la norma del 51% mirava appunto a garantire la preponderanza di voti
jugoslavi nelle decisioni. Si posero altre limitazioni: un’imposta del 33% sui guadagni, l’obbligo di
reinvestire il 20% dei profitti sul posto. Erano intoppi che si ponevano negli ingranaggi del modo di
produzione capitalistico, i quali dissuadevano i capitalisti a compiere investimenti in Jugoslavia, per cui
le società miste rimasero marginali.
Gli elementi di capitalismo che ormai si erano introdotti nel sistema e il socialismo dell’autogestione
entravano in contrasto tra loro e rendevano ingovernabile l’economia.
La stessa contraddizione si manifestò quando si fecero forti investimenti tecnologici, che aumentarono
notevolmente la produttività del lavoro. Come vuole la legge del valore, aumento della produttività
significa disoccupazione e ciò urta contro il diritto al lavoro; ma non si volle rinnegare il principio
socialista secondo il quale le macchine non devono essere usate contro gli uomini e le donne, per cui
le imprese furono obbligate a salvaguardare i livelli occupazionali acquisiti. L’organizzazione
dell’autogestione impediva di licenziare: “Nessun Consiglio operaio accetterebbe di congedare i
lavoratori eccedenti” constatavano i dirigenti, i quali ritenevano che l’autogestione non fosse più
adeguata al “socialismo di mercato avanzato”; e il secondo Congresso dell’autogestione relazionava:
“Nel complesso minerario e metallurgico di Zenica si è sancito il principio che nessun operaio potrà
essere licenziato per ragioni di ammodernamento o di ristrutturazione delle fabbriche o delle unità
lavorative . . . Anche nel bacino minerario e metallurgico di Bor si è dato valore di legge al principio
che nessun operaio può essere licenziato per eccedenza di manodopera” 4. Di conseguenza,
nonostante l’aumento della produttività non si potevano abbattere i costi.
4
In: C. Samary, L’esperienza dei paesi cosiddetti socialisti
11
Ma esistevano tuttavia oggettive pressioni mercantili a cui le imprese erano ormai soggette e ciò le
spinse a comprimere le assunzioni determinando una forte disoccupazione demografica: nel 1971, il
numero di lavoratori in cerca di occupazione ammontava a trecentomila unità, su una popolazione di
circa venti milioni di abitanti, mentre, contemporaneamente, settecentomila lavoratori erano emigrati.
Disgregazione della cooperazione contadina
Anche nel campo agricolo, il sistema si andava scompaginando: radicalmente ridotto il fondo federale
per il finanziamento degli investimenti, secondo i criteri della riforma, le fattorie di stato furono
costrette a ridurre di un terzo il consumo dei fertilizzanti e della metà il numero degli addetti, dei trattori
e dei capi di bestiame: buona parte del materiale veniva rivenduto al settore privato. A questo si
aggiungevano le violazioni dei vincoli contrattuali, i conflitti nella distribuzione dei redditi e il
progressivo disgregarsi dell’autogestione: i contadini avevano diritto ormai semplicemente ad un voto
indicativo nelle decisioni relative alla cooperazione.
Lo stimolo verso la cooperazione diminuiva progressivamente, poiché il settore privato, la cui
autonomizzazione la riforma favoriva, offriva maggiori possibilità di miglioramento individuale, mentre il
settore collettivizzato si deteriorava rapidamente: la cooperazione calò della metà.
Disgregazione economica
Il 16 novembre 1968 il noto settimanale The Economist scriveva: “Le imprese jugoslave possono
adesso associarsi per la realizzazione di progetti con condivisione delle entrate e delle responsabilità,
ma è dubbio che i salariati possano influenzare l’operazione. Anche il più semplice accordo
sull’investimento di un’impresa in un’altra indebolisce il controllo dei lavoratori; questo sistema, nel
quale sono assenti gli investitori di capitale di rischio, presenta indubbiamente un punto debole”. Si
trattava cioè di un capitalismo senza capitalisti. Una vera e propria restaurazione capitalistica non era
ancora avvenuta, poiché, affinché il sistema sia completo, è necessario che la dominazione
capitalistica sia legittimata e quindi protetta dallo stato. Perciò era un modo di produzione capitalistico
in un sistema che non era ancora capitalista. Mancava un insieme coerente di meccanismi, perché
non si era ancora messo in azione il motore sociale del capitalismo, mentre già si era arrestato quello
del socialismo. Si diffondevano gli arricchimenti che, in assenza di una completa legalizzazione della
proprietà privata, prendevano vie illegali. Soprattutto nel settore socializzato si registravano abusi,
sperpero di fondi sociali, privilegi di consumo, attività illecite.
Anche l’organizzazione dell’autogestione si andava corrompendo: i consigli operai contavano un
numero progressivamente decrescente di operai, le responsabilità di gestione si accrescevano a
favore delle équipes dirigenti e il potere passava ai tecnocrati, i quali acquistavano un tenor di vita
notevolmente superiore a quello degli operai ed ostentavano la loro posizione di privilegio con i
numerosi oggetti che fungono da simbolo di un livello sociale privilegiato. Questa nuova e ormai
accettata diseguaglianza sociale stimolava ambizioni e carrierismo, induceva bisogni crescenti e
smantellava, così nell’organizzazione dell’attività produttiva come nelle coscienze, il principio di
solidarietà.
Forte disavanzo
Tutte le regioni sentirono gli effetti di questa trasformazione, ma, in particolare, ne furono danneggiate
quelle sottosviluppate – Macedonia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Kosovo – il cui reddito pro
capite, nonostante le sovvenzioni ricevute dalla Federazione, scese fino alla metà di quello delle
regioni ricche. Questa disparità, che già sarebbe stata difficile colmare in un’economia di
accentramento e di redistribuzione della ricchezza, era destinata invece ad aumentare con il nuovo
regime di decentramento.
Ma ciò che condusse il regime verso il disfacimento fu la voragine del debito estero, che dette l’avvio
alla famosa spirale autogenerantesi: nel ’71 era arrivata a rappresentare il 30% del P.i.l. L’OCSE ne
attribuiva la causa alla contaminazione di due opposti sistemi economici. Scriveva, a questo proposito,
nel suo rapporto del 1970: “Un sistema istituzionale che permette ai consigli operai di fissare al tempo
stesso i prezzi di vendita dei prodotti e la massa salariale da distribuire al personale dell’impresa,
costituisce un elemento strutturale di inflazione” 5. Ma la causa principale che innescò il disavanzo
commerciale estero fu piuttosto l’indebitamento interno delle imprese, le quali erano anche le principali
azioniste delle banche creditizie.
5
In: J. Krulic, Storia della Jugoslavia, Bompiani
12
Erano stati ridotti i poteri reali di direzione e di regolazione del piano, ma la regolazione del mercato
non si era attivata e la ”economia” non aveva prodotto quel sistema coerente che i dirigenti si erano
attesi dalla riforma. Il paese andava alla deriva.
Tensioni sociali
Grande era il malcontento nella popolazione. Fra il ’68 e il ’71, si svilupparono conflitti tra lavoratori e
dirigenti e forti proteste per le crescenti diseguaglianze prodotte dal mercato. Con il movimento
studentesco del '68, la protesta prese forma politica e si rivolse contemporaneamente contro la
burocrazia e contro il capitalismo: gli studenti non protestavano contro il regime, come avveniva in
Occidente, bensì contro la sua degenerazione. Nel loro giornale ufficiale, Student, essi pubblicarono le
loro rivendicazioni: denunciavano la grande disparità sociale e i privilegi connessi con l’esercizio del
potere, rivendicavano l’applicazione del principio socialista della distribuzione secondo il lavoro e la
realizzazione del diritto al lavoro in tutto il paese, suggerivano di raggiungere questa meta riducendo
al minimo il lavoro “onorario” o straordinario; chiedevano uno sviluppo del sistema dell’autogestione,
non solo in fabbrica ma a tutti i livelli, comunale e federale, “sradicando le forze burocratiche che ne
avevano ostacolato lo sviluppo”, “così da rendere possibile un controllo reale dei produttori sugli
organismi produttivi”, poiché, “una vera autogestione consiste nella possibilità, da parte dei lavoratori,
di assumere autonomamente le decisioni su tutte le condizioni di lavoro e di distribuzione del plusvalore”; infine affermavano che dovevano essere stroncati i tentativi di “disintegrazione della proprietà
sociale in proprietà privata” e quelli tendenti a “trasformare il lavoro personale in capitale individuale” 6.
Il malcontento degli operai esplose anch’esso nel ’68 e nel quarto Congresso sindacale del giugno di
quell’anno si espresse in forme che superarono “in ampiezza e rilevanza sociale, la rivolta degli
studenti”7. Dicevano: “Siamo stufi del socialismo sulla carta” e denunciavano: “Si è verificato un
impoverimento della classe operaia. Si tratta di coloro che producono! E mentre questi sono costretti a
battersi per i loro diritti elementari, gli altri si arricchiscono. Chi possiede case, ville, macchine, può
godersi le vacanze . . . I nostri operai emigrano oppure sono disoccupati”. “Il malcontento era talmente
forte che Tito ripeté la stessa manovra messa in atto in occasione della rivolta studentesca. Prese la
parola al Congresso e pronunciò una violenta requisitoria contro le conseguenze negative della
riforma economica”8.
Il contrasto fra le nazionalità
Risorgevano anche i contrasti fra le nazionalità. Alla fine del ’68, la Lega dei comunisti di BosniaErzegovina votò una risoluzione che chiedeva compensi per gli effetti sfavorevoli che la riforma aveva
prodotto nelle regioni meno sviluppate. La Slovenia, dal canto suo, protestò per essere stata esclusa
da un finanziamento internazionale destinato alla costruzione di strade, poiché ciò le impediva la
progettata costruzione di un’autostrada che avrebbe dovuto congiungere la capitale slovena con il
confine italiano. Il progetto si ispirava ad un evidente localismo ed era influenzato dall’Occidente,
perché privilegiava i rapporti con l’Europa occidentale rispetto all’integrazione con l’economia
jugoslava. I dirigenti jugoslavi, che avevano invece elaborato un progetto di collegamento con le
regioni interne, rifiutarono e alla conseguente protesta ufficiale del governo sloveno si
accompagnarono manifestazioni popolari a Lubjana.
Ma più grave di tutte fu la crisi croata, che cominciò nel 1971. Gli economisti croati rivendicavano il
diritto di mantenere nella propria regione la valuta straniera, di cui la regione, grazie al turismo, era la
maggiore produttrice, ed affermavano che la Croazia non era mai stata così sfruttata rispetto alle altre
regioni, né dall’Austria-Ungheria né dalla monarchia Karageorgevic.
Un’antica accademia letteraria, fondata all’incirca nel 1840, riprese ora la sua attività con la
pubblicazione del periodico Kritica, che denunciava l’emarginazione subita dai croati residenti in altre
province. Metteva inoltre in discussione l’unità della lingua, affermando che il croato era una lingua
distinta dal serbo, e chiedeva la revisione della storiografia in chiave nazionalistica. Si raccolse attorno
alla rivista un folto gruppo di intellettuali, fra cui Franjo Tudjman, i quali estesero il loro controllo sui
maggiori enti culturali croati. Vi aderirono anche alcuni esponenti della Lega dei comunisti.
Tito si rese conto della gravità di questo movimento, che rischiava di distruggere tutto il lavoro fatto
per il rinnovamento dell’Jugoslavia e pronunciò al Comitato esecutivo del luglio ’71 un discorso, che
antivedeva la precipitazione degli eventi e metteva in guardia sulla tragedia che ne sarebbe derivata:
“Col pretesto dello ‘interesse nazionale’, tutto ciò va a finire nella controrivoluzione . . . In certi villaggi,
6
In: C. Samary, Op. cit.
Da: Quatrième internationale, in: C. Samary, Op. cit.
8 Vedi nota precedente.
7
13
i serbi, diventati nervosi, si armano . . . Volete tornare forse al 1941? . . . Sapete che altri verranno, se
qui si produce il disordine? Io preferisco riportare l’ordine con il nostro esercito, piuttosto che
permettere ad altri di farlo; altrimenti, quando non ci sarò più io, il paese esploderà. Il nemico interno
gode di molti appoggi all’esterno. Le grandi potenze utilizzeranno tutti gli elementi utili, comunisti o
no”9. Ma i dirigenti croati risposero riconfermando la linea politica già approvata in un loro precedente
Plenum, in cui si era affermata l’unità fra le nazionalità e il partito di massa, e accusavano di
deviazionismo “quelli che respingono il sostegno delle masse . . . in nome di una purezza
rivoluzionaria astratta che non rappresenta nient’altro che settarismo e paura della mobilitazione delle
masse, come se noi comunisti fossimo una setta chiusa che ritiene che la società e le masse operaie
esistano solo per noi e non noi per esse”10. Risultava così rovesciata la concezione leninista del
partito.
Si andava anche discutendo di un progetto di costituzione croata, che prevedeva una “Dichiarazione
di sovranità”, moneta separata, una banca centrale, il controllo di tutte le entrate prodotte in Croazia,
ammettendo solo la possibilità di contributi volontari alle residue strutture federali che dalla riforma
sarebbero derivate. Tito parlò alla radio di controrivoluzione e la cosa si concluse con le dimissioni dei
principali dirigenti croati e l’arresto di quelli studenteschi (più di quattrocento). Questo però non
provocò resistenze da parte della popolazione.
Riforma istituzionale del ‘71
Queste diversificate tensioni sociali condussero, nel 1971, ad una ulteriore svolta istituzionale. Sul
piano economico venne adottato un pacchetto di misure di stabilizzazione, che comprendeva la
svalutazione del dinaro. Contemporaneamente venne modificata la Costituzione, introducendovi
elementi di confederazione: si riconobbe una rappresentazione paritaria di repubbliche e regioni nella
Camera dei Popoli, una delle due assemblee da cui era costituito il Parlamento Federale, e si stabilì
che le decisioni più importanti venissero prese solo per consenso unanime, con ciò riconoscendo alle
repubbliche e regioni il diritto di veto. I diritti della Federazione ne risultarono limitati, mentre erano
state accolte le richieste di autonomia delle repubbliche e delle regioni.
Ma ciò non era sufficiente alle regioni, in cui si andava disgregando il sentimento dell’unità. In Croazia
si era costituito un movimento di massa (Maspok), che alimentava il clima nazionalistico e ne faceva
propaganda con metodi brutali. Chiedeva la riunione di tutti i croati in un unico stato fino alla Drina
(cioè includendo la Bosnia-Erzegovina) e rivendicava il controllo di polizia ed esercito, si parlò perfino
dell’adesione della Croazia all’ONU. Di contro, la popolazione serba di Croazia rivendicò lo statuto di
regione autonoma e chiese la costituzione di una camera delle nazionalità.
Il movimento fu represso imponendo un mutamento del gruppo dirigente comunista in tutta la
repubblica e l’arresto dei maggiori esponenti del nazionalismo. Tra di essi c’era Franjo Tudjiman.
La riforma del ’74
Lo sfaldamento del sistema e dei legami di solidarietà aveva raggiunto livelli irreversibili.
Si cercò di porvi rimedio nel 1974 con una nuova riforma costituzionale, elaborata da Tito e Kardelj. Si
rinazionalizzarono le banche e si cercò di riconciliare il processo decisionale decentrato con le
esigenze di un’azione nazionale coordinata, attraverso nuove procedure nella pianificazione degli
investimenti, che rendessero le operazioni di mercato più coerenti con le finalità sociali. Tuttora
convinti che l’autogestione assicurasse la necessaria flessibilità all’economia, mantenendo aperta la
prospettiva socialista, i due dirigenti rafforzarono il sistema del decentramento amministrativo,
ponendo a suo fondamento le comunità locali. Si realizzò così un processo di radicale distribuzione
dei poteri e delle competenze tanto nell’amministrazione pubblica quanto nel sistema economico e
nell’organizzazione produttiva. In quest’ambito, volendo garantire un’autogestione ‘reale’, si crearono
“Organizzazioni di Base del Lavoro Associato” (OBLA), che costituivano la nuova cellula di base. Le
OBLA potevano costituire un’impresa, ma si provvide a introdurre norme che impedissero la
burocratizzazione dei delegati. I poteri e le competenze dello stato furono distribuiti fra i comuni, le
repubbliche e le regioni. Ai comuni spettava di raccogliere i contributi delle imprese, però il maggior
vantaggio della riforma andò alle repubbliche e alle regioni autonome, che furono incaricate di
cogestire con la Federazione il commercio estero, il controllo della valuta e i servizi segreti, lasciando
al Governo Federale soltanto la politica estera e la presidenza dell’esercito. Inoltre, la riforma
elettorale, istituendo un sistema piramidale di assemblee di elettori, fece delle singole repubbliche
l’unico collegio elettorale dei candidati. L’ambito effettivo della vita politica e il solo ove era possibile
9
In: J. Krulic, Op. cit.
In: J. Krulic, Op. cit.
10
14
costruirsi una carriera politica diventò la repubblica. Fu in quest’occasione che venne concessa la
massima autonomia alle province del Kosovo e della Vojvodina. Ne derivò uno degli stati più
decentrati del mondo, come ebbe ad osservare la Banca Mondiale.
Ma in quella delega di poteri la reale rappresentanza era solo poco più che formale, in quanto ne
risultò uno svuotamento istituzionalistico dei consigli operai, mentre si ebbe l’allargamento del
federalismo, soprattutto sul piano della gestione economica, finanziaria e fiscale. La stessa Banca
Mondiale osservava che “l’ideologia comunista si indeboliva e il nazionalismo si rafforzava”.
Era proprio così: era l’inizio della fine.
Verso la disgregazione
Si era aperta tuttavia una fase di sviluppo economico. Le misure di stabilizzazione adottate nel ’71
avevano avuto successo, la politica economica era divenuta più espansiva e la crescita procedeva
assai spedita. Ma la fase dell’espansione coincise con l’aumento del prezzo del petrolio e con la
recessione delle economie dei paesi industrializzati e ciò determinò un effetto negativo sulle
esportazioni. Si riaprì il disavanzo della bilancia commerciale e l’inflazione ricominciò a crescere. La
grave crisi economica che ne derivò si inseriva in una situazione generale, poiché costituiva la
controoffensiva imperialistica alla crisi mondiale; però l’Jugoslavia ne fu particolarmente colpita. La
crisi petrolifera del ’79 determinò una crescita dell’inflazione, insieme ad una contemporanea facilità di
ottenere prestiti da parte di quei paesi che avevano un’eccedenza di surplus, sì che le repubbliche e le
regioni promossero enormi investimenti. Aumentò così vertiginosamente l’indebitamento con l’estero:
negli anni ’80 raggiunse i venti milioni di dollari, senza che fosse cresciuta la disponibilità di valuta
estera per la loro restituzione.
Nel febbraio del ’79 morì Kardelj e, nel maggio dell’80, scomparve anche Tito. La grande crisi coincise
appunto con il dopo-Tito; però, nemmeno il grande vecchio, “Stari”, come veniva chiamato con
attestazione di rispetto, nonostante tutta la sua capacità soggettiva, avrebbe potuto resistere
all’oggettività del travolgente peggioramento economico. Continuava la controoffensiva imperialistica
durante tutti gli anni ’80 e ’90; però la crisi dell’Jugoslavia dipese anche dalla costituzione del ’74. Il
decentramento dei poteri aveva portato al minimo il potere federale e ridotta la sua capacità di
condizionamento politico nell’economia. Ne era derivato un rapido deterioramento delle relazioni tra le
repubbliche: ciascuna, per salvare il proprio apparato produttivo e occupazionale, aveva chiuso il
mercato entro i propri limiti territoriali, annullando il mercato federale: non c’era più né mercato né
piano, ma tanti compartimenti stagni che ricordavano il particolarismo feudale. Il sistema mancava di
criteri regolatori e di meccanismi che ne garantissero il superamento. Perciò la chiusura
imprenditoriale determinò a sua volta la difesa degli interessi locali, una specie di nazionalismo
economico, che si saldava con l’interesse dei gruppi dirigenti: molti piccoli capi approfittavano della
lotta per sopravvivere per accrescere il proprio potere e le proprie ricchezze a danno della
popolazione.
Un’altra grave causa della crisi fu il profondo divario fra il Nord e il Sud del paese, i cui estremi erano
rappresentati dalla progredita Slovenia, con alto tenor di vita e piena occupazione, e dal Kosovo,
molto arretrato e con una disoccupazione al 27%: il suo degrado veniva guardato con disprezzo dalle
regioni forti, che, date le notevoli sovvenzioni che la regione aveva ricevuto, lo attribuivano ad
incapacità di autoamministrarsi.
La disgregazione
Il primo segnale di disgregazione partì appunto dal Kosovo, dove, nel marzo 1981, esplose il
nazionalismo degli albanesi. Poiché il loro territorio era rimasto fino ad allora regione autonoma
nell’ambito della Repubblica Serba, essi chiedevano lo statuto di repubblica. La loro presenza nella
regione, da tempo maggioritaria rispetto a quella dei serbi, fra il 1961 e il 1981 era passata dal 67% al
77% e il numero assoluto dei serbi era diminuito di 28.000 unità. Ciò era dovuto al loro forte
incremento demografico, però ne erano state responsabili anche le riforme, in particolare quella del
’74, con cui avevano ottenuto un crescente potere amministrativo: grazie alle pressioni amministrative,
l’acquisto di terre realizzato con i fondi degli aiuti federali destinati al risanamento della regione, la
solidarietà delle grandi famiglie albanesi, essi avevano indotto molti serbi ad abbandonare la regione
(più di centomila persone in venti anni, su di una popolazione serba di duecentoventimila persone nel
1965) 11.
11
Queste informazioni sono riportate in: J. Krulic, Op. cit., il quale rimanda a: A.N. Dragnic/S. Todorovic, The
saga of Kossovo, focus of serbian-albanian relations, e al saggio di M. Roucs, Le Kossovo: développement
régional et intégration en Jugoslavie, Hérodote 1982.
15
La richiesta del nuovo statuto provocò la reazione dei serbi, che, proprio a causa della presenza nel
loro territorio delle due regioni autonome, Kosovo e Vojvodina, largamente favorite dalla riforma del
’74, si sentivano penalizzati rispetto alle altre repubbliche perché impediti nel controllo del loro
territorio. Essi ostacolavano la costituzione del Kosovo in repubblica, poiché temevano che ciò
costituisse il primo passo verso la secessione: il rifiuto dello statuto di repubblica divenne il centro del
problema.
Nel 1985 ne conseguì una grave manifestazione di nazionalismo serbo. Si trattò di un memorandum
redatto da alcuni membri dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di Serbia – che avevano in Dobrica
Kosic (poi divenuto presidente della Serbia) il loro massimo esponente – svolto secondo una tesi di
forte nazionalismo in chiave antititoista, contro la Croazia e contro l’autonomia delle provincia della
Vojvodina e del Kosovo. Contemporaneamente, la rivista slovena Nova Remija pubblicò una raccolta
di sedici saggi con il titolo Contributo per un programma nazionale sloveno. I due documenti politici
scatenarono forti polemiche.
Il memorandum aprì la strada a Slobodan Milosevic, che nel 1986 divenne segretario del Partito
Socialista Serbo e concluse la sua campagna fortemente improntata ad un nazionalismo serbo
antialbanese. Notava il resoconto della Banca Mondiale: “La sua ascesa era stata favorita
dall’apparato del Partito e dal sistema bancario ma con un riferimento popolare. Tuttavia questo
riferimento non aveva più niente di comunista, bensì di un nazionalismo basato su seicento anni di
storia dopo la sconfitta del Kosovo” 12.
La Lega dei Comunisti (che ormai registrava solo il 5% di operai e l’1% dei contadini, rispetto al 43%
di reggenti di impresa, 25% tecnici e 23% insegnanti) si trasformò in un partito nazionalista la cui
principale motivazione era il promuovere gli interessi serbi. Su queste basi, nell’87, avvenne in Serbia,
all’interno del Partito e del governo, un vero colpo di mano nazionalista e antialbanese da parte di
Milosevic e della sua maggioranza familiare (la moglie, i figli, i parenti vari) con l’espulsione del gruppo
dirigente. Nel marzo dell’89 questo nuovo governo serbo, appoggiato da grandi manifestazioni
popolari, modificò la costituzione della Serbia e abolì l’autonomia delle province del Kosovo e della
Vojvodina, provocando moti in Kosovo a cui seguì una repressione cruenta.
Il 28 giugno 1989, una grande celebrazione del seicentesimo anniversario della famosa battaglia
condusse nel Kosovo centinaia di migliaia di serbi, che un bellicoso discorso di Milosevic infiammò di
patriottismo nazionalista.
Così, ancora una volta, quell’antica sconfitta produsse i suoi effetti nefasti.
Barbarano, 23 gennaio 2001
Nedda Petroni
Via Tavella, 10
36021 Barbarano Vic. (VI)
Tel. 0444/886093
E-mail: [email protected]
12
In: Contraddizione n. 74 del
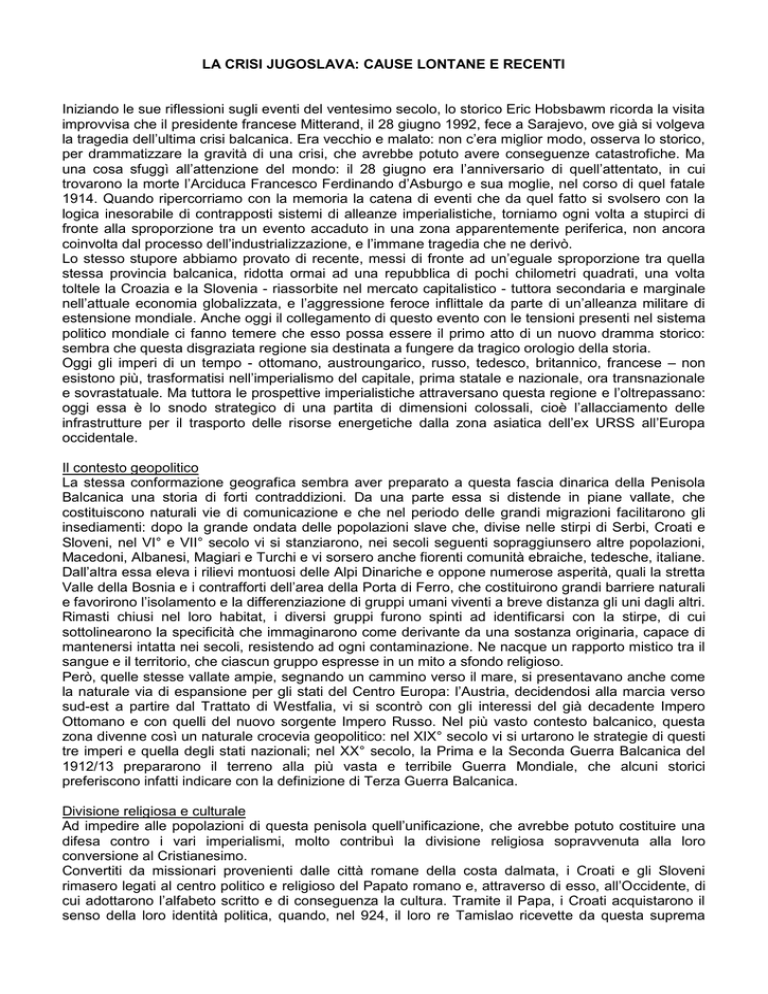


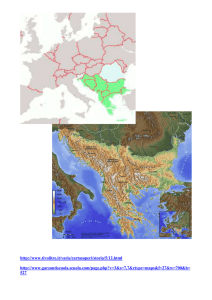


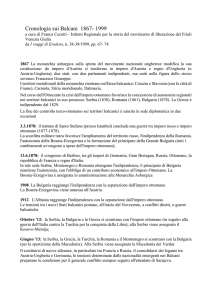
![(Microsoft PowerPoint - ex-jugoslavia [modalit\340 compatibilit\340])](http://s1.studylibit.com/store/data/001320611_1-7ee84abf992ab22f3b60e5ebbffaf648-300x300.png)