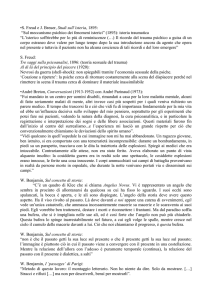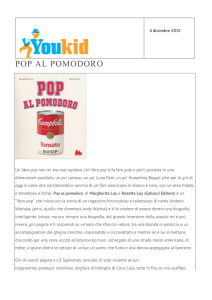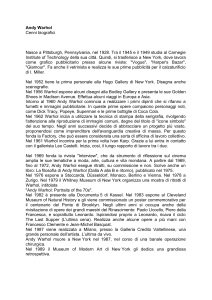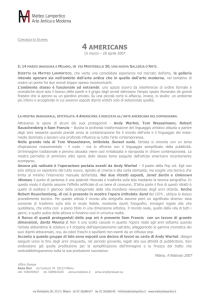Della pop-litica
di lanfranco caminiti [www.lanfranco.org]
Racconterò una storia.
In principio c’è Andy Warhol.
Nel 1972 Warhol produce una serie di dieci ritratti in tecnica mista [dipinto a mano su
serigrafia di acetato] di Mao, il Grande Timoniere. Era lo stesso procedimento usato, un
decennio prima, per la serie di 12 opere dedicate a Marilyn Monroe, per le Sedici Jackies –
immagini di Jacqueline Kennedy prima dell'assassinio del marito a Dallas e poi in lutto –,
per gli Elvis, per le Liz Taylor.
Mao, il padre della Rivoluzione cinese – l’uomo che aveva incitato le Guardie rosse a
bombardare il quartier generale, il cui ritratto veniva innalzato e fatto sfilare come un
messaggio di contropotere e di un’apocalisse in arrivo in tutte le piazze dell’occidente da
Parigi e Berlino a Milano e Roma a San Francisco e Chicago –, diventa una star. E un’icona
pop. Come Marilyn, come Jackie, come Elvis, come Liz.
Ma Warhol non si fermò qui. Nel 1977 presenzia a Parigi al vernissage della sua nuova
mostra, in una galleria vicino il Centre Beauborg, da poco inaugurato. La sua nuova serie
si intitola Falce e martello. Una cosa assolutamente inconsueta, già solo per un americano.
Ma Warhol aveva più volte, negli anni precedenti, visitato l’Europa rimanendo colpito
dalle scritte comuniste che aveva ritrovato sui muri di tutte le città. [da Howard Sounes,
Anni 70, la musica le idee i miti, Laterza] Quelle scritte erano talmente ripetute da diventare
ormai un fatto astratto, uno sguardo distratto, come le lattine di zuppa Campbell’s o le
scatole di detersivo Brill. Ora, fissandole, manipolandole e facendone quadri, Warhol le
trasformava in arte. In arte pop. In arte perché erano pop.
Il punto di forza della pop art era quello di sottrarre ogni sentimento alla pittura. Warhol
pensava a sé come un artista-macchina che opera su scala industriale operando nella
ripetizione.
La politica, l’azione politica, si mostrava nella serie Falce e martello per quello che stava
diventando: un’azione ripetitiva e meccanica, priva di sentimento, in cui potevano
emergere figure iconiche di uno star system, come Mao. Il più è detto.
La storia prosegue: è proprio al ritratto di Mao che nel 1991 Don DeLillo dedica un libro:
Mao II. Il romanzo intreccia e sovrappone il terrorismo internazionale, le follie di massa di
una setta planetaria, la storia di uno scrittore solitario e di una fotografa che cerca di
fissare immagini del suo lavoro – lo aveva colpito la «caccia» fotografica a Salinger,
appartato da sempre. Nel corso del suo viaggio italiano nel 1992, DeLillo dichiara che il
suo lavoro è in una certa misura analogo a quello di Warhol, a metà strada tra arte e mass
media. Il tema principale del libro è la ripetizione: «Warhol è una figura che in qualche
modo si distacca dalla storia, galleggia sulla superficie delle cose, diventa icona, immagine
‘sacra’, come Elvis Presley e Mao Tse Tung. Il titolo del mio libro Mao II vuol dire questo.
Siamo fuori dalla storia e dentro la ripetizione, la fotografia, la reiterazione di massa,
l’obliterazione delle distinzioni, di ogni differenza». DeLillo osservava che si è rovesciata
la previsione di Walter Benjamin secondo cui la riproduzione dell’immagine di un’opera
d’arte uccide la sua «aura»: «L’aura si crea col passaggio dei flash dei fotografi, dei
registratori. Non c’è che l’aura, che si sta sostituendo alla realtà» [da
www.carmillaonline.com].
La storia non finisce qui, con il percorso del ritratto di Mao dall’arte pop alla letteratura e
quindi alla sua «multipla» capacità di evocazione – come, alla fine dell’Underworld sempre
di DeLillo, il tabellone pubblicitario che diventa un’immagine sacra presso la quale si
raccolgono fedeli in preghiera.
Nel novembre del 2006, nel corso di un’asta Christie's a New York, il ritratto di Mao è
diventato il pezzo più costoso di Warhol – ancora vivo ne sarebbe stato felicissimo,
mettendosi a far di conto – venduto per 17,3 milioni di dollari. A comprarlo, un privato di
Hong Kong, che alla fine di quell’anno lo ha portato in Cina. Il percorso ora è compiuto: in
un certo senso, il ritratto «torna» in Cina – a ricongiungersi con i milioni di immagini
riprodotte del Grande Timoniere. Perché, all’incontrario, è quel ritratto adesso l’ispiratore
di questi milioni di immagini. È il vero Mao di questa falsa Cina, il «fondamento»
dell’impero del falso e della ripetizione, dell’inautentico, della copia. È Warhol ora il
Grande Timoniere. Dovrebbero esporlo sulla piazza Tiananmen.
Fine della storia.
C’è una piccola appendice: proprio pochi giorni fa, la Citroën spagnola, per rilanciare la
propria immagine e una nuova vettura, ha usato in una campagna pubblicitaria un ritratto
d’un Mao che fa le smorfie indispettito. La comunità cinese di Spagna se n’è sentita offesa,
e ha baccagliato tanto da farla ritirare.
Ma l’accostamento e l’uso di un’icona politica in pubblicità – il Gandhi del «Think
different» o il Gorbaciov che tiene vicino le borse Vuitton – è già una questione ulteriore e
il segno d’un decadimento. Come tutto ciò che è ammiccante.
Come per la coppia Bruni-Sarkozy o quella Campbell-Chavez, l’accumulazione distrae e
perde il carattere iconico per farsi vulgata. È l’effetto «Lady D», la «principessa del
popolo» – quello del gioco di trascinamento dello star system «a fianco e dentro» la
politica.
Un procedimento di retorica popolare.
Di cui non ci si rende conto. In cui si galleggia senza rendersene conto. Come nessuno si
rendeva conto di «toccare» l’arte comprando le scatole di detersivo Brill, non è dato aver
coscienza di «vivere» la politica odierna leggendo e parteggiando per le storie di Sarkó e
Cecilia e Carla. Ma questo ci tocca: la politica è una saga pop – il «sentimento» qui è
sovrabbondante e ridondante – di cui attendiamo trepidanti la prossima puntata.
Roma, 20 gennaio 2008