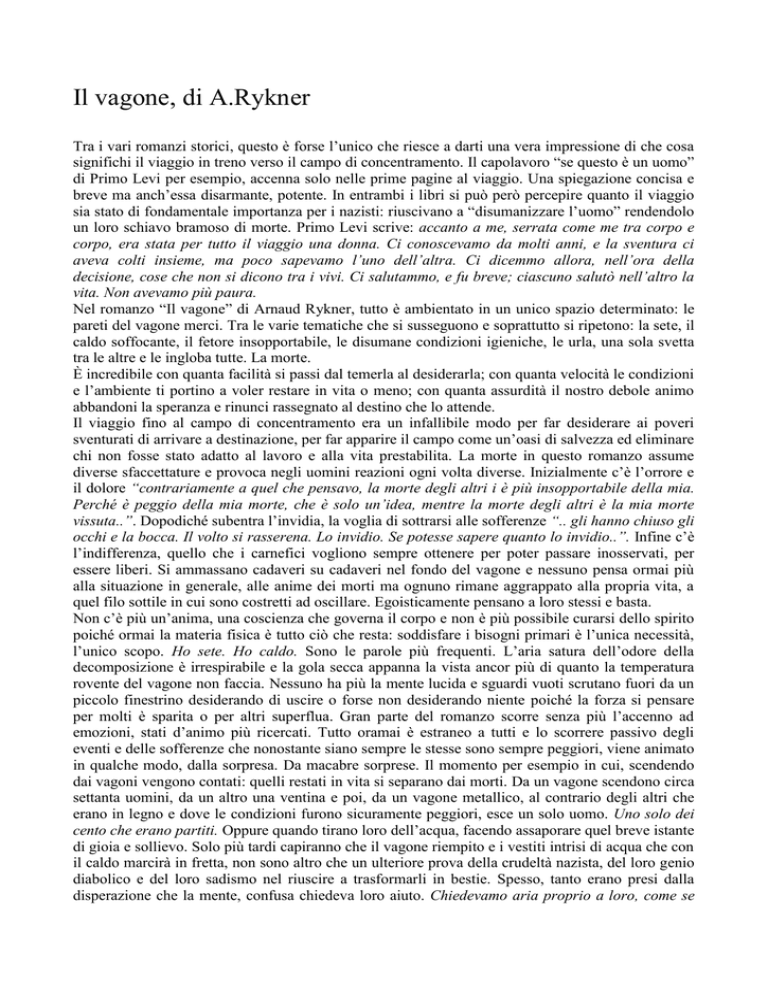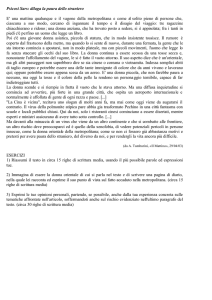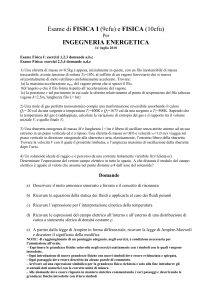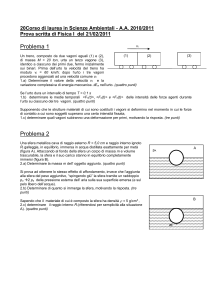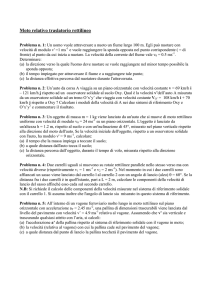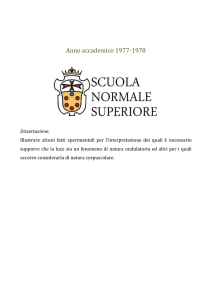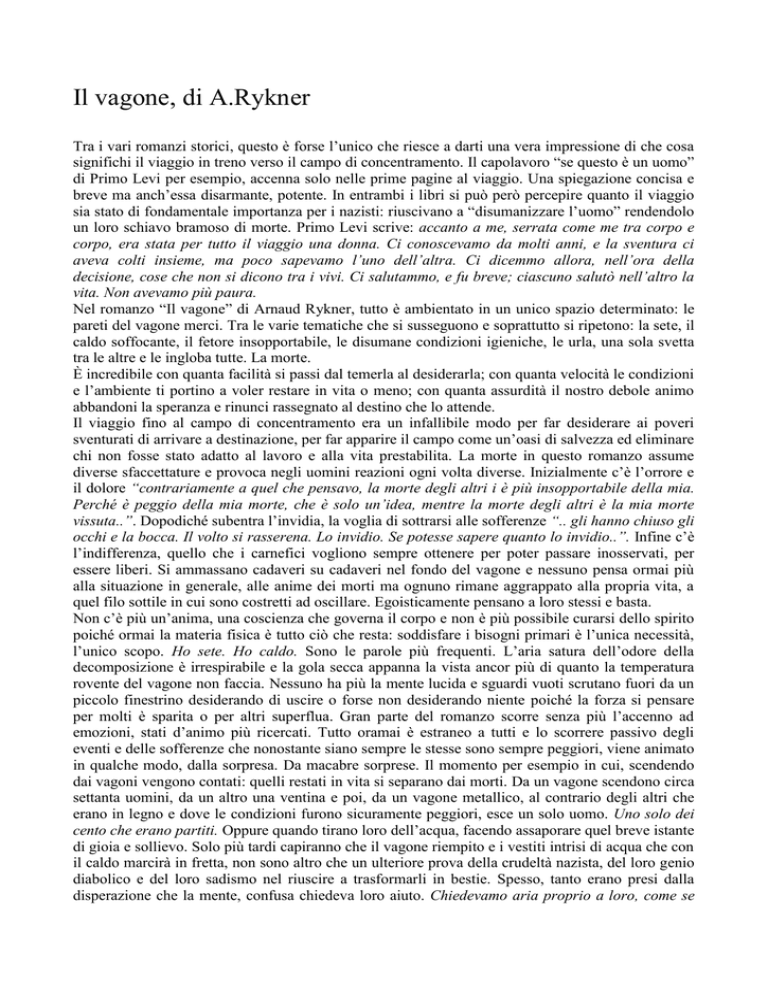
Il vagone, di A.Rykner
Tra i vari romanzi storici, questo è forse l’unico che riesce a darti una vera impressione di che cosa
significhi il viaggio in treno verso il campo di concentramento. Il capolavoro “se questo è un uomo”
di Primo Levi per esempio, accenna solo nelle prime pagine al viaggio. Una spiegazione concisa e
breve ma anch’essa disarmante, potente. In entrambi i libri si può però percepire quanto il viaggio
sia stato di fondamentale importanza per i nazisti: riuscivano a “disumanizzare l’uomo” rendendolo
un loro schiavo bramoso di morte. Primo Levi scrive: accanto a me, serrata come me tra corpo e
corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni, e la sventura ci
aveva colti insieme, ma poco sapevamo l’uno dell’altra. Ci dicemmo allora, nell’ora della
decisione, cose che non si dicono tra i vivi. Ci salutammo, e fu breve; ciascuno salutò nell’altro la
vita. Non avevamo più paura.
Nel romanzo “Il vagone” di Arnaud Rykner, tutto è ambientato in un unico spazio determinato: le
pareti del vagone merci. Tra le varie tematiche che si susseguono e soprattutto si ripetono: la sete, il
caldo soffocante, il fetore insopportabile, le disumane condizioni igieniche, le urla, una sola svetta
tra le altre e le ingloba tutte. La morte.
È incredibile con quanta facilità si passi dal temerla al desiderarla; con quanta velocità le condizioni
e l’ambiente ti portino a voler restare in vita o meno; con quanta assurdità il nostro debole animo
abbandoni la speranza e rinunci rassegnato al destino che lo attende.
Il viaggio fino al campo di concentramento era un infallibile modo per far desiderare ai poveri
sventurati di arrivare a destinazione, per far apparire il campo come un’oasi di salvezza ed eliminare
chi non fosse stato adatto al lavoro e alla vita prestabilita. La morte in questo romanzo assume
diverse sfaccettature e provoca negli uomini reazioni ogni volta diverse. Inizialmente c’è l’orrore e
il dolore “contrariamente a quel che pensavo, la morte degli altri i è più insopportabile della mia.
Perché è peggio della mia morte, che è solo un’idea, mentre la morte degli altri è la mia morte
vissuta..”. Dopodiché subentra l’invidia, la voglia di sottrarsi alle sofferenze “.. gli hanno chiuso gli
occhi e la bocca. Il volto si rasserena. Lo invidio. Se potesse sapere quanto lo invidio..”. Infine c’è
l’indifferenza, quello che i carnefici vogliono sempre ottenere per poter passare inosservati, per
essere liberi. Si ammassano cadaveri su cadaveri nel fondo del vagone e nessuno pensa ormai più
alla situazione in generale, alle anime dei morti ma ognuno rimane aggrappato alla propria vita, a
quel filo sottile in cui sono costretti ad oscillare. Egoisticamente pensano a loro stessi e basta.
Non c’è più un’anima, una coscienza che governa il corpo e non è più possibile curarsi dello spirito
poiché ormai la materia fisica è tutto ciò che resta: soddisfare i bisogni primari è l’unica necessità,
l’unico scopo. Ho sete. Ho caldo. Sono le parole più frequenti. L’aria satura dell’odore della
decomposizione è irrespirabile e la gola secca appanna la vista ancor più di quanto la temperatura
rovente del vagone non faccia. Nessuno ha più la mente lucida e sguardi vuoti scrutano fuori da un
piccolo finestrino desiderando di uscire o forse non desiderando niente poiché la forza si pensare
per molti è sparita o per altri superflua. Gran parte del romanzo scorre senza più l’accenno ad
emozioni, stati d’animo più ricercati. Tutto oramai è estraneo a tutti e lo scorrere passivo degli
eventi e delle sofferenze che nonostante siano sempre le stesse sono sempre peggiori, viene animato
in qualche modo, dalla sorpresa. Da macabre sorprese. Il momento per esempio in cui, scendendo
dai vagoni vengono contati: quelli restati in vita si separano dai morti. Da un vagone scendono circa
settanta uomini, da un altro una ventina e poi, da un vagone metallico, al contrario degli altri che
erano in legno e dove le condizioni furono sicuramente peggiori, esce un solo uomo. Uno solo dei
cento che erano partiti. Oppure quando tirano loro dell’acqua, facendo assaporare quel breve istante
di gioia e sollievo. Solo più tardi capiranno che il vagone riempito e i vestiti intrisi di acqua che con
il caldo marcirà in fretta, non sono altro che un ulteriore prova della crudeltà nazista, del loro genio
diabolico e del loro sadismo nel riuscire a trasformarli in bestie. Spesso, tanto erano presi dalla
disperazione che la mente, confusa chiedeva loro aiuto. Chiedevamo aria proprio a loro, come se
avessimo dimenticato chi sono, come se non sapessimo più chi ci ha rinchiusi qui dentro a
soffocare fra queste esalazioni mortali.
Ogni tanto un soffio vitale risveglia qualcuno che prova ad uscire dal vagone, prova a salvarsi,
prova a chiedere aiuto. Le urla vengono ignorate, tutto viene ignorato e nessuno agisce, forse per
paura. Ci guardano impotenti, dice il protagonista parlando delle donne che ad una delle poche
fermate del treno portano loro da mangiare. Una poesia di Giuseppe Ungaretti recita: “Ma le mie
urla – feriscono - come fulmini - la campana fioca – del cielo. Sprofondano – impaurite.” dando una
immagine nitida e palese di quanto tanto rumore a volte, non provochi altro che frustrazione e come
conseguenza ancora silenzio.
Al contrario di testi come: “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman o “il bambino con il pigiama a
righe” di John Boyne che, parlando entrambi della storia di due bambini, uno ebreo e un altro di
famiglia ariana, narrano del viaggio inteso come percorso di vita: le situazioni che si accavallano, il
legame indissolubile dell’amicizia nonostante si appartenga a due mondi differenti e la forza
dell’innocenza; il “Vagone” parla del viaggio concreto, più crudo, reale. Sviluppato in pochi giorni
le quali ore però appaiono infinite, troppo lunghe.
Non c’è quello sfondo di poesia ma solo strazio, angoscia, dolore e sfiducia che attanagliano il
lettore per tutto il tempo, quasi come se fossi lì, con lui. Come se sentissi anche tu la sete e la
sensazione di soffocamento. Come se anche tu non vedessi l’ora di arrivare ed entrare nel campo di
stermino.
Alla fine il treno si ferma, definitivamente a Dachau. È su quella grossa candela che fuma laggiù
che mi toccherà soffiare? Oggi compio ventidue anni e non sono completamente morto. Con queste
ultime frasi si conclude il libro. Toccanti e forse un po’ lugubri che con un velo di sadica ironia
sottolineano quanto la sua umanità sia soltanto un ricordo ed ora è solo il suo corpo vuoto che
cresce.
Elisa Vitali 4°E