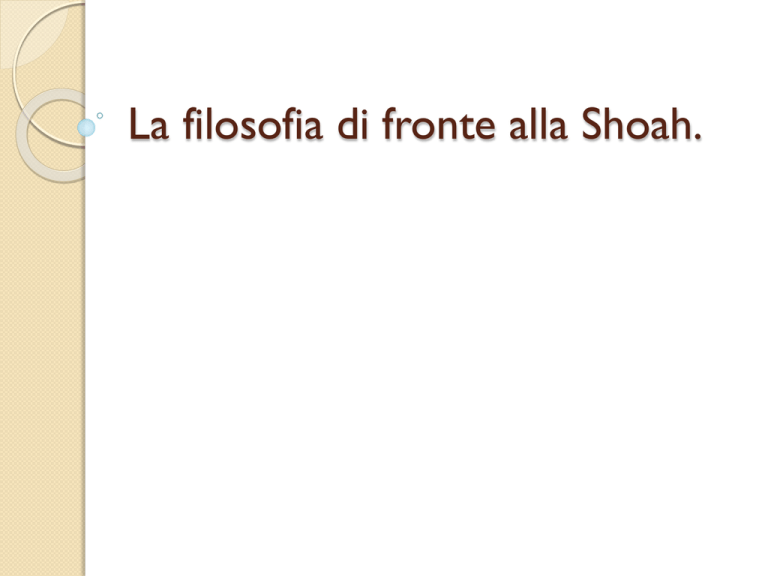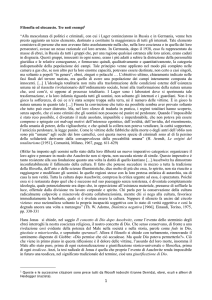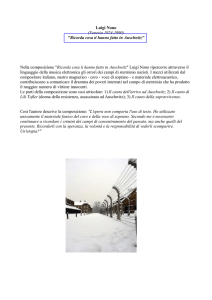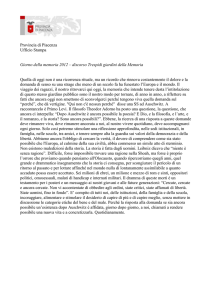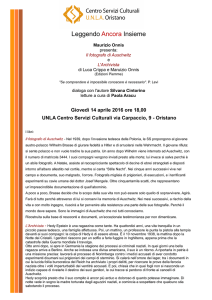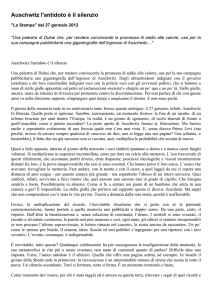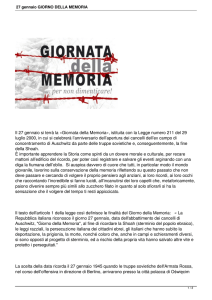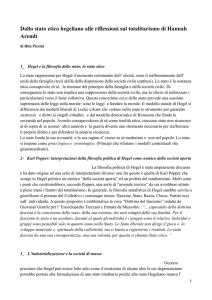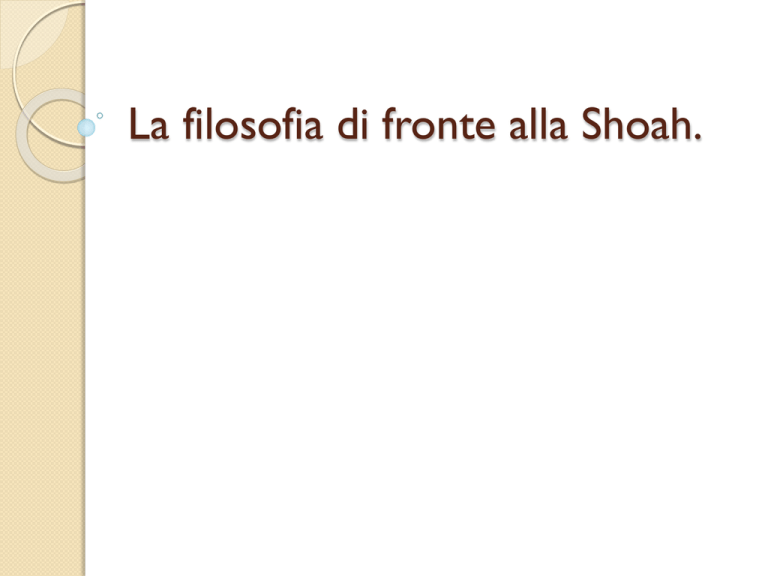
La filosofia di fronte alla Shoah.
Responsabilità.
Marc Chagall, La crocifissione bianca.
Il contesto storico.
Il concetto di genocidio.
Il processo di Norimberga.
Il processo di Eichmann a Gerusalemme.
3
Il concetto di “genocidio”.
Il giurista americano Raphael Lemkin, fin dal
1944, fu uno dei primi a rendersi conto della
novità dei crimini nazisti: a suo parere, essi erano
così particolari, da richiedere una parola del tutto
nuova. Lemkin, pertanto, coniò l’espressione
genocidio, cui diede il seguente significato:
«distruzione di una nazione o di un gruppo etnico» nel
suo complesso.
Il genocidio, proseguiva Lemkin, «è diretto contro il
gruppo nazionale in quanto entità, e le azioni che
esso provoca sono condotte contro individui, non
a causa delle loro qualità individuali, ma in quanto
membri del gruppo nazionale».
4
Il processo di Norimberga
E’ il primo è più
famoso processo
contro i criminali
nazisti. Come sede
del dibattimento,
fu scelta la città di
Norimberga per il
fatto che, prima
della guerra, ogni
anno aveva
regolarmente
ospitato il
congresso del
partito nazista.
Hermann Goering,
l’imputato più
famoso
del processo di
Norimberga,
fotografato
durante l’istruttoria
(1945).
5
Gli imputati.
Furono ventidue alte personalità.
La figura più importante (dopo il
suicidio di Hitler, Himmler e
Goebbels) era Hermann Göring,
comandante supremo
dell’aviazione e responsabile
dell’economia del Reich; fra gli
altri: personaggi di spicco R.
Hess (che fino al 1941 fu
stretto collaboratore
di Hitler e, nel 1924, ne aveva
scritto materialmente il Mein
Kampf, sotto dettatura
del Führer), J. von Ribbentrop
(ministro degli Esteri), Hans
Frank (governatore
della Polonia occupata) e Albert
Speer (che aveva diretto la
produzione bellica
tedesca negli ultimi anni di
guerra).
6
Vincitori e vinti.
Per tutti, le imputazioni erano quattro: cospirazione per
condurre una guerra d’aggressione, crimini contro la
pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Per
l’accusa, il ruolo principale fu assunto dal procuratore
americano J.R.H. Jackson, che spesso si trovò in palese
difficoltà a collaborare con il suo collega sovietico Ion
Nikitcenko: i russi, infatti, a Norimberga, cercarono
soprattutto di addossare ai tedeschi il crimine della
foresta di Katyn.
A giudicare i nazisti vi era una giuria composta da quattro
giudici: uno statunitense, uno
sovietico, uno inglese e uno francese.Vennero inoltre
nominati quattro sostituti dei giudici
principali, sempre appartenenti ai medesimi Stati.
Alla fine di un processo complessivamente equo, nel
quale agli imputati fu concesso di parlare e di difendersi,
furono emesse undici condanne a morte, eseguite il
16 ottobre 1946;
quattro imputati furono assolti, mentre ai rimanenti (tra
cui Hess e Speer) furono inflitte
Vincitori e vinti
(Judgment at Nuremberg)
è il titolo italiano di un
noto film del 1961 diretto
da S. Kramer che tratta
del processo di
Norimberga.
lunghe pene detentive.
La sentenza finale, inoltre, dichiarò che la direzione del
partito nazista, la Gestapo, le SS e l’SD (il servizio
segreto delle SS) erano organizzazioni criminali.
7
Gli altri processi.
“All’inizio la persecuzione dei crimini venne fatta dai vincitori. Non solo
contro i criminali maggiori e chi li aveva sostenuti, ma anche con migliaia
di processi gestiti autonomamente da americani, britannici, francesi e
sovietici. Una prima ondata che costrinse a fare subito i conti con il
passato, ma produsse anche un effetto di difesa collettiva, con
dichiarazioni e testimonianze favorevoli agli imputati che tendevano ad
accreditare una certa versione del passato bellico.
La politica giudiziaria della Repubblica federale tedesca è invece più
complessa. A partire dalla fine degli anni Cinquanta si perseguirono
ampiamente i crimini di carattere antisemita, come nel grande processo
di Francoforte contro gli aguzzini di Auschwitz che informò l’opinione
pubblica su ciò che era successo.
Diverso è invece il caso dei crimini di guerra commessi dalle Forze
Armate e, attraverso lo strumento della prescrizione del reato, si
arrivò per molti a un’amnistia indiretta … Usando le leve del diritto si
poteva infatti passare dall’omicidio doloso a quello colposo, oppure dalla
posizione di autore del reato a quella di esecutore di un ordine, come dire
un complice non colpevole.”.
(Lutz Klinkhammer, storico tedesco)
8
Il processo Eichmann e i “testimoni”.
Nel 1960, fu catturato a Buenos Aires,
dagli agenti dei servizi segreti
israeliani, Adolf Eichmann, il
funzionario della Gestapo
responsabile della deportazione
degli ebrei ungheresi e di azioni si
trasferimento forzato ad Auschwitz.
Nel 1962, fu condannato a
morte a Gerusalemme, ove si
scelse di dare al processo un taglio
completamente diverso da quello
di Norimberga. Il processo di
Gerusalemme presentò la Shoah
come un evento specifico e
segnò la nascita sociale della figura
del testimone, inteso come
portatore di una memoria che
non poteva essere perduta.
9
Le risposte della filosofia.
Lo scacco: Adorno, Jean Améry.
La questione della colpa (Jaspers).
La “banalità del male” (Arendt).
Il problema di Dio dopo Auschwitz
(Jonas).
10
La filosofia di fronte ad Auschwitz.
Di fronte al genocidio insensato messo in atto dai nazisti, i
filosofi del Novecento hanno reagito in vario modo:
negando la possibilità di fornire una spiegazione
razionale alla Shoah (Adorno, Jean Améry);
ponendo la questione della colpa della nazione tedesca
(Jaspers);
richiamandosi alla perdita del senso di responsabilità da
parte di una società di massa cresciuta all’ombra del
totalitarismo (Arendt);
fornendo una risposta teologica (Jonas) o un’indicazione
morale sul valore dell’Altro (Lévinas).
11
Adorno: no man’s land.
Th. W. Adorno scrisse nel 1966:
“Dopo Auschwitz, nessuna poesia,
nessuna forma d'arte, nessuna
affermazione creatrice è più
possibile. Il rapporto delle cose non
può stabilirsi che in un terreno
vago, in una specie di no man's land
filosofica” (Dialettica negativa,
Einaudi, Torino 2004, p. 326)
12
Adorno: “l’inferno reale”.
Secondo il filosofo tedesco Theodor Wiesengrund Adorno, dopo Auschwitz la
trascendenza non offre piú all’immanenza alcun significato. Auschwitz ha lo stesso
effetto in campo sociale che il terremoto di Lisbona ha avuto nel campo dei
fenomeni naturali. La malvagità umana ha realizzato “l’inferno reale”.
”Il terremoto di Lisbona fu sufficiente per guarire Voltaire dalla teodicea leibniziana, e la
catastrofe ancora comprensibile della prima natura fu minima confrontata con la seconda,
sociale, che si sottrae all’immaginazione umana, preparando l’inferno reale sulla base della
malvagità umana. La capacità alla metafisica è paralizzata perché ciò che è successo ha
mandato a pezzi la base dell’unificabilità del pensiero speculativo metafisico con
l’esperienza. Ancora una volta trionfa, indicibilmente, il motivo dialettico del rovesciarsi della
quantità in qualità. La morte, con l’assassinio burocratico di milioni di persone, è diventata
qualcosa che non era mai stata tanto da temere. Non c’è più alcuna possibilità che essa
entri nella vita vissuta dei singoli come un qualcosa che concordi con il suo corso. L’individuo
viene spossessato dell’ultima e più misera cosa che gli era rimasta. Poiché nei campi di
concentramento non moriva più l’individuo, ma l’esemplare, il morire deve attaccarsi anche
a quelli sfuggiti a tale misura. Il genocidio è l’integrazione assoluta che si prepara ovunque,
dove uomini vengono omogeneizzati, “scafati” – come si dice in gergo militare – finché li si
estirpa letteralmente, deviazioni dal concetto della loro completa nullità. Auschwitz
conferma la norma filosofica della pura identità come morte” Th. W. Adorno, Dialettica
negativa, Einaudi, Torino, 1975, pagg. 326-327
13
Il fallimento della cultura.
Dopo Auschwitz, Hitler ci costringe ad impegnarci con tutte le nostre forze per fare in modo
che ciò che è avvenuto non possa ripetersi. Questo è diventato l’“imperativo categorico” della
nostra epoca. Auschwitz dimostra inconfutabilmente il fallimento della cultura e
dell’interpretazione illuminista della storia. Ma la negazione della cultura non è una soluzione.
Neppure il silenzio.
”Hitler ha imposto agli uomini nello stato della loro illibertà un nuovo imperativo categorico:
organizzare il loro agire e pensare in modo che Auschwitz non si ripeta, non succeda niente di simile.
Questo imperativo è tanto resistente alla sua fondazione quanto una volta la datità di quello kantiano.
[...].
Auschwitz ha dimostrato inconfutabilmente il fallimento della cultura. Il fatto che potesse succedere in
mezzo a tutta la tradizione della filosofia, dell’arte e delle scienze illuministiche, dice molto di più che
essa, lo spirito, non sia riuscito a raggiungere e modificare gli uomini...Tutta la cultura dopo Auschwitz,
compresa la critica urgente ad essa, è spazzatura. Poiché essa si è restaurata dopo quel che è successo
nel suo paesaggio senza resistenza, è diventata completamente ideologia, quale potenzialmente era
dopo che, in opposizione all’esistenza materiale, presunse di soffiarle la luce, offertale dalla divisione tra
lavoro corporale e spirito. Chi parla per la conservazione della cultura radicalmente colpevole e
miserevole diventa collaborazionista, mentre chi si nega alla cultura, favorisce immediatamente la
barbarie, quale si è rivelata essere la cultura. Neppure il silenzio fa uscire dal circolo vizioso: esso
razionalizza soltanto la propria incapacità soggettiva con lo stato di verità oggettiva e così la degrada
ancora una volta a menzogna”.
Th. W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1975, pagg. 330-331
14
Jaspers e la questione della colpa.
Il filosofo esistenzialista Karl Jaspers (1883-1969) dedica a questi
temi un semestre di lezioni nel 1946, poi pubblicato nel saggio La
questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, in
cui stabilisce quattro diversi livelli di colpa:
una colpa giuridica,che riguarda la violazione di una legge ed è
propria del singolo;
una colpa morale, che riguarda la coscienza individuale e dunque
implica una responsabilità verso le azioni compiute dall’individuo;
una colpa politica, che riguarda la corresponsabilità dei cittadini nelle
azioni di stato;
una colpa metafisica, intesa come una forma di annichilimento della
“solidarietà assoluta” degli uomini tra loro. Per Jaspers questa
solidarietà deve intendersi come un impulso incondizionato che
precede la razionalità propria della sfera morale: riguarda la sfera
del comune sentire che ha permesso a tutti gli esseri umani, almeno
una volta nella vita, di sentire nel dolore o nella passione un’unione
costitutiva con l’Altro.
15
Arendt e la colpa
Influenzata dal maestro Karl Jaspers, Hannah Arendt
(1906-1975) distingue nettamente colpa e responsabilità
in Responsabilità collettiva, saggio pubblicato postumo:
mentre la colpa si riferisce sempre alle azioni
compiute da un singolo soggetto agente, la
responsabilità è intesa come ‘collettiva’ sulla base
del principio di appartenenza di un soggetto ad un
gruppo.
Arendt specifica che la linea di divisione che separa la
colpa dalla responsabilità rimanda alla più profonda
distinzione tra morale e politica: colpevole è chi ha
violato una legge, sia essa morale o giuridica, mentre la
responsabilità collettiva si riferisce alla sfera
politica, che riguarda l’intera comunità per gli atti
compiuti dai suoi membri. In questo secondo senso,
ciascun uomo è, in condivisione con gli altri,
“responsabile” per le azioni che sono state compiute dai
cittadini della sua nazione, senza esserne moralmente
colpevole. In altre parole, per Arendt esiste una
responsabilità squisitamente politica di tutti
coloro che hanno vissuto passivamente sotto il
regime nazista.
16
Arendt e la “banalità del male”.
Inviata a Gerusalemme come
corrispondente del giornale statunitense
“The New Yorker”, Hannah Arendt
rimase sorpresa dalla figura di Eichmann,
un burocrate zelante, che parlava per
cliché e frasi fatte.
La studiosa coniò l’espressione
“banalità del male” per indicare che
crimini efferati come quelli compiuti dai
nazisti non erano espressione di un
“male radicale” ma il risultato di una
semplice routine amministrativa che
privava gli uomini della facoltà di pensare
e agire autonomamente.
17
La responsabilità del pensare.
In concreto, il mio interesse per le attività spirituali ha origine in due esperienze abbastanza diverse. Lo stimolo
immediato mi venne assistendo al processo Eichmann a Gerusalemme. Nel resoconto che ho lasciato
parlavo della “banalità del male”. Tale espressione non implicava allora nessuna tesi o dottrina, anche se mi
rendevo conto, confusamente, che essa andava in direzione opposta a quanto asserito dalla nostra tradizione di
pensiero – letteraria, teologica o filosofica – intorno al fenomeno del male. [...] Nondimeno, ciò che avevo sotto
gli occhi a Gerusalemme, qualcosa di totalmente diverso, era pure innegabilmente un fatto. Restai colpita dalla
superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l’incontestabile superficialità dei
suoi atti a un livello più profondo di cause e motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l’attore – per lo meno
l’attore tremendamente efficace che si trovava sul banco degli imputati – risultava quanto mai ordinario, mediocre,
tutt’altro che demoniaco o mostruoso. Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche
motivazioni malvagie, e l’unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento
passato, come quello tenuto durante il processo e lungo tutto l’interrogatorio della polizia prima del processo,
era qualcosa di interamente negativo: non stupidità, ma mancanza di pensiero. Sulla scena del tribunale
israeliano e delle procedure carcerarie egli si comportava come avrebbe fatto nel regime nazista, ma di fronte a
situazioni in cui tali procedure di routine non esistevano, eccolo improvvisamente smarrito, mentre il suo
linguaggio dominato dai clichés produceva in tribunale, come certo doveva essere avvenuto altre volte nella sua
vita ufficiale, una sorta di macabra commedia. Clichés, frasi fatte, l’adesione a codici d’espressione e di
condotta convenzionali e standardizzati adempiono la funzione socialmente riconosciuta di
proteggerci dalla realtà, cioè dalla pretesa che tutti gli eventi e tutti i fatti, in virtù della loro esistenza,
avanzano all’attenzione del nostro pensiero. Saremmo rapidamente esausti se fossimo ogni volta sensibili a tale
pretesa: la sola differenza fra Eichmann e il resto dell’umanità è che, manifestatamente, egli la ignorava del tutto. Fu
proprio questa assenza di pensiero – così consueta nella vita di tutti i giorni, quando si ha appena il tempo, o
anche solo la voglia, di fermarci a pensare – che destò il mio interesse. È possibile fare il male (le colpe di
omissione sono alla stessa stregua di quelle commesse) in mancanza non solo di “moventi abietti” (come li
chiama la legge), ma di moventi tout court, di uno stimolo particolare dell’interesse o della volizione? Si può
credere che la malvagità, comunque la si definisca, questa “determinazione a dimostrarsi scellerati”, non sia una
condizione necessaria per compiere il male? Il problema del bene e del male, la nostra facoltà di
distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato sarebbe forse connesso con la nostra facoltà di
pensiero? […] Potrebbe questa attività (il pensare) rientrare nelle condizioni che inducono gli
uomini ad astenersi dal fare il male, o perfino li “dispongono”contro di esso?
(H.Arendt, La vita della mente)
18
Stanley Milgram: un esperimento
sulla “banalità del male”.
Nel luglio 1961, sono passati solo tre mesi dal processo di
Eichmann e le dichiarazioni del nazista hanno stupito lo
psicoloco sociale Stanley Milgram a tal punto da indurlo a
progettare un esperimento che esplori le dinamiche
psicologiche dell’obbedienza.
Un soggetto viene reclutato, dietro compenso, da un
importante e riconosciuto Istituto di ricerca, e viene
invitato a porre domande ad un uomo. Se le risposte risultano
sbagliate, il soggetto deve tirare un piccola leva che genera
una lieve scossa elettrica (punizione) all’ uomo sottoposto all’
esperimento. Le scosse elettriche aumento di intensità ad ogni
risposta errata, e per questo motivo arriva un momento in cui
l’ uomo dell’ esperimento chiede al soggetto di smettere ma
gli scienziati invitano il soggetto a continuare l’ esperimento
ed a infliggere scosse ancora più pesanti in caso di errore da
parte dell’ uomo dell’ esperimento. In realtà, l’ uomo dell’
esperimento è un attore che collabora con gli scienziati, e la
scossa elettrica non esiste perchè è tutta finzione, ma il
soggetto reclutato per l’ esperimento non lo sa ed è
pienamente convinto che sia tutto vero. L’ esperimento
termina quando l’ uomo dell’ esperimento, che subisce le
scosse elettriche, fingendo, perde i sensi non fornendo più
nessun segno di vita.
Risultati:
- nel 1961, il 62,5% dei soggetti arriva alla fine
dell'esperimento obbedendo alle autorità scientifiche,
commettendo in prima persona delle azioni oggettivamente
criminose, e rimettendo alle autorità qualsiasi responsabilità.
19
Jonas: la Shoah, una sfida teologica.
Hans Jonas (1903-1993) studiò teologia e filosofia in Germania con Husserl, Heidegger
e Bultmann. Emigrò nel 1933 e quindi riuscì a evitare la Shoah, che invece travolse
sua madre. Noto per i suoi studi sullo gnosticismo e per i suoi trattati di etica (Il
principio responsabilità), Jonas tenne la conferenza Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
Una voce ebraica a Tubinga, nel 1984. In quella circostanza, Jonas avanzò
provocatoriamente la proposta di cancellare l’onnipotenza dagli attributi di Dio,
pena la rinuncia alla Sua bontà e alla comprensibilità del Suo agire nel mondo e nella
storia.
20
Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
“L’onnipotenza divina può coesistere con la bontà assoluta di Dio solo al prezzo di una
totale non comprensibilità di Dio, cioè dell’accezione di Dio come mistero assoluto. [...]
Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con estrema decisione che una
Divinità onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile (nel governo del
mondo in cui noi unicamente siamo in condizione di comprenderla). [...] Di fronte alle
cose veramente inaudite che, nel creato, alcune creature fatte a sua somiglianza, hanno
fatto ad altre creature innocenti, ci si dovrebbe aspettare che il Dio, somma bontà, [...]
intervenga con un miracolo di salvezza. Ma questo miracolo non c’è stato; durante gli
anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz Dio restò muto. [...] Dio tacque. Ed ora
aggiungo: non intervenne, non perché non lo volle, ma perché non fu in condizione di
farlo. Per ragioni che in modo decisivo derivano dall’esperienza contemporanea,
propongo quindi l’idea di un Dio che per un’epoca determinata – l’epoca del processo
cosmico – ha abdicato ad ogni potere di intervento nel corso fisico del mondo. [...] La
creazione fu l’atto di assoluta sovranità, con cui la Divinità ha consentito a non essere
più, per lungo tempo, assoluta – una opzione radicale a tutto vantaggio dell’esistenza di
un essere finito capace di autodeterminare se stesso – un atto infine
dell’autoalienazione divina”.
H. JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il Melangolo,
Genova 1989, pp. 33-37, trad. it C. ANGELIN
21
si rifà alla dottrina
Una risposta a Giobbe. Jonas
ebraica dello
Giobbe è un patriarca biblico, che rappresenta l'immagine
dell’uomo giusto la cui fede è messa alla prova da parte
di Dio attraverso una serie di sventure e sofferenze. Dio
gli appare spiegando che l’onnipotenza divina non può
essere sottoposta alla logica umana e lo ricompenserà con
nuovi e maggiori averi. La risposta di Jonas al problema del
male è rovesciata: egli si richiama all’impotenza divina,
dovuta a una decisione volontaria del Creatore di
contrarsi per fare spazio al mondo e all’uomo.
“Rinunciando alla propria invulnerabilità il principio eterno ha
permesso al mondo di essere. A questa autonegazione ogni
creatura deve la propria esistenza e ha ricevuto ciò che vi è da
ricevere dall’Aldilà. Dopo essersi dato completamente nel
mondo in divenire, Dio non ha più niente da dare: ora sta
all’uomo dargli qualcosa.
Anche ogni risposta alla domanda di Giobbe non può che
essere tale. La mia è contrapposta a quella del libro di Giobbe:
quella invoca la pienezza della potenza del Dio creatore; la mia
la sua rinuncia alla potenza. E tuttavia, strano a dirsi, sono
entrambe a sua lode: è grazie alla rinuncia che noi siamo potuti
essere. Anche questa, mi pare, è una risposta a Giobbe: che
anche Dio soffre. Se questa sia vera non lo possiamo sapere da
alcuna risposta”.
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
tzimtzum (rielaborata
soprattutto nel ‘500 dal
cabalista Luria), che vede un
perpetuo atto di contrazione
di Dio e contemporaneamente
di emanazione della sua luce
sull'universo. Dio si sarebbe
ritirato, producendo uno
spazio in cui la creazione
potesse cominciare; dopo aver
creato dei vasi nello spazio
vuoto, avrebbe iniziato a
riversare la Sua luce nei vasi,
ma questi ultimi non avrebbero
sostenuto la potenza della luce
divina, frantumandosi. Il popolo
ebraico deve quindi raccogliere
insieme le scintille di Luce
Divina che sono state portate
giù con i frantumi dei vasi
spezzati.
22
Lévinas, Alcune riflessioni sulla
filosofia dell’hitlerismo.
Nel saggio sull’hitlerismo, uscito nel 1934 sulla rivista “Esprit”, Lévinas si misura con il fenomeno
nazista “pressappoco all’indomani dell’arrivo di Hitler al potere”. Egli si sofferma con lucidità sul
“risveglio di sentimenti elementari” che lo caratterizza, come senso di una comunità di suolo e
di sangue, che radica l’uomo in un corpo e in una terra. “Perché i sentimenti elementari
racchiudono una filosofia; esprimono la prima attitudine di un animo di fronte all’insieme del
reale e al suo destino. Predeterminano o prefigurano il senso della sua avventura nel mondo.”
Levinas (1905-1994) insiste sulla contiguità di tale filosofia con le postazioni più avanzate del
pensiero contemporaneo, da cui proprio in quegli anni – in virtù di una visione radicalmente
nuova della natura umana – giungeva uno scacco irrevocabile all’universalismo cristiano e al
liberalismo idealista, cioè alle due strategie elaborate dall’uomo europeo per sentirsi libero
rispetto alla sua contingenza storica e corporea. È possibile che le acquisizioni filosofiche
dell’epoca, per un verso così feconde da alimentare il cammino del pensiero fino a oggi, covino
in seno costitutivamente il seme di fenomeni così aberranti e catastrofici? E in che senso oggi
dovremmo sentircene ormai al riparo?
Il suo scritto “procede dalla convinzione che l’origine della sanguinosa barbarie del
nazionalsocialismo non sia in una qualche anomalia della ragione umana, né in un qualche
malinteso ideologico accidentale”, ma che “tale origine attenga ad una possibilità essenziale
del Male elementale cui ogni buona logica può condurre e nei cui confronti la filosofia
occidentale non si era abbastanza assicurata.
23
Appendice.
• Arendt.
Jonas.
•Lévinas
•
ARENDT
25
Hannah Arendt
Hannah Arendt (1906-1975), nata da famiglia ebrea a Hannover, dopo gli studi
universitari (tra i suoi maestri ricordiamo Heidegger, con il quale ebbe anche una
relazione sentimentale, Husserl e Jaspers) abbandona la Germania per motivi
politici;, rifugiandosi in Francia (1933) e stabilendosi negli Stati Uniti (1941). Muore
mentre si accinge a scrivere la terza e ultima parte della Vita della mente, il suo
ultimo capolavoro pubblicato postumo nel 1978.
Opere. L'opera che la renderà famosa in tutto il mondo è il monumentale saggio
del 1951 (di circa 700 pagine), intitolato Le origini del totalitarismo. Nel 1958
seguirà La condizione umana, titolo voluto dall'editore americano, mentre la Arendt
preferiva il titolo di Vita activa, conservato nella traduzione italiana del libro
realizzata nel 1964. Di particolare rilevanza è inoltre il libro del 1963 intitolato La
banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, scritto in occasione del processo
contro il criminale nazista Adolf Eichmann, che aveva mandato a morte centinaia di
migliaia di ebrei. La Arendt, che aveva preso parte al processo tenutosi a
Gerusalemme come inviata speciale del «New Yorker», si convince che le ragioni
profonde dei crimini nazisti risiedono non tanto nella cattiveria o nella mostruosità
di alcuni carnefici, ma nell'assenza di pensiero in uomini del tutto normali
(«banali») nella vita familiare, che, però, se inseriti in una macchina infernale quale
l'organizzazione nazista, diventano capaci delle più disumane atrocità.
26
Le origini del totalitarismo
Le origini del totalitarismo, apparso all'indomani della seconda guerra
mondiale e in piena guerra fredda, è una delle più importanti opere storicopolitiche del Novecento. Essa si propone di analizzare le cause e il
funzionamento dei regimi totalitari, considerati come una conseguenza
tragica della società di massa, in cui gli uomini sono resi atomi, sradicati
da ogni relazione interumana e privati dello stesso spazio pubblico in cui
hanno senso l'azione e il discorso. Il manoscritto, già ultimato nell'autunno
del 1949, uscì in prima edizione nel 1951.
Il suo contributo è particolarmente rilevante sotto due aspetti: a) quello
storico-politico, in quanto analizza i tratti di fondo della storia europea
moderna e contemporanea e, in particolare, il periodo che va dagli ultimi
venti anni dell'Ottocento fino alla seconda guerra mondiale; b) quello
filosofico-politico, in quanto elabora uno schema generale del
regime totalitario, con esclusivo riferimento al nazismo e allo
stalinismo, visti come due fenomeni riconducibili alla medesima idea di
totalitarismo, essendo del tutto marginale l'interesse per altre forme di
dittatura come, ad esempio, il fascismo.
27
Le parti del libro
Il libro si divide in tre parti.
La prima è dedicata allo studio del fenomeno dell'antisemitismo,
ritenuto come una delle premesse del totalitarismo, con un'attenzione
particolare alla condizione ebraica nella storia moderna e un'approfondita analisi
dell'affare Dreyfus.*
La seconda affronta il tema dell'imperialismo, nel periodo che va dalla fine
dell'Ottocento allo scoppio della prima guerra mondiale, con il nuovo
protagonismo della borghesia che ora, per la prima volta, aspira al «dominio
politico» oltre che a quello economico. Le conseguenze dell'antisemitismo,
coniugate con la crisi dell'imperialismo sucessiva alla prima guerra mondiale, sono,
secondo Hannah Arendt, le cause da cui è scaturito il totalitarismo nella
Germania nazista e nell'Unione Sovietica stalinista, cui deve aggiungersi il
fenomeno inedito dell'avvento della società di massa e «senza classi», in cui
gli individui sono alla mercé di ristretti gruppi di potere (le élites).
La terza parte del libro analizza i caratteri del totalitarismo nella società di massa,
secondo il binomio ideologia-terrore.
*Scandalo politico che scosse fortemente la Francia di fine '800. Prese il nome da Alfred Dreyfus, ufficiale ebreo in servizio presso lo stato
maggiore, che venne arrestato per spionaggio in seguito al rinvenimento di una lettera anonima diretta all'addetto militare tedesco a Parigi,
nella quale si preannunciava l'invio di dati tecnici sull'artiglieria francese. Fu condannato per alto tradimento alla degradazione e alla
deportazione a vita nell'isola del Diavolo, ma, dati i dubbi sulla sua colpevolezza, il caso fu riaperto e Dreyfus si vide commutare la pena a 10
anni di detenzione, ottenendo poi la grazia e venendo definitivamente assolto e reintegrato nell'esercito nel 1906.
28
La novità del totalitarismo
L’essenza del totalitarismo consiste nel binomio «terrore e ideologia». Il terrore è
esercitato sia attraverso la polizia segreta che, con il suo continuo spionaggio,
pervade la società, sia attraverso i campi di concentramento, che hanno la
funzione di annientare gli oppositori politici trasformati in «nemici»: «L'inferno nel
senso più letterale della era costituito da quei tipi di campi perfezionati dai nazisti, in
cui l'intera vita era sistematicamente organizzata per infliggere il massimo tormento
possibile. […] Le masse umane segregate in essi sono trattate come se
non esistessero più, come se la sorte loro toccata non interessasse più nessuno..,
in un mondo privo di quella struttura di conseguenze e responsabilità senza
la quale la realtà rimane per noi una massa di dati incomprensibili».
Il totalitarismo è una vera novità del Novecento, diversa dalle forme di
dispotismo antico in quanto pervade la società in maniera totalizzante, uccide
l'uomo nello spirito, rendendolo un essere superfluo e senza nome, attraverso
l'ideologia. Il totalitarismo è un fenomeno «essenzialmente diverso da altre forme
conosciute di oppressione politica come il dispotismo, la tirannide, la dittatura.
Dovunque è giunto al potere, esso ha creato istituzioni assolutamente nuove e
distrutto tutte le tradizioni sociali, giuridiche e politiche del paese. A prescindere
dalla specifica matrice nazionale e dalla particolare fonte ideologica, ha
trasformato le classi in masse, sostituito il sistema dei partiti non con la
dittatura del partito unico, ma con un movimento di massa, trasferito il
centro del potere dall'esercito alla polizia e perseguito una politica
estera apertamente diretta al dominio del mondo».
29
La distruzione della vita privata.
Dal punto di vista organizzativo, l'ideologia e il terrore si esplicano
attraverso gli strumenti del partito unico e della polizia segreta, che
sono controllati completamente dal capo supremo, a cui rendono
personalmente conto. La volontà del capo è l'unica legge del partito, che
tutti i burocrati devono rispettare e far rispettare. Il potere viene a
distribuirsi in maniera gerarchica, secondo il grado di maggiore (o minore)
prossimità al capo: quanto più si è vicini al leader, tanto più si ha potere.
La condizione degli individui è quella dell'isolamento totale nella sfera
politica e dell'estraniazione in quella dei rapporti sociali. Il regime totalitario,
alla pari di ogni altra forma di tirannide, deve la sua esistenza alla
distruzione della vita politica democratica, ottenuta diffondendo paura e
sospetto tra gli individui (non più cittadini) isolati. Ma esso, aggiunge H.
Arendt, distrugge anche la vita privata delle persone,
estraniandole dal mondo, tagliando ogni radice sociale e
rendendole tra loro nemiche: e ciò rappresenta una più atroce novità del
moderno totalitarismo rispetto al vecchio dispotismo.
30
Il conformismo.
Il tratto che distigue l'indagine arendtiana sul totalitarismo — ad esempio,
rispetto al modello di Friedrich e Brzezinski — risiede nell'enfasi posta
sulla condizione di isolamento degli uomini nella società di massa,
ove il conformismo sociale è una minaccia costante alla libertà
politica. Da questo punto di vista, il totalitarismo può essere concepito
come «una potenzialità» e «un costante pericolo», anche dopo la
scomparsa delle sue forme storiche del Novecento, il nazismo e lo
stalinismo: esso «ci resterà probabilmente alle costole per l'avvenire». «Le
preoccupazioni della Arendt — scrive Alberto Martinelli, nella Introduzione
all'edizione italiana di Le origini del totalitarismo — sono senza dubbio
dettate dal trauma profondo suscitato dalle tragedie degli anni Trenta e
della seconda guerra mondiale, ancora così vicine al momento della stesura
del libro, e possono apparire eccessive se riferite alle società occidentali in
generale e in particolare ai sistemi di più antica democrazia di tipo
anglosassone, che hanno sviluppato più efficaci anticorpi contro le
trasformazioni in senso totalitario.”
31
Il totalitarismo controlla in modo totale la società e la vita del
singolo.
32
Vita activa.
Vita activa: la condizione umana, pubblicato nel 1958 negli
Stati Uniti, si fonda sulla tesi che, a partire dalla fine della
polis greco-romana, l'agire, inteso come civiltà
dell'azione e del discorso, è stato sostituito
prima dal «fare» e poi dal «lavorare», teso
unicamente ad assicurare la pura sopravvivenza.
Il libro si occupa, quindi, non della dimensione
contemplativa ma della vita attiva dell’uomo.
33
La condizione umana
Arendt, diversamente dai filosofi classici, parla di «condizione» e
non di «natura» umana. Riguardo alla «natura» degli uomini, osserva
Arendt, possiamo dire solo che essi sono esseri condizionati
(donde «condizione umana»). Le condizioni dell'esistenza umana
sono rappresentate da «vita, natalità e mortalità, mondanità,
pluralità e terra».
L'uomo però non si riduce alle sue sole condizioni, che non lo
determinano in modo assoluto: «Oggi possiamo quasi dire di aver
dimostrato anche scientificamente che, sebbene noi ora viviamo, e
probabilmente vivremo sempre, soggetti alle condizioni della terra,
non siamo meramente creature legate-alla-terra».
34
Tre forme di vita activa
La «vita activa, cioè l'agire umano, si articola in tre
forme fondamentali:
l'attività lavorativa (o animal laborans);
l'operare (o homo faber);
c) l'agire (o zoon politikón).
35
L’attività lavorativa (labor).
L'attività lavorativa «corrisponde allo sviluppo biologico del corpo
umano, il cui accrescimento spontaneo, metabolismo e decadimento finale
sono legati alle necessità prodotte e alimentate nel processo vitale dalla
stessa attività lavorativa. La condizione umana di quest'ultima è la vita
stessa».
Nell’Antichità gli schiavi esercitavano tale attività, che è l'energia che si
sprigiona e «si consuma» per provvedere alle esigenze fondamentali
della vita (cibo, riproduzione) senza produrre oggetti durevoli. «Il fardello
della vita biologica che opprime e consuma lo spazio vitale specificamente
umano tra la nascita e la morte, può essere eliminato dall'uso dei servi, e la
funzione principale degli schiavi antichi era portare il fardello del
consumo nella comunità domestica più che produrre per la società in
senso lato».
36
L’operare (work) e l’agire.
L'operare è, invece, «l'attività che corrisponde alla dimensione nonnaturale dell'esistenza umana, che non è assorbita nel ciclo vitale sempre
ricorrente della specie e che, se si dissolve, non è compensata da esso. Il
frutto dell'operare è un mondo "artificiale" di cose, nettamente
distinto dall'ambiente naturale». L'operare è proprio dell'homo faber,
attivo a partire dall'età moderna: è l'uomo tecnologico che tende a
produrre oggetti duraturi (opere), tanto da trasformare lo stesso aspetto
della Terra. «L'opera delle nostre mani distinta dal lavoro del nostro corpo
— l'homo faber che fa e letteralmente "opera", distinto dall'animal laborans
che lavora e "si mescola con" —fabbrica l'infinita varietà delle cose la cui
somma totale costituisce il mondo artificiale dell'uomo».
L'azione è propria dell’uomo come animale politico (zoon politikón):
«L'azione, la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la
mediazione di cose materiali, corrisponde alla condizione umana della
pluralità, al fatto che gli uomini, e non l'Uomo, vivono sulla terra e abitano
il mondo”.
37
La polis.
Il sorgere della città-stato significò per l'uomo ricevere accanto alla sua vita privata una sorta di
seconda vita, quella politica, in diretto contrasto con l'associazione naturale della famiglia, che aveva il
suo centro nella casa (oikìa). Tra tutte le attività praticate nelle comunità umane, Aristotele riteneva che
solo l'azione (praxis) e il discorso (lexis) appartenessero veramente all'agire politico.
Essere politici, cioè vivere nella polis, per i Greci significava abbandonare la violenza e riporre ogni
fiducia nella forza persuasiva del discorso. Al contrario, la sfera della costrizione e della necessità
era considerata pre-politica, tipica della famiglia, in cui il capofamiglia esercitava un potere dispotico
sugli schiavi, sui figli e sulla moglie (anche se a livelli diversi), o degli imperi barbarici dell'Asia. Al
contrario, la polis era la sfera della libertà.
«Ciò che tutti i filosofi greci, anche se contrari alla polis, tenevano per certo è che la libertà risiede
esclusivamente nella sfera politica, mentre la necessità è soprattutto un fenomeno
prepolitico, caratteristico dell'organizzazione domestica privata, e che la forza e la violenza
sono giustificate in questa sfera perché sono i soli mezzi per aver ragione della necessità — per
esempio, mediante il dominio sugli schiavi — e diventare liberi. Poiché tutti gli esseri umani sono
soggetti alla necessità, essi sono disposti alla violenza verso gli altri; e questa non è altro che l'atto prepolitico di liberarsi dalla necessità della vita in nome della libertà del mondo. Questa libertà è la
condizione essenziale di quella che i Greci chiamavano felicità, eudaimonìa, che era una condizione
oggettiva legata prima di tutto alla ricchezza e alla salute. Essere poveri o essere ammalati significava
essere soggetti alla necessità fisica, ed essere schiavi significava essere soggetti, in aggiunta, alla violenza
umana. Questa duplice e raddoppiata "infelicità" della schiavitù era del tutto indipendente dal reale
benessere soggettivo dello schiavo».
38
JONAS
39
Hans Jonas
Tra i filosofi contemporanei che hanno tentato di
elaborare una nuova etica globale della civiltà
tecnologica il filosofo tedesco Hans Jonas (19031993).
Formatosi alla scuola di Husserl e Heidegger, ha
avuto come compagna di studio Hannah Arendt.
Ebreo di nascita, dopo l'avvento del nazismo è
emigrato prima in Inghilterra e poi in Palestina.
Dopo aver combattuto come volontario
nell'esercito inglese, nel dopoguerra è stato
docente in varie Università canadesi e statunitensi.
Opere: Il principio responsabilità. Ricerca di un'etica
per la civiltà tecnologica (1979) e la conferenza Il
concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica
(1984).
40
Il principio responsabilità.
Di fronte al “Prometeo scatenato” dell’odierna civiltà tecnologica non possiamo più
richiamarci alle consuete etiche della coscienza o dell'intenzione, ignorando le
conseguenze dei nostri atti. Non basta più essere a posto con la propria coscienza o
accontentarsi di regole formali di tipo evangelico o kantiano; occorre saper
prevedere gli influssi che le nostre azioni potranno avere sulle sorti future
dell'umanità e del pianeta, ad esempio ponendoci la domanda: «Se continuiamo a
consumare energia e a inquinare il pianeta con gli attuali ritmi, che destino
riserveremo ai nostri figli e nipoti?».
Al vecchio imperativo categorico kantiano, Jonas contrappone quindi il
nuovo imperativo dell'età tecnologica: «Agisci in modo che le
conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di
un'autentica vita umana sulla terra». Oppure, tradotto in negativo, «Agisci in
modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di
tale vita». Oppure, semplicemente: «Non mettere in pericolo le condizioni della
sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla terra». O ancora, tradotto nuovamente in
positivo: «Includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto
della tua volontà»
41
L’imperativo ecologico di Jonas.
42
L’archetipo genitoriale.
La manifestazione concreta dell'imperativo categorico — e quindi
della disponibilità a favorire, mediante l'azione, il sì alla vita — è il
senso di responsabilità. Responsabilità che trova il suo archetipo
originario nelle cure dei genitori verso i figli. Infatti, è proprio il
neonato, nella sua nuda e indifesa esistenza, che funge da
attestazione evidente e da inconfutabile «paradigma montico» della
coincidenza ontologica fra essere e dover essere, fra la vita e
l'appello a far sì che la vita continui: «Mostrateci un unico caso [...]
in cui abbia luogo tale coincidenza», «si potrà indicare la cosa più
familiare a tutti: il neonato, il cui solo respiro rivolge
inconfutabilmente un "devi" all'ambiente circostante affinché si
prenda cura di lui. Guarda e saprai!» . La responsabilità parentale
trova la sua generalizzazione nelle cure dell'uomo di Stato verso la
cosa pubblica.
43
L’euristica della paura
“Al principio speranza contrapponiamo il principio responsabilità e non il
principio paura. Ma la paura fa parte della responsabilità altrettanto
quanto la speranza, e noi dobbiamo [...] perorarne ancora la causa, poiché
la paura è oggi più necessaria che in qualsiasi altra epoca in cui, animati
dalla fiducia nel buon andamento delle cose umane, si poteva considerarla
con sufficienza una debolezza dei pusillanimi e dei nevrotici»; .«Quando
parliamo della paura che per natura fa parte della responsabilità, non
intendiamo la paura che dissuade dall'azione, ma quella che esorta a
compierla; intendiamo la paura per l'oggetto della responsabilità”.
Questa valorizzazione della paura porta Jonas a parlare di una «euristica
della paura», cioè di una ricerca stimolata da tale stato d'animo, a cui il
filosofo affida la scoperta dei nuovi (e ancora sconosciuti) principi etici che
devono ispirare i nuovi doveri concreti dell'individuo tecnologico, al fine di
tutelare l'uomo e il mondo da scelte irresponsabili.
44
Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
Jonas ritiene che di fronte al male nel mondo — esemplificato da
Auschwitz — non si possa più sostenere la simultanea bontà,
comprensibilità e onnipotenza di Dio. Infatti, se posta in rapporto
con il male, una divinità onnipotente «o è priva di bontà o è
totalmente incomprensibile». Ma un Dio privo di bontà cessa di
essere Dio, mentre un Dio totalmente incomprensibile è qualcosa
di cui non possiamo neppure discorrere.
Non resta quindi che abbandonare il problematico concetto di
onnipotenza (per quanto «scandalosa» possa apparire questa scelta
e ammettere che Egli non è intervenuto ad impedire Auschwitz
«non perché non lo volle, ma perché non fu in condizione di farlo».
Infatti, concedendo all'uomo la libertà, Dio ha rinunciato alla sua
potenza.
45
Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
“L’onnipotenza divina può coesistere con la bontà assoluta di Dio solo al prezzo di una
totale non comprensibilità di Dio, cioè dell’accezione di Dio come mistero assoluto. [...]
Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con estrema decisione che una
Divinità onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile (nel governo del
mondo in cui noi unicamente siamo in condizione di comprenderla). [...] Di fronte alle
cose veramente inaudite che, nel creato, alcune creature fatte a sua somiglianza, hanno
fatto ad altre creature innocenti, ci si dovrebbe aspettare che il Dio, somma bontà, [...]
intervenga con un miracolo di salvezza. Ma questo miracolo non c’è stato; durante gli
anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz Dio restò muto. [...] Dio tacque. Ed ora
aggiungo: non intervenne, non perché non lo volle, ma perché non fu in condizione di
farlo. Per ragioni che in modo decisivo derivano dall’esperienza contemporanea,
propongo quindi l’idea di un Dio che per un’epoca determinata – l’epoca del processo
cosmico – ha abdicato ad ogni potere di intervento nel corso fisico del mondo. [...] La
creazione fu l’atto di assoluta sovranità, con cui la Divinità ha consentito a non essere
più, per lungo tempo, assoluta – una opzione radicale a tutto vantaggio dell’esistenza di
un essere finito capace di autodeterminare se stesso – un atto infine
dell’autoalienazione divina”.
H. JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il Melangolo,
Genova 1989, pp. 33-37, trad. it C. ANGELIN
46
si rifà alla dottrina
Una risposta a Giobbe. Jonas
ebraica dello
Giobbe è un patriarca biblico, che rappresenta l'immagine
dell’uomo giusto la cui fede è messa alla prova da parte
di Dio attraverso una serie di sventure e sofferenze. Dio
gli appare spiegando che l’onnipotenza divina non può
essere sottoposta alla logica umana e lo ricompenserà con
nuovi e maggiori averi. La risposta di Jonas al problema del
male è rovesciata: egli si richiama all’impotenza divina,
dovuta a una decisione volontaria del Creatore di
contrarsi per fare spazio al mondo e all’uomo.
“Rinunciando alla propria invulnerabilità il principio eterno ha
permesso al mondo di essere. A questa autonegazione ogni
creatura deve la propria esistenza e ha ricevuto ciò che vi è da
ricevere dall’Aldilà. Dopo essersi dato completamente nel
mondo in divenire, Dio non ha più niente da dare: ora sta
all’uomo dargli qualcosa.
Anche ogni risposta alla domanda di Giobbe non può che
essere tale. La mia è contrapposta a quella del libro di Giobbe:
quella invoca la pienezza della potenza del Dio creatore; la mia
la sua rinuncia alla potenza. E tuttavia, strano a dirsi, sono
entrambe a sua lode: è grazie alla rinuncia che noi siamo potuti
essere. Anche questa, mi pare, è una risposta a Giobbe: che
anche Dio soffre. Se questa sia vera non lo possiamo sapere da
alcuna risposta”.
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
tzimtzum (rielaborata
soprattutto nel ‘500 dal
cabalista Luria), che vede un
perpetuo atto di contrazione
di Dio e contemporaneamente
di emanazione della sua luce
sull'universo. Dio si sarebbe
ritirato, producendo uno
spazio in cui la creazione
potesse cominciare; dopo aver
creato dei vasi nello spazio
vuoto, avrebbe iniziato a
riversare la Sua luce nei vasi,
ma questi ultimi non avrebbero
sostenuto la potenza della luce
divina, frantumandosi. Il popolo
ebraico deve quindi raccogliere
insieme le scintille di Luce
Divina che sono state portate
giù con i frantumi dei vasi
spezzati.
47
LÉVINAS
48
Emmanuel Lévinas
Il filosofo ebreo lituano Emmanuel Lévinas (1905-1995) studia a
Strasburgo e a Friburgo, dove ha modo di ascoltare le lezioni di
Husserl e di Heidegger, che farà conoscere in Francia. Chiamato alle
armi nel 1939, viene fatto prigioniero e internato in un campo di
concentramento. Nel dopoguerra insegna in alcune università
francesi e alla Sorbona.
Opere: Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo (1934), Totalità e
infinito (1961) e Altrimenti che essere o al di là dell'essenza (1974).
Il pensiero di Lévinas risulta caratterizzato da una programmatica
apertura nei confronti dei problemi dell'alterità e del prossimo;
il suo pensiero ha un’impronta etica. La tragedia dei campi di
concentramento nazisti, secondo lui, trova le sue radici in quel
rifiuto dell'«Altro» che è proprio di gran parte della cultura
dell'Occidente.
49
L’imperialismo del Medesimo.
Lévinas accusa la filosofia occidentale di «imperialismo del
Medesimo» e di «violenza ontologica», ossia di aver racchiuso il
molteplice e il diverso nell'ambito di una totalità che ha soffocato
ogni forma di alterità e trascendenza: «la filosofia occidentale è
stata per lo più un'ontologia, una riduzione dell'Altro al
Medesimo» (Totalità e infinito).
Si tratta di uscire di contestare alle radici la «filosofia della
potenza» e «l'ontologia della guerra», a livello non teorico o
conoscitivo, bensì etico e pratico, ossia tramite l'incontro con
l'Altro, incarnato dal prossimo.
50
L’etica del volto.
Il modo in cui si presenta l'Altro è il volto. In quanto si
impone di per sé, indipendentemente dal contesto fisico e
sociale, il volto appare come l'assolutamente trascendente.
Ma la trascendenza, per il fatto stesso di essere tale,
cioè per il suo porsi al di là di ogni totalità
immanente, richiama l'infinito, o meglio, è la modalità
con cui l'infinito si manifesta all'uomo: «l'infinito è il carattere
proprio di un essere trascendente in quanto trascendente,
l'infinito è l'assolutamente altro». Pertanto, se la totalità
corrisponde all'essere immanente e inglobante della
tradizione ontologica, l'infinito coincide con quella realtà
trascendente che è l'Altro (da ciò il titolo del capolavoro di
Lévinas).
Il volto ha un'esplicita valenza etica, poiché manifestandosi
biblicamente, nel povero e nello straniero, nella vedova e
nell'orfano, porta scritto, in se medesimo, il comandamento
«non uccidere». Per queste sue caratteristiche, il volto mi
coinvolge e mi mette in discussione, rendendomi
responsabile nei suoi riguardi: «Il volto mi chiede e mi
ordina». «Fare qualcosa per un altro. Donare. Essere spirito
umano significa questo».
51
Altrimenti che essere.
L'importanza attribuita alla relazione etica con l'Altro, che supera la dimensione
del puro essere, cioè dell'egoismo, per procedere al di là dell'essere, cioè verso
l'altruismo (come suggerisce il titolo della seconda opera basilare del filosofo:
Altrimenti che essere o al di là dell'essenza), spiega l'innovativa tesi di Lévinas,
secondo cui «la morale non è un ramo della filosofia, ma la filosofia prima»,
cioè la metafisica stessa. Da ciò l'identità metafisica = etica. Identità che si inscrive a
sua volta nella più ampia equazione metafisica = etica = religione. Infatti,
secondo Lévinas, l'etica implica non solo un riferimento al prossimo, ma
anche a quell'Altro per antonomasia che è Dio, cui rinvia il volto altrui.
Dato che Dio, biblicamente parlando, è l'invisibile per eccellenza (nell'Esodo Dio
dice a Mosè: «Tu non potrai vedere il mio volto, poiché nessuno può vedermi e
restare vivo»), l'unico modo per incontrarlo è il prossimo: «Non può esserci
alcuna "conoscenza" di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini. La fede
monoteistica in un Dio trascendente implica, secondo Lévinas, l'esperienza del
«disincantamento del mondo», ovvero quella separazione fra uomo e Dio che, sola,
risulta capace di salvaguardare l'infinita distanza del Creatore e la libertà della
creatura. Da ciò la valorizzazione dell'ateismo, inteso come momento di passaggio
per una fede autentica (che per Lévinas non può mai ridursi alle fedi confessionali).
52
Glossario
Ontologia. Termine usato da Lévinas per designare la metafisica
tradizionale, che ha tentato di racchiudere il molteplice e il diverso
nell'ambito di una totalità soffocatrice di ogni forma di alterità e
trascendenza.
Totalità. L'essere immanente e inglobante della tradizione ontologica. Si
oppone all’infinito.
Infinito. È la realtà trascendente dell'Altro. «L'infinito è il carattere proprio
di un essere trascendente in quanto trascendente, l'infinito è l'assolutamente
altro».
Altro. Allude sia alla trascendente alterità dell'altro uomo («l'Altro in
quanto altro è Altri») sia a Dio o all'Assoluto (cui rimanda il prossimo) sia
all'alterità in generale. In ogni caso, l'Altro non è un «dato» che viene
afferrato, ma una realtà trascendente che si impone con la sua irriducibile
alterità. Il concetto di Altro risulta strettamente connesso a quello di volto.
Volto. Espressione usata da Lévinas per indicare «il modo in cui si presenta
l'Altro». Il volto, che vive biblicamente «nel povero, nello straniero, nella
vedova e nell'orfano», possiede un'esplicita valenza etica. Ponendosi al di là
di ogni totalità immanente, il volto richiama l'infinito, o meglio rappresenta la
maniera con cui l'infinità dell'infinito ci viene incontro e si rivela come tale.
53
Manuali e siti consultati.
Abbagnano, Fornero, Nuovo Protagonisti e
testi della filosofia, Paravia.
www.vitellaro.it
http://www.robertocrosio.net/MODULI/perc_mappa.htm
54