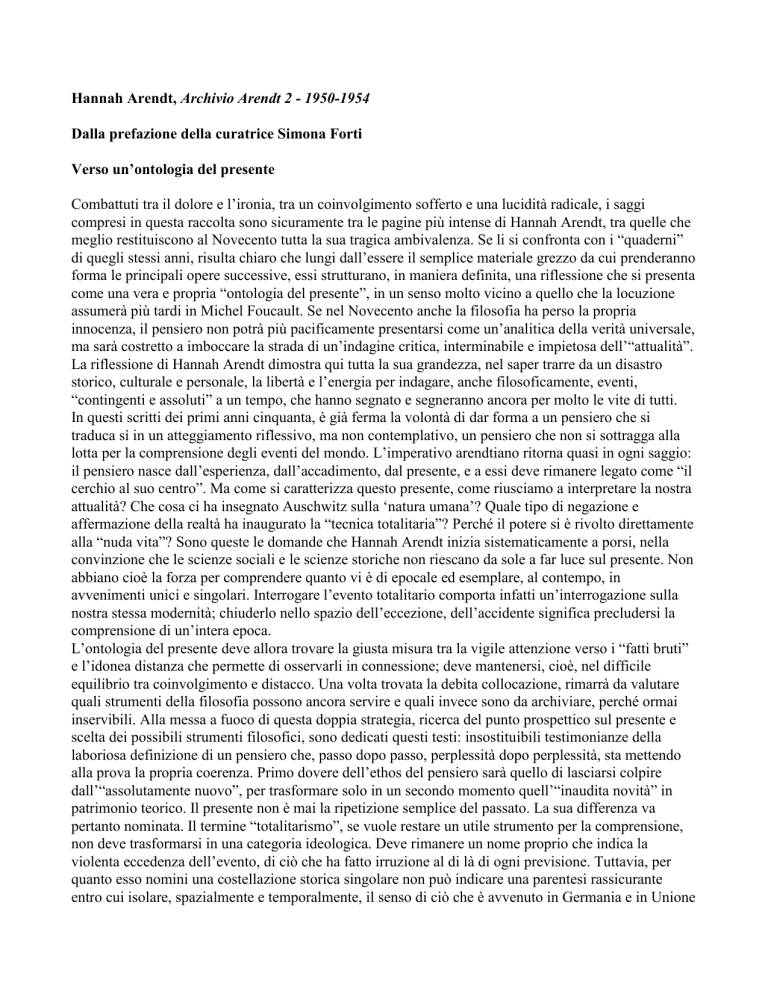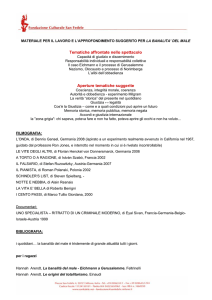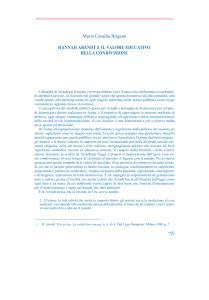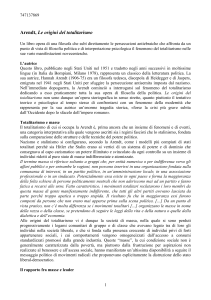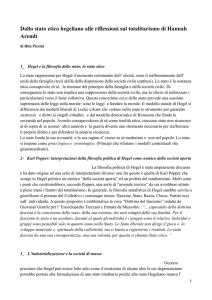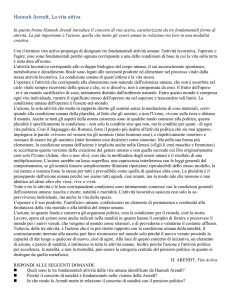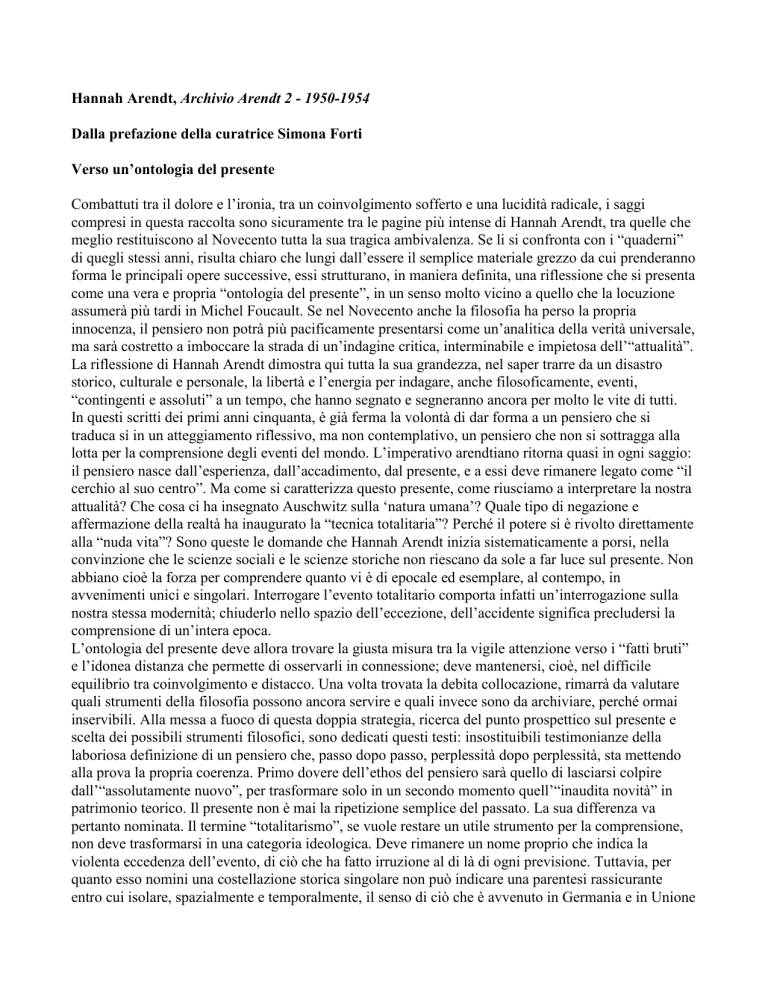
Hannah Arendt, Archivio Arendt 2 - 1950-1954
Dalla prefazione della curatrice Simona Forti
Verso un’ontologia del presente
Combattuti tra il dolore e l’ironia, tra un coinvolgimento sofferto e una lucidità radicale, i saggi
compresi in questa raccolta sono sicuramente tra le pagine più intense di Hannah Arendt, tra quelle che
meglio restituiscono al Novecento tutta la sua tragica ambivalenza. Se li si confronta con i “quaderni”
di quegli stessi anni, risulta chiaro che lungi dall’essere il semplice materiale grezzo da cui prenderanno
forma le principali opere successive, essi strutturano, in maniera definita, una riflessione che si presenta
come una vera e propria “ontologia del presente”, in un senso molto vicino a quello che la locuzione
assumerà più tardi in Michel Foucault. Se nel Novecento anche la filosofia ha perso la propria
innocenza, il pensiero non potrà più pacificamente presentarsi come un’analitica della verità universale,
ma sarà costretto a imboccare la strada di un’indagine critica, interminabile e impietosa dell’“attualità”.
La riflessione di Hannah Arendt dimostra qui tutta la sua grandezza, nel saper trarre da un disastro
storico, culturale e personale, la libertà e l’energia per indagare, anche filosoficamente, eventi,
“contingenti e assoluti” a un tempo, che hanno segnato e segneranno ancora per molto le vite di tutti.
In questi scritti dei primi anni cinquanta, è già ferma la volontà di dar forma a un pensiero che si
traduca sì in un atteggiamento riflessivo, ma non contemplativo, un pensiero che non si sottragga alla
lotta per la comprensione degli eventi del mondo. L’imperativo arendtiano ritorna quasi in ogni saggio:
il pensiero nasce dall’esperienza, dall’accadimento, dal presente, e a essi deve rimanere legato come “il
cerchio al suo centro”. Ma come si caratterizza questo presente, come riusciamo a interpretare la nostra
attualità? Che cosa ci ha insegnato Auschwitz sulla ‘natura umana’? Quale tipo di negazione e
affermazione della realtà ha inaugurato la “tecnica totalitaria”? Perché il potere si è rivolto direttamente
alla “nuda vita”? Sono queste le domande che Hannah Arendt inizia sistematicamente a porsi, nella
convinzione che le scienze sociali e le scienze storiche non riescano da sole a far luce sul presente. Non
abbiano cioè la forza per comprendere quanto vi è di epocale ed esemplare, al contempo, in
avvenimenti unici e singolari. Interrogare l’evento totalitario comporta infatti un’interrogazione sulla
nostra stessa modernità; chiuderlo nello spazio dell’eccezione, dell’accidente significa precludersi la
comprensione di un’intera epoca.
L’ontologia del presente deve allora trovare la giusta misura tra la vigile attenzione verso i “fatti bruti”
e l’idonea distanza che permette di osservarli in connessione; deve mantenersi, cioè, nel difficile
equilibrio tra coinvolgimento e distacco. Una volta trovata la debita collocazione, rimarrà da valutare
quali strumenti della filosofia possono ancora servire e quali invece sono da archiviare, perché ormai
inservibili. Alla messa a fuoco di questa doppia strategia, ricerca del punto prospettico sul presente e
scelta dei possibili strumenti filosofici, sono dedicati questi testi: insostituibili testimonianze della
laboriosa definizione di un pensiero che, passo dopo passo, perplessità dopo perplessità, sta mettendo
alla prova la propria coerenza. Primo dovere dell’ethos del pensiero sarà quello di lasciarsi colpire
dall’“assolutamente nuovo”, per trasformare solo in un secondo momento quell’“inaudita novità” in
patrimonio teorico. Il presente non è mai la ripetizione semplice del passato. La sua differenza va
pertanto nominata. Il termine “totalitarismo”, se vuole restare un utile strumento per la comprensione,
non deve trasformarsi in una categoria ideologica. Deve rimanere un nome proprio che indica la
violenta eccedenza dell’evento, di ciò che ha fatto irruzione al di là di ogni previsione. Tuttavia, per
quanto esso nomini una costellazione storica singolare non può indicare una parentesi rassicurante
entro cui isolare, spazialmente e temporalmente, il senso di ciò che è avvenuto in Germania e in Unione
Sovietica. Il totalitarismo deve produrre, oltre allo sconcerto, quello stupore che i greci indicavano
come origine di ogni autentica riflessione. In quanto emerso in un mondo non-totalitario, esso deve
aprire l’indagine sul “nostro secolo”, in particolare sul luogo specifico della modernità in cui siamo
collocati.
È dunque ciò che la Arendt chiama “il potere delle cose reali”, quel potere che la realtà detiene di
oltrepassare ogni nostra aspettativa, a innescare il processo della comprensione: quel “circolo vizioso”
in cui i pensieri ritornano ininterrottamente su loro stessi impegnando la mente umana
nell’interminabile dialogo con le cose del mondo. La superiorità del pensiero riflessivo sulle scienze
sociali e storiche sta appunto nel non congelare la questione del senso in categorie tipologiche, ma nel
lasciarla aperta per rilanciarla di continuo in un nuovo confronto. Solo così il fenomeno analizzato, la
cui novità cogliamo immediatamente grazie a un’intuizione di cui tuttavia non ci fidiamo, evita di venir
‘normalizzato’ in una serie ordinata di cause storiche, sociali ed economiche. Per cogliere la singolarità
degli eventi non possiamo sussumerla sotto gli universali, non possiamo dunque affidarci al giudizio
determinante. Eppure quell’unicità va colta, anche se gli strumenti di cui disponiamo sono perlopiù
inservibili; anche se il linguaggio comune si trasforma spesso nel più pericoloso veicolo del
fraintendimento. Sin da ora è evidente che il giudizio riflettente, lungi dal costituire l’epilogo “kantiano
e contemplativo” a cui la riflessione arendtiana approderebbe, è la cifra di un’ingiunzione duplice e
contraddittoria che attraversa ogni fase della sua opera.
È un difficile equilibrio quello che la Arendt sta cercando tra pensiero e realtà. Perché se è vero che la
comprensione addomestica l’effetto estraniante della novità rendendocela familiare, essa non può
tuttavia “perdonarla”, consegnarla cioè a una conciliazione nel senso hegeliano. Il reale, quel reale che
si è manifestato così violentemente nel totalitarismo, non potrà mai diventare razionale. Ma non è
nemmeno possibile liquidarlo come irrazionale. Nel processo di comprensione non è pertanto
semplicemente in gioco lo statuto della realtà, ma anche la responsabilità stessa del pensiero. E se il
soccorso chiesto ora dalla Arendt all’immaginazione lascerà il posto al più solido ausilio fornito dal
giudizio riflettente, la partita non verrà mai definitivamente conclusa. Anche perché nessuna
epistemologia, nessuna scienza cognitiva, potrà mai risolvere il mistero di un “pensiero comprendente”
che è per lei tutt’uno con l’enigma stesso dell’esistenza: “La comprensione”, infatti, “rappresenta il
modo specificamente umano di rimanere vivi”.