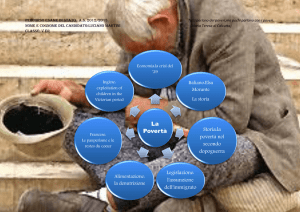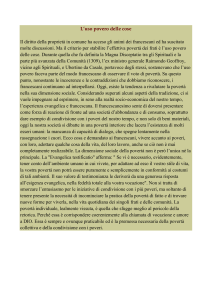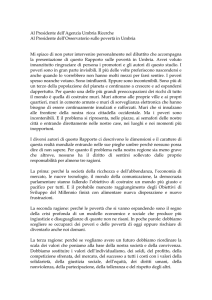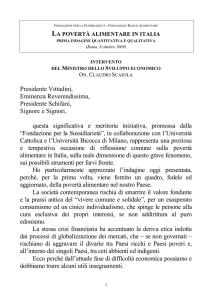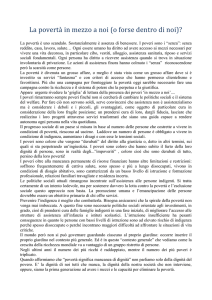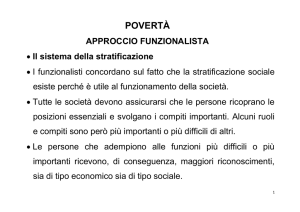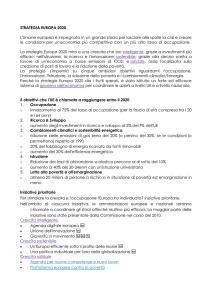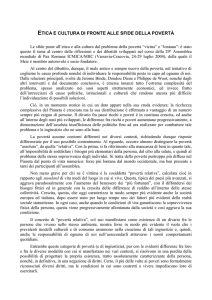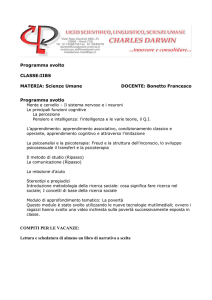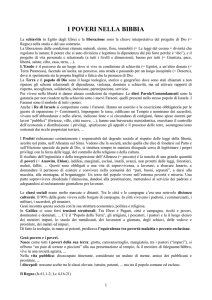S T U D I
IL MITO DEL MERITO
NELLA SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE
Riflessioni provocatorie su meritocrazia, eguaglianza e povertà
Francesca Rigotti
L’enfasi del merito si insinua, in modo a volte tacito e accondiscendente,
altre volte in modo esplicito e rancoroso, nei diversi aspetti della vita sociale
incrinando e spezzando legami di solidarietà per lo più di tipo emotivo e poco
allenati a fare i conti con una lettura complessa degli insuccessi come dei successi
delle persone. Uscire da tale enfasi chiede di mettere in luce le radici nascoste
dei discorsi di ogni giorno e il peso negativo che questi hanno nell’alimentare
l’approccio meritocratico oggi spesso alla base delle politiche sociali.
mmaginate di chiedere a un vostro amico
americano molto ricco come ha fatto a diventarlo. Vi dirà che è stato grazie ai suoi
meriti: perché ha lavorato duro, meglio e più
a lungo di altri, per la sua intelligenza, la sua
preparazione, il suo impegno. Adesso provate a proporgli, per vagliare la coerenza della
sua risposta, di mandare il figlio a una scuola
di quartiere, una normale scuola pubblica più
o meno degradata come ce ne sono tante negli
Stati Uniti. Vi guarderà inorridito. La reazione alla proposta testimonia in maniera eloquente che anche il nostro self-made-man riconosce come elemento di riuscita economica
e sociale l’importanza dell’ambiente e della
formazione, insomma dei fattori sociali che
erano stati in un primo tempo negati in nome
di meriti e capacità innate.
L’ideologia del merito e della «meritocrazia» è diventata nella società post-industriale,
nonostante le sue molte contraddizioni, la nuova
parola d’ordine trionfante, capace di mietere
consensi a destra e a sinistra, persino tra coloro che un tempo si proclamavano per l’eguaglianza e ora si dichiarano per l’«inclusione».
I
Animazione Sociale
Il fascino della premiazione del merito sta nel
fatto che esso si presenta immune dal vizio della
premiazione del privilegio: il merito è naturale, sembra, puro e incontaminato come una sorgente d’acqua fresca. Scaturisce da alcune persone come una mera forza naturale; non è distribuito e controllato artificialmente, né viene
socialmente indotto o estorto. In una società
come la nostra che la natura l’ha quasi del tutto
persa, il mito del merito è una specie di fortunosa scoperta di un’isola di bontà incontaminata, una garanzia di genuinità: il merito è come
un prodotto alimentare biologico, fa parte della
vita nella sua manifestazione primigenia e incorrotta. Questo soprattutto se associato con
l’altra parola o concetto magico, quello delle
«pari opportunità». Secondo questa teoria infatti, una volta concesse a tutti pari opportunità di partenza la gara della vita può cominciare, e chi arriva primo e spoglia l’albero della
cuccagna non lasciando niente agli altri, può
farlo perché è merito suo.
A coloro che ingenuamente credono che
il merito sia tutto e che i fattori sociali non
spieghino o promuovano il successo — anche
2000 Agosto/Settembre 9
S T U D I
se ovviamente non tutti i cultori della meritocrazia sono così ingenui — si possono ricordare, in una lista assai parziale, alcuni elementi che contribuiscono al successo in maniera superiore al presunto merito personale.
Tali elementi sono (1): l’accesso a una buona
educazione e istruzione; l’attrazione fisica (altezza, peso, sesso, colore della pelle e degli
occhi); i legami sociali e il nepotismo, le conoscenze, gli amici; il reddito e la composizione sociale della comunità di origine; le lingue conosciute. Come si vede, alcuni di questi fattori sono anch’essi elementi naturali,
quelli legati all’aspetto fisico (2), mentre altri
(l’educazione e l’istruzione, il nepotismo e l’origine sociale o etnica) sono chiaramente elementi sociali legati all’ambiente. A tutto ciò
va aggiunto inoltre un fattore molto «machiavelliano»: la fortuna, la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, di aver
posato i piedi su un terreno dal quale affiora
il petrolio o più modestamente di trovarsi a
vivere nell’Italia del boom, come successe ai
nostri genitori e nonni.
Meritocraticisti ed egualitaristi
Detto questo, chiamerò «meritocraticisti»
i difensori del sistema di distribuzione sociale
basato sul merito, che vedono con favore le
differenze individuali naturali, e «egualitaristi» i loro avversari, che accolgono per lo meno
con sospetto tali differenze considerandole
moralmente contrarie allo stato, considerato
preferibile, dell’eguaglianza. Gli egualitaristi,
soprattutto se radicali, criticheranno il sistema meritocratico sostenendo che le persone
nulla possono rispetto ai loro talenti e alle loro
doti. Premiare bellezza, prestanza fisica, abilità nel cantare o tirar calci al pallone, persino
intelligenza, non è conforme a criteri di giustizia. Perché si dovrebbe favorire un individuo che in un certo senso è già premiato dalla
sorte perché dispone di maggiori talenti naturali? Qui si potrebbero scomodare come pezze
d’appoggio a favore di questa tesi il principio
marxiano di giustizia comunista, quello che
10 Agosto/Settembre 2000
dice: «Da ciascuno secondo le sue capacità, a
ciascuno secondo i suoi bisogni» o i criteri di
giustizia di John Rawls, secondo i quali le parti
che non conoscono le loro posizioni in termini di vantaggio (o svantaggio) sociale scelgono la distribuzione in cui è migliore la condizione di chi sta peggio. L’idea è, in entrambi i
casi, che non si debba tener conto, nella distribuzione dei benefici sociali, della superiore disponibilità di talenti naturali.
A questa interpretazione egualitarista i meritocraticisti possono rispondere distinguendo in primo luogo tra capacità e merito.
Capacità corrisponderebbe al set di dotazioni
naturali per le quali non si può fare nulla; come
ammetteva sconsolatamente don Abbondio,
che era nato vaso di coccio tra i vasi di ferro:
«Il coraggio, uno non se lo può dare». O ce
l’ha o non ce l’ha. Merito invece andrebbe interpretato propriamente in quanto disponibilità a impegnarsi, a sobbarcarsi impegni gravosi, a lavorare duro, ad andare al lavoro presto restandoci a lungo: in una parola, merito
corrisponderebbe a quantità e qualità di lavoro volontariamente svolto.
A questo punto ridiamo la parola all’egualitarista, che risponderà magari al meritocraticista che la «capacità di lavorare duro»
può essere un talento naturale come un altro,
oppure una competenza che si acquista in certe
famiglie o in certi ambienti e non in altri; che
in una società post-freudiana il concetto di
«voglia di lavorare» appare per lo meno opinabile se lo si svincola dai condizionamenti sociali e dagli impulsi della psiche. E infine che
se tutto è geneticamente predisposto, come ci
dicono, possiamo rinunciare a qualsivoglia categorizzazione morale e abbandonarci al fato,
oppure cercare di valorizzare non si sa come i
nostri geni e quelli dei nostri figli.
La posizione meritocraticista, se ancora
risulta giustificabile per quanto concerne le
(1)
Cfr. per questa lista Jencks Chr. et al., Inequality.
A reassesment of the Effect of the Family and Schooling in
America, Basic Books, New York 1972.
(2)
O pseudonaturali, giacché molti fattori fisici come
corporatura, prestanza fisica, peso, muscolatura sono socialmente modellabili.
Animazione Sociale
S T U D I
fasce sociali investite dal benessere, non lo è
più per quanto riguarda la società del malessere, voglio dire le fasce a reddito basso, misero o a non-reddito (se va bene, a «reddito
minimo di inserimento»). All’interno della
prima fascia pare non ci sia nulla da obiettare se il reddito di un top-manager o di un chirurgo è dalle quaranta alle cento volte superiore a quello dell’impiegato o dell’infermiere che lavorano nella stessa struttura, magari fianco a fianco. Questione di merito, si dirà.
Anzi, la diseguaglianza incoraggia la lotta e
la competizione, è «la molla della vita sociale. L’appiattimento fa parte di un’ipocrita visione ottimistica dei rapporti sociali, che non
sono improntati a criteri di proporzionalità»
(3)
. Anche se diversi studi sembrano aver provato che le compagnie col minimo divario di
retribuzione tra dirigenti e dipendenti sono
quelle che godono del tasso più alto di crescita economica e anche se un divario altissimo si dimostra un disincentivo per i lavoratori meno pagati (e non è nemmeno più un
incentivo per i più pagati, che già lavorano al
massimo delle loro forze fisiche e mentali)
molti non sembrano disposti a far nulla per
ridurre l’ampiezza della forbice.
All’interno della seconda fascia, quella del
malessere, dove dominano povertà, marginalità ed esclusione, le conseguenze di questo
modo di pensare sono a mio avviso ancora più
gravi. Il mito che dice che «la ricchezza è merito» va infatti a braccetto con quello che sostiene che «la povertà è demerito», incapacità,
inettitudine, non-abilità, colpa. «Non hanno
voglia di lavorare» mi dicevano talvolta quando ero bambina e incontravamo dei mendicanti all’uscita della chiesa e io stringevo la
mano dell’adulto che mi accompagnava per
chiedere spiegazione e aiuto.
Povertà come dono di Dio
e povertà come fallimento
Nel corso della storia europea si è assistito a una trasformazione del concetto di povertà: da condizione voluta da Dio, o addiAnimazione Sociale
rittura dono divino, la povertà è passata a essere intesa come fallimento individuale. Nel
Medio Evo, per esempio, dove l’assistenza ai
poveri avveniva soprattutto sotto forma di
elemosina, esistevano addirittura forme di
povertà volontaria (i francescani). Col passaggio all’età moderna l’uomo scoprì che poteva cambiare e modellare la realtà e cominciò a sentirsi maggiormente responsabile per
le proprie azioni. Per l’uomo dell’età moderna non è più la collocazione adeguata nell’ordinamento divino a rappresentare il suo
fine: nasce in seguito a questa trasformazione un’interpretazione secolarizzata della povertà come fallimento individuale e come pericolo sociale. La povertà che fino alla fine
del Medio Evo era stata vista come destino
inevitabile diventa una forma di sorte cercata: sempre più povertà è assimilata a non-lavoro. Nella società liberale nascono forme di
lavoro coatto per i poveri affinché essi possano collaborare alla loro stessa redenzione
e realizzazione.
Le ultime decadi hanno assistito a un deterioramento delle condizioni di vita dei più
svantaggiati in ogni genere di società. Oltre
che nel terzo e nel secondo mondo — i paesi
ex-comunisti dove, fino al 1989, è stato detto,
«molti avevano freddo ma pochi gelavano»
— la proporzione del reddito che va agli svantaggiati è diminuita, mentre è cresciuto ovunque il numero di quelli che si rivolgono all’assistenza sociale (4). Nell’ultimo decennio
del Novecento i poveri sono cresciuti a milioni e il tasso di disoccupazione è rimasto
ostinatamente alto, mentre il povero è diventato soggetto di «moralizzazione» tramite obbligazione all’interno di politiche di inclusione sociale perseguite con misure coercitive per attivare e inserire i caduti, i falliti,
le persone dimostratesi vulnerabili alla trasformazione delle condizioni di vita imposte,
tra l’altro, dalla globalizzazione.
(3)
Parole del filosofo Armando Plebe riportate
nell’Avvenire del 26.5.1999.
(4)
Cfr. Jordan B., A Theory of Poverty & Social
Esclusion, Polity Press, Cambridge 1996.
2000 Agosto/Settembre 11
S T U D I
Merito e povertà
Sono in molti a essere convinti che contro la
globalizzazione e i suoi esiti infausti e irrazionali — che sarebbero di gran lunga inferiori a quelli fausti e razionali — non ci sia nulla da fare.
Non è più possibile invertire la subordinazione
della politica agli imperativi di una società mondiale integrata dal mercato, sostiene per esempio Jürgen Habermas. Tuttavia, aggiunge
Habermas stesso, non basta «limitarsi a reagire
alle condizioni di valorizzazione del capitale investibile». Bisogna anche impegnarsi, il più attivamente possibile, «nel riqualificare i membri
della società addestrandoli alla concorrenza...
La nota massima “aiutalo a fare da sé” acquista
il senso economistico di un addestramento che
— abilitando tutti ad assumersi responsabilità
e iniziative — serve ad affermarsi con competenza sul mercato e a non dover dipendere come
“falliti” dall’assistenza sociale» (5).
Siamo quasi ritornati, mi pare, a una concezione laica, pagana quasi, della povertà, che mi
ha richiamato alla mente un passo della celeberrima orazione funebre di Pericle per i caduti, riportata da Tucidide. Esaltando la forma ateniese di governo democratico, aperta al mondo,
libera e regolata dalle leggi, Pericle sostiene che
ad Atene ammettere la povertà di qualcuno non
è disgrazia: disgrazia è non fare alcuno sforzo
per evitarla (6). Sull’opportunità di evitare la povertà credo ci sia consenso generale: sul modo
di evitarla un po’ meno. Certo, sarebbe altamente desiderabile disporre di una tale quantità e varietà di posti di lavoro che ciascuno possa
più o meno scegliere. Ma se questo non è possibile, evitare la povertà costringendo le persone a «riqualificarsi» sotto minaccia di non ricevere più il sussidio di disoccupazione può avere
risvolti umilianti per il riqualificando.
Le politiche di incoraggiamento, addestramento, riqualificazione, reinserimento, vengono tutte compendiate nella celebre frase:
«Non regalare un pesce, insegna a pescare» (7).
Tanto per rimanere in tema ittico, questo vuol
dire che, seguendo un’altra metafora evangelica suggerita da Giuliano Amato, invece di
12 Agosto/Settembre 2000
pensare alla «moltiplicazione dei pani e dei
pesci» dovremmo pensare all’«alzati e cammina». Ma dobbiamo proprio pensare a una
coercizione ad alzarci, camminare e andare a
prendere il pesce coi nuovi strumenti acquisiti, magari in nome del «nostro bene», che qualcuno conosce sempre meglio di noi? Dobbiamo
pensare solo al povero meritevole, disposto a
riqualificarsi e reinserirsi nonché consenziente a sottoporsi a procedure spesso umilianti e
mortificanti quali quelle inflitte in molti uffici di collocamento, nei quali Habermas non è
sicuramente mai entrato in vita sua?
Il tema dell’umiliazione ha ricevuto recentemente una nuova luce dagli studi del filosofo
e giornalista israeliano Avishai Margalit, che lo
ha introdotto come criterio di definizione di una
società decente: una società decente, scrive infatti Margalit, è quella che non umilia, che riconosce la centralità dei concetti di onore e dignità e del loro contrario, umiliazione appunto, nella vita delle persone (8). Ma umiliare uno
svantaggiato, un individuo vulnerabile che soffre di carenza grave di beni materiali e sociali
(definizione scientifica di povero), trattandolo
magari come un minore che bisogna aiutare a
recuperare un ritardo, riabilitare e promuovere, mi sembra un rischio da non correre.
Diritti, capacità, merito
La posizione meritocraticistica giustifica,
come s’è visto, differenze di status e di reddito
basate su abilità, quindi su talenti naturali coltivati e sviluppati tramite sforzo e impegno individuale. A coloro che faranno fruttare i loro
talenti, che non li seppelliranno in giardino né
li nasconderanno in un fazzoletto, sarà dato di
più; a chi invece non li avrà fatti fruttare, o sem(5)
Habermas J., La costellazione postnazionale. Mercato
globale, nazioni e democrazia, tr. it., Feltrinelli, Milano
1999, p. 113.
(6)
Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 40.
(7)
Commentata nel bel Patchwork del n. 3, 2000 di
«Animazione Sociale», pp. 89-96.
(8)
Margalit A., La società decente, tr. it., Guerini e associati, Milano 1998.
Animazione Sociale
S T U D I
plicemente non avrà i talenti richiesti quel giorno dal mercato, sarà tolto anche quello che ha.
La posizione meritocraticistica è una posizione elitaria, basata su privilegio, anche se non
di nascita o di sangue. Una posizione egualitaristica, di contro, dovrebbe invece insistere sul
tema dei diritti, che sono veramente di tutti e
non solo degli abili, dei dotati o dei capaci.
Diritto a un reddito minimo di base, che tutti
i governi dovrebbero provvedere per i loro cittadini; diritto al rispetto e alla salvaguardia della
dignità e dell’onore delle persone; diritto a essere trattati come fini e non come mezzi, ogni
persona come un fine (non donne usate, manipolate e trasportate per fini altrui).
Non mi interessa tanto o non solo la soddisfazione — anche in termini di reddito — di
una persona per ciò che sa fare; mi interessa ciò
che fa, ciò che è in posizione di fare per quanto glielo permettano le sue opportunità e la sua
libertà. La filosofa americana Martha Nussbaum
propone di riarticolare il principio di ogni persona come fine nel principio delle capacità di
ogni persona (9). Il fine politico diventa qui la
promozione delle capacità di ogni persona per
quanto sa e può fare. Una proposta affascinante in questa direzione è il microcredito della
Banca Grameen, forse l’esperienza più attraente
ed efficace per spazzar via la povertà senza umiliare i poveri. «Ciascuno di noi» scrive
Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri «ha
un potenziale illimitato... in ognuno di noi si
cela molto più di quanto finora si sia avuto la
possibilità di esplorare» (10). I poveri non sono
poveri perché manchino di competenze o istruzione, ma perché non riescono a conservare i
profitti del loro lavoro, se hanno un lavoro. Nei
programmi di formazione e riqualificazione i
poveri sono sollecitati a partecipare per mezzo
di incentivi o costretti a farlo per mezzo di minacce e ricatti (sospensione dell’idennità di disoccupazione). L’apprendimento forzato di
(9)
Nussbaum M. C., Women and Human Development.
The Capabilities Approach, Cambridge University Press,
Cambridge 2000.
(10)
Yunus M., Il banchiere dei poveri, tr. it. Feltrinelli,
Milano 1998.
(11)
Ivi, p. 217. Corsivo mio.
Animazione Sociale
competenze vendibili è per molti un’esperienza traumatica, soprattutto se imposta e non frutto di esigenza sentita. Non dico che la formazione e la riqualificazione sia negativa in assoluto, dico, associandomi a Yunus, che è altrettanto importante, o più importante, «lasciare
che le capacità naturali si espandano e si irrobustiscano, invece di ingabbiarle in una struttura costrittiva» (11). In questo senso il microcredito — cioè la concessione di un credito bancario modesto, a tassi bonificati e senza garanzie — è una formula che unisce la moltiplicazione dei pani con la formula dell’alzati e cammina: tu mi dai i pesci affinché io possa investire il loro valore in un’iniziativa decisa da me,
in base alle mie capacità e alle mie potenzialità,
affinché io possa prendere in mano il mio destino e decidere che cosa fare dei pesci. E te li
restituirò moltiplicati.
Solo a quel punto, nella moltiplicazione dei
pesci che farò io e che non sarà un miracolo
ma una normale azione umana, risiederà, se
così si può dire, il mio merito di persona attiva, che a quel punto, ma solo a quel punto,
opera scelte e assume responsabilità. Se di merito si può parlare, lo si può fare solo ex post,
alla fine cioè di un lungo percorso che porta le
persone dalla posizione di paziente (il minore,
il povero) a quella di agente. Sono debitrice,
per questa terminologia e per questi spunti, nei
confronti di Salvatore Veca. Conversando con
lui che mi è risultato più chiaro che il merito
può essere accolto nel discorso sociale unicamente se sono stati soddisfatti i diritti e se sono
state sviluppate le capacità e i talenti di ognuno. Miriamo cioè a garantire uguali diritti, affinché i bisogni più urgenti di ognuno risultino coperti, poi miriamo a egualizzare per quanto possibile le capacità — ma questo è tremendamente difficile, per non dire utopistico
— cercando di aprire al massimo il ventaglio
dei funzionamenti alternativi: solo allora, forse,
potremo far intervenire il merito.
Francesca Rigotti - docente di dottrine e istituzioni politiche dell’Università della Svizzera italiana
(Lugano) - tel. (0323) 401840 - e-mail: francesca.
[email protected]
2000 Agosto/Settembre 13