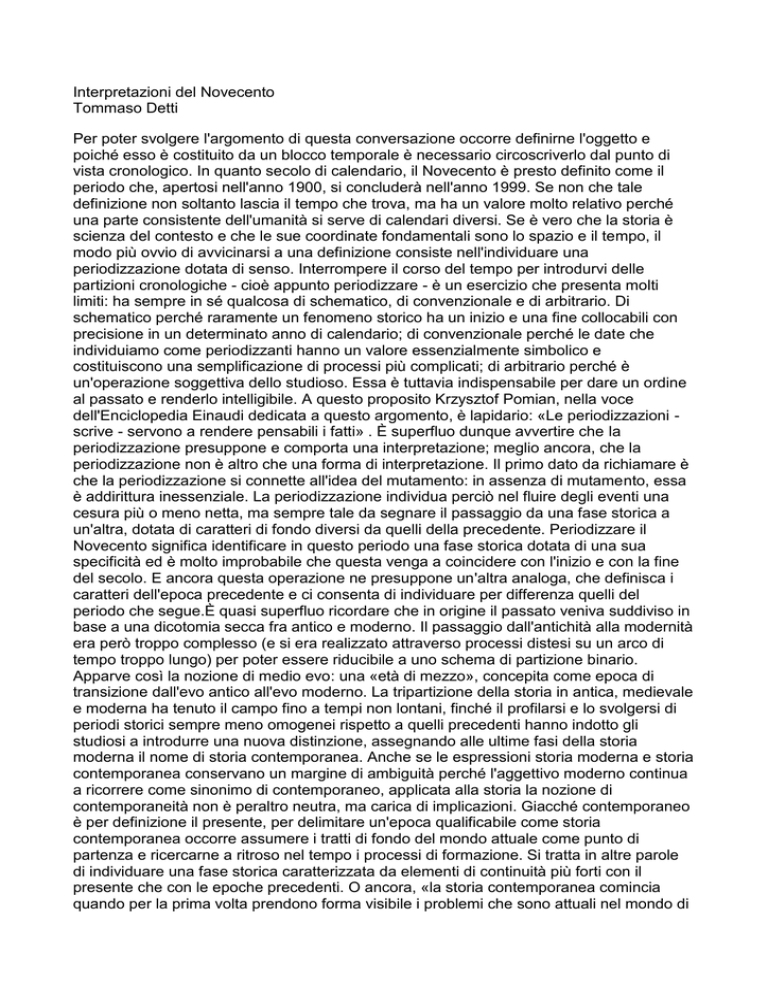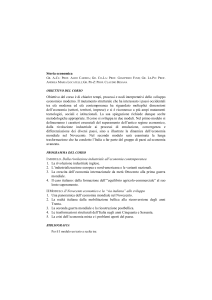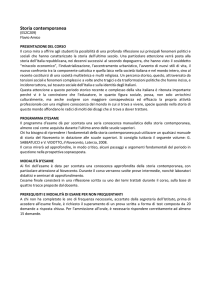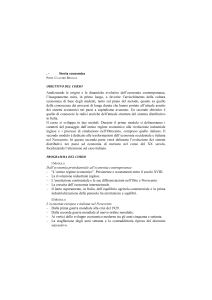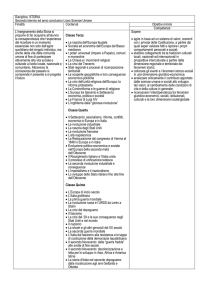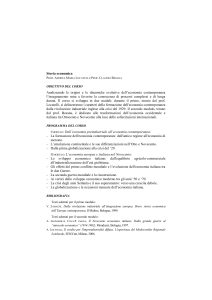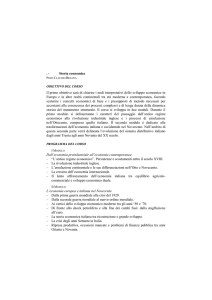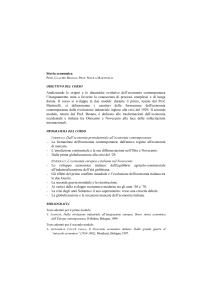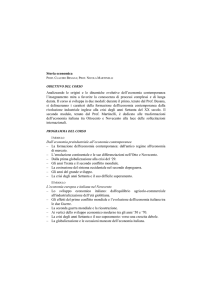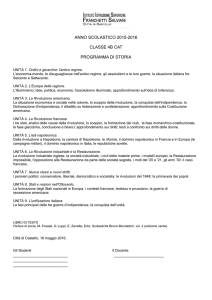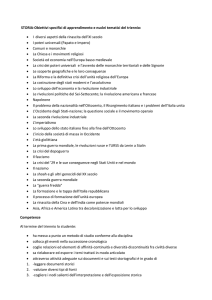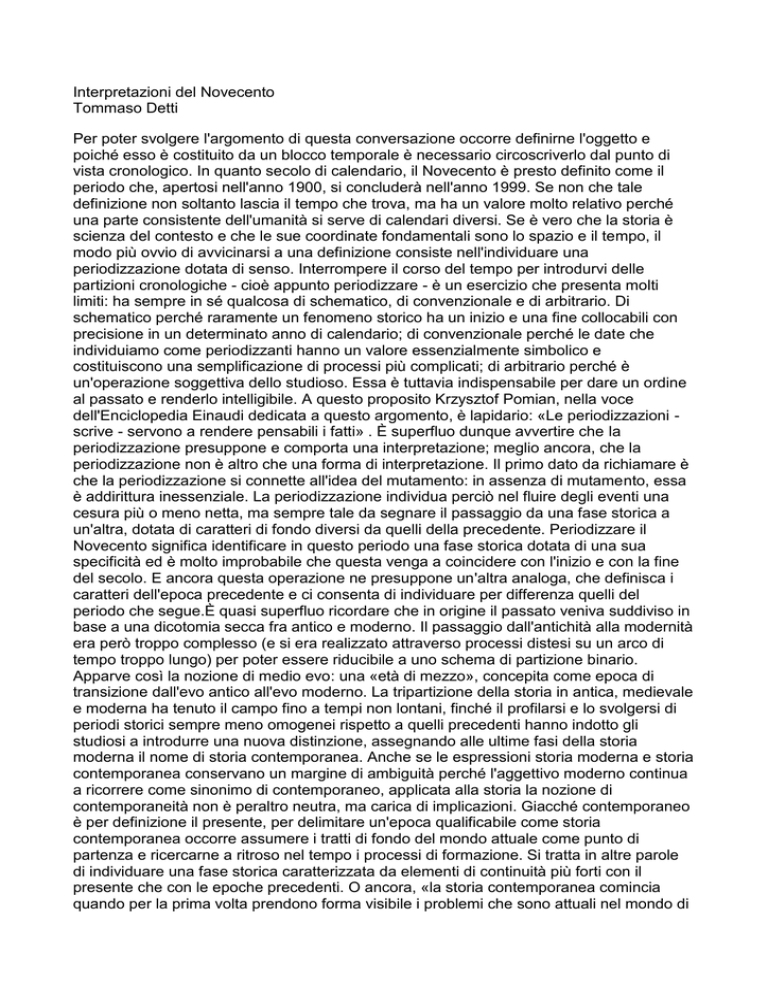
Interpretazioni del Novecento
Tommaso Detti
Per poter svolgere l'argomento di questa conversazione occorre definirne l'oggetto e
poiché esso è costituito da un blocco temporale è necessario circoscriverlo dal punto di
vista cronologico. In quanto secolo di calendario, il Novecento è presto definito come il
periodo che, apertosi nell'anno 1900, si concluderà nell'anno 1999. Se non che tale
definizione non soltanto lascia il tempo che trova, ma ha un valore molto relativo perché
una parte consistente dell'umanità si serve di calendari diversi. Se è vero che la storia è
scienza del contesto e che le sue coordinate fondamentali sono lo spazio e il tempo, il
modo più ovvio di avvicinarsi a una definizione consiste nell'individuare una
periodizzazione dotata di senso. Interrompere il corso del tempo per introdurvi delle
partizioni cronologiche - cioè appunto periodizzare - è un esercizio che presenta molti
limiti: ha sempre in sé qualcosa di schematico, di convenzionale e di arbitrario. Di
schematico perché raramente un fenomeno storico ha un inizio e una fine collocabili con
precisione in un determinato anno di calendario; di convenzionale perché le date che
individuiamo come periodizzanti hanno un valore essenzialmente simbolico e
costituiscono una semplificazione di processi più complicati; di arbitrario perché è
un'operazione soggettiva dello studioso. Essa è tuttavia indispensabile per dare un ordine
al passato e renderlo intelligibile. A questo proposito Krzysztof Pomian, nella voce
dell'Enciclopedia Einaudi dedicata a questo argomento, è lapidario: «Le periodizzazioni scrive - servono a rendere pensabili i fatti» . È superfluo dunque avvertire che la
periodizzazione presuppone e comporta una interpretazione; meglio ancora, che la
periodizzazione non è altro che una forma di interpretazione. Il primo dato da richiamare è
che la periodizzazione si connette all'idea del mutamento: in assenza di mutamento, essa
è addirittura inessenziale. La periodizzazione individua perciò nel fluire degli eventi una
cesura più o meno netta, ma sempre tale da segnare il passaggio da una fase storica a
un'altra, dotata di caratteri di fondo diversi da quelli della precedente. Periodizzare il
Novecento significa identificare in questo periodo una fase storica dotata di una sua
specificità ed è molto improbabile che questa venga a coincidere con l'inizio e con la fine
del secolo. E ancora questa operazione ne presuppone un'altra analoga, che definisca i
caratteri dell'epoca precedente e ci consenta di individuare per differenza quelli del
periodo che segue.È quasi superfluo ricordare che in origine il passato veniva suddiviso in
base a una dicotomia secca fra antico e moderno. Il passaggio dall'antichità alla modernità
era però troppo complesso (e si era realizzato attraverso processi distesi su un arco di
tempo troppo lungo) per poter essere riducibile a uno schema di partizione binario.
Apparve così la nozione di medio evo: una «età di mezzo», concepita come epoca di
transizione dall'evo antico all'evo moderno. La tripartizione della storia in antica, medievale
e moderna ha tenuto il campo fino a tempi non lontani, finché il profilarsi e lo svolgersi di
periodi storici sempre meno omogenei rispetto a quelli precedenti hanno indotto gli
studiosi a introdurre una nuova distinzione, assegnando alle ultime fasi della storia
moderna il nome di storia contemporanea. Anche se le espressioni storia moderna e storia
contemporanea conservano un margine di ambiguità perché l'aggettivo moderno continua
a ricorrere come sinonimo di contemporaneo, applicata alla storia la nozione di
contemporaneità non è peraltro neutra, ma carica di implicazioni. Giacché contemporaneo
è per definizione il presente, per delimitare un'epoca qualificabile come storia
contemporanea occorre assumere i tratti di fondo del mondo attuale come punto di
partenza e ricercarne a ritroso nel tempo i processi di formazione. Si tratta in altre parole
di individuare una fase storica caratterizzata da elementi di continuità più forti con il
presente che con le epoche precedenti. O ancora, «la storia contemporanea comincia
quando per la prima volta prendono forma visibile i problemi che sono attuali nel mondo di
oggi», come scrisse nel 1964 Geoffrey Barraclough in quella Guida alla storia
contemporanea, che conserva tuttora la sua validità, benché appaia ormai, in alcune parti,
inevitabilmente datata . Del resto, che lo storico guardi al passato con gli occhi del
presente non è vero soltanto per la storia contemporanea, né questo è un punto sul quale
sia necessario insistere. Benché corretta e feconda, questa procedura non è tuttavia priva
di inconvenienti, che vanno sottolineati. Come ha osservato Scipione Guarracino nel suo Il
Novecento e le sue storie , il nostro secolo ha cambiato volto continuamente: si era
annunciato come compimento del secolo delle nazionalità, ma la grande guerra ne fece il
tempo della rivoluzione. Negli anni '30 apparve come l'epoca del comunismo e del
fascismo, ma presto divenne il secolo dei conflitti mondiali e dello sterminio di massa.
Dopo gli anni '50 vestì i panni di un'età della decolonizzazione, dello sviluppo illimitato, del
confronto fra capitalismo e comunismo, e infine dagli anni '70 ha mutato ancora
sembianze. La continua accelerazione del cambiamento, che è un tratto tipico dell'età
contemporanea, rende cioè particolarmente difficile una individuazione preventiva dei suoi
caratteri salienti. Questo susseguirsi di proposte è stato in effetti un prodotto del fluire del
tempo, che ha offerto agli studiosi sempre nuovi punti vista per formulare interpretazioni e
periodizzazioni, confermandone poi alcune, smentendone o ridimensionandone altre.
Com'è noto anche le periodizzazioni più generali della storia contemporanea sono state
molte: quella che ne fissava l'inizio nel congresso di Vienna ha avuto ad esempio notevole
fortuna nella storiografia italiana ed è tuttora in uso in molti manuali. Adottarla significava
sottolineare da un lato il rilievo prioritario di fenomeni politico-istituzionali e diplomatici,
dall'altro quello di alcuni esiti della Restaurazione: in Italia, in particolare, la formazione
dello Stato nazionale. Quando poi si è cominciato a collocare il terminus a quo della storia
contemporanea nell'ultimo quarto del Settecento - e segnatamente nell'industrializzazione
inglese e nella rivoluzione francese - non si sono soltanto ampliati gli orizzonti di
riferimento dall'Italia all'Europa e tendenzialmente al mondo intero, ma di fatto si è definita
la contemporaneità come epoca del capitalismo industriale e della democrazia. A questa
periodizzazione, accreditata nel 1962 da The Age of Revolutions di Eric Hobsbawm , altri
studiosi hanno poi portato molte conferme, ravvisando nella rivoluzione industriale la più
grande trasformazione della storia dell'umanità dopo la cosiddetta rivoluzione neolitica,
che segnò la comparsa dell'agricoltura, della divisione del lavoro, della città e dello Stato.
Non passarono molti anni e altri storici proposero di attribuire maggiore rilievo alla cesura
rappresentata dalla cosiddetta seconda rivoluzione industriale: poiché un requisito
accertato della contemporaneità consisteva nel suo ritmo sempre più accelerato, si
osservò che negli ultimi decenni del XIX secolo il ritmo della crescita economica e
dell'innovazione tecnologica era divenuto incomparabilmente più rapido, si sottolineò il
rilievo di fenomeni come il taylorismo e il fordismo e si aggiunse che con l'imperialismo
aveva preso corpo quella geografia economica mondiale basata sulla dicotomia svilupposottosviluppo, che sembrava ancora attuale negli anni '60-70. Negli stessi anni si era
ormai consolidata, e non soltanto nei paesi del socialismo reale, un'ampia letteratura sul
carattere di cesura zeitgeschichtlich - epocale - del 1917, anno della rivoluzione russa. E vi
sono state molte altre proposte, da quelle centrate sul valore periodizzante della grande
crisi del 1929 a quella di Barraclough, che collocava negli anni '60 l'inizio dell'età
contemporanea, ravvisandone gli ingredienti essenziali nel bipolarismo fra Stati Uniti e
Unione Sovietica, nella decolonizzazione e nella rivoluzione termonucleare. Si noti, per
inciso, che in questa fase la nozione di Novecento in quanto periodo storico distinto dai
precedenti era del tutto assente per l'ovvio motivo che troppa parte del secolo
apparteneva ancora al futuro. A prescindere dalla loro pertinenza, queste datazioni
spostavano l'inizio dell'età contemporanea sempre più vicino nel tempo, con il risultato che
le fasi storiche da esse risospinte nell'epoca precedente apparivano sempre più
difficilmente riconducibili all'età moderna perché non omogenee ai suoi tratti di fondo.
Come già era divenuta inadeguata la vecchia distinzione binaria tra evo antico ed evo
moderno, così il fluire del tempo ha reso inservibile quella tra storia moderna e storia
contemporanea. La nettezza della cesura della cosiddetta «duplice rivoluzione» - bene
espressa da concetti quali decollo industriale e ancien régime, quest'ultimo coniato dalla
stessa rivoluzione francese per definire il suo contrario - è stata d'altra parte attenuata da
studi come quelli di Franklin F. Mendels sulla «protoindustrializzazione» e di Arno J. Mayer
sulla persistenza dell'antico regime fino al 1914, ma che quella cesura vi sia stata e
conservi un fondamentale valore periodizzante resta fuori discussione per la maggior parte
degli studiosi. Se abbia ancora senso catalogare l'intero periodo dall'ultimo quarto del
Settecento a oggi come storia contemporanea, è questione sulla quale tornerò più avanti.
Sta di fatto che questi due secoli sono caratterizzati da una tale accelerazione del
cambiamento, che per interpretarli erano indispensabili ulteriori scansioni. Quella che ha
incontrato i maggiori consensi è stata la nozione di «lungo Ottocento» proposta da
Hobsbawm. Su di essa non mi soffermo perché è divenuta quasi un luogo comune;
osservo soltanto che sulle prime tale interpretazione non ha conferito al periodo tra la
duplice rivoluzione e il 1914 la fisionomia di una sorta di nuovo medio evo, di una fase di
transizione fra l'età moderna e un'epoca storica nuova e diversa. Perché ciò accadesse,
era necessario che il periodo successivo al 1914 cessasse di essere una fase aperta e in
divenire. Ciò non è accaduto prima del 1989-91 e soltanto allora, da semplice partizione di
calendario, il Novecento è divenuto un problema storiografico. Un nodo cruciale della gran
parte delle interpretazioni è comunque costituito dal valore di spartiacque della «grande
guerra», che rinvia all'immagine più fortunata e consolidata del Novecento: quella che lo
vuole secolo del fascismo e del comunismo ed è stata amplificata dai mass media fino a
divenire un vero e proprio senso comune storiografico. Non sempre, peraltro, gli studi che
più hanno contribuito a fare della «grande guerra» la levatrice del Novecento hanno
assunto esplicitamente il nesso che la lega alla nascita del fascismo e del comunismo
come pernio di una proposta interpretativa di carattere generale. Non l'hanno fatto, ad
esempio, opere come quelle di Paul Fussel e di Eric J. Leed , che pure hanno gettato
nuova luce sul nesso tecnologia - guerra di massa istituitosi nel 191418, indagando le
profonde trasformazioni delle mentalità individuali e collettive prodotte dal conflitto e
mostrando come fosse il binomio tecnologia-distruzione a introdurre la gente comune alla
società massificata del Novecento. Si tratta in realtà di punti di riferimento essenziali
anche per lo studio del fascismo e del comunismo, se è vero, come ha sostenuto Ulrich
Herbert, che la «grande guerra» in Germania e la guerra civile in Russia sono state
all'origine del nazismo e dello stalinismo . Pur essendo imprescindibili per comprendere
anche altri nodi cruciali della storia del secolo, come la seconda guerra mondiale e lo
sterminio di massa, tali opere non propongono tuttavia interpretazioni generali del
Novecento, né sono centrate sul tema dell'economia di guerra, che pure presuppongono.
Maggiori implicazioni ha, da questo punto di vista, la proposta interpretativa avanzata da
Arno J. Mayer nel suo libro sulla persistenza dell'ancien régime fino al 1914 . Per lui la
«grande guerra» fu il prodotto della resistenza delle forze dell'antico regime, indebolite
dallo sviluppo del capitalismo ma ancora molto consistenti. Il conflitto dette un fiero colpo
alle fondamenta del vecchio ordine, ma queste crollarono soltanto nel paese meno
strutturato e più rigido: la Russia. Per il resto, scrive Mayer, «le forze della persistenza si
ripresero abbastanza da aggravare la crisi generale dell'Europa, patrocinare il fascismo e
contribuire al riemergere della guerra totale nel 1939». Coerente con questo assunto è la
sua proposta, che ha incontrato larghi consensi, di leggere l'intero periodo 1914-1945
come una fase omogenea, che definisce «guerra dei trent'anni del Novecento». Un
concetto solo apparentemente analogo, quello di «guerra civile europea», presiede
all'interpretazione di Ernst Nolte . Come terminus a quo egli non assume infatti il 1914, ma
il 1917. La differenza non è lieve perché in tal modo la guerra civile europea viene ridotta
ad un confronto tra bolscevismo e nazismo. Non entro nel merito delle tesi «revisioniste»
di Nolte secondo le quali il nazismo fu una sorta di replica al bolscevismo, perché ciò esula
dal mio tema; voglio piuttosto rilevare che sono state tesi del genere ad accreditare
un'interpretazione del Novecento assai riduttiva perché molto sbilanciata su temi
ideologico-politici. Per Nolte, come anche per François Furet , il secolo si svolge infatti
all'insegna della lotta tra l'Occidente liberale e i due opposti totalitarismi generati dal primo
conflitto mondiale: dopo la sconfitta del nazismo la «guerra civile europea» diviene
planetaria e si chiude nel 1989-91 con la vittoria finale del capitalismo sul comunismo. Una
forte sottolineatura dei medesimi aspetti politico-ideologici caratterizza com'è noto anche
l'interpretazione di Eric Hobsbawm , al quale si deve l'idea di un «secolo breve» che si
apre con la «grande guerra» per chiudersi nel 1989-91. Per lui il conflitto del 1914-18 ha
un valore periodizzante sia perché marca uno stacco netto rispetto al periodo precedente,
sia perché segna gli sviluppi successivi del Novecento: il secolo si apre con una guerra tra
gli Stati-nazione che fa precipitare la crisi del mondo liberale ottocentesco, generando il
comunismo e il fascismo. Tali esiti, attraverso la guerra del 1939-45, condizionano in larga
misura anche la seconda metà del secolo, quando - sconfitto il fascismo - emerge il
dualismo tra le superpotenze sovietica e statunitense. La più significativa differenza tra
Hobsbawm e gli altri autori ai quali ho accennato non si limita tuttavia a una diversa lettura
della parabola del comunismo. Egli non riduce infatti il Novecento ad un conflitto fra
questo e il capitalismo. Nella dissoluzione dell'Urss vede piuttosto un effetto della generale
crisi economica del 1973-92 ed è tale crisi, più che il crollo del comunismo, a segnare a
suo giudizio la fine del secolo. Il dato più rilevante è anzi costituito dal fondamentale ruolo
periodizzante che l'autore assegna a questo ventennio di crisi, che pone fine a un'«età
dell'oro» caratterizzata da un'eccezionale espansione dell'economia, dell'occupazione, dei
consumi e delle politiche sociali. Resta il fatto che la complessità e l'articolazione di
giudizio che sono tra i pregi maggiori de Il secolo breve ed hanno conferito tanta autorità
alla sua lettura del Novecento non hanno impedito a Hobsbawm di mantenere al centro
dell'attenzione i fenomeni ideologico-politici più appariscenti del secolo e di datarne la fine
per l'appunto al 1989-91. Almeno in parte non è dunque infondata la critica di chi lo ha
accusato di aver fatto della storia del Novecento una sorta di «dramma ideologico». A
formularla è stato lo storico americano Charles Maier in un saggio significativamente
intitolato Secolo corto o epoca lunga? , sul quale vorrei soffermarmi perché riformula
decisamente (e a mio avviso opportunamente) i termini della questione. Con ciò non
intendo negare il rilievo cruciale del fascismo e del comunismo nella storia del Novecento:
mi propongo soltanto di richiamare l'attenzione su altre tematiche, suscettibili di arricchire
e di modificare sensibilmente la nostra immagine di questo secolo.
Secondo Maier la crisi economica degli anni '70-80 ha posto fine a una fase di sviluppo
iniziata non nel 1914, ma alla metà dell'Ottocento. I suoi caratteri originali sono un ordine
industriale fordista «fondato sull'acciaio e la chimica e sul movimento fisico di persone e
merci» e una «organizzazione territoriale dell'umanità» centrata sullo Stato-nazione, che
per lui, a differenza di quanto ritengono studiosi come Ernest Gellner, Benedict Anderson
e lo stesso Hobsbawm , non si afferma alla fine del Settecento, ma più tardi. «Lo spazio
politico - scrive Maier - venne riorganizzato in modo decisivo nei decenni successivi al
1850 (o 1860). I territori nazionali vennero considerati ambiti spaziali che potevano essere
dominati fisicamente tramite la ferrovia e i trasporti. Le strutture di governo divennero più
centralizzate [...]. Una nuova consapevolezza dello spazio circoscritto, una
preoccupazione di stabilire linee di confine, di demarcazione tra chi era dentro e chi fuori,
tra pubblico e privato, trasformò la coscienza sociale». Questa fondamentale
ristrutturazione dello spazio non subì sostanziali mutamenti nella prima metà del
Novecento, anche se il primato della territorialità affermatosi nei cinquant'anni precedenti
ebbe una prima crisi con le rivalità nazionali e imperiali culminate nella «grande guerra»,
entrando poi in contraddizione, tra i due conflitti mondiali, con la dimensione
transnazionale acquista dalle forze economiche e finanziarie. Negli anni '3070, infine, gli
Stati-nazione sfruttarono la crisi mondiale e la guerra «per rinegoziare le soluzioni
territoriali e la ripresa di economie industriali fondate sull'alta occupazione». Visti con gli
occhi di oggi, gli aspri conflitti ideologici di questi decenni, il fascismo e il comunismo, non
hanno lasciato a giudizio di Maier segni profondi: il tratto più significativo della sua «epoca
lunga» è invece costituito dalla territorialità in quanto principio di organizzazione politicosociale ed economica. Ed è stata appunto la sua dissoluzione a sancire la fine di tale
epoca quando «la crisi degli anni settanta e ottanta, unita a una nuova tecnologia di
trasformazione», ha annullato «le premesse territoriali dell'organizzazione politica ed
economica». Agenti di tale mutamento sono stati la cosiddetta «globalizzazione», ovvero
l'internazionalizzazione delle grandi corporations e la dislocazione delle fabbriche lontano
dai centri direzionali delle imprese, nonché lo sviluppo di una comunicazione non
gerarchica su Internet e di un'economia centrata non più tanto sui metalli e sugli altiforni,
sulla produzione in serie e sul movimento fisico dei beni, quanto sulla trasmissione di dati.
Alle linee e ai confini che segnavano lo spazio si sono sostituite reti e anche i rapporti
sociali sono mutati: élites e masse non sono più disposte a piramide, ma per cerchi
concentrici; le prime stanno al centro e controllano il flusso transnazionale delle
informazioni e dei simboli, le seconde sono relegate nella periferia e questa stratificazione
è a scala mondiale. Alla base di tali mutamenti l'autore pone l'espansione del fordismo in
Asia e nell'America Latina e la diffusione di una nuova economia basata sull'elettronica e
sui servizi nel Nordamerica e in Europa. La crisi degli anni '70-80 ha ulteriormente
indebolito la territorialità facendo fallire, con il governo dell'economia e le politiche sociali
dell'Occidente, la fiducia nella possibilità di un controllo politico del mutamento sociale. Il
territorio ha cessato di essere così importante perché gli spazi dell'identità e quelli della
decisione non coincidono più. Personalmente dissento da alcuni punti dell'analisi di Maier,
e in particolare dalla sua proposta di periodizzazione. Datando agli anni '50-60
dell'Ottocento l'inizio di quella che definisce come «età industriale» e l'avvento dello Statonazione, infatti, egli risospinge nell'età moderna l'industrializzazione inglese e la
rivoluzione francese, con una discutibile sottovalutazione della svolta epocale dell'ultimo
quarto del Settecento. Sul carattere essenzialmente unitario dei processi innescati da tale
svolta tornerò fra poco. Quanto alla rivoluzione industriale, sono tra coloro secondo i quali
gli studi sulla «protoindustria» non hanno ridimensionato che in piccola parte la portata di
questo fenomeno e che continuano a considerarlo come la più grande trasformazione
della storia dell'umanità dopo la «rivoluzione neolitica». Altrettanto discutibile mi appare la
sua trascuratezza della cesura della «grande guerra»: senza entrare nel merito di una
svalutazione a mio parere eccessiva del rilievo dei grandi conflitti politici e ideologici del
Novecento, l'ordine industriale fondista che Maier considera un tratto di fondo della sua
«epoca lunga» non si afferma compiutamente né alla metà dell'Ottocento, né con la
cosiddetta «seconda rivoluzione industriale»: benché l'organizzazione scientifica del
lavoro e il fordismo si sviluppino come risposte alla «grande depressione» del 1873-96,
soltanto con il primo conflitto mondiale e con il balzo della produzione e dei consumi di
massa del dopoguerra il fordismo si afferma fino a divenire criterio di organizzazione
dell'intera società. Rilievi analoghi muoverei anche alle tesi, peraltro molto stimolanti,
avanzate da Leonardo Paggi, che ha visto nel Novecento un «secolo spezzato» e tuttora
aperto, individuando una rottura epocale nel 1945. Secondo Paggi occorre abbandonare il
1914 come punto di partenza della narrazione e pensare unitariamente il periodo 18701945 perché i problemi di cui siamo contemporanei non nascono nel 1914, ma
all'indomani della seconda guerra mondiale . Se per altri aspetti proposte interpretative
come queste mi appaiono molto feconde (e mi scuso se per motivi di tempo non rendo
conto come meriterebbe del contributo di Paggi), dal punto di vista della periodizzazione
continuo insomma a ritenere più pertinente la proposta avanzata da Hobsbawm in The
Age of Revolutions, sviluppata dallo stesso autore con la nozione di un «lungo Ottocento»
disteso tra la «duplice rivoluzione» e il 1914 e prolungata infine con una lettura del
Novecento come secolo breve . Ciò a maggior ragione, in quanto la forte sottolineatura
degli aspetti ideologico-politici della storia del XX secolo, indubbiamente presente nel libro
del grande storico inglese, risulta molto ridimensionata da una rilettura unitaria della sua
opera, che faccia de Il secolo breve l'epilogo della precedente trilogia costituita da Le
rivoluzioni borghesi, Il trionfo della borghesia e L'età degli imperi. In quest'ottica, dunque,
mi è sembrato possibile proporre una riformulazione delle tesi di Maier basata sull'ipotesi
che i due secoli compresi fra la rivoluzione industriale inglese e la crisi economica degli
anni '70-90 del Novecento costituiscano un periodo storico sostanzialmente omogeneo.
Fino a un certo punto il «lungo Ottocento» è potuto apparire come una sorta di nuovo
medio evo, una fase di transizione fra l'età moderna e l'età contemporanea. Da quando il
periodo successivo ha cessato di essere una fase storica aperta e il Novecento è divenuto
un problema storiografico, si può invece pensare che sia quell'intero blocco bisecolare a
dover essere visto unitariamente come l'«età industriale» della storia dell'umanità.
Argomenterò questa ipotesi richiamando alcune considerazioni del sociologo Luciano
Gallino sull'organizzazione della produzione e del lavoro . Secondo questo studioso la
travolgente innovazione tecnologica del nostro tempo ha prodotto alcune profonde
trasformazioni, portando con sé: 1) un lavoro privo di luogo, del quale cioè non si può dire
dove venga prodotto il valore aggiunto. Si tratta di un lavoro mobile, autonomo e senza
vincoli di orario, svolto con il telefono e il personal computer; 2) un lavoro privo di struttura:
le mansioni fisse descritte nei manuali aziendali si stanno destrutturando, mentre si
sviluppano gruppi fluttuanti e di progettazione. Fra gli effetti di questa trasformazione vi
sono la diminuzione del numero dei livelli gerarchici e la diffusione di orari flessibili, cioè in
sostanza una riduzione della divisione del lavoro: 3) un lavoro privo di corporeità: accanto
all'economia materiale si è sviluppata un'economia smaterializzata, le cui stesse strutture
organizzative non sono materiali, ma consistono in testi accessibili sulle reti telematiche. I
mercati di questa «cybereconomia» sono costituiti da circa 200.000 terminali sui quali
girano dati e i cui scambi non hanno per oggetto beni o servizi, ma sono puramente
finanziari. Il valore di tali scambi è 100 volte maggiore di quello dell'economia materiale; 4)
un lavoro privo di contenuto: si sviluppano linguaggi precodificati, messaggi e compiti
lavorativi frammentati, indipendenti dal contenuto del prodotto e suscettibili di molteplici
applicazioni; 5) un lavoro privo di attaccamento e di memoria: l'attaccamento al lavoro si
riduce con l'abbreviarsi del tempo di permanenza del personale nell'azienda e i continui,
consistenti «sfoltimenti» di personale determinano una perdita di memoria. Si perde cioè il
sapere organizzativo immagazzinato nelle memorie individuali, che non si riproducono a
causa della brevità della permanenza nell'azienda; 6) un lavoro breve, legato
all'accorciamento dei cicli tecnologici. Oltre agli impianti, che si ricostruiscono ogni 5-10
anni perché ammodernarli non è remunerativo, diventano rapidamente obsolescenti anche
le qualificazioni professionali. I lavoratori che hanno sviluppato competenze funzionali a un
ciclo tecnologico sono inadatti a quello successivo e perciò vengono perciò licenziati molto
presto, o al massimo sono riassunti in qualifiche più basse. Si sono infine determinati
rapporti funzionali di tipo nuovo tra lavoro ad alta tecnologia e lavoro a bassa tecnologia:
ciò è dovuto alla «esternalizzazione» da parte delle aziende di parti del lavoro che prima
venivano spesso gestite in proprio, come le mense, i trasporti, la contabilità, l'inserimento
dati, le manutenzioni, la pulizia delle macchine e la sorveglianza. Si è cioè sviluppato un
sistema di commesse e subappalti, che collega aziende modernissime e aziende non
moderne, fino all'economia sommersa, la quale è alimentata dallo sviluppo tecnologico.
Ebbene, queste trasformazioni sembrano indicare una netta inversione di tendenza
rispetto ai modelli affermatisi duecento anni fa nell'Inghilterra della rivoluzione industriale.
Se allora il lavoro, dopo essere stato decentrato per secoli a domicilio, venne accentrato
nella fabbrica, oggi esso torna ad essere privo di un luogo fisico ben definito. Se allora i
lavoratori dovettero rinunciare a stabilire il proprio orario per assoggettarsi alla disciplina
imposta dalle macchine, oggi gli orari tornano ad essere flessibili. Se la divisione del
lavoro fu un aspetto decisivo del nuovo modo di produzione capitalistico, oggi essa si
riduce e diviene meno rigida. Se lo sviluppo economico portato dall'industrializzazione si
fondò sulla produzione e sulla commercializzazione di massa di beni materiali, oggi
l'economia poggia in misura crescente su scambi finanziari ai quali non corrisponde uno
scambio di merci e la specializzazione del lavoro può essere indipendente dal suo
contenuto. La figura dell'operaio specializzato che organizza la produzione e controlla il
mercato del lavoro appartiene alle prime fasi dell'industrializzazione e l'immagine di un
proletariato composto da persone che facevano l'operaio per tutta la vita è stata smentita,
per il Novecento, dagli studi più recenti. Ciò nonostante un'innovazione tecnologica così
rapida da indurre una perdita di attaccamento e memoria perché abbrevia drasticamente il
tempo di lavoro e provoca una mobilità discendente con l'avanzare dell'età è anch'essa
segno di una profonda trasformazione. Si aggiunga che da anni i tassi di sviluppo
economico più sostenuti non sono più quelli della Germania o degli Stati Uniti e neppure
del Giappone, ma si trovano in Indonesia, in Thailandia, in Malesia, nel Vietnam, nelle
Filippine, in Cina e in India. È un dato che fa riflettere perché non riguarda più soltanto le
cosiddette «quattro tigri» asiatiche: Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore
hanno un numero limitato di abitanti e il loro peso nell'economia mondiale è relativo.
Prodotti da paesi come la Cina e l'India, che detengono una fetta molto consistente della
popolazione del pianeta, gli stessi tassi di sviluppo segnalano fenomeni macroscopici e di
portata sconvolgente. Sembra proprio che dall'Occidente europeo e nordamericano, dove
l'aveva collocato l'industrializzazione, il baricentro dello sviluppo si stia spostando in Asia.
Né si tratta soltanto di fenomeni economici, per quanto decisivo possa essere il loro peso.
Il concetto di «duplice rivoluzione», che richiama l'unitarietà di fondo dei processi avviatisi
con l'industrializzazione inglese e la rivoluzione francese, chiarisce bene il nesso su cui si
è fondato il modello occidentale di sviluppo degli ultimi 200 anni: quello tra estensione dei
consumi e democratizzazione. Molto spesso, invece, i paesi asiatici in via di espansione
sono retti da regimi autoritari. C'è allora da domandarsi se il binomio sviluppo economico autoritarismo diffuso nelle aree trainanti del continente asiatico, sulle cui implicazioni si è
interrogato Ralf Dahrendorf in anni non lontani, non configuri anche sul piano culturale un
modello alternativo a quello occidentale, basato sull'organizzazione giuridica dello Stato e
sulla universalità dei diritti. Le tensioni sociali e politiche che attraversano questi paesi,
assieme alle loro ricorrenti crisi finanziarie, non consentono di dare a tale quesito una
risposta affermativa, ma il problema è aperto. Tra i molti argomenti che potrebbero essere
addotti a sostegno di questa tesi l'unico che vorrei ancora richiamare è quello del
cosiddetto sviluppo compatibile. Dato che tra i suoi fattori è indubbiamente centrale
l'erosione delle risorse minerali non reintegrabili che furono alla base
dell'industrializzazione, non è azzardato pensare che ci troviamo, anche da questo punto
di vista, a un tornante cruciale: il modello di sviluppo fondato sullo sfruttamento illimitato
delle risorse e dell'ambiente non è entrato in crisi soltanto nella coscienza di un numero
crescente di persone, ma per ragioni oggettive e dovrà cedere il passo ad altri modelli
perché ad essere in discussione è la stessa sopravvivenza del genere umano. Se infine
collochiamo questi fenomeni sullo sfondo più generale della globalizzazione e della
rivoluzione telematica, possiamo ben trarne l'impressione che il periodo in cui stiamo
vivendo possa risultare un momento di svolta epocale di rilievo molto maggiore che non la
fine del Novecento. A volgere al termine potrebbe essere davvero l'intera fase storica
apertasi due secoli fa con la «duplice rivoluzione», cioè proprio quella che a lungo
abbiamo chiamato storia contemporanea. Tale ipotesi, che ho via via sviluppato negli
ultimi due anni in una serie di conversazioni come questa, può essere oggi verificata alla
luce di alcuni elementi nuovi. È fresco di stampa un volumetto intitolato L'età degli estremi,
contenente gli atti di un seminario del 1996 durante il quale studiosi come Giuliano
Procacci, Arno J. Mayer, Alan Milward, Franco De Felice e Moshe Lewin hanno discusso
con Hobsbawm il suo Secolo breve . Milward, in particolare, ha individuato nel 1974 non
soltanto il punto di passaggio dalla cosiddetta «età dell'oro» a una fase di grave e
prolungata crisi economica, ma «il grande anno di svolta del XX secolo». Di più:
utilizzando dati e stime secondo i quali nei paesi sviluppati, dal 1974 al 1994, il 60-70%
degli occupati ha avuto redditi reali calanti e ponendoli in relazione con quelli che
segnalano un forte aumento della disoccupazione giovanile, egli ha sottolineato come nel
quadro dell'epoca storica apertasi nel 1789 tali fenomeni costituiscano elementi di
assoluta novità. Assunti come criterio di valutazione la tendenza alla regolamentazione del
lavoro tipica delle fasi precedenti e il fatto che il predominio dell'industria nella produzione
e nell'occupazione sia venuto meno nel 1974, l'«età dell'oro» 1945-73 è apparsa a Milward
come «il culmine di ciò che gli storici erano abituati a chiamare "la rivoluzione
industriale"». Il venir meno di un rapporto fisso tra occupazione e reddito, a suo parere,
potrebbe addirittura «sancire un cambiamento radicale nella storia moderna, non soltanto
nella storia del XX secolo».
Benché lo stesso Milward abbia avvertito che il suo punto di vista è limitato perché si
fonda su fenomeni riguardanti solamente i paesi più sviluppati, esso suffraga come si vede
la mia ipotesi di periodizzazione. Una sola divergenza riguarda la tendenza di Milward, a
mio avviso discutibile, a collocare in un momento preciso - il 1974 - un mutamento epocale
di tali proporzioni, laddove è forse preferibile pensare a una fase di transizione distesa nel
tempo, apertasi allora ma tuttora in corso, come hanno mostrato di ritenere anche Giuliano
Procacci e Franco De Felice. Quest'ultimo, in particolare, ha sottolineato come la
globalizzazione tenda ad azzerare tutte le forme (culturali, politiche, istituzionali e sociali, e
tra queste segnatamente lo Stato-nazione) che si sono definite nel corso dell'Ottocento e
che ancora nel Novecento hanno permesso di governare il mondo. Si sarebbe così
compiuta, nella fase che stiamo vivendo, una lunga fase di transizione all'età
contemporanea. A conclusioni non dissimili era già approdato uno stimolante libro del
sociologo Giovanni Arrighi, apparso nel 1994 contemporaneamente a Il secolo breve. La
coincidenza è singolare perché i due testi si presentano come diametralmente opposti:
The Short Twentieth Century è il sottotitolo dell'edizione inglese dell'opera di Hobsbawm,
The Long Twentieth Century si intitola il saggio di Arrighi . Alla grande «fortuna» della
prima ha fatto però riscontro una scarsa visibilità del secondo, che in Italia è passato quasi
sotto silenzio. Vero è che esso riguarda soltanto in parte il Novecento, sviluppando in
realtà un'interpretazione generale della storia del capitalismo dal XV secolo a oggi. Si
tratta tuttavia di un importante contributo alla comprensione del mondo contemporaneo ed
è perciò opportuno richiamarne alcuni aspetti essenziali. La nozione di «secolo lungo» che
dà il titolo al libro non è riferita al solo Novecento: l'autore parte dall'idea di un «lungo XVI
secolo» disteso tra il 1450 e il 1640, formulata da Fernand Braudel , e ne fa la scansione
di base di un modello di interpretazione della storia di quella che definisce come
«economia-mondo capitalistica». Un lungo Cinquecento di ben 290 anni dice già che la
nozione di secolo ha del tutto perduto il suo significato originario, per assumere quello di
blocco cronologico omogeneo, indipendentemente dalla sua lunghezza. L'autore ritiene in
effetti che 100 anni siano troppo pochi per essere significativi nella storia dello sviluppo
capitalistico. Oltre al lungo XVI secolo, Arrighi individua un lungo XVII secolo che va dal
1560 agli anni '80 del Settecento, un lungo XIX secolo dal 1740 agli anni '30 del
Novecento e un lungo XX secolo aperto dalla «grande depressione» del 1873-96 e non
ancora concluso. Come si vede, ognuno di essi si sovrappone al precedente. Un secolo
lungo è infatti costituito da tre fasi distinte, la prima delle quali coincide con la terza del
secolo precedente. Tale scansione corrisponde a un preciso schema concettuale: ogni
secolo è un ciclo di accumulazione del capitale, la cui prima fase è caratterizzata dalla
prevalenza di intermediazioni e speculazioni finanziarie, la seconda da un'espansione del
commercio e della produzione, la terza da una ripresa di attività finanziarie. In questo
modello la prevalenza delle attività finanziarie è considerata il segnale della crisi di un
regime di accumulazione e dell'emergere di un nuovo regime. Lo sviluppo dell'economiamondo si articola dunque così: 1) un ciclo di evoluzione del capitalismo delle città-Stato
dell'Italia settentrionale, dominato dai mercanti-banchieri genovesi che operano mediante
flussi finanziari e commerciali fuori da ogni centro statale; 2) la terza fase di questo ciclo
«genovese», concluso dalla pace di Vestfalia del 1648, coincide con l'inizio di un ciclo
«olandese», nel quale sono le Province Unite a fondare un nuovo sviluppo capitalistico,
ponendosi al centro di un sistema di Stati territoriali; 3) la crisi del regime olandese si
distende nel periodo tra la rivoluzione americana e le guerre napoleoniche, da cui emerge
una nuova egemonia «britannica». Il regime inglese supera e amplia quello olandese,
fondandosi su quello che Arrighi chiama «imperialismo del libero scambio», cioè una
combinazione delle logiche di potere capitalista e territoriale prevalenti nei primi due cicli;
4) Negli anni '30 il governo mondiale del Regno Unito viene infine soppiantato da un
regime «statunitense», che domina l'economia capitalistica nel lungo XX secolo aperto
dalla «grande depressione» ed è caratterizzato dal ridimensionamento del libero scambio
e della sovranità degli Stati-nazione, nonché da una crescente integrazione centrata sulle
grandi imprese multinazionali. Per non citare che un dato, nel 1990 più della metà delle
importazioni e delle esportazioni americane era costituita da trasferimenti di beni e servizi
all'interno delle grandi imprese globali, che differiscono dalle compagnie privilegiate
olandesi e inglesi perché queste sono esclusivamente imprenditoriali, mentre quelle erano
al tempo stesso statali e imprenditoriali. «La territorialità come base per l'organizzazione
della vita politica - scrive Arrighi - sembra essere superata da uno spazio funzionale e non
territoriale cresciuto all'interno del moderno sistema di dominio, ma che costituisce una
negazione istituzionale dell'esclusività territoriale di quel sistema». Vi è insomma uno
«spazio-di-flussi» decentrato ma integrato, che opera in tempo reale a fianco degli «spazidi-luoghi» che chiamiamo economie nazionali e rende molto problematico distinguere tra
diverse economie, tra mercato interno ed estero. Questo spazio non territoriale è a sua
volta analogo a quello dei mercati internazionali dei banchieri genovesi di un tempo e il
suo equivalente postmoderno è il mercato dell'eurodollaro, che consiste in una rete di
telefoni e telescriventi disseminati per il mondo. Alla base di questo modello sta, come si
vede, una concezione braudeliana del capitalismo non come economia di mercato ma
come fusione tra Stato e capitale, tra detentori di denaro e detentori di potere politico. Lo
sviluppo dell'economia-mondo capitalistica è cioè dovuto all'iniziativa di forze non solo
imprenditoriali, ma anche statali, sicché il prodigioso sviluppo degli ultimi 500 anni poggia
essenzialmente sulla concorrenza tra tali forze e su una crescente concentrazione del
potere capitalistico su scala mondiale. Il meccanismo ha un andamento ciclico, alternando
fasi estensive (quella genovese e quella britannica) che realizzano l'espansione
dell'economia-mondo e fasi intensive (quella olandese e quella statunitense), responsabili
del suo consolidamento geografico. In ogni ciclo si assiste alla ricomparsa e alla
metamorfosi di forme tipiche dei cicli precedenti. Il regime statunitense del lungo XX
secolo è entrato per Arrighi nella sua terza fase con la crisi economica degli anni '70-90,
come indica la prevalenza, in questa fase, delle intermediazioni e delle speculazioni
finanziarie sugli investimenti. Un'altra spia della crisi dell'egemonia statunitense è inoltre
costituita da un fondamentale mutamento spaziale, determinato dalla spettacolare ascesa
di un arcipelago produttivo e finanziario nell'Asia orientale e sudorientale. Il suo pernio è il
Giappone, intorno al quale stanno le cosiddette «quattro tigri» e gli altri paesi più popolosi
dell'area, uniti da un sistema flessibile di subappalti su più livelli fondato sui bassi costi di
una sterminata riserva di manodopera. Questo sistema asiatico detiene ormai il quasi
monopolio della liquidità mondiale: nel 1989 il Giappone era il maggiore investitore
all'estero con 44,1 miliardi di dollari contro i 31,7 degli Stati Uniti. Alla potenza economicofinanziaria della costellazione asiatica non corrisponde tuttavia una potenza statale e
militare: il quasi monopolio della violenza legittima è nelle mani degli Stati Uniti, che usano
il Fondo monetario internazionale come ministero del tesoro mondiale e le Nazioni unite
come ministero di polizia mondiale, mentre dal punto di vista militare il Giappone è ancora
una sorta di protettorato americano. Come si risolveranno le tensioni di questo periodo
della storia dell'umanità è impossibile dire perché la terza fase del lungo XX secolo è
tuttora in divenire. A conclusione del suo lavoro, chiedendosi quale esito avrà
l'emancipazione del regime di accumulazione dell'Asia orientale dal vecchio regime
statunitense, Arrighi prospetta tre scenari: 1) Gli Stati Uniti potrebbero riuscire ad arrestare
il corso della storia del capitalismo sfruttando le loro capacità belliche e di formazione dello
Stato. Ciò comporterebbe la fine del capitalismo in quanto sistema di accumulazione e di
governo interstatale e la sua sostituzione con un impero mondiale globale statunitense; 2)
Se la vecchia nazione egemone non vi riuscisse, il capitale dell'Asia orientale potrebbe
acquisire una posizione dominante, ma la nuova nazione egemone sarebbe priva delle
capacità belliche e di formazione dello Stato storicamente associate alla riproduzione
capitalistica. Il capitalismo giungerebbe allora a termine come conseguenza non
intenzionale dello sviluppo del mercato mondiale, che si evolverebbe verso un'economia di
mercato dotata di un «ordine anarchico»; 3) Anziché soffocare in un impero mondiale
postcapitalistico o in una società mondiale di mercato postcapitalistica, l'umanità potrebbe
bruciare nella crescente violenza che ha accompagnato la liquidazione dell'ordine della
guerra fredda. In tal caso la fine del capitalismo darebbe luogo a un ritorno al «caos
sistemico», dal quale esso ebbe origine seicento anni fa. Fine del capitalismo, dunque?
Soltanto il tempo darà una risposta a questo interrogativo. Frattanto sembra più prudente,
come lo stesso Hobsbawm ha riconosciuto nel seminario sopra citato, sospendere il
giudizio sulla fine del secolo, piuttosto che datarne la fine al 1898-91. Fermo restando che
anche il modello interpretativo di Arrighi avalla la mia riformulazione dell'ipotesi di Maier
sulla fine dell'età industriale, ritengo comunque che schemi di lungo periodo come questo,
benché necessariamente caratterizzati da un alto grado di astrazione, siano punti di
riferimento essenziali per tentare di ricostruire le nostre coordinate interpretative sull'età
contemporanea, di effettuare una nuova attribuzione di significato alla storia del nostro
tempo. Se le argomentazioni che ho cercato di sviluppare non sono infondate, in ogni
caso, allora è giunto il momento di pensare che le concezioni della storia contemporanea
alle quali ci siamo richiamati sino a pochi anni fa hanno fatto il loro tempo. E di cominciare
a usare tale espressione per indicare un'epoca storica dai contorni ancora indecifrabili
perché essa è appena iniziata, o forse addirittura incipiente.