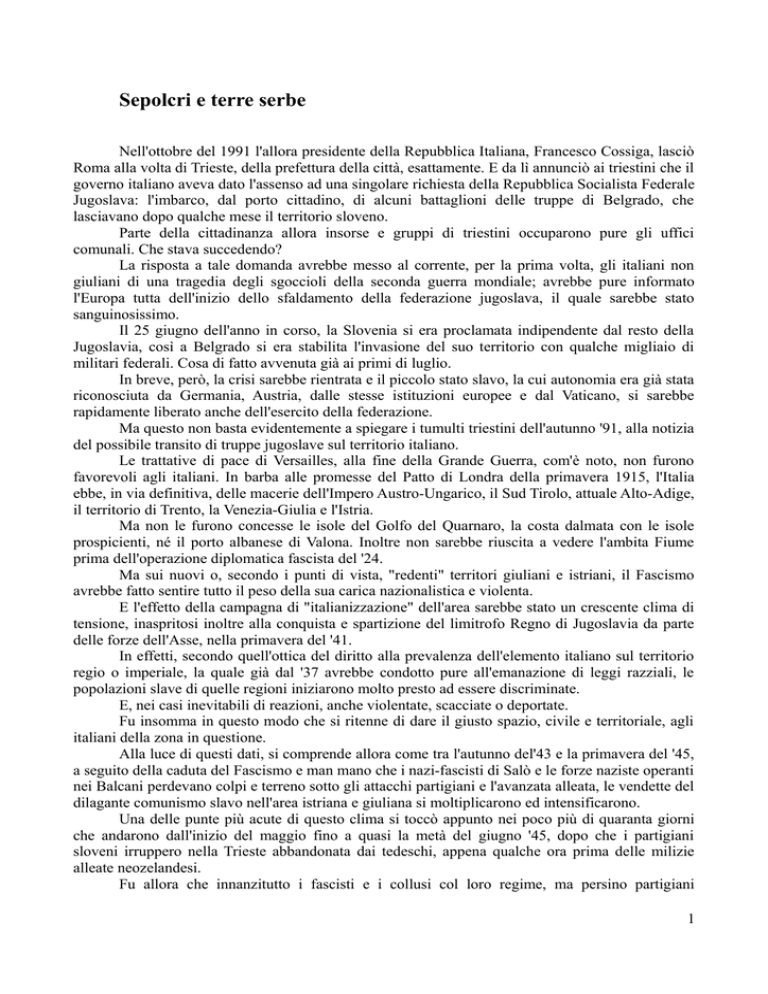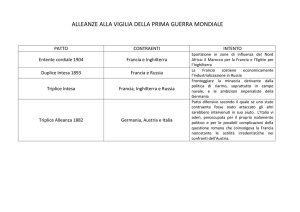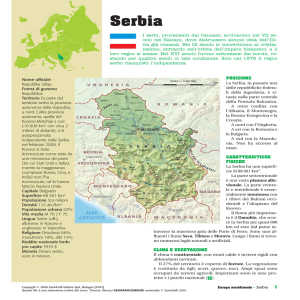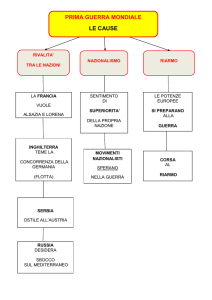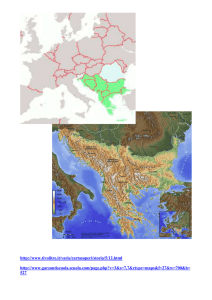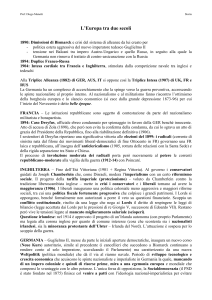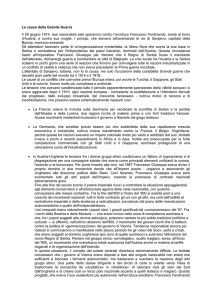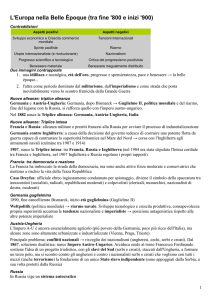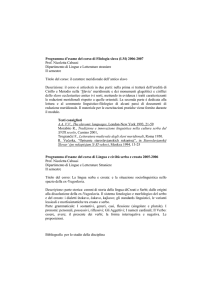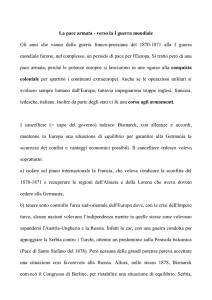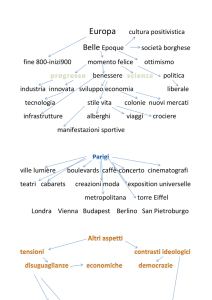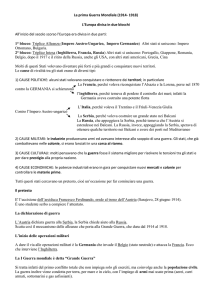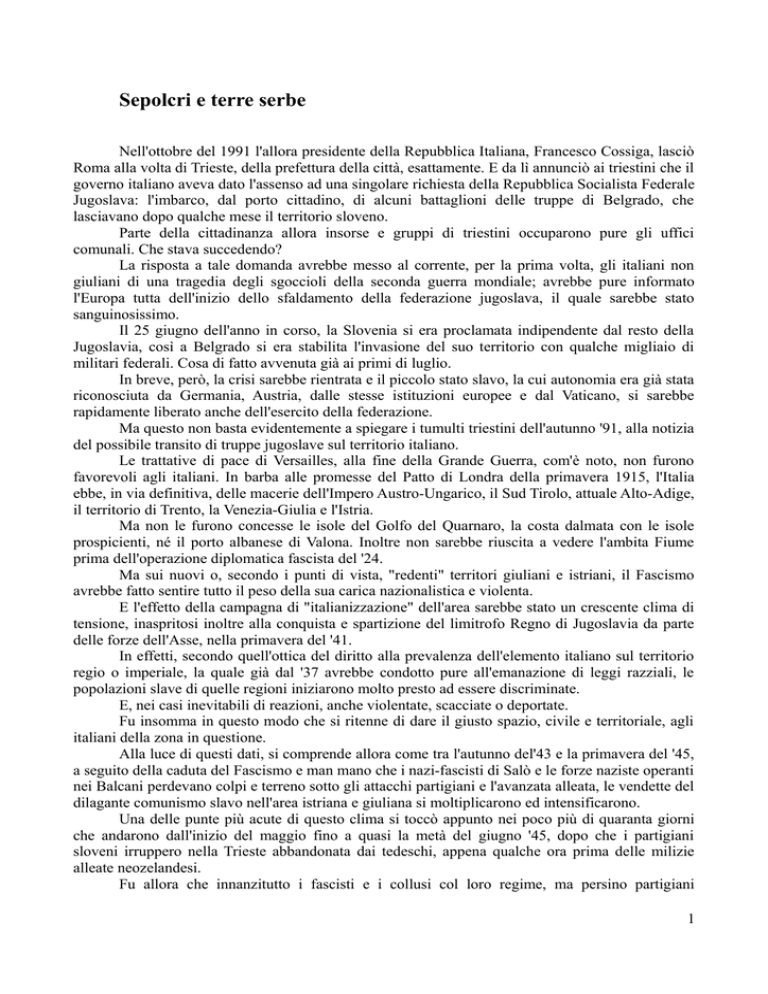
Sepolcri e terre serbe
Nell'ottobre del 1991 l'allora presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, lasciò
Roma alla volta di Trieste, della prefettura della città, esattamente. E da lì annunciò ai triestini che il
governo italiano aveva dato l'assenso ad una singolare richiesta della Repubblica Socialista Federale
Jugoslava: l'imbarco, dal porto cittadino, di alcuni battaglioni delle truppe di Belgrado, che
lasciavano dopo qualche mese il territorio sloveno.
Parte della cittadinanza allora insorse e gruppi di triestini occuparono pure gli uffici
comunali. Che stava succedendo?
La risposta a tale domanda avrebbe messo al corrente, per la prima volta, gli italiani non
giuliani di una tragedia degli sgoccioli della seconda guerra mondiale; avrebbe pure informato
l'Europa tutta dell'inizio dello sfaldamento della federazione jugoslava, il quale sarebbe stato
sanguinosissimo.
Il 25 giugno dell'anno in corso, la Slovenia si era proclamata indipendente dal resto della
Jugoslavia, così a Belgrado si era stabilita l'invasione del suo territorio con qualche migliaio di
militari federali. Cosa di fatto avvenuta già ai primi di luglio.
In breve, però, la crisi sarebbe rientrata e il piccolo stato slavo, la cui autonomia era già stata
riconosciuta da Germania, Austria, dalle stesse istituzioni europee e dal Vaticano, si sarebbe
rapidamente liberato anche dell'esercito della federazione.
Ma questo non basta evidentemente a spiegare i tumulti triestini dell'autunno '91, alla notizia
del possibile transito di truppe jugoslave sul territorio italiano.
Le trattative di pace di Versailles, alla fine della Grande Guerra, com'è noto, non furono
favorevoli agli italiani. In barba alle promesse del Patto di Londra della primavera 1915, l'Italia
ebbe, in via definitiva, delle macerie dell'Impero Austro-Ungarico, il Sud Tirolo, attuale Alto-Adige,
il territorio di Trento, la Venezia-Giulia e l'Istria.
Ma non le furono concesse le isole del Golfo del Quarnaro, la costa dalmata con le isole
prospicienti, né il porto albanese di Valona. Inoltre non sarebbe riuscita a vedere l'ambita Fiume
prima dell'operazione diplomatica fascista del '24.
Ma sui nuovi o, secondo i punti di vista, "redenti" territori giuliani e istriani, il Fascismo
avrebbe fatto sentire tutto il peso della sua carica nazionalistica e violenta.
E l'effetto della campagna di "italianizzazione" dell'area sarebbe stato un crescente clima di
tensione, inaspritosi inoltre alla conquista e spartizione del limitrofo Regno di Jugoslavia da parte
delle forze dell'Asse, nella primavera del '41.
In effetti, secondo quell'ottica del diritto alla prevalenza dell'elemento italiano sul territorio
regio o imperiale, la quale già dal '37 avrebbe condotto pure all'emanazione di leggi razziali, le
popolazioni slave di quelle regioni iniziarono molto presto ad essere discriminate.
E, nei casi inevitabili di reazioni, anche violentate, scacciate o deportate.
Fu insomma in questo modo che si ritenne di dare il giusto spazio, civile e territoriale, agli
italiani della zona in questione.
Alla luce di questi dati, si comprende allora come tra l'autunno del'43 e la primavera del '45,
a seguito della caduta del Fascismo e man mano che i nazi-fascisti di Salò e le forze naziste operanti
nei Balcani perdevano colpi e terreno sotto gli attacchi partigiani e l'avanzata alleata, le vendette del
dilagante comunismo slavo nell'area istriana e giuliana si moltiplicarono ed intensificarono.
Una delle punte più acute di questo clima si toccò appunto nei poco più di quaranta giorni
che andarono dall'inizio del maggio fino a quasi la metà del giugno '45, dopo che i partigiani
sloveni irruppero nella Trieste abbandonata dai tedeschi, appena qualche ora prima delle milizie
alleate neozelandesi.
Fu allora che innanzitutto i fascisti e i collusi col loro regime, ma persino partigiani
1
comunisti e ancora liberali, fedeli al re, cattolici, insomma tutti coloro che avrebbero potuto
comunque costituire un ostacolo all'annessione del territorio triestino alla Slovenia e alla futura
federazione jugoslava, purché catturati, vennero in parte internati, per lo più giustiziati.
E affinché un'eliminazione di tal genere e portata fosse anche sbrigativa e nascosta, a
migliaia i prigionieri furono gettati, spesso ancora vivi, nelle cosiddette "foibe", le naturali e
profonde aperture della montagna carsica, attraversate anche da rivoli sotterranei, le quali già da
mesi costituivano nell'area un facile mezzo di occultamento dei cadaveri o di diretta soppressione
del nemico.
Gli accordi internazionali impedirono però agli sloveni di fare il resto. Ed essi dovettero
lasciare la provincia triestina, come si è detto, intorno alla metà del giugno dello stesso anno.
Di lì a poco venne allora costituito il territorio libero di Trieste, grosso modo comprendente
quest'ultima ed una fascia per lo più costiera fino a Cittanova d'Istria, il quale finiva sotto il
controllo ONU e la cui gestione era anglo-americana quanto a Trieste e dintorni, jugoslava per il
resto.
Nel '54 soltanto Trieste sarebbe tornata sotto amministrazione italiana e solo col Trattato di
Osimo del novembre 1975 la città si sarebbe integrata, a tutti gli effetti, col territorio dello stato
italiano.
Ma i triestini non dimenticarono.
D'altra parte, violenze del tipo di quelle perpetrate a Trieste avevano interessato tutta la zona
giuliana ed istriana; inoltre dall'Istria medesima, all'annessione di essa alla Jugoslavia titina, era
iniziato un esodo in massa di italiani; e contrasti fra triestini e sloveni si erano protratti in
continuazione, anche dopo la fine del conflitto.
La sommossa di Trieste dell'ottobre '91 indusse allora le autorità italiane a chiedere a
Lubiana perché le truppe federali non venissero imbarcate da qualche porto sloveno. La risposta fu
che se lo avessero voluto, a patto di transitare disarmate su territorio sloveno e con la sola eccezione
degli ufficiali, l'imbarco sarebbe avvenuto a Capodistria.
Belgrado accettò. E il contrasto trovò una rapida soluzione.
Nel frattempo la Slovenia si era resa indipendente dalla federazione di Jugoslavia. L'Italia
veniva al corrente del massacro delle "foibe". E Cossiga, dal canto suo, avrebbe forse fatto
ammenda dell'affrettata concessione governativa, non ritardando appunto la sua presenza alla
cerimonia di ricordo dei morti nella foiba di Basovizza.
Rimangono da chiarire allora altri punti. Perché la Slovenia avesse richiesto la secessione e
perché gli organismi federali jugoslavi non si fossero in sostanza opposti alla dichiarazione di
indipendenza.
Nel breve periodo di recessione che l'Europa conobbe tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei
'90, la Croazia e la Slovenia si erano scoperte più ricche e produttive delle restanti repubbliche
jugoslave, dalle quali dunque, in quanto integrate tutte nel medesimo organismo istituzionale ed
amministrativo, si intesero allora anche sfruttate.
Si trattava comunque di comunità di religione cattolica e inoltre, dal punto di vista politico,
contraddistinte come nel passato da forti spinte nazionalistiche. Soprattutto la Croazia. Mentre nel
resto dei Balcani il culto dominante era quello greco-ortodosso, uno minoritario il musulmano e,
perlopiù in Serbia, si erano evolute tendenze politiche neocomuniste.
Uno degli aspetti più romantici del comunismo sta nel vagheggiamento di un regime, che sia
una "grande patria" degli uomini tutti, aliena da confini e limiti temporali. Il comunismo è con tutta
evidenza un'ideologia universalista, la quale sogna rivoluzioni capaci di portare ovunque la
medesima giustizia sociale, di ricucire quindi sotto l'unica bandiera dell'eguaglianza economica i
territori di nazioni divise dall'oppressione capitalistica, imperialistica, nazionalistica borghese.
In effetti, gli stessi tratti dell'antropologia marxiana, consentono con facilità di cogliere una
nozione univoca di natura umana. Quindi anche una sostanziale identità di problemi e di relative
soluzioni esistenziali.
2
Così, una cultura socialista, più o meno spontanea, più o meno propagandata o imposta
dall'alto che fosse, era riuscita in una sorta di miracolo nell'intricata e complicata combinazione di
etnie e culture, tipica dei Balcani: l'assicurazione di una convivenza pacifica per quasi mezzo
secolo, sino alla fine dell'esperienza del socialismo reale negli ultimi anni '80 del secolo passato.
Man mano infatti che tale collante ideologico venne meno, vuoi per l'incapacità delle nuove
generazioni di comprenderlo, vuoi per il disfarsi degli stessi sistemi comunisti, incapaci infine di
garantire alle popolazioni oltre che libertà civili e politiche pure i beni e i servizi essenziali, la zona
balcanica riacquisì improvvisamente la sua storica varietà di culture e tradizioni.
E con essa i contrasti etnici del passato.
E fra tutte le tradizioni riemersero pure le più perniciose: per esempio il nazionalismo ed il
progetto grande-serbo.
Fu nell'epoca romantica e restauratrice, i primi decenni dell'Ottocento, che anche gli slavi,
nell'Est Europa, iniziarono a riconoscersi rappresentanti di una cultura dai tratti essenziali nel
complesso omogenei.
Secondo l'ipotesi più attendibile, infatti, popolazioni già denominabili slave abitarono alle
origini la zona a cavallo delle due regioni della Polesia e della Volinia, rispettivamente il Sud
dell'attuale Bielorussia, il Nord dell'Ucraina di oggi.
Forse a causa di un progressivo aumento demografico, più verosimilmente perché sospinte
da nomadi delle steppe asiatiche o caucasici, intorno alla fine del primo millennio a. C. esse
iniziarono a migrare verso Est, Ovest, Sud.
Così da dare man mano nascita alle etnie russe e rutene, a quelle occidentali polacche, ceche
e slovacche, alla compagine degli slavi meridionali, costituita di Sloveni, Croati, Bosniaci, Serbi,
Macedoni, Bulgari.
Se dunque oggi esiste contiguità tra slavi dell'Est e dell'Ovest, la fascia etnica e linguistica
rappresentata da Magiari e Romeni spezza la continuità slava verso Sud.
In ogni caso, la diffusione degli Slavi in Europa si intensificò a partire dalla metà del primo
millennio dell'era cristiana, cosicché già nel VII secolo la presenza slava nel Vecchio Continente è
un dato importante.
La popolazione in questione, che sciamò appunto in Europa nel corso di quasi mille anni
dopo Cristo, era di tipo patriarcale e stanziale.
Al di sopra della famiglia, essa riconosceva l'esistenza di stirpi e tribù.
Praticava l'agricoltura e l'allevamento e, prima di recepire, probabilmente dagli stessi
Franchi, il sistema feudale, aveva un'organizzazione politica di genere comunitario e democratico.
In concomitanza con la sua espansione dal territorio di partenza, essa venne evangelizzata.
Ad Est da missionari di culto greco-ortodosso, ad Occidente da uomini di chiesa portavoci piuttosto
di una dottrina latino-germanica.
Ciò fa sì che si abbiano veramente poche notizie sulla religione slava delle origini, la quale,
secondo le ipotesi più valide, avrebbe espresso monoteismi dominati da divinità maschili e locali,
diverse eppure sostanzialmente affini, di gruppo in gruppo, di zona in zona.
Ma le differenti sorgenti della conversione, spiegano pure perché già nel Medioevo
l'universo slavo presentasse una spaccatura tra popoli cattolici, vale a dire Polacchi, Cechi,
Slovacchi, Sloveni e Croati, e genti ortodosse, a cominciare dai Russi, per passare a Bielorussi e
Ucraini, fino ad arrivare, nel Sud, a Serbi, Macedoni e Bulgari.
In ogni caso, il vero fattore unitario delle comunità slave era ed è attualmente rappresentato
dalla lingua.
Quest'ultima manifesta innegabili tratti simili di nazione in nazione, e ciò sarebbe il risultato
di una tendenza alla conservazione spontanea di certi caratteri nel tempo o all'evoluzione analoga di
altri all'interno della cultura delle varie stirpi, ma anche dei frequenti contatti storici fra i popoli
dell'etnia in questione.
Linguisti e filologi hanno ricostruito un "protoslavo", una parlata degli slavi delle origini, di
3
cui non esiste alcuna attestazione scritta.
Così, la prima forma di lingua slava della quale si abbia documentazione è il cosiddetto
"paleoslavo" o "antico slavo ecclesiastico".
Di esso è testimonianza la traduzione dal greco della Bibbia, opera dei fratelli Cirillo e
Metodio, i santi evangelizzatori dell'area slava, la quale risalirebbe alla seconda metà del IX secolo.
Si tratterebbe di una parlata bulgaro-macedone, secondo alcuni direttamente ricollegabile a un
ceppo balto-slavo, indirettamente indoeuropea, isoglossa di genere "satəm".
Dal momento della sua creazione, la lingua biblica di Cirillo e Metodio avrebbe svolto il
ruolo di lingua del Testo Sacro e della liturgia ortodossa, funzione equivalente a quella del latino nel
mondo cattolico, se non fosse per il fatto che essa si presentava molto più simile a dialetti dell'area,
di cui veicolava la nuova tradizione religiosa.
Per questo tale lingua avrebbe fortemente influenzato più o meno tutte le parlate slave, in
particolar modo quelle orientali, a partire dal russo e dall'ucraino, e le meridionali, quali il serbo, il
croato, il bulgaro.
Rispetto all'indoeuropeo originario, lo slavo odierno e dei secoli passati offre allora una serie
di precise varianti fonetiche e grammaticali.
Quanto alla fonetica balza infatti all'evidenza come per un verso il paleoslavo presenti
un'opposizione di vocali aspre e velari e di vocali molli, palatali; per un altro una notevole
differenza tra vocali ultrabrevi e vocali molto lunghe.
Dalle vocali indoeuropee *ā e *ō, *e, *ī, *ĭ, *ă e *ŏ, *ŭ, *ū, sono rispettivamente derivate a,
e, i, una ĭ ultrabreve, o, una ŭ ultrabreve, y.
Inoltre, da quel fenomeno già tipico dello slavo ecclesiatico, ovvero la monottongazione di
tutti i dittonghi indoeuropei, derivano pure altri suoni vocalici.
Così da *ai ed *oi, *ei, *au/*eu/*ou, vengono, parallelamente, la vocale molto lunga ě,
un'altra i, quindi un'ulteriore u.
Riguardo infine alle due semivocali indoeuropee, *ii e *ṷ, dobbiamo allora dire che nel
paleoslavo la prima è proseguita in j, l'altra si è consonantizzata nella labiodentale sonora v.
Da notare inoltre la protesizzazione paleoslava di una semivocale per lo più avventizia,
scomparsa dunque nello slavo moderno, davanti a parola iniziante con determinate vocali.
Così la *ĭ iniziale diventa jĭ-, che poi si contrae in i-; *e- diviene je-; infine *ŭ- si evolve in
vŭ-.
Altre vocali paleoslave sono i due suoni nasali ę ed ǫ. Essi sono appunto il frutto della
vocalizzazione delle due sonanti nasali indoeuropee *ṃ ed *ṇ in posizione anteconsonantica,
successivi quindi a morfemi radicali al grado vocalico zero.
Quanto al consonantismo, il paleoslavo è evoluzione dell'indoeuropeo in alcune direzioni
fondamentali.
Innanzitutto, in relazione alle occlusive, esso presenta una riduzione delle medie aspirate
indoeuropee labiali, dentali e labiovelari, *bh/*dh/*gh, e *guh, rispettivamente nelle corrispondenti
medie b/d/g; offre quindi velari sorde, k e g, o come continuazione delle indouropee *k e *g/*gh o
invece derivazione delle labiovelari precedenti *qu e *gu/*guh; ma soprattutto palatalizza le velari in
questione davanti a vocali di timbro e ed i, generando l'affricata sorda č da k, da g la sibilante
sonora ž; infine il paleoslavo si caratterizza pure per l'assibilizazione delle velari palatali *kk e *g
rispettivamente nelle due spiranti alveolari, sorda e sonora, s e z.
Quest'ultima trasformazione ne segna appunto l'appartenenza al gruppo indoeuropeo di
denominazione "satǝm", com'è noto distinto dall'altra grande isoglossa indoeuropea, costituita
invece dalle lingue cosiddette "kentum", le quali fanno confluire le antiche palatali nelle
corrispondenti velari.
La differenza in questione è allora comprensibile se si guarda al termine indoeuropeo delle
origini, "*kkṃtom", il numerale cardinale in italiano reso da "cento", cui si fa appunto riferimento.
Quanto alle restanti consonanti, stavolta non occlusive, si è già indicata la scomparsa delle
4
sonanti nasali indoeuropee, seguite da consonanti, precedute da morfemi radicali al grado vocalico
zero.
Lo stesso fenomeno si verifica con la nascita di un suono vocalico seguente alle altre due
sonanti indoeuropee, le liquide laterali o vibranti *ḷ ed *ṛ, ugualmente posizionate, e cioè con la
relativa consonantizzazione di queste ultime nei gruppi lu/li, ru/ri.
Infine, nei casi in cui le consonanti originarie *l/*r, *m/*n, si vennero a trovare tra radice al
grado zero e vocale, si sviluppò una vocale i davanti a ciascuna di esse, secondo l'esito il/ir, im/in.
Lo slavo moderno conserva grosso modo i tratti fonetici elencati.
Varianti di rilevanza sono allora un successivo sviluppo della sibilante alveolare sorda s
nella palatale corrispondente š dopo i, u, r, k, quindi la sua evoluzione nella consonante doppia x; e
ancora una seconda palatalizzazione in c e dz/z rispettivamente delle gutturali k e g davanti a vocali
palatali secondarie: cioè quasi sempre prima della ě o di una ī derivanti dalla monottongazione di
*ai, *oi, dittonghi ancora evidentemente intatti ai tempi della prima palatalizzazione delle medesime
velari.
Non dimentichiamo infine la conservazione, in rari casi, di sonanti indoeuropee
interconsonantiche, come nel caso della *ṛ del serbo-croato "Trst", Trieste, o del ceco "Brno".
Per ciò che concerne l'alfabeto, occorre sottolineare che la traduzione biblica dei fratelli
Cirillo e Metodio avvenne con lettere da essi stessi allo scopo create, nel complesso costituenti il
cosiddetto alfabeto "glagolitico".
Oggi, come sappiamo, i popoli slavi ortodossi si servono del cirillico, dell'alfabeto latino
fanno invece uso i cattolici, cioè polacchi, cechi, boemi, moravi, sloveni e croati.
Anche dal punto di vista grammaticale lo slavo moderno ha mantenuto caratteristiche
fondamentali, già tipiche dello slavo ecclesiastico.
Innanzitutto si tratta di una lingua agglutinante, flessiva, dalla morfologia fusiva.
Le lingue slave inoltre, ad eccezione del bulgaro e del macedone che li hanno perduti tutti,
hanno mantenuto fino ad oggi sette degli originari casi indoeuropei, compresi lo strumentale e il
locativo, ma con la scomparsa dell'ablativo, le cui funzioni e uscite sono state progressivamente
assorbite dal genitivo.
Quest'ultimo nello slavo moderno ha finito per assolvere spesso pure i compiti
dell'accusativo, quasi fosse un genitivo di quantità: pensiamo, per intenderci, alle espressioni
italiane "vorrei acqua" e "vorrei dell'acqua".
E tale fenomeno risulta oggi una costante nelle proposizioni con oggetto e negative.
Lo slavo moderno presenta poi morfemi specifici per le due categorie dell'"animato" e
dell'"inanimato" ed ha mantenuto, sin dai tempi del paleoslavo, i tre generi, maschile femminile e
neutro.
Inoltre, gia lo slavo ecclesiastico offriva una doppia flessione per l'aggettivo: una per
l'indeterminato, una seconda per il determinato. Insomma, mentre in italiano o nel francese o
l'inglese la determinazione viene dall'articolo, nell'aggettivo paleoslavo essa è segnata da un suffisso
postdesinenziale, -ji/-ja/-je, che ha il valore del dimostrativo "quello, quella, quello (neutro)".
Si pensi ad esempio all'opposizione "nova/novaja", cioè "una nuova/la nuova".
Lo slavo è ancora una lingua rimasta fedele all'aspetto verbale, caratteristico pure di diverse
parlate indoueropee, la quale si distingue pure per lo sviluppo di un'ulteriore participio, oltre a quelli
dei singoli tempi, detto "resultativo" e riscontrabile nella formazione di un perfetto perifrastico in
combinazione col verbo "essere".
Nello slavo ecclesiastico il participio in questione presenta un'uscita in -lo, poi oscuratasi ed
abbreviatasi in -lŭ.
Altri tratti tipici dello slavo moderno sono la definitiva trasformazione dell'originaria
desinenza -bh in -m, la scarsità di vocoidi, la tendenza infine a gruppi consonantici complessi,
soprattutto presso gli slavi occidentali. Pensiamo per esempio al polacco "bezwzględny", ovvero
"assoluto".
5
Quando allora, nel pieno dell'età della Restaurazione, si rafforzò l'idea di un'entità etnica e
civile slava, l'identificazione di quest'ultima fu innanzitutto fondata appunto sulle evidenti
comunanze linguistiche degli idiomi di date nazioni.
E' noto che nel corso del periodo romantico si assistè alla riscoperta dei concetti di popolo,
tradizione, civiltà.
Ma è anche comprensibile come l'area di espansione di una certa cultura, nel momento
stesso della definizione di quest'ultima, non sempre si estendesse su regioni sotto il controllo di una
o più autorità politiche espresse dalla cultura stessa.
All'epoca, anzi, risultavano veramente poche le civiltà eventualmente delimitabili rispetto al
territorio e dotate d'amministrazione propria.
Nel caso poi di quelle che vennero catalogate come popolazioni slave, la situazione
appariva, sotto il profilo politico, deprimente.
Boemi, Cechi, Moravi, Sloveni e Croati cadevano a quel tempo sotto l'autorità imperiale
austro-ungarica; Bosniaci, Serbi, Montenegrini, Macedoni, Bulgari, grosso modo gli slavi a Sud del
Danubio e della zona balcanica abitavano, peggio ancora, sangiaccati turchi.
La situazione era forse in tal senso migliore per i Polacchi, gli Ucraini, i Bielorussi, inclusi
nel vasto territorio amministrato dall'Imperatore russo.
Con tutta evidenza, dunque, il Congresso di Vienna, non aveva tenuto in nessun conto
l'esistenza o perlomeno le specifiche esigenze di popolazioni "slave".
Per primo lo scrittore slovacco Jan Kollár nel suo saggio "Sulla reciprocità letteraria dei
diversi ceppi e dialetti della nazione slava" del 1836, isolò alcune parlate di determinate zone
dell'Europa orientale e meridionale, di cui sostenne un'origine comune.
Siamo allora, con l'opera in questione, di fronte ad uno dei primi tentativi di linguistica
orientata alla ricostruzione di una lingua "protoslava".
Lo stesso Kollár fu l'autore di altre opere di poesia e di indirizzo patriottico, per esempio
"Slávy Dcera", "la figlia di Slava", le quali guardavano ad un mitico passato slavo e costituivano,
con quelle storiografiche ed etnografiche di altri scrittori, quali Josef Dobrovský, Pavol Josef
Šafařik, anch'essi cittadini slavi dell'Impero austro-ungarico, la testimonianza della nascita di una
nuova corrente romantica.
L'idea di una civiltà comune, e con aspetti pure gloriosi, diffusa in tutta l'Europa Orientale,
tranne che in nazioni quali la magiara, la romena, quella greca, si sviluppò dunque già in età
napoleonica e fra le èlite intellettuali dell'Impero asburgico.
Ed assieme ad essa appunto quell'ideologia successivamente denominata "panslavismo".
Il panslavismo è una corrente di pensiero di genere romantico, fondata sulla convinzione
nell'esistenza di precise costanti civili, identificanti le genti slave, postulante allora la necessità se
non dell'unificazione politica di queste ultime, almeno di una data forma di solidarietà tra di esse.
Essa nacque nei circoli colti dei paesi slavi sotto la dominazione asburgica, ed inizialmente
si limitò ad un'ipotesi di federazione a questi limitata e comunque integrata nelle maglie del sistema
politico ed amministrativo austroungarico.
Per questo tale prospettiva sarebbe stata indicata come "austroslavismo".
In ogni caso, al primo congresso panslavo in assoluto, il quale si tenne a Praga nel 1848,
furono convocati anche delegati di popolazione slave diverse da quelle governate dall'Imperatore
austriaco.
La riunione fu presieduta da František Palacký. Era costui uno storiografo dei paesi cechi,
un membro del suddetto gruppo di intellettuali patrioti, il cui obiettivo era la costituzione di una
federazione dei paesi asburgici, nei quali fosse garantità l'indipendenza delle nazioni slave e magari
anche la possibilità di relazioni politiche speciali fra esse.
Convennero allora al congresso 340 delegati, tra polacchi, ucraini, rappresentanti dei popoli
slavi balcanici, oltreché naturalmente delle nazioni sottoposte al regime asburgico. Ne scaturì
l'approvazione di un romantico, generico manifesto rivendicante parità di diritti politici fra le
6
nazioni d'Europa, ma nessun programma concreto di azione, al conseguimento di un obiettivo del
genere volta.
Insomma, la situazione sancita dal Congresso di Vienna non ricevette di sicuro minacce
dall'altro congresso, il panslavo. Una novità destinata a riproporsi sarebbe stata invece la scelta di
una bandiera slava: un tricolore a strisce orizzontali, della stessa altezza, in ordine e dal basso rossa,
bianca e blu, il quale, come sappiamo, sarebbe poi divenuto l'insegna ufficiale dei successivi regno
e federazione socialista jugoslavi, nonché della Russia post-comunista.
Il panslavismo subì un'evoluzione nella seconda parte del secolo, quando appunto nella
cultura russa il suo nucleo ideale si fuse col mito della "Terza Roma" moscovita, ovvero di
un'ulteriore capitale civile, universale, dopo la Roma vera e propria delle origini e Costantinopoli.
Questa posizione, ugualmente romantica, vedeva nella Russia zarista, assolutista e
autocratica, un centro di civiltà tradizionale, antioccidentale, agli antipodi rispetto alle ideologie
laiche, liberali o peggio ancora socialiste del Vecchio Continente, dalla fede infine genuinamente
cristiana e ortodossa.
Su questo retaggio si innestò allora il panslavismo, con il risultato della nascita di un
progetto, aspirante alla federazione politica di tutte le genti slave sotto la guida della nazione
eurasiatica, con cui esse condividevano i tratti etnici ed il culto cristiano, nella maggior parte dei
casi ortodosso.
Del resto la civiltà russa, con i suoi innumerevoli agglomerati di contadini organizzati nei
"mir", testimoniava meglio che le altre le tendenze comunitarie e democratiche ascritte allora alle
stirpi slave delle origini e storiche, il loro presunto aspetto naturalmente solidale.
Così, già negli anni '60 dell'Ottocento il "Grande Panslavismo", quello incudente la Russia,
anzi a questa assegnante il ruolo riunificatore dell'Oriente europeo, era decollato. Anche se proprio
intorno alla metà del secolo nacquero o si acuirono i contrasti tra certi paesi o popoli slavi;
nonostante gli Zar finissero presto per fare dell'aspirazione in questione il semplice, calzante
fondamento ideologico di una politica imperialistica, il cui scopo immediato e realistico era la
conquista strategica degli stretti governati dai Turchi: Dardanelli e Bosforo.
Tuttavia la strana convivenza di aspirazioni panslave e interessi mediterranei, alla corte
imperiale russa esisteva da secoli.
Uno dei vanti personali dello zar Pietro il Grande era stata la conquista della fortezza turca
di Azov, alle foci del Don, sul mare omonimo, all'ingresso del Mar Nero.
Essa avvenne nel 1696. Ma gli accordi di Belgrado del 1739, che la ratificavano, impedirono
comunque alla Russia l'accesso al mare a partire dalla città acquisita.
Tale ingresso fu in ogni caso ottenuto dall'Impero russo sotto Caterina II, la Grande, con la
vittoria nel conflitto russo-turco tra il 1768 ed il '74: quello chiusosi con la resa di Nicopoli e la
stipula del trattato di Kuciuk Kainargi.
Segnando infatti l'annessione russa dello Jedesan, della Cabardia e dei porti crimeani di Kerc
ed Enicale, quindi l'accesso al mare da Azov e l'indipendenza dai turchi dell'intero canato tartaro di
Crimea, destinato nel volgere di pochi anni all'inglobamento nella Russia, il trattato in questione
sanciva il controllo zarista della costa Nord ed Est del Mar Nero.
Ma diceva pure altro.
Che allora le navi russe avevano diritto al transito per lo stretto di Dardanelli e il canale del
Bosforo; che l'Impero russo poteva riservarsi il diritto di protezione dei fedeli greco-ortodossi, sul
vasto territorio turco.
E a nulla sarebbe valso il nuovo conflitto, scatenato stavolta dagli Ottomani, tra l'87 e il '92.
Comunque sia, quando i pensatori slavofili manifestavano le proprie opinioni in merito alle
differenze civili tra Europa dell'Ovest e dell'Est, la cosiddetta "Questione d'Oriente", concernente le
sorti del territorio del vastissimo e fragile Impero Ottomano, disteso fra Egeo e Mediterraneo, Mar
Rosso e Nero, si era da un pezzo imposta.
Ed uno dei problemi nei quali si articolava, era quello dell'accesso all'Asia via Mediterraneo
7
da parte delle potenze occidentali.
La Russia infatti, secondo quanto appena detto, usufruiva già da un pezzo degli stretti, ma
non li controllava, e tale situazione era sostenuta da paesi come Francia e Inghilterra, preoccupati
della politica espansionistica e della cultura antioccidentale di quella nazione, da sempre tesa più
all'imperialismo che all'affarismo.
D'altra parte, la contesa sul territorio di un'autorità in progressivo disfacimento, era già sorta
agli inizi dell'Ottocento, quando l'albanese Muhamet Alì, divenuto pascià della provincia egiziana,
vi aveva iniziato una politica sostanzialmente indipendente dalle decisioni del sultano, dando
origine ad un "kedivato", un viceregno, autonomo.
Ma essa esplose sicuramente con la conquista dell'indipendenza da parte dei greci.
Si trattò dell'epilogo di una cruenta guerra, chiusa dalla resa turca e dal Trattato di
Adrianopoli del 1831, dal quale i greci ottennero comunque un solo paio di regioni di quello che
sarebbe stato il successivo paese, quindi il governo di una dinastia tedesca, con cautela concordata
dagli alleati inglesi e russi.
La seconda tappa della questione orientale si sarebbe poi identificata con la "Guerra di
Crimea", la quale nel triennio '53/'56 vide contrapporsi Turchia, Inghilterra, Francia e Italia da un
lato e Impero russo dall'altro.
Il conflitto nacque con l'invasione dei principati turchi di Moldavia e Valacchia da parte
della Russia: lo zar puntava infatti, secondo un piano corroborato da retorica e ideologia panslave,
ad un protettorato su popoli balcanici di fede ortodossa e dominio ottomano.
Così, anche se sotto la pressione diplomatica austriaca e prussiana, lo zar cedeva sul ritiro
dai principati danubiani, Francia e Inghilterra, nel '54, avevano ormai avviato la spedizione in
soccorso della Turchia, cui avrebbe contribuito poi, e per i noti interessi risorgimentali, anche un
battaglione italiano di circa 15000 uomini al comando del La Marmora.
In ogni caso, l'espugnazione della fortezza di Sebastopoli, sulle coste della Crimea, e la
conseguente sconfitta russa dell'estate '56, stando alle decisioni del Congresso di Parigi, non
avrebbero mutato la situazione politico-territoriale sancita a Vienna quarant'anni prima.
In tal modo l'Impero russo non aveva ottenuto nulla, se non il deteriorasi definitivo dei
rapporti con quello austroungarico. Inoltre il suo progetto panslavo e mediterraneo subiva una
prima battuta d'arresto.
Tuttavia, l'idea di un Oriente europeo slavo e a guida russa era ancora vitale.
Nel 1871 lo scrittore e politico filoslavo russo Nikolaj Jakovlevič Danilevskij pubblicava a
San Pietroburgo "La Russia e l'Europa", opera chiave del panslavismo, nella quale l'intellettuale
svolgeva essenzialmente un'analisi della situazione balcanica e delle possibilità d'azione e
penetrazione, che essa concedeva all'Impero zarista.
Ma il Danilevskij andava anche oltre.
Egli sosteneva una sorta di primato della civiltà slava su quella occidentale, propugnava
allora la riunificazione politica di tutti gli slavi in una federazione con a capo la Russia e capitale
Costantinopoli e, al motto "Dall'Adriatico al Pacifico, dai mari polari all'Egeo", nel rispetto della
spaccatura segnata tra Ovest ed Est dalla nota linea Trieste-Stettino, immaginava un unico grande
organismo politico slavo, inclusivo pure di Ungheresi, Romeni, Greci.
Genti che egli considerava ormai slavizzate, soprattutto le due ultime, perché partecipi della
comune fede ortodossa.
Gli fecero eco, di lì a poco, altri due scrittori connazionali, interessati però più alle
definizioni etiche e civili che ai disegni politici.
Il celebre romanziere Fëdor Dostoevskij, nel suo "Diario di uno scrittore", il medico e
monaco Kostantin Nikolaevič Leont'ev, in "L'Oriente, la Russia e gli Slavi", videro appunto nella
Russia l'alveo del genuino cristianesimo, l'ortodosso.
Essi espressero una serrata critica al culto cristiano occidentale, cattolico, protestante e
anglicano, dal loro punto costituente una deviazione dal vero messaggio evangelico, nonché al mito
8
borghese e liberale, altrettanto europeo, della ricchezza e della prosperità economica; si
pronunciarono invece a favore di un'etica della santità e del rispetto della tradizione, tipica, a loro
giudizio, dell'animo del popolo russo e delle genti slave di culto ortodosso.
E se Dostoevskij avrebbe voluto allora una politica disinteressata della Russia nei confronti
degli altri popoli fratelli, slavi e ortodossi, fatta di solidarietà, alleanza e protezione, Leont'ev, il
quale nell'Occidente vedeva un mondo sulla strada della decadenza, si faceva fautore di una politica
di espansione spirituale della sua patria verso Est, in direzione di India e Cina.
Nel frattempo, esattamente nel 1860, era per la prima volta nato a Mosca un comitato
panslavo ad opera di un gruppo di intellettuali slavofili e sotto la direzione di Mikhail Pogodin.
Appunto sotto la spinta del "Moscow slavic benevolent committee", nel 1869, a Mosca
stessa, venne organizzato un nuovo Congresso panslavo. Mentre le idee del comitato di riferimento
si diffondevano con tale rapidità ed entusiasmo, che nuove sedi di esso erano aperte a San
Pietroburgo, Kiev, Odessa.
In questo clima, una serie di eventi segnano la nascita di una parte consistente dell'attuale
Europa dell'Est ma, al contempo, la fine del sogno di un panslavismo a guida russa.
Già nel 1875 tumulti popolari contro la dominazione turca si erano verificati in Bosnia e
Serbia.
La stessa cosa sarebbe avvenuta l'anno successivo in Bulgaria, ma in proporzioni maggiori,
cosicché la durissima repressione turca avrebbe dato origine a quelli che la stampa internazionale,
soprattutto inglese, definì "orrori bulgari".
D'altra parte, al Congresso di Costantinopoli della fine del 1876, cui convennero i delegati di
diversi paesi europei e convocato con l'obiettivo di una soluzione all'arretratezza dell'Impero
ottomano, il sultano promise una costituzione, che in seguito non avrebba mai concessa.
Allora questi dati, che fomentavano il nazionalismo slavo, la possibilità di svincolarsi da
alcune clausole del trattato di Parigi offerta dallo scontro franco-tedesco, nonché il continuo
miraggio del possesso di una zona delicata, per la quale passava una rilevantissima percentuale del
commercio russo nel Mediterraneo, indussero la corte zarista a preparare e scatenare l'ennesimo
conflitto russo-turco, quello del biennio '77/'78.
La cui base propagandistica fu appunto fornita allora dal progetto di riunificazione panslava
sotto l'egida moscovita.
D'altra parte, l'indifferenza turca rispetto ad ogni miglioramento delle condizioni politiche
delle popolazioni balcaniche assoggettate e la ferocia delle recenti repressioni, avevano finito per
alienare al sultano persino l'interessato appoggio inglese.
L'aggressione alla Turchia sarebbe infatti partita una volta che l'Inghilterra ebbe dal governo
dello zar garanzie sull'integrità dell'Egitto, nonché sull'arresto a debita distanza da Istanbul
dell'auspicata e progettata avanzata delle truppe imperiali in territorio tracio.
La vittoria fu russa e vantagiossima per l'autocrazia zarista fu pure la sorte di un'ingente
zone balcanica e tracia, da secoli turca, alla Turchia stessa imposta col trattato di Santo Stefano, la
cui sigla data il 13 giugno 1878.
La novità più consistente era la nascita di una "Grande Bulgaria", la quale si estendeva dal
Mar Nero all'Egeo, penetrava abbondantemente nei balcani e, benché restasse ancora tributaria
dell'Impero ottomano, finiva sotto il protettorato russo.
Ma non meno importante appariva il conseguimento dell'indipendenza di una serie di
nazioni balcaniche, vassalle del sultano.
Insomma, Santo Stefano sanciva la fine della Turchia europea, l'accesso della Russia,
diretto, al Mediterraneo ed un grande trionfo per il panslavismo.
Troppo e tutto d'un colpo. Almeno per le democrazie occidentali, liberiste e con grossi
interessi in Oriente.
In men che non si dica, con la mediazione di Bismark, si riunirono a Berlino le diplomazie
russa, turca, inglese, francese, austriaca e italiana, ed il risultato del confronto non riuscì affatto
9
gradito agli slavofili e ai panslavisti russi.
Il Trattato di Berlino, di appena un mese successivo a quello di Santo Stefano, confermava la
nascita di Serbia, Montenegro e Romania, ma assegnava all'Austria l'amministrazione della Bosnia,
ad Austria e Turchia la gestione congiunta del Sangiaccato di Novi Pazar, strategicamente vitale,
poiché interposto tra Montenegro e Serbia; legittimava sì una lieve estensione della Russia stessa
nella regione della Bessarabia, ma riduceva drasticamente la "Grande Bulgaria".
Questa perdeva l'agognato sbocco slavo sull'Egeo e rientrava così tanto a Nord della Tracia,
da esser limitata a Sud dalla regione della cosiddetta "Rumelia orientale": regione cuscinetto,
dell'Impero turco, ma con una certa autonomia, a cui gli inglesi si affrettarono ad imporre il
suddetto nome al posto della pericolosa denominazione di "Bulgaria meridionale".
In tal modo la Turchia manteneva la sua presenza balcanica dagli stretti fino all'Adriatico;
l'Impero russo seguitava ad esser tagliato fuori dall'Egeo e dagli ambiti stretti; infine, come
compenso del generoso aiuto, la Gran Bretagna otteneva dai turchi Cipro, la Francia mano libera
per la colonizzazione della zona tunisina.
Lo scavo francese del Canale di Suez ad opera del De Lesseps, tra il '59 ed il '69, aveva
comunque da un pezzo spostato l'attenzione degli inglesi verso l'Egitto, ridotto, con un'operazione
che creò forte tensione con la Francia stessa, a protettorato della corona nel 1881.
Intanto però, il decisivo peso dell'Inghilterra negli accordi di Berlino, aveva fornito la spinta
verso quella sistemazione territoriale, che in Russia provocò lo sdegno degli slavisti e, di fatto,
condusse alla fine l'ideale di un panslavismo a guida russa.
La delusione per la cessione agli interessi dell'affarismo occidentale, a scapito della libertà di
diverse terre slave, di tanti fratelli ortodossi, quindi del diritto russo ad una legittima presenza sul
Mediterraneo fu tale, che nello stesso anno del Trattato di Berlino il "Committee" si sciolse, le sue
sedi scomparvero.
Ma non tutto era finito.
Con l'indipendenza della Serbia, poteva finalmente, dopo secoli di repressione e controllo
turchi, riprendere piede un'altro genere di nazionalismo slavo: il "panserbismo".
Di esso, il primo segnale chiaro sarebbe stata la guerra serbo-bulgara di appena qualche
anno dopo il '78, cioè uno scontro stavolta tra slavi e dalla Serbia stessa, con un pretesto, scatenato.
Sostiene un celeberrimo adagio serbo che "laddove c'è la tomba di un serbo, lì c'è la Serbia".
D'altra parte il motto nazionale serbo è: "I Serbi vincono, se uniti.".
Dunque, tirando le conclusioni da simili sentenze, si giunge ad immaginare il presunto tratto
speciale del popolo in questione, cui spetterebbe il controllo della terra ospitante la semplice
sepoltura di uno dei suoi e di vittoria capace solo se coeso, non frammisto cioè ad altre etnie.
E infatti, da secoli una corrente di pensiero coltiva l'idea della santità serba, attribuisce cioè
il pregio dei pregi individuali ad una nazione tutta.
Le immagini di rubiconde contadine serbe, dal fazzoletto nero in testa, che si portano la
mano al petto e la liberano distendendone solo indice, medio e anulare verso le truppe nazionali in
marcia, il medesimo omaggio ai tifosi del calciatore di Belgrado o di cittadini di Bor, affollati, verso
il palco di una manifestazione, costituiscono di ciò prova oculare.
Comunicano infatti la convinzione in una sorta di trinità serba le dita allungate a ricordare i
valori di Dio, patria, famiglia.
Il popolo serbo sarebbe allora quello "santo": così la terra su cui vive gli verrebbe destinata
da Dio; e da Dio stesso le sue famiglie sarebbero pure benedette.
La storia serba è da sempre quella di un tale modo di vedere le cose o almeno anche di esso,
fra altre impostazioni.
E' la narrazione di un nazionalismo neanche riducibile alla normale equazione romantica tra
natura e civiltà, etnia e ideologia, secondo la quale una cultura emergerebbe comunque dalle pieghe
di una modalità dell'indole, esemplificando la gente in questione la vittoria finale dello spirito sulla
materia.
10
Se infatti Dio avrebbe eletto gli Ebrei a gente consacrata alla Rivelazione, dal punto di vista
dei nazionalisti serbi il loro sarebbe il popolo capace del rapporto corretto col Padreterno, portatore
cioè della vera fede cristiana.
Ma, paradossalmente, Dio solo sa a cosa tale forma di ultraromanticismo abbia in diverse
occasioni condotto.
Insomma, nel Romanticismo vero e proprio le cose sono più semplici e le pretese del
nazionalista forse minori.
Credere di essere il "popolo santo", il quale avrebbe dunque diritto alla terra sui cui per
volontà imperscrutabile e superiore risiedesse, vuol dire allora sostenere una tesi incapace di
poggiare su dati oggettivi, da chiunque raggiungibili, semplicemente associare ad un'etnia e una
cultura un certo attributo di santità.
E toccare, di conseguenza, i vertici del ridicolo.
Infatti, la santità cristiana impone in ogni caso l'adesione ad una Rivelazione, per cui è
possibile solo l'individuo "santo", mai intere popolazioni, figurarsi nazioni determinate!
La prova dunque della distanza tra la prospettiva panslava ed il panserbismo è fornita dal
sostanziale dinteresse della stessa Serbia nei confronti di una Bulgaria pressocchè priva di
insediamenti storici di propri connazionali e, al contempo, dalle sue costanti mire nei confronti dei
restanti stati balcanici, da sempre ospitanti più o meno numerose, compatte comunità serbe.
Eppure l'etimologia del termine "Jugoslavia" attesta come esso designi, nel complesso, la
"terra degli slavi", "-slavia", "del Sud", "Jugo-". Bulgari, va da sé, inclusi.
Nel settembre del 1885 la Bulgaria si annetteva la regione al confine Sud, ovvero la Rumelia
orientale, con capitale Plovdiv, Filippopoli per gli occidentali.
Si trattava del territorio compreso tra i monti Rodopi e Balcani, cioè come già detto di una
provincia dell'Impero turco relativamente autonoma, in maggioranza bulgara, in misura minore
popolata da traci e greci.
A questa evidente violazione del trattato di Berlino non reagì neanche la Turchia. Provvide
però la Serbia.
Che ai serbi poco interessasse la Rumelia, con la quale il loro stato non spartiva né confini,
né connazionali, né importanti interessi, era chiaro.
Esistevano invece da un pezzo frizioni alla frontiera tra Serbia e Bulgaria: quest'ultima
ospitava così dissidenti serbi, mentre della prima era ormai nota l'intenzione di estendersi ad Est a
tutela di propri villaggi e postazioni militari, per motivi politici o accidentali finiti in territorio
bulgaro.
In ogni caso il conflitto durò poco, nella seconda metà del novembre dello stesso '85. Alla
minaccia di un intervento austriaco in appoggio alla Serbia, sconfitta e persino invasa, la Bulgaria
isolata e vincente cedette.
Con la pace di Bucarest del 1886 essa inglobò allora ufficialmente la Rumelia e mantenne
intatti tutti i confini precedenti. E la conseguente rinuncia serba a poche e limitate zone oltre
frontiera segnò la fine della solidarietà tra i due stati balcanici.
Ai congressi panslavi di Praga, del 1908, e addirittura di Sofia, del 1910, nei quali l'universo
slavo tese a ridefinirsi emancipandosi dalla tutela russa, i bulgari rimasero tagliati fuori da ogni
ipotesi di federazione.
Si pensò infatti allora di costituire tre organismi politici: gli slavi dell'Est, Polacchi e
Ucraini; dell'Ovest, Boemi, Moravi e Slovacchi; e del Sud, ovvero Serbi, Croati, Sloveni e Dalmati.
Quando poi, nel dibattito politico in seno all'Impero Austro-Ungarico, alla tradizionale
impostazione amministrativa dualistica, si affiancò l'idea del cosiddetto "trialismo", che vedeva
nell'ulteriore autonomia della zona dei popoli balcanici un limite al peso interno ungherese ed alle
velleità panserbe, l'iniziativa venne accolta male non solo dagli stessi Magiari o dai centralisti di
Vienna o dagli irredentisti italiani o dai nazionalisti pancroati, ma anche e peggio dai Serbi.
E un commando terroristico serbo, per mano dello studente Gravilo Princip, alla fine del
11
giugno del 1914, a Sarajevo, assassinò appunto uno dei maggiori fautori del sistema trialistico,
l'erede al trono asburgico arciduca Francesco Ferdinando.
Provocando lo scoppio del primo conflitto mondiale.
Ma già poco prima, nelle due guerre balcaniche, si erano rivelate con nettezza le aspirazioni
serbe.
Nel 1908 uno preciso contatto tra Austria e Turchia si era concluso con la totale annessione
austriaca della Bosnia-Erzegovina, quindi con quella turca del sangiaccato di Novi Pazar, tra Serbia
e Montenegro.
Tra nazioni che vi videro un danno alla loro politica estera e stati intenzionati a strappare
territorio ai turchi, sotto la spinta della stessa Russia, si costituì allora in funzione antiturca una lega
balcanica, la quale nel '12 sconfisse gli ottomani, ma i cui membri non si accordarono sulla
spartizione delle terre conquistate nell'immediata pace di Londra.
La questione più spinosa riguardava l'attribuzione della zona macedone al confine fra Serbia,
Grecia e Bulgaria. Essa si risolse con un accordo tra serbi e greci, quindi con l'ulteriore conflitto del
'13, in cui stavolta la Bulgaria, insoddisfatta, aggredì Serbia e Grecia.
La capitolazione bulgara, sancita dalla pace di Bucarest del '13, vide la Macedonia spartita
tra greci e serbi, inoltre la cessione da parte dei bulgari di parte della Dobrugia alla Romania e della
propaggine tracia fino ad Adrianopoli alla Turchia.
Infatti, approfittando delle difficoltà bulgare, questi ultimi due paesi avevano attaccato. In
particolare i turchi, i quali nel conflitto precedente avevano perduto ogni posizione nei balcani
Infine la Serbia divideva ora col Montenegro il Sangiaccato di Novi Pazar.
Dal canto suo l'Austria avrebbe iniziato a studiare la soluzione trialistica, con le
conseguenze che sappiamo, proprio a seguito dell'annessione della Bosnia-Erzogovina.
La storia poi di quella formazione politica balcanica che, nata col crollo dell'Impero austroungarico al termine della Grande Guerra, sarebbe stata prima il Regno di Serbi, Croati e Sloveni,
quindi di Jugoslavia, è quella di un contrasto continuo tra le tendenze accentratrici della prevalente
dirigenza serba e della monarchia dei Karadjordjevič e le spinte nazionalistiche e autonomiste di
varie popolazioni, innanzitutto la croata.
Alla fine, dopo più di un decennio di contrasti etnici e politici, nel '29 e in concomitanza con
la trasformazione del regno di partenza in Regno di Jugoslavia, Alessandro I Karadjordjevič abolì
ogni libertà politica e di stampa ed instaurò una dittatura.
Ma nel '34 sarebbe stato ucciso da un ùstascia croato.
Fu appunto la nascita di violenti partiti fascisti fra i popoli del Regno di Jugoslavia a
condurre quest'ultimo, nella primavera del '41, all'adesione al Patto Tripartito. Ma un colpo di stato
nazionalista serbo, lo staccò da tale accordo e lo avvicinò all'Inghilterra.
Le potenze dell'Asse lo invaserò così, fulmineamente, di lì a pochissimo. E ad eccezione di
pochi territori di confine se lo spartirono. Alla Germania parte della Slovenia e la Serbia, all'Italia il
resto della Slovenia, la Dalmazia e una zona costiera del Montenegro.
Ma all'Italia sarebbe andato inoltre il protettorato su un nuovo regno satellite dell'Asse, il
Regno di Croazia, la cui corona fu assegnata ad un esponente del ramo dei Savoia-Aosta, che non
mise mai piede nel paese, il governo affidato ad Ante Pavelič, il leader degli ùstascia, i fascisti
croati.
La situazione allora si ribaltò e nella regione iniziarono persecuzioni croate nei confronti dei
serbi. E la violenza ed il disordine furono tali, che nel '42 l'intera nazione venne spartita fra Italia e
Germania e militarizzata. Nonostante le vibranti proteste del governo italiano, il quale non gradì la
spaccatura territoriale.
Poco male.
Di lì ad appena un anno l'influenza tedesca sarebbe stata giocoforza l'unica, data la caduta di
Mussolini e la relativa fine del Fascismo.
I partigiani del maresciallo Tito, tra il '44 e il '45, avrebbero infine liberato l'intero territorio
12
dell'ex regno dai nazisti e da qualsiasi fazione nazionalista e fascista.
Il nuovo stato federale e socialista, con capitale Belgrado ma con a capo il croato Josip Broz,
appunto "Tito", si sarebbe allora lasciato alle spalle i contrasti etnici.
Tito l'avrebbe anche sottratto all'influenza staliniana e sovietica e, nonostante l'anatema di
Mosca, che bollò il socialismo jugoslavo di "deviazionismo", egli lo iscrisse nel gruppo dei paesi
non allineati, dandogli pure un'economia relativamente elastica, pianificata, ma capace di giochi di
mercato.
In ogni caso, alla morte del "maresciallo", nel 1980, i segni di una ripresa del panserbismo e
degli autonomismi c'erano già tutti. Anche per via della differenza di ricchezza tra le repubbliche
federate del Nord e quelle del Sud.
Infatti, alle prime elezioni libere del '90, seguenti il crollo dei regimi socialisti europei, alla
vittoria in Serbia dei neocomunisti panserbi di Slobodan Milosevič si oppose ancora una volta
quella delle destre nazionaliste delle altre aree del paese, soprattutto nelle ricche repubbliche di
Slovenia e Croazia.
E a distanza di un anno circa dal risultato elettorale, da Nord a Sud della federazione
jugoslava si susseguirono a catena dichiarazioni di indipendenza da Belgrado, che i serbi
mostrarono da subito di non digerire.
E tuttavia essi effettuarono una selezione.
La Slovenia e la Macedonia, che proclamarono la loro autonomia nel '91, evidentemente in
quanto la presenza serba in tali regioni era esigua, non raggiungendo il 2% di popolazioni già
numericamente non abbondanti, vennero presto lasciate a se stesse.
Le cose andarono invece diversamente per la Croazia e la Bosnia-Erzegovina: stati in cui i
serbi erano minoranze consistenti e dislocate su aree più o meno omogenee.
Basti pensare che al momento della dichiarazione di indipendenza da parte di entrambe le
repubbliche in questione, del '91 quella croata, dell'anno seguente la bosniaca, le comunità serbe, in
accordo con Belgrado, avevano già dato origine a stati indipendenti all'interno dei territori
nazionali: la Repubblica Serba di Krajina, nella Krajina e nella Slavonia croate, con capitale Knin;
la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, con capitale Pale, nella zona di Nord-Est della
Bosnia.
Ne scaturì una violentissima guerra civile, alimentata da una compresenza pressocché
continua di etnie diverse nelle medesime regioni, in cui inoltre la Serbia assicurò un appoggio
costante, in termini di armi, truppe regolari e spietate formazioni paramilitari, ai connazionali
secessionisti.
Alla fine, dopo un tragico assedio di quasi quattro anni dei Serbi di Bosnia alla capitale di
quest'ultima, Sarajevo, ripetuti bombardamenti aerei internazionali della NATO alle postazioni
serbe sulle colline attorno alla città e fra la primavera e il settembre del '95, condussero alla
soluzione del complessivo conflitto interetnico.
Sarajevo venne liberata, mentre le truppe croate, approfittando dell'attacco NATO,
nell'agosto dello stesso anno avevano già sferrato una decisiva e vittoriosa campagna contro i serbi
di Croazia.
In tal modo, con gli accordi di Dayton della fine del '95, la Croazia tornò sotto il completo
controllo del governo di Zagabria; la Bosnia-Erzegovina finì spaccata tra uno stato serbo a Nord ed
uno bosniaco e croato nel centro e nelle zone a meridione.
E tuttavia le guerre balcaniche degli anni Novanta del '900, non dovevano ancora chiudersi.
All'indomani della presa del potere nell''89, Milosevič, il leader neocomunista e nazionalista
serbo, aveva ridotto l'autonomia di due storiche regioni della sua patria, la Vojvodina a Nord, per
circa il 70% serba, il Kossovo a Sud, che Belgrado aveva in passato ripetutamente e invano tentato
di slavizzare, dato che esso restava serbo solo all'11% di una popolazione in maggioranza albanese.
Ma dopo gli accordi di Dayton, nello stesso Kossovo, accanto a partiti albanesi
indipendentisti e pacifici, nacque una milizia albanese armata, l'UCK, tesa all'autonomia della
13
regione, se necessario anche con la forza.
Il conflitto con le truppe regolari serbe divampò nel '98, vide la Serbia attuare, nel contesto
delle operazioni belliche, la vecchia pratica della deportazione di centinaia di migliaia di albanesi
oltre confine, verso Albania e Macedonia, si concluse nella primavera del '99.
Un nuovo e stavolta indiscriminato bombardamento aereo NATO su caserme, infrastrutture,
centri di produzione, palazzi del potere del territorio federale e in special modo dell'area di
Belgrado piegarono la Serbia, segnando il tramonto di Milosevič e del suo decennale progetto
panserbo.
La successiva dirigenza serba ebbe da quel momento in avanti l'obiettivo della risoluzione
della crisi economica prodotta dalla guerra e lo perseguì mediante una politica di inserimento del
paese in un sistema di accordi economici, commerciali, politici internazionali.
Infatti, l'ultimo strappo da Belgrado, cioè quello della repubblica montenegrina, sarebbe
avvenuto per motivi di ordine economico e commerciale e consensualmente nel 2006.
Comunque sia, il nazionalismo serbo integra, per l'ennesima volta, un'atteggiamento dello
spirito ampiamente razionalizzato dalla filosofia idealista dell'epoca romantica o dallo storicismo
dei primi decenni del '900, ma a varie riprese e in diverse aree del pianeta affiorato sin dalle epoche
più antiche.
Nell'Idealismo del filosofo tedesco Fichte, si immagina la coscienza umana come una sintesi
di Io, soggetto, intento pensante, e non-Io, oggetto, ovvero l'idea, il prodotto del soggetto stesso; si
assiste inoltre all'identificazione del momento teoretico con quello pratico, di conoscenza e morale,
ed il fine della coscienza stessa è colto nel suo tentativo costante di superarsi e liberarsi all'infinito,
mediante elaborazione di contenuti originali e sempre più razionali.
Dunque, ciascuna creazione soggettiva, già in Fichte presenta aspetti più o meno istintivi,
più o meno spirituali. E già in questo filosofo idealista, attivo nel primo clima romantico a cavallo
tra '700 e '800, natura e cultura convivono nel pensiero, in percentuali differenti, segno del grado
dell'evoluzione individuale.
Ma le realtà in questione sono comunque inscindibili e loro inverse proporzioni, nei vari
prodotti della coscienza, ne implicano pure, di volta in volta, specifiche connotazioni qualitative.
A conclusioni identiche si giunge pure se si guarda alle tesi dei successivi idealisti, nei quali
avviene il salvataggio della consistenza ontologica della natura, mediante l'idea di un "Assoluto" o
"Infinito", come fondamento comune e di quella e dell'essenza.
Nel pensiero di uno Schelling o di un Hegel, infatti, lo spirito altro non sarebbe che il
progressivo recupero di sé, nella coscienza umana, di un "Essere", cioè di una perfezione razionale,
secondo Schelling intrinseco alla natura, che a parer di Hegel in quest'ultima avrebbe solo la sua
fase negativa, di scomparsa, necessaria al proprio ripristino dialettico lungo la storia.
Dunque per tali filosofi, la storia costituirebbe una teoria di formazioni civili in misura
inversamente proporzionale impulsive e spirituali, contraddistinte così da un legame indissolubile
tra un certo tipo di natura e un genere preciso di cultura.
In Croce, la cui filosofia, nella prima metà del '900, è espressione di uno storicismo totale, la
distinzione hegeliana o schellinghiana tra spirito e natura scompare e quest'ultima si configura come
l'infima manifestazione del primo: un complesso di percezioni sensibili e sensoriali, di affetti,
caratterizzanti l'anima di chi fa, "economicamente", il proprio utile.
Tuttavia, la situazione non muta.
E' vera infatti la contestazione crociana di una dialettica degli opposti estesa da Hegel pure
al rapporto tra forme dello spirito, ma nel pensiero del filosofo italiano tale dialettica rimarrebbe
comunque interna alle fasi delle singole forme, così da cagionarne l'elevazione progressiva e corale,
data la loro necessaria influenza reciproca.
In tal modo, ad esempio, ad un livello d'arte corrisponde un coerente grado di filosofia, etica,
economia.
E ad una cultura, in generale, una certa elaborazione della natura.
14
Giovanni Gentile, altro neoidealista del primo '900, alla maniera crociana nega la possibilità
di mondo e natura come entità altre dal pensiero.
Quest'ultimo allora, nel filosofo in questione, solo all'apparenza si scinderebbe in "pensante"
e "pensato", poiché la seconda realtà altro non sarebbe che azione del "pensante", cioè "pensiero in
atto".
Di conseguenza, nel cosiddetto "attualismo" gentiliano la natura si riduce a pensato
irripetibile, vale a dire temporaneo e molteplice, a differenza della cultura, fatta di concetti
ricorrenti. E in ogni caso, secondo tale impostazione, natura e cultura darebbero vita ad un
opposizione dialettica di atti del medesimo pensiero, diversa, a seconda delle fasi di esso.
Guardiamo allora, ad esempio, all'idea di Hegel sul mondo antico.
Nella "Fenomenologia dello spirito", a proposito della cosiddetta "dialettica servo-padrone",
la quale connoterebbe il relazionarsi dell'"autocoscienza", Hegel fa notare come la fase soggettiva
che la produrebbe, corrisponderebbe alla storia di culture come la greco-romana, in cui gagliardi
condottieri e geniali artisti, filosofi, letterati, scienziati, erano in realtà liberi da cure, il cui carico
gravava però su schiavi.
Nelle quali dunque, la civiltà della partecipazione collettiva alla gestione della cosa
pubblica, dell'assenza di distinzione tra dimensione privata e statale, si accompagnava ancora alla
violenza dell'istituzione servile.
Così, nel linguaggio immediato di chi ovviamente si stupisce della compresenza di raffinate
elaborazioni spirituali e normalizzazione della schiavitù, quest'ultima figura tout court come scritta
nel DNA dei popoli antichi.
In ogni caso, il panserbismo accompagna da sempre la storia della gente in esame.
Per esempio nel Basso Medioevo, tra la fine del XII e quella del XIV secolo e sotto la
dinastia dei Nemanjici, un esponente della quale, Stefano IX Dušan, intorno alla metà del Trecento
riuscì persino a riunirla in un impero che si estendeva su regni e principati balcanici abitati non solo
da serbi, fino addirittura al territorio greco dell'Istmo di Corinto.
Ma c'è di più.
Nel corso di tale fase storica il principato serbo riuscì a rendersi notevolmente indipendente
da Bisanzio, sotto il cui controllo politico ed amministrativo cadeva appunto la zona balcanica,
tracia ed egea; e inoltre, sfilandosi pure dai tentativi di riconquista dottrinale e liturgica della Chiesa
di Roma, si legò a tal punto a quella greco-ortodossa, che ai tempi del Dušan già il patriarca di Peć
era eletto da soli vescovi serbi e proprio da lui venne l'incoronazione di quello, col titolo appunto di
"Zar di tutti i serbi".
Questa forma particolare di nazionalismo sarebbe poi sempre serpeggiata fra la gente serba,
anche nelle epoche dell'occupazione straniera.
Quando nella "Piana dei merli" e nella battaglia di Kossovo Poljie del 1389, i serbi furono
sbaragliati dai turchi, ne nacque addirittura un'epica nazionale fatta di canti eseguiti dai "guslari",
nei quali i comandanti ed il principe serbo figurano perdenti a causa del numero e di un tradimento,
nonostante l'eroismo in abbondanza profuso.
In ogni caso, perché la nazione serba finisse sotto il giogo ottomano, sarebbe dovuto arrivare
il 1459, a conclusione di un settantennio alternante fasi di dipendenza e indipendenza dai turchi
stessi. Nelle epoche successive, inoltre, il patriarcato di Peć fu per lo più dagli ottomani affidato a
religiosi ortodossi greci, i quali, a differenza dei serbi, non tramavano con la popolazione contro gli
occupanti.
Così, dopo secoli di difficile dominio straniero, fu solo con la ventata di nazionalismo del
clima romantico di inizio '800 che la Serbia ottenne una relativa autonomia. Ciò avvenne nel 1830,
quando essa si sarebbe costituita in principato sotto la dinastia ora degli Obrenovič ora dei
Karadjordjevič.
Di lì a poco poi, esattamente nel '44, Ilija Garašanin avrebbe redatto ed edito il
"Načertanjie", ossia il documento del panserbismo, nel quale si sosteneva la necessità storica di una
15
riunificazione politica di tutti i Serbi sottoposti a stranieri, austriaci o turchi che fossero, a
prescindere dalla convivenza di essi con altre etnie in una medesima regione.
Ma in che cosa consisterebbe allora quella "santità", per secoli sbandierata dagli slavi
ortodossi contro il mito occidentale della ricchezza, cattolico e protestante, di cui i serbi addirittura,
da sempre, si sentirebbero interpreti autentici, esclusivi?
L'XI secolo aveva visto la penetrazione di un razionalismo di tipo aristotelico nella teologia
occidentale. Di tale evento una prima, chiara testimonianza era stata la dottrina di Anselmo d'Aosta,
la quale ritornava dritta alle prove logiche dell'esistenza di Dio. Ma la stessa filosofia scolastica
della fase della "fioritura", culminata nel sistema teologico di Tommaso D'Aquino della metà del
Duecento, si sarebbe rivelata improntata a quell'ordine antico di idee.
Viceversa, nell'Oriente cristiano bizantino, nel medesimo periodo, si accentuava un
misticismo di verosimile matrice neoplatonica.
L'effetto di tale divergenza culturale, manifestatasi già in contrasti precedenti e non
indifferenti, fu la frattura del Cristianesimo in fedi diverse, a quel tempo ormai inconciliabili. Come
dimostrato dallo Scisma del 1054.
Con uomini di chiesa come Simeone il "Nuovo Teologo", vissuto a cavallo tra il X e l'XI
secolo, le tradizionali pratiche mistiche del monachesimo orientale, prima fra tutte l'"esicasmo",
l'orazione ripetuta e ritmata, coordinata col respiro e riflessa verso il proprio corpo, cominciarono
ad essere concepite come indispensabili al conseguimento di un fine originale in confronto a quello
dell'ascetismo tradizionale, ossia liberazione dal mondo e comunione col divino.
Obiettivo di esperienze del genere era infatti la ricezione, mediante condivisione di energie
divine autentiche, "increate", di verità di fede, di perfezioni concettuali concernenti Dio e il suo
disegno.
La stessa tradizione monastica mediorientale si era da subito caratterizzata per un tratto di
misticismo, notevolmente più marcato rispetto a quello che nel monachesimo occidentale si
accompagava ad un intenso attivismo caritatevole, culturale e persino economico.
Alla sua base, sin dalle origini, stava un modello d'uomo diverso da quello proposto dai
Padri della Chiesa del territorio occidentale dell'impero, quindi un rapporto tra Dio e creatura
prediletta nell'essenza divergente da quello fondamentale e agostiniano.
Presso i padri d'Oriente si era infatti affermata un'antropologia, tendente ad attribuire
all'individuo, accanto alla sfera sensibile ed intellettiva ed a quella razionale, responsabile della
disciplina etica, una facoltà spirituale tale da consentirgli per via diretta ed intuitiva il
raggiungimento delle verità di fede, delle realtà riguardanti Dio e il suo progetto.
La zona dell'anima in questione esigeva però un momento di purificazione del soggetto dalla
pressione delle passioni terrene e lo conseguiva essenzialmente tramite le pratiche della preghiera.
Nella rinnovata condizione individuale, la facoltà spirituale realizzava il contatto col divino o
meglio con le energie increate di esso, e ne riceveva le suddette verità.
L'uomo dei teologi orientali possedeva dunque un intelletto adeguato alla conoscenza
empirica ed una ragione capace di vagliare i risvolti morali delle vicende e di normalizzare dal
punto di vista etico il comportamento. Ma riusciva ad accedere alle verità di fede non attraverso le
vie di una ragione isolata o coadiuvata dalla fede, bensì tramite l'ascesi.
Con la conseguenza della certezza di apprezzarle nella loro pienezza, senza il rischio di
dover talvolta accettare dei dogmi ultrarazionali.
Così la teoria e la pratica dell'ascetismo si accompagnarono in Oriente al diffondersi del
cristianesimo, finendo anzi per rappresentare lo sfondo culturale su cui esso si sarebbe innestato. La
teologia bizantina previde per esempio il già citato esicasmo, una sorta di preghiera contemplativa,
consistente nella combinazione di orazione ripetitiva e disciplina del respiro.
L'esicasmo divenne una pratica di preghiera ammessa dai cristiani ortodossi soltanto per
opera del teologo bizantino Gregorio Palamàs, monaco ed arcivescovo di Tessalonica in vita, santo
della Chiesa greca dopo la morte. Questi nella prima metà del '300 ne diede una formulazione
16
dottrinale, permettendone l'inserimento fra i generi di preghiera riconosciuti dal magistero ufficiale
ortodosso.
Se passiamo dall'antropologia all'escatologia dei padri orientali, pure nella concezione del
destino finale dell'uomo cogliamo lo stesso tratto mistico, già tipico della loro peculiare nozione di
natura umana.
I teologi orientali avrebbe presto deviato dalla prospettiva agostiniana "amartiocentrica",
imperniata cioè sull'interpretazione della vicenda di Cristo nei termini di un sacrificio
indispensabile ai fini del riscatto dell'uomo dal peccato originale.
Infatti, nella speculazione orientale l'uomo, persino quello della vicenda paradisiaca, in
quanto anche corpo è imperfetto e tende per natura all'errore; inoltre nella condizione terrena egli
eredita non il peccato d'Adamo, ma le conseguenze di esso.
A sua volta Cristo sarebbe allora il Figlio di Dio disceso in terra per insegnargli a vincere la
morte, ad ottenere l'assunzione accanto alla Santissima Trinità, secondo una prospettiva ultima di
divinizzazione, per realizzare la quale Dio si sarebbe ugualmente incarnato, anche se gli uomini non
si fossero fatti bandire dal paradiso.
Dunque, per i dotti orientali, la parabola ideale dell'esistenza umana contemplata dal
progetto divino si identificherebbe nel passaggio da uno stato originario, in cui la tendenza al
peccato sarebbe connaturata all'uomo, ad una situazione di sconfitta di quest'ultimo e di definitiva
convivenza spirituale con il Padre stesso.
L'idea centrale di questa teologia sarebbe allora quella di una sorta di complicazione
prodottasi con il peccato delle origini, lungo la strada maestra della divinizzazione umana. Frutto
del peccato sarebbe stata infatti la morte dell'uomo e la parallela caducità delle realtà terrene,
dunque la tirannia di Satana su una creatura ora avvilita da una condizione precaria, di dolore.
Sono evidenti allora i connotati neoplatonici di quest'impostazione.
Essa infatti concepisce il mondo alla stregua di una realtà inferiore, giocoforza concreta in
quanto ricettacolo degli esemplari possibili, inevitabilmente richiamati dalle perfezioni pensate da
Dio, ben lontana dunque da quel frutto sublime dell'atto creativo di un Dio generoso, immaginato
dagli occidentali.
Inoltre nell'uomo vede l'unica realtà imperfetta, in cui tuttavia il divino progressivamente
dispersosi nella materia possa recuperarsi, se solo egli scelga di affrancarsi da quest'ultima.
E, naturalmente, una cosa risulta quindi la santità nelle confessioni evangeliche e cattoliche,
un'altra nell'ortodossia.
Se infatti un Dio che è pienezza di bene, in virtù della sua stessa bontà è creativo e manifesta
ciò nel progetto universale, e se per giustizia, ma con lacerante dolore ha spostato l'uomo dal
paradiso alla terra, allora la santità è opera caritatevole e culturale, cioè arricchimento di sé, degli
altri, del contesto, in un commovente tentativo di ricreare una condizione con strazio umano e del
cielo medesimo per sempre perduta.
Ma nel considerare il mondo e l'uomo stesso entità di per sé corrotte dall'elemento di materia
e corpo, non c'è altra santità che quella di chi mediante preghiera e ascesi di questi dati si priva e si
fa analogo a Dio, e alle verità supreme, infine, accede.
Ecco perché da sempre l'universo ortodosso, persino negli spiriti più illuminati, del tipo, ad
esempio, di un Dostoevskij, ha sempre visto nell'Occidente la bolgia dell'affarismo e del mito della
ricchezza; ha idealizzato invece un uomo che solo per il necessario alla vita si giovi di un mondo,
cui riservare per il resto disprezzo e il distacco nella preghiera e nel culto della solidarietà.
La prova di tutto ciò è sociale: i popoli ortodossi non conoscono ancora oggi quel ceto
imprenditoriale e capitalistico, che nelle nazioni protestanti, cattoliche e di culto anglicano da
sempre è traino all'economia.
Gran parte di esse, anzi, per decenni, sono crollate nel comunismo e nella sofferenza del
conseguente ateismo.
E a conferma di ciò basta infatti qualche esempio.
17
Subito dopo il fallito colpo di stato reazionario, sovietico, sotto la presidenza Gorbaciov, e
la conseguente presa del potere da parte di Eltsin, già nei primi mesi del '92 iniziò in Russia un
vasto programma di liberalizzazione dei prezzi e del commercio estero; di legalizzazione di
proprietà e imprese nei fatti già private; di privatizzazione del patrimonio dello stato.
Gli effetti di un simile, drastico, ideologico mutamento sistemico furono nell'immediato
catastrofici.
L'inflazione alta, nascosta dalla pianificazione socialista dei prezzi, venne soltanto allo
scoperto e si verificò la rapida concentrazione di tutta la ricchezza nelle mani di pochi.
Infatti l'élite politica ebbe accesso esclusivo ai prodotti primari, quali gas e petrolio, e i
dirigenti finirono per accaparrarsi le aziende di stato, rastrellando anche le azioni cedute
originariamente a dipendenti incapaci o troppo deboli per farle fruttare.
Dal canto loro i banchieri fecero facilmente propri i loro istituti, grazie alla conversione dei
crediti statali nei confronti delle banche in azioni bancarie, dallo stato stesso vendute a prezzi bassi.
In tal modo, sotto il profilo sociale si assistette alla nascita nel paese di un'oligarchia di
plurimiliardari e le disuguglianze del reddito divennero vertiginose.
Sul piano finanziario invece lo stato, privo delle entrate delle aziende più redditizie e con
introiti fiscali inadeguati a pareggiarle, iniziò un periodo ininterrotto di deficit e nel 1998,
nonostante gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e dei paesi europei, scivolò nel default,
poiché incapace di onorare il suo debito con gli acquirenti di titoli di stato.
La ripresa avrebbe comunque fatto capolino già l'anno dopo.
Essa fu dovuta all'arrivo di capitali stranieri, ma soprattutto al consistente rincaro dei prezzi
di gas e petrolio, con poche interruzioni continuo o comunque sempre notevole fino ai giorni nostri.
Ciò consentì più ricchezza ad uno stato, ancora in parte proprietario delle compagnie
petrolifere e del gas, oltre che nel complesso maggiori entrate fiscali.
Quanto al rilancio, ora possibile, dell'economia, provvide Putin, il nuovo presidente della
nazione russa.
Nell'ambito di una complessiva e oculata politica macroeconomica e monetaria, Putin
sviluppò il vecchio progetto di liberalizzazione: svalutò il rublo ai fini del rilancio del commercio
estero; abbassò ulterioremente la tassazione sul lavoro; snellì la burocrazia.
In tal modo, nei periodi successivi la Russia avrebbe attirato investimenti stranieri, fino a
quasi 28 miliardi di dollari l'anno, e avrebbe conosciuto pure uno stimolo degli investimenti e della
domanda interni.
Così inoltre, per tutti gli anni Duemila e col solo freno del biennio di crisi mondiale 2008/9,
nel paese in esame la disoccupazione e la povertà si sarebbero progressivamente abbassate, si
sarebbe formata una consistente classe media ed il PIL sarebbe con costanza cresciuto, fino a punte
annue del 7%.
Ma la gestione Putin assicurò il rilancio di una nazione, anche per via di un cambiamento di
strategia politico-economica in corso d'opera.
A partire dal 2003, infatti, il presidente invertì la marcia liberale e diede inizio ad un
processo di riappropriazione da parte dello stato, forzata, di notevoli quote azionarie di banche e
aziende redditizie già privatizzate, a cominciare dalle compagnie di gas e petrolio.
In effetti, la presenza pubblica nell'industria del petrolio passò in poco tempo dal 20 al 50%,
quella negli istituti di credito giunse quasi al 40%.
La conseguenza di questa nuova linea sarebbe stata la nascita di un'economia e di una
finanza russe doppie, nelle quali la libertà del privato sarebbe rimasta in sostanza garantita solo in
settori non strategici.
Ad oggi, insomma, la Russia è una nazione in cui lo stato è molto forte e presente
nell'industria dell'energia ed in generale in quella pesante; che fonda la sua ricchezza
sull'esportazione di gas e petrolio, nonché di poche altre materie prime, quali il ferro, l'acciaio, il
legno; il cui ceto borghese è tuttora fondamentalmente legato alla gestione del patrimonio dei centri
18
produttivi del vecchio regime.
E, per quel che più ci riguarda, non in grado di offrire ancora un tessuto di piccole e medie
imprese manifatturiere, così da dover per esempio importare dall'Europa circa i 2/3 dei prodotti
finiti di cui necessita, a cominciare da quelli alimentari.
Non dissimile è il caso della Romania.
Negli anni di transito dall'economia pianificata a quella di mercato, il paese in questione
conobbe drastici cali del Pil e delle esportazioni, quindi elevata inflazione.
I governi di allora decisero di privatizzare le aziende di stato, cedendole per un terzo a
singoli, per il resto a società. Quanto alla terra, essa sarebbe dovuta tornare agli eredi o ai
proprietari, cui era stata tolta all'inizio dell'esperienza comunista.
Nei fatti, l'incidenza del privato nel settore industriale sarebbe rimasta molto bassa, mentre i
nuovi proprietari terrieri, che furono infine i vecchi potenti della politica, non riuscirono, vuoi per le
basse possibilità di accesso al credito o la scarsa meccanizzazione o l'incertezza degli stessi titoli
formali di proprietà, a mettere adeguatamente a frutto le terre acquisite.
Ciononostante, fino al biennio '95/'96 l'economia romena crebbe e in quegli anni il Fondo
Monetario Internazionale accordò al paese un prestito di 720 milioni di dollari, con l'obiettivo di
rendere più agevole la prosecuzione sulla via delle riforme strutturali. Le quali però fallirono
ancora.
Infatti la Romania avrebbe vissuto una sequenza di anni recessivi fino al '99, quando pure la
completa liberalizzazione dei prezzi si sarebbe fatta sentire in tutti i suoi effetti dannosi, con
un'inflazione del 50% annuo.
A partire dagli anni Duemila, i governi romeni hanno puntato allora su una politica di
inserimento del paese in circuiti economici e commerciali più vasti: per esempio con la firma
dell'"Accordo di libero scambio tra i paesi dell'Europa centrale", cui aderivano già, fra gli altri,
Ungheria e Slovenia, ma ancora presentando nel 2002 domanda d'ammissione all'Unione Europea.
Tale istanza venne accettata e, come sappiamo, pur mantenendo la sua moneta nazionale, il
leu, la Romania è entrata fra i paesi UE nel 2007, assieme alla Bulgaria.
Il mutamento di strategia politico-economica si è rivelato allora indispensabile al
progressivo aumento di IDE in entrata, già a partire dalla fine degli anni novanta.
In effetti, il basso costo della manodopera, peraltro qualificata, la altrettanto ridotta
tassazione, gli scarsi vincoli sindacali e burocratici, hanno fatto sì che la Romania vedesse presto,
per iniziativa straniera e soprattutto italiana e tedesca, la nascita di un tessuto di piccole e medie
imprese manifatturiere, spesso a capitale misto, per lo più alimentari, tessili, calzaturiere, dei
macchinari e dell'impiantistica.
Ugualmente, negli stessi anni, il paese ha assistito alla diffusione di aziende agricole estere,
attratte dalla fertilità del suolo, dai ridotti costi di locazione o acquisto di quest'ultimo, quindi
burocratici.
Sono stati appunto tali investimenti, che nei primi anni 2000 hanno toccato i 10 miliardi di
euro annui su un PIL di circa 150 miliardi, a risollevare le sorti di una nazione, dalla quale nel
frattempo era partita una forte emigrazione di uomini e donne, alla ricerca di maggior fortuna in
zone del continente più ricche.
E se la Romania ha conosciuto nuovi disagi economici e sociali a partire dal biennio di crisi
mondiale 2008/9, ciò è accaduto innanzitutto a causa di quella contrazione europea dei consumi, la
quale ha indotto alla riduzione produttiva o alla chiusura molte tra le decine di migliaia di aziende
straniere sul territorio, le cui possibilità d'esportazione si erano allora notevolmente ridotte.
Negli anni '10 del terzo millennio, il paese in questione ha dunque, come gli altri più poveri
dell'Unione, ricevuto prestiti dagli istituti internazionali in cambio dell'avvio di dure politiche di
risparmio e risanamento dei conti pubblici. Tuttavia esso resta ancora una zona del Vecchio
Continente beneficiante e di molto, e nell'industria e nell'agricoltura, dell'iniziativa privata straniera;
i cui emigrati, infine, in rari casi hanno capitalizzato le rimesse in vista dell'impianto di imprese
19
private.
Nelle migliori ipotesi il denaro di questi ultimi è finito investito nell'acquisto di immobili,
cosicché una delle concause della crisi di qualche anno fa, sarebbe stato pure il rapido esaurirsi del
mercato immobiliare.
Casi analoghi a quello russo e romeno sono la Bulgaria, la nazione più povera dell'Unione
Europea, e la Grecia, quest'ultima per motivi però diversi.
Infatti, in Grecia, un capitalismo invece abbastanza solido e aggressivo, sostanzialmente
intatto dalla crisi degli anni recenti, capace di investimenti nei Balcani, in Russia, in Turchia, di
esportazione nei paesi della stessa Unione Europea, sembra essere sottaciuto e quasi disprezzato.
E di un simile atteggiamento risultano portatori non solo i partiti conservatori, che ne
potrebbero pure fare una strategia necessaria alla difesa delle misure di austerity, ma persino i partiti
socialisti e popolari, per i quali quello permane una sorta di affarismo arretrato e subordinato al
capitale straniero, con cui non valga quasi la pena confrontarsi.
Ma veniamo adesso al caso serbo.
All'indomani della fine della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, mentre già si
profilavano i contrasti con le nazionalità esigenti autonomia da Belgrado, i vertici della Repubblica
Serba avviarono un programma economico di liberalizzazioni.
Ma è evidente che le crisi degli anni '90, cioè i conflitti contro gli indipendentisti croati,
bosniaci e kossovari, avrebbero vanificato il tentativo di riforme strutturali in direzione liberista,
miranti a scardinare per sempre il sistema in prevalenza pianificato dei decenni passati.
Anzi, le spese e i sacrifici in funzione della guerra, un tasso di inflazione elevatissimo,
l'isolamento e le sanzioni internazionali, infine i danni dei bombardamenti Nato anche a
infrastrutture e centri di produzione, avrebbero al contrario messo in ginocchio il paese.
Sarebbe stato allora l'esautoramento dell'intera dirigenza serba del decennio bellico ad aprire
la strada al cambiamento liberista.
La nuova Serbia riusciva così a riprendere i contatti con la comunità internazionale e ad
aderire ad accordi di mercato. Si vedeva annullare sanzioni e divieti e si metteva anche nelle
condizioni di ricevere aiuti dagli istituti di credito mondiali. In cambio aveva il compito di sopire le
istanze interne nazionaliste, consegnare quindi ai tribunali sovranazionali gli esponenti del regime
vecchio, civili e militari, accusati di crimini contro l'umanità.
E in concomitanza con il nuovo corso politico pacifista, il paese avviava allora il programma
di un rinnovamento liberista, finalizzato all'attrazione di investimenti esteri in entrata.
La strategia, cioè, del "tappeto rosso" per gli investitori stranieri.
Essa consisteva nella privatizzazione delle aziende di stato, quindi nell'assicurazione di
bassa fiscalità, incentivi e irrilevamenti impedimenti burocratici a privati o società estere che ne
acquistassero le rilevanti quote azionarie rese disponibili dallo stato.
La politica del "tappeto rosso" avrebbe portato in Serbia circa una ventina di miliardi di
dollari di IDE a partire all'incirca dal 2000 fino agli anni recenti, con la sola contrazione del biennio
di crisi 2008/9. E gli investitori sarebbero stati per lo più tedeschi, italiani, russi, austriaci e greci.
Costoro avrebbero inoltre indirizzato i loro affari verso il settore dei servizi e, in misura minore,
dell'industria.
Nonostante il sostanziale successo di questa strategia, testimoniato innanzitutto dal rapporto
annuo tra gli IDE ed un prodotto interno lordo notevolmente basso, in Serbia la disoccupazione è
rimasta sempre alta.
Inoltre, il paese in più occasioni ha dimostrato di non saper onorare gli impegni presi con gli
stranieri, quanto a compartecipazione azionaria e facilitazioni fiscali.
Per questo, rivoltosi agli isitituti di credito internazionali, si è visto richiedere in cambio dei
sussidi una politica di corretta gestione del denaro e del debito pubblici, da perseguirsi innanzitutto
mediante tagli a sprechi e privilegi.
La conseguente riduzione della spesa pubblica, ottenuta anche con decurtazioni di stipendi e
20
pensioni, il rialzo dell'IVA al fine di far cassa, hanno però acuito in diverse occasioni il malumore
sociale e rafforzato le fazioni nazionaliste e comuniste, a priori ostili a quell'ingresso nella UE, per
cui la Serbia ha fatto ufficiale domanda nella primavera 2012.
Insomma, ad oggi, il paese in questione, il cui prodotto interno lordo è sorretto poco
dall'agricoltura, molto più dai settori secondario e terziario, non offre in questi ambiti un ceto
borghese proprio, in grado di garantirne autonomamente l'espansione, continua invece nella ricerca
di uomini d'affari stranieri, che di un simile compito, al contrario, per via indiretta, si facciano
comunque carico.
Placato più o meno a forza il tradizionale nazionalismo serbo soltanto nell'ultimo decennio,
qual è invece la vicenda del panslavismo russo all'indomani del Congresso di Berlino?
Esso conobbe un brevissimo momento di reviviscenza allo scoppio del primo conflitto
mondiale, ma l'interruzione della guerra operata dalla rivoluzione bolscevica, quindi i conseguenti
sogni internazionalistici di estensione del socialismo oltre i confini patrii, lo ricacciarono ancora una
volta indietro nella storia.
Ma nel corso della seconda guerra mondiale, fu addirittura per iniziativa di Stalin che esso si
ripropose.
Colpa del Nazismo e della prospettiva dell'acquisizione violenta di "lebensraum", "spazio
vitale", per i tedeschi, ad Est e a danno di popoli ritenuti inferiori come gli slavi.
Così, nello stesso anno dell'invasione tedesca della Russia, il 1941, Stalin stesso promosse
una politica comune e solidale fra le genti slave, in funzione anticapitalista e antifascista. Strumento
di essa fu la formazione a Mosca di un comitato panslavo, che si dotò della rivista "Slavjiane" come
organo di propaganda e organizzò pure congressi a Sofia, Bratislava e Belgrado.
E' evidente però che col crollo dei regimi fascisti in Europa e il dilagare del socialismo in
quasi tutto l'Est del Vecchio Continente, di disegni panslavi d'emergenza non si sentì più alcun
bisogno.
O forse la realizzazione di un blocco di nazioni comuniste e perlopiù slave, riunite nel Patto
di Varsavia e sotto la direzione sovietica, costituì appunto, oltre che il trionfo del socialismo reale,
pure la materializzazione dell'idea panslava e di una Mosca che fosse terza Roma imperiale dopo
l'Urbe e Bisanzio.
Se anche in fondo fosse così, almeno nella forma tale alleanza di genti non avvenne che
sulla base di una comune ideologia socialista e internazionalista, non slavofila.
In ogni caso, l'epoca attuale vede da Est a Ovest, da Nord a Sud del Vecchio Continente il
prevalere di un processo di integrazione nella federazione europea, la quale intende esplicitamente
ispirarsi a principi illuministici e borghesi, kantiani, e, con uno strano sincretismo, pure ai valori
della solidarietà cristiana.
In questo contesto dunque, la consacrazione della tradizione e del sangue che la
inventerebbe restano obiettivi, nonostante tutto, minoritari.
E c'è da credere che la sicurezza dalle istituzioni europee garantita alle nazioni concorrenti
sotto il profilo macroeconomico e monetario, rappresenterà per qualche tempo un argine concreto,
insormontabile, ai patriottismi vari.
Persino più forte dell'ecumenismo cristiano o liberale.
21
Bibliografia
•
Anselmo d'Aosta, Proslogion, nella collana "I classici del pensiero", introduzione,
traduzione e note di L. Pozzi, "Fabbri Editori", Milano 2006.
•
Bianchini Stefano, Le sfide della modernità. Idee, politiche e percorsi dell'Europa
orientale nel XIX e XX secolo, "Rubettino", Soveria Mannelli (CZ) 2009.
•
Cesa Claudio, Fichte e il primo idealismo, "Sansoni", Firenze 1975.
•
Cilento Vincenzo, Saggi su Plotino, "Mursia", Milano 1973.
•
Ducellier Alain - Kaplan Michel, Byzance (IV e-XV
Fondamentaux", "Hachette Supérieure", Parigi 2005.
•
Dvornik Francis, Gli slavi nella storia e nella civiltà europea, nella collana "Storia e
Civiltà", traduzione di P. Portoghese, Edizioni Dedalo, Bari 1993.
•
Galasso Giuseppe, Croce e il suo tempo storico, "Il Saggiatore", Milano 1990.
•
Giardina Andrea, Sabbatucci Giovanni, Vidotto Vittorio, Guida alla storia – Dal
Novecento a oggi, "Laterza", Roma-Bari 2001.
•
Gusmani Roberto, Elementi di fonetica storica delle lingue indoeuropee, "Peloritana
Editrice", Messina 1971.
•
Hegel George Wilhelm Friedrich, Fenomenologia dello spirito, introduzione, traduzione,
note e apparati di V. Cicero, "Bompiani testi a fronte", Varese 2008.
•
Hösch Edgar, Storia dei Balcani, nella collana "Universale Paperbacks", a cura di E. Ivetíc,
"Il Mulino", Bologna 2006.
•
Kersevan Alessandra, Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per
civili jugoslavi 1941-1943, "Nutrimenti", Roma 2008.
•
Lo Schiavo Aldo, Introduzione a Gentile, "Laterza", Roma-Bari 1974.
•
Massari Maurizio, Russia: democrazia europea o potenza globale. A vent'anni dalla fine
della guerra fredda, "Guerini e Associati", Milano 2009.
•
Moiso Francesco, Vita, natura, libertà. Schelling (1795-1809), "Mursia", Milano 1979.
•
Mondin Battista, Il sistema filosofico di Tommaso d'Aquino, "Massimo", Milano 1985.
•
Petrà Basilio, La chiesa dei Padri. Breve introduzione all'ortodossia, nella collana "Nuovi
saggi teologici", "Edizioni Dehoniane Bologna", Bologna 1998.
•
Pitassio Armando, Storia dell'Europa Orientale, nella collana "Storia", "Morlacchi
e
siécle), nella collana "Les
22
Editore", Perugia 2011.
•
Privitera Francesco, La crisi economica globale e il suo impatto sull'Europa centroorientale e balcanica, speciale su Guida ai Paesi dell’Europa Centrale, Orientale e
Balcanica 2010, a cura di F. Privitera., "Il Mulino", Bologna 2011.
•
Romanidis Giovanni, Un virus mortale. Il peccato originale secondo San Paolo, nella
collana "Piccola bibliothiki", traduzione di P. Chiaranz, "Asterios", Trieste 2006.
•
Rumiz Paolo, E' Oriente, nella collana "I Narratori", "Feltrinelli", Milano 2013.
•
Vannini Marco, Invito al pensiero di Sant'Agostino, "Mursia", Milano 1989.
•
Verra Valerio, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma-Bari 1988.
•
Villari Rosario, Storia contemporanea, "Laterza", Roma-Bari 1984.
23