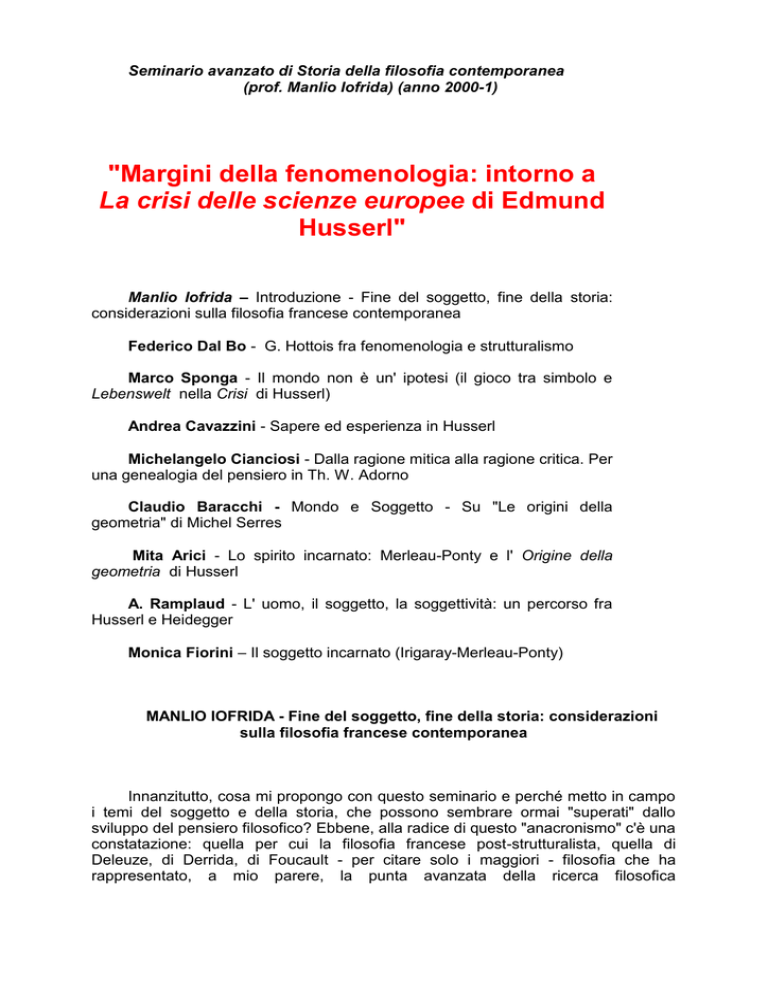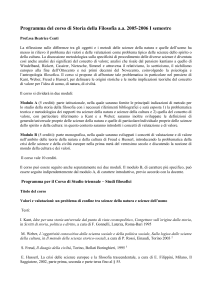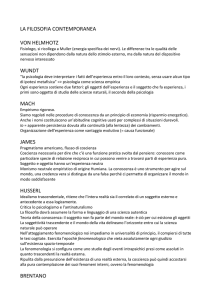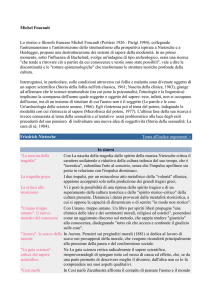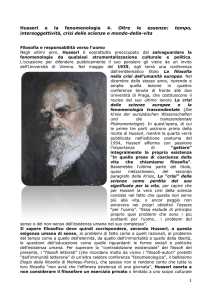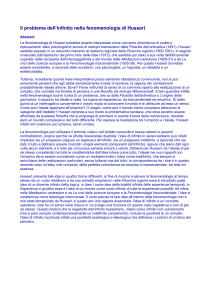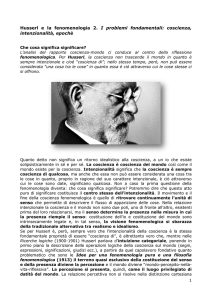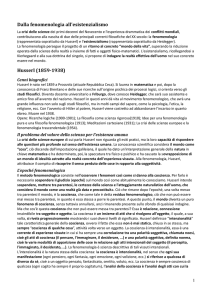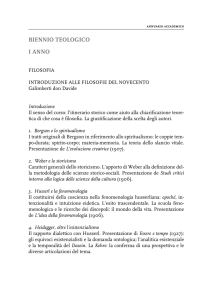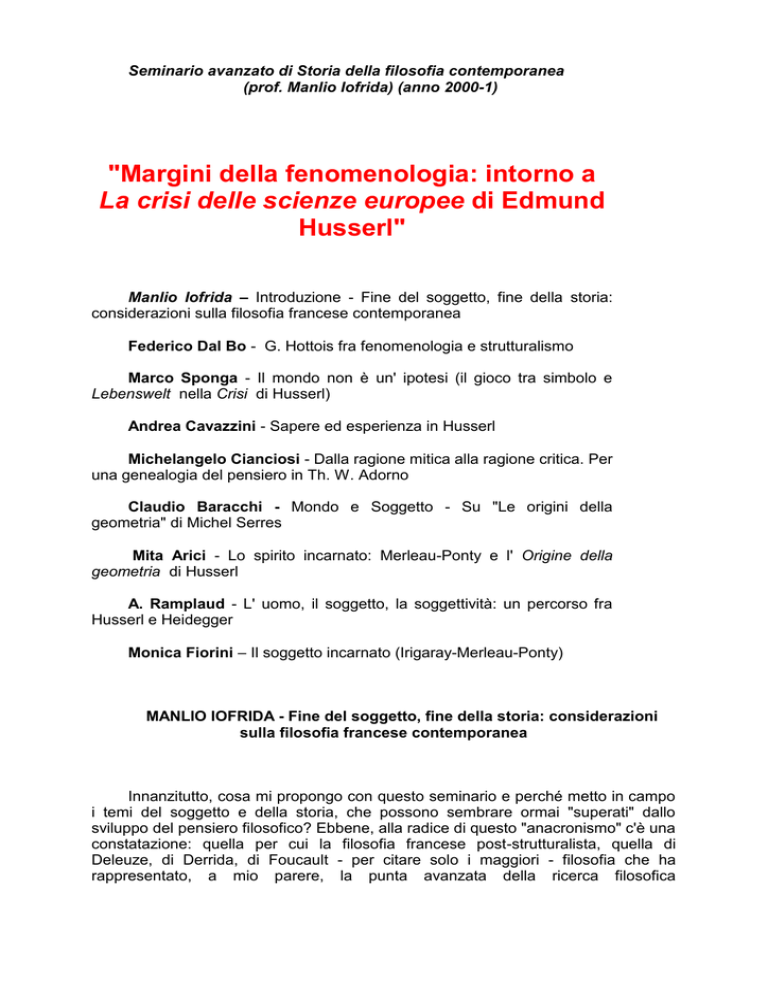
Seminario avanzato di Storia della filosofia contemporanea
(prof. Manlio Iofrida) (anno 2000-1)
"Margini della fenomenologia: intorno a
La crisi delle scienze europee di Edmund
Husserl"
Manlio Iofrida – Introduzione - Fine del soggetto, fine della storia:
considerazioni sulla filosofia francese contemporanea
Federico Dal Bo - G. Hottois fra fenomenologia e strutturalismo
Marco Sponga - Il mondo non è un' ipotesi (il gioco tra simbolo e
Lebenswelt nella Crisi di Husserl)
Andrea Cavazzini - Sapere ed esperienza in Husserl
Michelangelo Cianciosi - Dalla ragione mitica alla ragione critica. Per
una genealogia del pensiero in Th. W. Adorno
Claudio Baracchi - Mondo e Soggetto - Su "Le origini della
geometria" di Michel Serres
Mita Arici - Lo spirito incarnato: Merleau-Ponty e l' Origine della
geometria di Husserl
A. Ramplaud - L' uomo, il soggetto, la soggettività: un percorso fra
Husserl e Heidegger
Monica Fiorini – Il soggetto incarnato (Irigaray-Merleau-Ponty)
MANLIO IOFRIDA - Fine del soggetto, fine della storia: considerazioni
sulla filosofia francese contemporanea
Innanzitutto, cosa mi propongo con questo seminario e perché metto in campo
i temi del soggetto e della storia, che possono sembrare ormai "superati" dallo
sviluppo del pensiero filosofico? Ebbene, alla radice di questo "anacronismo" c'è una
constatazione: quella per cui la filosofia francese post-strutturalista, quella di
Deleuze, di Derrida, di Foucault - per citare solo i maggiori - filosofia che ha
rappresentato, a mio parere, la punta avanzata della ricerca filosofica
contemporanea, è ormai da diversi anni in crisi. Questa constatazione non è
naturalmente qualcosa di "oggettivo": è la presa d' atto, che non è solo mia, ma che
è diffusa, in modo tacito o in modo esplicito, del fatto che questa corrente filosofica
ha cessato di corrispondere al nostro tempo, che non riesce più ad elaborare
risposte ricche e sensate alla situazione storica, politica e culturale in cui ci troviamo;
noterete che, usando questo criterio, non uso un criterio estrinseco, ma un criterio
riconosciuto da questi stessi filosofi, oltre che, dovrei dire, da molti altri prima di loro,
dalla filosofia europea a partire dalla Rivoluzione francese in poi almeno. Perché
questa incapacità, questa "inattualità" in senso negativo? È quello che cercherò di
dire articolatamente nel corso di questa esposizione; ma, in via di traccia
preliminare, in modo da indicare con la massima chiarezza il percorso che intendo
seguire, dirò questo: le filosofie post-strutturalistiche hanno rappresentato un
tentativo di risposta a un insieme di questioni, filosofiche e politiche insieme: in primo
luogo, alla questione della scienza, dello statuto di razionalità dell' impresa
scientifica e dei suoi rapporti col potere; in secondo luogo, alla questione di una
fuoriuscita dal capitalismo radicalmente diversa da quella del "socialismo reale", ma
pur sempre collegata, in un modo o nell' altro, con il marxismo. In modo diverso,
questi filosofi hanno condiviso una prospettiva rivoluzionaria e, soprattutto,
anticapitalistica. Naturalmente le due questioni sono fra loro inscindibili. Ebbene,
oggi, a partire dalla caduta del Muro di Berlino, sembra essersi chiusa ogni idea di
alternativa al capitalismo - il crollo del socialismo reale ha rapidamente fatto tacere
ogni altra idea di alternativa. Data la connessione fra le due questioni, quella della
razionalità scientifica e quella politica, anche l' idea di una critica della razionalità
strumentale o, nella forma che i francesi hanno dato a questo discorso, la critica dell'
episteme scientifica, la storicizzazione della razionalità scientifica sembra
estinguersi: c' è un' unica razionalità, strumentale e tecnico-scientifica insieme; l'
idea di altri tipi di razionalità è "fuori gioco". A questo ha corrisposto una nuova
vague di positivismo logico; d' altra parte, l' ideologia più diffusa in Occidente negli
ultimi anni, quella postmoderna, in quanto riduzione della filosofia a estetica e
letteratura, non è affatto un' alternativa a questa razionalità irrigidita e mitizzata
come unica: il postmoderno è piuttosto il complemento del neopositivismo; in una
specie di divisione delle aree di influenza, il neopositivismo mantiene il monopolio
sulla razionalità e lascia alla filosofia, nella forma del post-moderno, solo la
letteratura, depotenziata a sua volta a ornamento e a industria culturale. In tutto ciò,
l' idea di una nuova forma di razionalità, o piuttosto di un superamento della ragione
classica, e quella connessa di nuove forme di vita sociale sono state abbastanza
tacitamente cancellate. Un ultimo punto generale per definire il mio percorso: la
grande filosofia francese di questo secolo - e questo vale non solo per gli autori di
cui parlo ma parte almeno dagli anni '30 - è una forma di originale assimilazione
della filosofia tedesca - in particolare della fenomenologia di Husserl e dell' ontologia
di Heidegger. Badate bene: parlo di "originale assimilazione", potrei anche usare,
nello stesso senso, la categoria di "traduzione", nel senso forte che Alunni ha
contribuito a accreditare alcuni anni fa e con questo non intendo togliere valore all'
originalità di questi pensatori; al contrario, essi sono riusciti in un' operazione di
altissimo profilo e della massima difficoltà, quella di confrontarsi con tre pensatori - a
Husserl e Heidegger bisogna aggiungere Nietzsche - che rappresentavano i vertici
del pensiero europeo dell' ultimo secolo. Quest' operazione di traduzione e di
assimilazione è così riuscita che quella di Deleuze, di Derrida e di Foucault è senza
dubbio una filosofia francese . Per un lato, questo fatto rinvia al carattere storico e
dinamico dell' identità, e dell' identità nazionale in particolare: un' identità nazionale
non è mai la purezza e la continuità di un ceppo, è piuttosto la capacità di assimilare
altre linee in tale ceppo, di innestarvi elementi estranei, trasformando in questo
modo se stessa. Per un altro lato, questo fatto non è altro che l' ennesima
manifestazione di una caratteristica essenziale della cultura europea: il rapporto
complesso, ma comunque strettissimo fra Francia e Germania che si stringe a
partire dalla Rivoluzione francese e dell' età romantica: è da allora che datano quegli
"annali franco-tedeschi" (cito ancora Alunni), quello scambio reciproco fra cultura
tedesca e cultura francese che ha sempre prodotto, nell' interrelazione, due culture
distinte e anche polemicamente diverse . Sarebbe anche interessante, in questo
quadro, vedere come, in questo gioco a due franco-tedesco, si inseriscono culture
meno di primo piano, ma di grande rilievo, come quella italiana e quella spagnola per es. l' Italia alterna il riferimento alla Francia e alla Germania. Ma non ho
introdotto questo tema per parlarne diffusamente; nel quadro di quello che intendo
trattare oggi, mi ci sono riferito per un motivo interno all' argomento di cui tratto e a
cui ho or ora accennato: il rapporto dei filosofi post-strutturalisti con il pensiero
tedesco. Tale rapporto può essere ulteriormente specificato: gli specialisti del
pensiero francese sanno che, negli anni '50, si verifica una svolta nella filosofia
francese; ora, tale svolta ha per oggetto proprio il modo in cui viene letta la filosofia
di Husserl e, complementarmente, quella di Heidegger: C' era un modo di leggere la
fenomenologia che, grosso modo , a partire dagli anni '30, era stato quello di Sartre
e, poco dopo, di Merleau-Ponty; con questo modo di interpretare la fenomenologia si
verifica, negli anni '50, una rottura, a partire dalla quale prende avvio la costruzione
di un nuovo paradigma filosofico. Richiamo l' attenzione su questo perché la tesi che
intendo sostenere e che è sottesa a tutta questa mia esposizione è che risiede
proprio qui l' origine della crisi attuale: la via che fu scelta negli anni '50 chiuse alcuni
orizzonti (il soggetto, la storia), cosicché oggi ci ritroviamo sguarniti rispetto al
compito di "pensare il nostro presente".
Il seguito della mia esposizione sarà dunque così articolato: in una prima parte,
cercherò di documentare quanto ho or ora detto sulla "svolta degli anni '50", sia sulla
base delle affermazioni degli stessi post-strutturalisti sia in base a considerazioni
interne alle loro concezioni. Partirò da Foucault, a cui darò uno spazio privilegiato
per più motivi: perché è quello che più esplicitamente e più frequentemente ha
ricostruito il proprio cammino; perché è quello che è più coinvolto nello stesso tempo
nel tema della storia e nei riflessi politici del suo discorso; perché, infine, ha
impostato negli ultimi anni un' autocritica che porta allo scoperto il rapporto fra la
cultura francese e quella tedesca. Tratterò poi, più brevemente, delle concezioni di
Derrida e Deleuze; infine, cercherò di abbozzare qualche risposta in direzione di un'
uscita dalla situazione di crisi in cui ci troviamo oggi; la sostanza di quello che dirò in
proposito, e che non sarà che un accenno, si può compendiare nella domanda:
possono essere reintrodotti i concetti di "soggetto", "storia" e anche "natura"senza
ricadere in vecchie concezioni metafisiche e conservatrici (alludo ad esempio alle
posizioni di Habermas o a quelle di Ferry e Renaut)?
Partiamo dunque da Michel Foucault: nel suo caso, per i motivi che ho detto,
citerò abbastanza distesamente alcuni suoi testi; chiedo scusa di queste lunghe
citazioni, ma esse contengono alcune affermazioni che sono centrali per il mio
assunto e che si estendono in gran parte anche a Derrida e Deleuze. I testi di
Foucault a cui ci si può riferire sono numerosi, io mi limiterò all' essenziale. In primo
luogo, un testo molto noto, la prefazione alla traduzione inglese de La connaissance
de la vie di G. Canguilhem, che fu scritta da F nel 1978. In sintesi, F afferma: 1) che
la fenomenologia è stata il punto di partenza della sua riflessione; 2) che però in
essa si devono distinguere due correnti: la prima ruota intorno ai concetti di senso,
uomo, soggetto; la seconda è incentrata invece intorno ai temi del concetto, della
razionalità, delle episteme ; la prima corrente è quella di Sartre e Merleau-Ponty; la
seconda, che punta sullo Husserl dell' idealità , si rifà a Cavaillés1 e a Althusser e
integra nella fenomenologia la lezione di storici della scienza come Canguilhem e
Bachelard 3) tutto ciò viene da F legato strettamente al problema dell' Illuminismo e
al rapporto con la Scuola di Francoforte (due temi su cui, come è noto, l' ultimo F
tornerà sempre più spesso).
Leggiamo dunque un primo passo:
Sans méconnaitre les clivages qui ont pu pendant ces dernières années,
et depuis la fin de la guerre, opposer marxistes er non-marxistes, freudiens et
non-freudiens, spécialistes d'une discipline et philosophes, universitaires et
non-universitaires, théoriciens et politiques, il me semble bien qu'on pourrait
retrouver une autre ligne de partage qui traverse toutes ces oppositions. C'est
celle qui sépare une philosophie de l'expérience, du sens, du sujet et une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept. D' un côté, une filière qui est
celle de Sartre et de Merleau-Ponty; et puis une autre qui est celle de Cavaillès,
de Bachelard et de Canguilhem. En d'autres termes, il s'agit de deux modalités
selon lesquelles on a repris, en France, la phénoménologie, lorsque, bien
tardivement, vers 1930, elle a commencé enfin à être sinon connue, du moins
reconnue. La philosophie contemporaine en France débuta dans ces années-là.
Les Méditations cartésiennes * prononcées en 1929, traduites et publiées en
1931, marquent ce moment: la phénoménologie pénètre en France par ce
texte; mais il en permet deux lectures: l'une dans la direction d'une philosophie
du sujet - et ce sera l'article de Sartre sur < La Transcendance de l'ego ** >, en
1935: et l'autre qui remontera vers les problèmes fondateurs de la pensée de
Husserl, ceux du formalisme et de l' intuitionnisme, ceux de la théorie de la
science - et ce sera, en 1938, les deux thèses de Cavaillès, sur la Méthode
axiomatique et sur la Formation de la théorie des ensembles ***. Quels qu'aient
pu être par la suite les déplacements, les ramifications, les interférences, les
rapprochements méme, ces deux formes de pensée ont constitué en France
deux trames qui sont restées profondément hétérogènes. 2
p. 430
Dunque due opposte concezioni della fenomenologia; vi prego di notare come
lo Husserl che a Foucault interessa è proprio quello del formalismo, dell'
intuizionismo e della teoria della scienza.
Veniamo dunque a un secondo passo:
Il faudrait sans doute chercher pourquoi cette question de l' Aufklärung a
eu, sans disparaître jamais, un destin si différent en Allemagne, en France et
dans le pays anglo-saxons; pourquoi, ici et là, elle s'est investie dans des
domaines si divers, et selon des chronologies si variées. Disons en tout cas
que la philosophie allemande lui a donné corps surtout dans une réflexion
historique et politique sur la société (avec un moment privilégié: la Réforme; et
un problème central: 1'expérience religieuse dans son rapport avec l'économie
et l'Ètat); des hégéliens à l'école de Francfort et à Lukàcs, Feuerbach, Marx,
Nietzsche et Max Weber en portent témoignage. En France, c'est l'histoire des
sciences qui a surtout servi de support à la question philosophique de
l'Aufklärung ; après tout, le positivisme de Comte et de ses successeurs a bien
1 Sur la logique et la théorie de la science .
2 Dits et écrits , III, p. 430.
été une manière de reprendre l'interrogation de Mendelssohn et de Kant à
l'échelle d'une histoire générale des sociétés. Savoir et croyance, forme
scientifique de la connaissance et contenus religieux de la représentation, ou
passage du préscientifique au scientifique, constitution d'un savoir rationnel sur
fond d'une expérience traditionnelle, apparition, au milieu d'une histoire des
idées et des croyances, d'un type d'histoire propre à la connaissance
scientifique, origine et seuil de la rationalité, c'est sous cette forme qu'à travers
le positivisme (et ceux qui se sont opposés à lui), à travers Duhem, Poincaré,
les débats tapageurs sur le scientisme et les discussions académiques sur la
science médiévale, la question de l' Aufklärung s'est transmise en France. Et si
la phénoménologie, après une bien longue période où elle fut tenue en lisière,
a fini par pénétrer à son tour, c'est sans doute du jour où Husserl, dans les
Méditations cartésiennes et dans la Krisis *, a posé la question des rapports
entre le projet occidental d'un déploiement universel de la raison, la positivité
des sciences et la radicalité de la philosophie.
Si j'ai insisté sur ces points, c'est pour montrer que, depuis un siècle et
demi en France, l'histoire des sciences porte en soi des enjeux philosophiques
qui sont facilement reconnus. Des oeuvres comme celles de Koyré, de
Bachelard ou de Canguilhem peuvent bien avoir eu pour centres de référence
des domaines précis, <régionaux>, chronologiquement bien déterminés de
l'histoire des sciences; elles ont fonctionné comme des foyers d'élaboration
philosophique importants, dans la mesure où elles faisaient jouer sous
différentes facettes cette question de l' Aufklärung essentielle à la philosophie
contemporaine.
S'il fallait chercher hors de France quelque chose qui corresponde au travail de
Cavaillès, de Koyré, de Bachelard et de Canguilhem, c'est sans doute du côté de
l'école de Francfort qu'on le trouverait. Et pourtant, les styles sont bien différents
comme les manières de faire et les domaines traités. Mais les uns et les autres
posent finalne di questi salti; la natura è sempre e soltanto costruzione, artificio: nell'
ambito della coppia natura/cultura, F è un teorico del primato assoluto della cultura,
un negatore reciso di ogni naturalismo. Ora, non mi pare dubbio che tutte queste
coppie oppositive così radicali - senso e non senso, esperienza e ragione, natura e
cultura - rimandino a Descartes e al suo dualismo: chi più di Descartes ha teorizzato
il primato della ragione sull' esperienza? Chi ha ridotto la natura a materia passiva e
gli apesanteurs ou des coercitions qui l'assujettissent. Dans l'histoire des sciences
en France, comme dans la théorie critique allemande, ce qu'il s'agit d'examiner au
fond, c'est bien une raison dont l'autonomie de structures porte avec soi l'histoire
des dogmatismes et des despotismes - une raison, par conséquent, qui n'a d'effet
d'affranchissement qu'à la condition qu' elle parvienne à se liberer d' elle-même.3
Alcune osservazioni: è evidente come F sia consapevole del rapporto FranciaGermania, rapporto che implica punti di contatti e differenze; notate anche come il
discorso abbia un' ampio respiro storico-politico: Francia e Germania rappresentano
due modi differenti in cui si costituisce la società industriale moderna, che combina
insieme la tecnoscienza e lo sviluppo di apparati statali-burocratici; in questo quadro,
egli caratterizza la cultura francese come frutto di un innesto, nel positivismo di
Comte (di cui Canguilhem è per molti versi erede) dello Husserl delle Medit. cart. e
della Crisi . Infine, Cartesio contro Lutero: non ho tempo per analizzare questa
3 Ivi, p. 431-3.
riduzione di un intero filone della filosofia moderna a Lutero; ma voglio sottolineare il
riferimento a Descartes, che da certi punti di vista è sorprendente: F, che è stato per
molti versi il critico più radicale di Descartes, si richiama qui al suo nome: un segno
inequivocabile di come anche la sua filosofia si ponga in continuità col grande filone
francese dell' intellettualismo cartesiano.
Nello stesso anno (1978), F tiene alla Société Française de Philosophie la
conferenza che più tardi sarà pubblicata col titolo di Qu' est ce que la critique?. In
essa, lo vediamo preoccupato dagli stessi temi, che evidentemente erano al centro
della sua meditazione costante in questo periodo; ma qui il confronto con la
Germania e con la cultura tedesca è assai più sviluppato: F si riferisce con molto
insistenza a Max Weber; la sua valorizzazione della Scuola di Francoforte è più
accentuata - nel testo precedente, prevaleva la presa di distanza; qui, il fatto che la
Germania abbia intrapreso, come via alla libertà, la Riforma luterana, la critica
individuale alla fede, appare come un vantaggio rispetto a una Francia prima
illuminista e poi positivista, che ha dovuto fare un lungo détour per riscoprire il tema
della critica della razionalità; leggiamo il passo:
En France… le bloc constitué par les Lumières et la Révolution a sans
doute empêché d'une façon générale que l ' on remette réellement et
profondément en question ce rapport de la rationalisation et du pouvoir; peutêtre aussi le fait que la Réforme, c'est-à-dire ce que je crois avoir été, dans ses
racines très profondes, le premier mouvement critique comme art de n' être pas
gouverné, le fait que la Réforme n'ait pas eu en France l'ampleur et la réussìte
qu'elle a connues en Allemagne, a fait sans doute qu'en France cette notion d'
Aufk1ärung avec tous les problèmes qu'elle posait n'a pas eu une signification
aussi large, et d'ailleurs elle n'a jamais pris une référence historique d'aussi
longue portée qu'en Allemagne…
Or je crois que la situation en France a changé au cours des dernières années;
et qu'en fait ce problème de l' Aufk1ärung (tel qu'il avait été si important pour la
pensée allemande depuis Mendelssohn, Kant, en passant par Hegel, Nietzsche,
Husserl, l' École de Francfort, etc...), il me semble qu'en France on est venu à une
époque où précisément ce problème de l'Aufk1ärung peut être repris dans un
voisinage assez significatif avec, disons, les travaux de l'École de Francfort. Disons,
toujours pour faire bref, que - et ce n'est pas étonnant - c'est de la phénoménologie
et des problèmes posés par elle que nous est revenue la question de ce que c'est
que l'Aufklärung . Elle nous est revenue en effet à partir de la question du sens et de
ce qui peut constituer le sens. Comment se fait-il qu'il y ait du sens à partir du non
sens ? Comment le sens vient-il? Question dont on voit bien qu'elle est la
complémentaire de cette autre: comment se fait-il que le grand mouvement de la
rationalisation nous ait conduits à tant de bruit, à tant de fureur, à tant de silence et
de mecanisme morne ? Après tout il ne faut pas oublier que La Nausée est à peu de
mois près la contemporaine de la Krisis. Et c'est par l' analyse, après la guerre, de
ceci, à savoir que le sens ne se constitue que par des systèmes de contraintes
caractéristiques de la machinerie signifiante, c'est, me semble-t-il, par l'analyse de
ce fait qu'il n'y a de sens que par des effets de coercition propres à des structures,
que, par un étrange raccoirci, s'est retrouvé le problème entre ratio et pouvoir. Je
pense également (et là ce serait une étude à faire, sans doute) que les analyses
d'histoire des sciences, toute cette problématisation de l'histoire des sciences (qui,
elle aussi, s'enracine sans doute dans la phénoménologie, qui en France a suivi à
travers Cavaillès, à travers Bachelard, à travers Georges Canguilhem, toute une
autre histoire), il me semble que le problème historique de l'historicité des sciences
n'est pas sans avoir quelques rapports et analogies, sans faire jusqu'à un certain
point écho, à ce problème de la constitution du sens : comment nait, comment se
forme cette rationalité, à partir de quelque chose qui est tout autre? Voilà la
reciproque et l'inverse du problème de l'Aufklärung : comment se fait-il que la
rationalisation conduise à la fureur du pouvoir?4
Dunque, al posto delle due fenomenologie, qui F ci delinea questo quadro: da
un lato, c'è una corrente tedesca, che comprende anche un certo Husserl, e che
pone il problema: perché la ragione, sviluppandosi, produce dominio, oppressione,
totalitarismo; dall' altra, una corrente francese (e sorprendentemente Foucault fa il
nome di Sartre), che pone un problema reciproco: com' è che si sono formate le
strutture della scienza, che non sono frutto di una razionalità bell' e fatta, costituita,
ma della storia, di un processo costitutivo che ha a che fare col tempo - è chiaro
perché venga citato Bachelard, che ha tanto insistito sulla discontinuità fra i vari
momenti della cultura scientifica; è chiaro che pensa anche allo Husserl dell' Origine
della geometria , che si chiedeva: come si è storicamente formata la geometria
euclidea?, rifiutando con ciò il trascendentalismo kantiano. Ma è chiaro anche che,
quando F parla del fatto che il senso, l' idealità sorgono dal non-senso, egli si sta
riferendo insieme alla lezione dello strutturalismo e a quella di Nietzsche. È questo
(è un tedesco!) che differenzia i francesi dai tedeschi: questi ultimi partono dal
senso, dalla ragione, per poi delimitarla e criticarla, mentre i francesi partono dal non
senso per indagare come da esso si generi la ragione. Insisto molto su questo
perché qui è probabilmente il fuoco del problema: l' impostazione nietzscheana di un
passaggio dal non senso al senso condiziona molto tutta l' impostazione teorica di F
( e non solo la sua): ci tornerò presto.
Infine, vorrei richiamarvi alcuni passi di contenuto più autobiografico; in un'
intervista a Duccio Trombadori, che risale anch' essa al 1978, F sottolinea più
chiaramente il ruolo che Nietszche, Blanchot, Bataille hanno avuto nel determinare
la sua lettura della fenomenologia; è dalla congiunzione della loro lezione con quella
di Husserl e dello strutturalismo che è derivata la negazione del soggetto:
- Nietzsche, Blanchot et Bataille sont les auteurs qui m'ont permis de me libérer
de ceux qui ont dominé ma formation urnversitaire, au début des années 1950:
Hegel et la fénoménologie. Faire de la philosophie, alors, comme du reste
aujourd'hui, cela signifiait principalement faire de l'histoire de la philosophie; et celleci procé-dait, délimitée d'un côté par la théorie des systèmes de Hegel et de l'autre
par la philosophie du sujet, sous la forme de la phénoménologie et de
l'existentialisme. En substance, c'était Hegel qui prévalait.
Il s'agissait, en quelque sorte, pour la France d'une découverte récente, après
les travaux de Jean Wahl et la leçon d'Hyppolite. C'était un hégélianisme fortement
pénétré de phénoménologie et d'existentialisme, centré sur le thème de la
conscience malheurese. Et c'était, au fond, ce que l'Université française pouvait
offrir de mieux comme forme de compréhension, la plus vaste possible, du monde
contemporain, à peine sorti de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et des
grands bouleversements qui l'avaient précedée: la révolution russe, le nazisme, etc.
Si l'hégélianisme se présentait comme la façon de penser rationnellement le
tragique, vécu par la génération qui nous avait immédiatement precédés, et toujours
menaçant, hors de l'Université, c'était Sartre qui était en vogue avec sa philosophie
du sujet. Point de rencontre entre la tradition philosophique universitaire et la
4 Bull. Soc. Franç. de Philos., 1990, pp. 43-4.
phénoménologie, Merleau-Ponty développait le discours existentiel dans un
domaine particulier comme celui de l'intelligibilité du monde, du réel. C'est dans ce
panorama intellectuel qu'ont mûri mes choix: d'une part, ne pas être un historien de
la philosophie comme mes professeurs et, d'autre part, chercher quelque chose de
totalement différent de l'existentialisme: cela a été la lecture de Bataille et de
Blanchot et, à travers eux, de Nietzsche. Qu'est-ce qu'ils ont représenté pour moi?
D'abord, une invitation à remettre en question la catégorie du sujet, sa
suprématie, sa fonction fondatrice. Ensuite, la conviction qu'une telle opération
n'aurait eu aucun sens si elle restait limitée aux spéculations; remettre en question le
sujet signifiait expérimenter quelque chose qui aboutirait à sa destruction réelle, à sa
dissociation, à son explosion, à son retournement en tout autre chose. 5
Poco dopo, l' intervistatore pone a Foucault la seguente domanda:
-De quelle façon la problématique qui tournait autour de l' histoire des sciences
est-elle intervenue dans votre formation? 6
e F risponde:
- Paradoxalement, un peu dans le même sens que Nietzsche, Blanchot,
Bataille. On se demandait: dans quelle mesure l'histoire d'une science peut-elle
mettre en doute sa rationalité, la limiter, y introduire des éléments extérieurs? Quels
sont les effets contingents qui pénètrent une science à partir du moment où elle a
une histoire, où elle se développe dans une société historiquement déterminée?
D'autres questions suivaient celles-ci : peut-on faire une histoire de la science qui
soit rationnelle? Peut-on trouver un principe d'intelligibilité qui explique les diverses
péripéties et aussi, le cas échéant, des éléments irrationnels qui s'insinuent dans
l'histoire des sciences?
Tels étaient schématiquement les problèmes posés tant dans le marxisme que
dans la phénoménologie. Pour moi, au contraire, les questions se posaient de façon
légèrement différente. C'est là où la lecture de Nietzsche a été pour moi très
importante: il ne suffit pas de faite une histoire de la rationalité, mais l'histoire même
de la vérité. C'est-à-dire que, au lieu de demander à une science dans quelle
mesure son histoire l'a rapprochée de la vérité (ou lui a interdit l'accès à celle-ci), ne
faudrait-il pas plutôt se dire que la vérité consiste en un certain rapport que le
discours, le savoir entretient avec lui même, et se demander si ce rapport n'est ou
n'a pas lui-meme une histoire?7
Sottolineo che lo stesso Foucault parla di paradosso: associare l' evento
rappresentato dalla fondazione di una scienza alle esperienze limite di Nietzsche,
Blanchot, Bataille è effettivamente8 molto curioso; ma di nuovo, questo è un punto
cruciale: è questo paradosso che deve essere pensato per comprendere veramente
la filosofia post-strutturalista.
Traggo dunque qualche conclusione generale, partendo proprio da quest'
ultimo punto: attraverso le varie fasi della sua riflessione, che sono state molte e in
5 Dits et écrits , IV, p. 48.
6 Ivi, p. 54.
7 Ibid.
8 Come nota l' intervistatore poco dopo, ibid.
questa sede non era certo possibile ricostruirle, c'è una costante della posizione di
F: l' accostamento di un razionalismo rigoroso, temprato sullo Husserl dell' idealità,
sullo Husserl che ha riflettuto sullo statuto delle entità matematiche, a delle posizioni
fortemente "irrazionalistiche", "estreme": il salto fra non senso e senso, fra caos e
ordine, fra percezione e razionalità è assoluto; la storia è per F una successione di
questi salti; la natura è sempre e soltanto costruzione, artificio: nell' ambito della
coppia natura/cultura, F è un teorico del primato assoluto della cultura, un negatore
reciso di ogni naturalismo. Ora, non mi pare dubbio che tutte queste coppie
oppositive così radicali - senso e non senso, esperienza e ragione, natura e cultura rimandino a Descartes e al suo dualismo: chi più di Descartes ha teorizzato il
primato della ragione sull' esperienza? Chi ha ridotto la natura a materia passiva e
gli animali a macchine? Di fronte a questo razionalismo, è allora abbastanza chiaro il
ruolo che nell' edificio teorico di F vengono a rivestire Nietzsche, Blanchot e Bataille
(e nel passo che vi ho citato per ultimo F lo dice del resto esplicitamente): poiché,
per un lato, F vuole fuoriuscire dalla struttura opprimente della razionalità data,
costituita e, d' altro lato, dalla razionalità non è possibile uscire, poiché l' unica novità
che ci può essere è quella di altre strutture razionali , altre episteme, il pensiero di
quegli autori "negativi" fornisce per così dire il serbatoio infinito che assicura i
cambiamenti delle strutture concettuali; il dionisiaco, l' eccesso, l' al di là sono l'
infinito, l' elemento assoluto che garantisce la non chiusura delle strutture razionali
su se stesse, che le apre all' evento , al cambiamento: le apre, possiamo anche dire,
alla rivoluzione , perché è in questo senso e in questo punto che il pensiero di F è
rivoluzionario: egli teorizza ripetutamente l' avvento di un ordine assolutamente altro
- e questo vale anche per l' ultimo periodo della sua riflessione, nonostante le
apparenze (tutte queste considerazioni fatte sulle episteme e il loro mutamento
potrebbero essere ripetute senza variazioni per il rapporto fra il potere e i
contropoteri, fra le strutture del potere e il modo con cui si può organizzare la
resistenza ad esse, per i cambiamenti e le trasformazioni che la resistenza al potere
può indurre). Vorrei dunque che si tenesse ferma come conclusione provvisoria la
seguente: che F unisce in un modo che ha una sua coerenza e una sua necessità
un razionalismo e un intellettualismo rigorosi (cartesiano-husserliani) con una
concezione nietzscheana del dionisiaco, cioé con un' idea dell' Assoluto; è questo,
del resto, che gli consente di mettere da parte la problematica del soggetto.
Avendo largamente documentato la posizioni di Foucault, sarò molto più
sintetico su quelle di Derrida e Deleuze. Per quanto riguarda Derrida, il suo caso è in
un certo senso ancora più chiaro, dal punto di vista che ho scelto. È vero che,
nonostante il numero ormai grande di interviste di carattere autobiografico che egli
ha rilasciato, Derrida è molto meno esplicito di Foucault sulla sua formazione e ha
molto meno il gusto della ricostruzione storica ; tuttavia, in un testo che non è
nemmeno recentissimo, un' intervista del 1993 9, egli ricostruisce la sua
autobiografia intellettuale e ricorda: la sua formazione fenomenologica; la sua presa
di distanza, fin da giovanissimo, da Sartre e Merleau-Ponty; l' influenza di Althusser
e dello stesso Foucault: non c' è dubbio, insomma, che anche Derrida si inserisca
nella corrente fenomenologica di stampo intellettualistico individuata da F. E
specialmente i suoi lavori fino al 1967 lo confermano: si laurea con una tesi sul tema
della genesi in Husserl, cioé sul problema del rapporto fra storia e costituzione degli
oggetti ideali; il primo lavoro di una certa mole che pubblica, è la traduzione e il
commento a un testo husserliano sull' origine della geometria ed è dunque sullo
9 Derrida/Ferraris, Il gusto del segreto , Roma-Bari 1997, p. 40-1 e passim.
stesso tema: come si sono costituite nel tempo, nella storia le verità ideali della
geometria? Come è possibile che verità universali e necessarie come quelle
geometriche siano apparse ad un certo momento, siano insomma degli eventi storici
? Come è possibile che noi datiamo come un avvenimento storico la nascita della
geometria? Anche qui, insomma, il tema è quello di come si sia generato il senso a
partire dal non senso; però, nel caso di Derrida, c'è, nell' impostazione della
questione, una differenza sottile, ma importante, rispetto a F - e questa differenza è
probabilmente all' origine della dura polemica che li ha divisi: Derrida tende a
sottolineare come condizione dell' idealità, dell' universalità, della necessità sia un
certo rapporto con l' empirico , con il casuale , col non senso; più che di origine del
senso dal non senso, si dovrebbe allora parlare qui di costante limitazione del senso
da parte del non senso, di inevitabile parzialità del processo di idealizzazione, di un'
opacità che insieme è limite e condizione della luce, della trasparenza. È questo,
poi, il nocciolo del concetto derridiano di écriture : l' indispensabilità della scrittura
simboleggia il rapporto ineludibile che anche gli elementi più universali hanno con
quella cosa caduca, empirica, materiale che è la scrittura; e non è certo un caso né
un fatto secondario che, nel parlare di scrittura, è anche, e non in via secondaria, al
simbolismo matematico che Derrida pensa: nulla forse, più della scrittura
matematica, dà a vedere come anche i concetti più formalizzati sono condizionati da
qualcosa di empirico e di non riducibile al senso (a differenza del linguaggio
naturale , il linguaggio matematico non è fonetico , non è dunque nemmeno
possibile l' illusione, che il linguaggio naturale fonetico dà, che la scrittura sia solo un
momento di provvisoria opacità destinato a togliersi per dar luogo a un senso pieno
e integralmente razionale, a un significato puramente ideale e spirituale). Non mi
soffermerò oltre nel dare dettagli sulla decostruzione e sui vari sviluppi che Derrida
ha dato alla sua filosofia; mi limiterò a richiamare alcuni punti che si collegano al mio
intento di oggi. I primi due richiami, uno da un testo giovanile, l' altro da un testo
recentissimo, documentano la fedeltà di Derrida allo Husserl più rigoroso e il suo
distacco da Merleau-Ponty. Il primo testo riguarda la questione del mito e della
mentalità primitiva, che Derrida discute occupandosi della Lettera a Lévi-Bruhl di
Husserl, da lui conosciuta attraverso due saggi di Merleau-Ponty. La lettera è del
1935 e fu scritta da Husserl dopo la lettura de La mitologia primitiva di LB. Husserl,
riferisce MP (Signes , p. 135)
semble admettre ici que le philosophe ne saurait atteindre immédiatement à un
universel de simple réflexion, qu'il n'est pas en position de se passer de l'experiénce
anthropologique, ni de construire, par une variation simplement imaginaire de ses
propres expériences, ce qui fait le sens des autres expériences et des autres
civilisations… l'accès aux mondes archaiques nous est barré par notre propre
monde: les primitifs de Lévy-Bruhl sont « sans histoire > (geschichtlos), il s'agit chez
eux d' « une vie qui n'est que présent qui s'écoule » … Au contraire nous vivons
dans un monde historique, c'est-à-dire qui « a un avenir en partie réalisé (le < passé
> national) et un avenir en partie à réaliser ». L'analyse intentionnelle qui retrouvera
et reconstituera les structures du monde archaique ne saurait se borner à expliciter
celles du nôtre : car ce qui donne sens à ces structures, c'est le milieu, l'Umwelt,
dont elles sont le style typique, et l'on ne peut donc les comprendre à moins de
comprendre comment le temps s'écoule et comment l' être se constitue dans ces
cultures.
In sostanza, MP interpretava la posizione di Husserl come una limitazione del
suo logocentrismo, della sua tematica dell' unicità del logos : Levy-Bruhl ci presenta
delle mentalità strutturate secondo delle idee del tempo e dell' essere assoultamente
diverse dalla nostra; e questo la fenomenologia trascendentale deve accettarlo
come un fatto indeducibile dal suo metodo eidetico, fondato sulla mentalità dell'
uomo civilizzato. Mp indirizzava allora la fenomenologia di Husserl verso un pensiero
della storia vista come uscita dall' alternativa fra trascendentalismo puro e storicismo
e relativismo puri.
Ora, è notevole che, di fronte a un MP pronto a aprire Husserl verso un' alterità
totale dalla ragione , verso una mentalità primitiva, insomma verso una concezione
antiintellettualistica, D10 difenda un Husserl molto più razionalista. D insomma
sostiene che la lettera a Lb non costituisce affatto un mutamento di rotta di Husserl;
quando H afferma che certe mentalità diverse dalla nostra non possono essere
dedotte per via di variazione immaginaria dalla nostra mentalità, non sta mettendo in
causa il suo metodo trascendentale e la priorità della necessità di avere una
conoscenza dell' umanità in generale e delle sue strutture per poter accedere poi
alla conoscenza fattuale dei vari tipi di umanità. Certo, per poter conoscere le varie
culture, mi è necessario il materiale empirico e dunque l' apporto dell' etnologia; ma
esso non va a scalfire la purezza del modello teoretico trascendentale, che rimane
un presupposto indiscusso. Non mi interessa in questa sede discutere quali di
queste due interpretazioni del testo di Husserl, quella di MP e quella di D, sia più
corretta storicamente e filologicamente; è sul tipo di interpretazione che D dà di
Husserl che voglio richiamare l' attenzione: è lo Husserl più coerentemente
razionalista che D difende: fra senso e non senso, fra la razionalità e il suo altro non
ci può essere terreno di mediazione, mentre una certa valorizzazione del mito e dell'
immaginazione cerca di delineare quel tertium fra opposti che l' impostazione di
Derrida esclude.
Se ora andiamo a prendere un passo dell' opera, appena pubblicata, che D ha
dedicato a Nancy, vediamo che D si confronta con Merleau-Ponty sul problema,
legato al precedente, della relazione con l' altro e, in sostanza, gli rimprovera,
nuovamente, di essere poco fedele a uno Husserl la cui posizione è interpretata in
una chiave del tutto intellettualistica:
Les conséquences de cette «interprétation» active de Merleau-Ponty, et de
cette liberté prise au regard de ce à quoi Husserl sembie tenir le plus, nous les
disions donc « paradoxales et tvpiques». Typiques parce qu'elles ont souvent donné
lieu à des gestes ressemblants, notamment en France. Paradoxales parce que, au
moment d'orienter Husserl vers une prise en compte plus audacieuse de l'autre (d'un
autre originairement en moi ou pour moi, etc.), au détriment d'un Husserl plus
classique, plus égocentré, etc., on risque d'aboutir au résultat exactement inverse.
On risque de reconstituer un intuitionnisme de l'accès immédiat à l'autre, aussi
originaire que mon accès à mon propre le plus propre - et du coup, faisant
l'économie de l'apprésentation, de l'indirection, de l'Einfühlung, on risque aussi de
réapproprier l'altérité de l'autre plus sûrement, plus aveuglément, voire plus
violemment que jamais. A cet égard, la prudence husserlienne restera toujours
devant nous, comme un modèle de vigilance. Il faut veiller à I'altérité de l'autre :
celle-ci restera toujours inaccessible à une intuition donatrice originaire, à une
présentation immédiate et directe de l'ici. Il faut y veiller, même si c'est difficile à
assimiler par une phénoménologie fidèle à son «principe des principes»
intuitionniste - celui-là même qui commande l'haptocentrisme de Ideen II. Je sais ou
je sens qu'il y a un autre ici, certes, et puisque c'est notre thème, l'autre ici d'un
touchant-touché (lui-méme écarté de lui-même, jusque dans la présentation de son
10 Husserl, L'orig. de la géom. , tr. et intr. par J. Derrida, pp. 115 et suiv.
présent, par le temps de son expérience et par le simple écart, la non-coincidence
syncopée de son rapport à soi), mais cet autre « ici» se présente comme ce qui ne
sera jamais le mien, cette non-mienneté faisant partie du sens de cette présentation,
qui elle-même, comme la mienne propre, souffre déjà de la « méme» expropriation.
Sans substitution possible; et la logique la plus surprenante de la substitution,
partout où nécessairement elle opère, supposera la substitution des nonsubstituables, des uniques et des autres, des uniquement autres. Etre singulier
pluriel, dirait peut-étre alors Nancy.
Si j'ai souvent parlé de deuil pré-originaire à ce sujet, reliant ce motif à celui
d'une ex-appropriation, ce fut pour marquer que dans ce deuil d'avant la mort,
l'intériorisation, et méme l'introjection qu'on accorde souvent au deuil normal, ne
peut pas et ne doit pas s'accomplir. Deuil comme deuil im-possible. Et d'ailleurs anhumain, plus qu'humain, pré-humain, autre que l'humain «dans» l'humain de
l'humainisme. Eh bien, malgré toutes les différences qui séparent le discours que je
tiens à l'instant d'un discours de style husserlien, et sans doute des grands massifs
de la phénoménologie, je lui trouve plus d'affinité avec celui que Husserl maintient
obstinément au sujet de l'apprésentation (et que je suis tenté d'étendre er de
radicaliser, au prix des déplacements nécessaires, mais ce n'est pas le lieu d'y
insister) qu'avec celui d'un certain Merleau-Ponty:11
Quasi quarant' anni separano le prese di posizione che ho citato, eppure in
esse cogliamo, per così dire, l' ossatura del pensiero di Derrida: l' opzione per una
fenomenologia razionalistica e intellettualistica; bisogna anzi dire che da queste
premesse fenomenologiche Derrida deduce, ancora più recisamente di F, che il
logos , la razionalità è una e una sola (quella occidentale e greca) e che, se essa
deve essere criticata - e lo deve essere - ciò non può essere fatto proponendo una
sua trasformazione, un' altra possibile razionalità. La razionalità può essere criticata
solo mostrando i suoi paradossi, le sue contraddizioni, i suoi limiti - allora essa fa
trasparire quel suo Altro, quell' Assoluto che tuttavia non può essere mai attinto
come tale, né immesso nel logos : può essere solo intravisto da quei buchi che sono
la condizione e il limite della razionalità. Il logos può essere imbrogliato, eluso,
messo in contraddizione con se stesso, ne può essere rivelata la paradossalità, ma
non se ne può cambiare minimamente la struttura.
Toccando questo tema dell' Assoluto, veniamo così ad un altro punto che
volevo richiamare: il dualismo senso-non senso, ragione/empiria, che vale per
Derrida come per F, anche nel suo caso si collega a una ripresa di Nietzsche, di
Bataille, di Blachot, di Artaud. Per un lato, sappiamo che l' incontro con Nietzsche è
stato per D decisivo fin dagli anni del liceo, in Algeria; per l' altro proprio gli anni in
cui elabora i suoi migliori saggi di rigorosa esegesi husserliana, egli pubblica dei
lavori importanti su Artaud e su Bataille. Proprio a proposito del saggio che a Bataille
è dedicato ne La scrittura e la diff.12, val la pena di soffermarsi un momento, poiché
per un lato esso fornisce il primo schema di tutte le posizioni politiche di Derrida
(anche le più recenti, centrate sul tema del dono), per l' altro ci permette di
esplicitare la loro affinità con quelle di Foucault. Riprendendo Bataille e la sua
nozione di dépense , è la questione della critica e dei limiti della ragione strumentale
11 Le toucher ,Jean-Luc Nancy , Paris, 2000, p. 218.
12 De l' économie restreinte à l' économie générale - Un hegelianisme sans réserve .
che Derrida viene a investire; era in questa forma, del resto, attraverso Mauss, che
la cultura francese, negli anni '30, aveva impostato la critica della razionalità
capitalistica. In questo quadro, la lettura che Bataille aveva fatto di Mauss aveva
dato al pensiero di quest' ultimo un' inflessione particolare: Bataille aveva insistito
sull' idea dell' eccesso, di una dépense liberata dai limiti dell' utile e del bisogno,
sciolta da ogni calcolo. Ma, più delle posizioni effettive di Bataille, ci interessa la
lettura che Derrida ne dà nel 1967: tale lettura implica che il calcolo, quello che
Bataille chiama l' economia ristretta, sia nello stesso tempo ineludibile (esattamente
come il logos husserliano) e debordato, reso possibile dall' economia generale,
dalla dépense , dall' eccesso, dalla morte, che limitano e relativizzano il primo
momento, quello del calcolo. Insomma, siamo di fronte all' idea, che abbiamo già
incontrato in Foucault, di strutture razionali immodificabili (per Derrida sono, più che
per Foucault, veramente immodificabili) che però possono far uscire alla luce il loro
rovescio - la danza, l' eccesso, in una parola la vita. Se vogliamo dare il massimo di
esplicitezza a questo programma politico che in realtà non è mai stato molto esplicito
e articolato (il che non gli ha impedito di esercitare degli effetti potenti) potremmo
dire: il progetto era, non di modificare la razionalità utilitaria, ma di porla come un
elemento secondario, marginale, all' interno di un contesto vitale più ampio,
dominato non dall' utile, ma dalla dépense , dal gioco, dalla libertà. In tutto questo,
alla lezione di Nietzsche Derrida congiunge quella di Heidegger, che in Foucault è
più sottaciuta, ma anche meno accentuata. E tuttavia, l' impianto fondamentale del
discorso è lo stesso: anche in Derrida, abbiamo delle strutture razionali di cui
bisogna esplicitare la condizionatezza, ma che non potranno mai essere
trasformate; anche per lui l' unica via d' uscita è quella di portare allo scoperto quei
margini, quelle crepe , quei limiti in cui il senso fa posto al non senso, poiché essi
sono la vera riserva del senso, la risorsa che lo mette in moto e che ne impedisce
la fissazione. Di nuovo, insomma, abbiamo un non senso come riserva infinita, come
Assoluto, che rimane sempre oltre il senso, ma ne assicura sia la vita che la morte,
che insomma ne impone la circolazione. In D questo Assoluto, che è poi l' écriture ,
è assai vicino all' Essere di Heidegger. E anche D si è, a un certo punto, accostato,
a modo suo, all' idea di rivoluzione: basti pensare alle pagine della Grammatologie ,
che sono del 1967, e in cui si parla del prossimo avvento di un' era completamente
nuova, un' era di cui possiamo intuire la venuta, ma di cui, nella sua assoluta novità,
non è possibile dire positivamente nulla - e qui D si collegava, seppur criticamente,
al terzomondismo, a una certa cultura antropologica degli anni '60, alle idee
nietzscheano-heideggeriane sulla fine dell' Occidente. In seguito D non è più tornato
su questi toni apocalittici, che ha anzi esplicitamente criticato, ma il suo modo di
pensare la storia è rimasto lo stesso: storia è per lui l' avvento dell' alterità assoluta,
è dunque la dimensione dell' assolutamente nuovo e imprevedibile, la lacerazione
dell' evento, salvo che questa lacerazione lascerà intatte le strutture del logos (cosa
che, come dicevo, non vale per Foucault). Quanto al soggetto, fin dall' inizio Derrida
ha insistito sul fatto che esso andasse inteso, husserlianamente, come soggetto
depsicologizzato, cioé deumanizzato - insomma fin dall' inizio ha collegato il
razionalismo antipsicologico di Husserl all' antiumanesimo di Heidegger.
Dunque, tirando le somme, anche in Derrida, con le dovute differenze,
abbiamo un dualismo "cartesiano" che accoppia intellettualismo e Assoluto, Infinito,
eccesso. Questa struttura teorica comanda anche nel suo pensiero le prese di
posizione sul soggetto e sulla storia.
Il caso di Gilles Deleuze è, rispetto agli autori di cui ho parlato, almeno in
apparenza molto diverso; non c'è dubbio che D si sia spinto molto più in là nel far
prevalere il polo "irrazionale": egli sostiene una concezione bergsoniana del rizoma e
del flusso che comporta una negazione ancora più radicale del soggetto, una
filosofia della forza della forza che, inetrpretando Nietzsche, ne fa riemergere tutta la
prossimità al positivismo ottocentesco; e dall' inizio alla fine è questa versione del
pensiero di Nietzsche a essere dominante nella sua impostazione. Tuttavia,
chiunque abbia preso sul serio Deleuze come pensatore sa che, se una maggiore
accentuazione verso il polo della differenza e del flusso è indubbia nella sua
posizione, tale maggiore accentuazione avviene comunque all' interno di un rapporto
con l' altro polo, quello apollineo , della trasparenza, addirittura del rigore formale.
Ricorderò, molto schematicamente, solo alcuni dati di fatto: al posto della
fenomenologia e della storia delle scienze, alle quali, soprattutto alla prima, Deleuze
è rimasto estraneo, troviamo nella sua riflessione il riferimento allo strutturalismo e
alla logica formale: queste due correnti filosofiche sono anzi fondamentali per
Deleuze per sostituire, alla coscienza, come origine del senso, il calcolo delle
possibilità, il gioco combinatorio; ed è noto come in alcuni punti decisivi del suo
discorso, egli ricorra agli strumenti del calcolo differenziale e integrale. A questo
proposito, bisogna ricordare che due sono stati i maestri decisivi di Deleuze: Martial
Gueroult, che ha cercato di applicare la teoria strutturalistica dei sistemi alla storia
della filosofia, e Jules Villeumin, che, oltre ad aver orientato Deleuze verso la
filosofia post-kantiana, ha avuto profondi interessi di filosofia analitica. Ora si sa che
più volte Deleuze si è riferito al calcolo delle relazioni come a un fondamento per
eliminare il soggetto metafisico: quel calcolo evidenzia delle relazioni, la cui validità,
il cui senso è indipendente da contenuti e da soggetti, in cui insomma la relazione è
l' unico vero soggetto. In effetti, l' accoppiamento di una concezione del flusso e del
rizoma con un' esigenza di rigore sistematico ci dà la chiave per comprendere sia l'
opera su Spinoza che quella su Leibniz: due lavori che sono il tentativo di rovesciare
come guanti due grandi sistemi metafisici del razionalismo classico, mostrando
come alla loro base stia la volontà di potenza - nel caso di Spinoza il conatus , nel
caso di Leibniz la vis o nisus . Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte allo stesso
iato, allo stesso dualismo di forza e ordine, di non senso e senso che abbiamo visto
nei due autori precedenti; anche qui, fra ordine sistematico e rizoma, non si dà un
tertium ; quello che differenzia Deleuze e che costituisce la sua cifra specifica
rispetto a Foucault e Derrida è il fatto che, al costruttivismo e al culturalismo assoluti
di questi ultimi, Deleuze sostituisce un vero e proprio naturalismo: unico dei tre a
parlare di materialismo, egli è un filosofo dell' immanenza e dell' univocità dell'
essere; se ad esempio, il Nietzsche di F è quello della volontà di potenza come
potere costituente e genealogico , il Nietzsche di Deleuze è quello di una volontà di
potenza in cui si esprime la positività del dir di sì alla vita e rimanda dunque al
naturalismo insieme tragico e gioioso della nozione di dionisiaco. Questo
naturalismo in cui Nietzsche viene fatto convergere con Bergson ha poi le sue radici
- anche se Deleuze lo esplicita di rado - nella riflessione classica tedesca dell' era
post-kantiana. Dicevo dell' influenza di Gueroult e di Villeuimin; è stato in effetti sulla
scia di quest' ultimo che Deleuze si è soffermato su Maimon 13, sulla nozione di
intensità come veniva discussa dopo Kant (e del resto uno dei suoi primi libri è
proprio su Kant14). Il problema di una qualità che non può essere irregimentata
dalla quantità - questo problema così francofortese che è pure il tema fondamentale
della riflessione di Deleuze - deriva da queste discussioni molto classiche dell' epoca
del primo idealismo; perciò ritengo molto opportuno che l' autore di uno dei migliori
studi che possediamo su deleuze, A. Gualandi, abbia insistito sulla vicinanza fra la
13 Essai sur la philosophie transendentale , 1790.
14 La filosofia critica di Kant, 1963.
sua concezione e il naturalismo di Schelling15. Quest' ultimo, va da sé, concepisce
la Natura come Idea: e per questa via, oltre che per quella di Nietzsche, ritroviamo in
Deleuze il tema dell' Infinito e dell' Assoluto; in un certo senso, tale tema è ancora
più centrale che in Derrida e Foucault, è più evidente e scoperto: la filosofia
deleuziana del flusso, del divenire, della differenza è il tentativo di dar voce, in una
forma particolare, all' infinito. È noto, in questo senso, quanto D insista sul tema
della virtualità , che egli oppone alla potentia aristotelica: virtualità è appunto l'
espressione di quell' infinità dell' Essere che non si esaurisce mai nelle sue
determinazioni ma non è nemmeno mai anteriore ad esse: un' idea di essere come
pura produttività infinita di novità, di differenze, di eventi.
Se questa forma di naturalismo sostituisce in Deleuze il culturalismo assoluto
che troviamo in Foucault e Derrida, dal punto di vista della concezione della storia i
risultati non sono molto diversi; certo, Deleuze è più per una negazione di tale
concetto che per una sua riformulazione. Ma, in ogni caso, se di storia in Deleuze si
può parlare, è solo nel senso dell' evento, della novità assoluta, della rivoluzione
come prodursi improvviso di una rottura - tutti modi in cui Deleuze reinterpreta la
tematica nietzscheana dell' eterno ritorno. Tutta l' opposizione e la critica di D al
capitalismo - opposizione e critica che sono assai radicali - sono fondate su questa
categoria: il capitalismo è sedentarietà, radicamento, cattiva ripetizione,
accumulazione e messa in riserva della forza e dell' energia; la liberazione è il
nomadismo, la dispersione dell' identità, il perdersi del flusso vitale in mille rivoli; e D
non manca di rievocare il modello trotskista della rivoluzione permanente 16. Anche
qui, insomma, funziona lo schema binario razionalità/calcolo economico/ identità
narcisistica da un lato, desiderio, eccesso, incalcolabilità e incommensurabilità del
vitale e dell' energetico dall' altro; fra razionalità utilitaria e libertà non c' è possibilità
di mediazione, c'è un salto assoluto; ed anche per D, a suo modo, certo, è stato
valido il fatto che non si trattava di modificare la ratio utilitaria, né di puntare su un
progetto fondato su dei soggetti: la "rivoluzione" non poteva che venire da sé; la
scommessa era l' autoscioglimento delle strutture, l' autorovesciamento dei sistemi
razionali nel loro Altro. Ricorderò a questo proposito solo quest' affermazione, che è
del 1973 (e in cui naturalmente per "strutturalismo" si deve intendere "poststrutturalismo"):
…lo strutturalismo non è separabile da un nuovo materialismo,da un nuovo
ateismo, da un nuovo antiumanesimo. Se infatti il posto ha una priorità rispetto a
ciò che lo occupa, non sarà certo sufficiente mettere l' uomo al posto di Dio per
mutare la struttura. E se questo posto è il posto del morto, la morte di Dio
significa anche quella dell' uomo, in favore, speriamo, di qualcosa a venire], che
però non può venire se non nella struttura e attraverso il suo mutamento. Tale
appare il carattere immaginario dell' uomo (Foucault) o il carattere ideologico dell'
umanesimo (Althusser).17
Infine, qualche considerazione di sintesi e di prospettiva sul futuro.Innanzitutto,
sono ben consapevole del fatto che, in quest' esposizione molto schematica che ho
appena presentato, vi sono molte omissioni (ad esempio, quella, non certo
secondaria, di Althusser); credo, tuttavia, che le linee fondamentali che ho tracciato
15 A. Gualandi, Deleuze , Paris, les Belles Lettres, 1998.
16 Deleuze, Da che cosa si riconosce lo strutturalismo , in F. Châtelet, La filos. del XX secolo (Storia
della filos., vol. VIII), p. 216.
17 Ivi, p. 199.
siano, alla grossa, esatte: la filosofia post-strutturalista si è misurata nello stesso
tempo con il problema della scienza e con quello del capitalismo puntando su un'
interpretazione razionalistica e intellettualistica della fenomenologia di Husserl; ha
creduto che l' al di là della tecnoscienza capitalistica potesse essere il frutto dell'
automovimento e dell' autodissoluzione delle strutture di quella tecnoscienza; il suo
concetto di storicità è stato fondato non sul soggetto ma su un Assoluto, un Infinito,
un' Alterità che ognuno dei tre autori configura in modo diverso, ma che in ogni caso
è visto come l' altra faccia, il rovescio oscuro delle strutture razionali: la razionalità e
il suo Altro, l' ordine e l' innovazione non conoscono momenti di mediazione, sono in
qualche modo connessi in un rapporto che è insieme di correlazione e di
contraddizione reciproca. Questo lavoro filosofico si innestava su una determinata
situazione storico-politica, dando di essa un' interpretazione e una chiave di lettura
ben precise: capitalismo e socialismo reali si presentavano come il crescere
correlativo di strutture razionali e burocratiche oppressive e prive di senso; l' idea
post-strutturalista era che questo elemento di non senso, venendo sempre più alla
luce, potesse rovesciare la situazione: non si trattava di modificare le strutture
razionali, ma di far emergere e dar voce autonoma al loro fondamento nascosto di
non senso e di infinita energia vitale. Non credo che sia molto difficile rendersi conto
che ai giorni nostri questo progetto e l' analisi che gli stava dietro sono state
largamente superati dalla storia: dopo la caduta del Muro di Berlino, abbiamo
assistito al rafforzarsi di un capitalismo che ha uno dei suoi motori principali nell'
innovazione tecnologica; la razionalità strumentale, potenziata al massimo, ha
assunto un dominio indiscusso e illimitato: il suo autonomo sviluppo non sembra
certo portare in direzione di una sua messa in discussione, di una sua
autodissoluzione o comunque di una sua reinscrizione in una struttura più ampia che
lo limiti. Dunque a me pare che sia proprio la svolta degli anni '50 a dover esser
ripensata; sono proprio alcuni nodi teorici a cui in quegli anni sono state date certe
soluzioni che devono essere rivisti. La razionalità deve essere ancora concepita
secondo il modello che congiunge Husserl, Bachelard e Canguilhem? La storia deve
essere vista come lacerazione assoluta, come evento assoluto? L' unica alternativa
alla calcolabilità, alla ragione strumentale è costituita dall' appello, in una forma o in
un' altra, all' Infinito, all' Assoluto? L' eliminazione del soggetto non finisce per
favorire l' avversario - cioé per giustificare l' anonimato e l' insensatezza delle
strutture del capitalismo globalizzato? E l' idea di una natura completamente
culturalizzata, pura costruzione culturale non è anch' essa perdente politicamente,
oltre che dubbia sul piano filosofico? Quali sono le risposte alternative possibili a
questi nodi problematici? Alcune possono essere ritrovate in un grande pensatore
che la svolta degli anni '50 ha oscurato: alludo a M. Merleau-Ponty; nella sua
riflessione, la razionalità è integrata e corretta non da un Altro assoluto, ma da uno
stadio preriflessivo - quello della percezione - che non è né pura razionalità né mero
non senso; è questo strato intermedio fra la trasparenza del momento intellettuale e
la cecità del momento materiale che è visto insieme come la radice e il limite della
razionalità; è ancora riferendosi a questa sorta di "senso comune" preriflessivo che
Merleau-Ponty può criticare il soggetto cartesiano metafisico, occidentale, senza
cadere nell' assurdo di una negazione integrale di esso; il fondamento della critica
alla razionalità non è allora l' Infinito o l' Assoluto, ma la finitezza del corpo proprio
su queste stesse basi, Merleau-Ponty può criticare la concezione metafìsica della
storia di Marx o di Hegel per proporre un' idea di storia fondata su una concezione,
come egli diceva, "porosa" dell' Essere: un' idea di storia che facesse spazio al non
senso, all' evento, alla novità senza per questo ridurre la storia a mero salto fra puro
senso e puro non senso; infine, la sua idea di corpo proprio lo aveva condotto a una
rivalutazione del concetto di natura, di una falda dell' essere irriducibile alla pura
culturalizzazione, di un limite al costruttivismo assoluto cartesiano. L' altra direzione,
convergente con quella di Merleau-Ponty, a cui mi richiamo, segue, in un certo
senso, le indicazioni dell' ultimo Foucault: nella situazione filosofico-politica odierna,
è la riflessione di Adorno che mi sembra tornare di attualità: di Adorno, nel cui
pensiero si possono trovare molti paralleli con le posizioni di Merleau-Ponty: una
critica della razionalità strumentale fondata su una visione secondo la quale quest'
ultima non è che una delle possibili espressioni della vita; un materialismo che
contrapponendosi a tutti gli assoluti, rivaluta la corporeità e la finitezza e si propone
di "redimere" la natura - cioé di rispettarla, di limitare la violenza che la razionalità
tecnologica esercita su di essa, di stringere con essa una "nuova Alleanza"; un' idea
di soggetto che vuole disfarsi del vecchio soggetto teoretico della metafisica
occidentale, per dar spazio a un soggetto incarnato, a un soggetto definito
innanzitutto dal piacere e dal dolore. Al di là di questi cenni,e di queste indicazioni
sommarie io non so andare; l' unica cosa che voglio aggiungere, prima di finire, è
che essi mi sembrano andare ancora nella direzione di quell' alleanza "francotedesca", che, negli ultimi secoli, ha prodotto il meglio della cultura filosofica
europea.
Hottois tra fenomenologia e strutturalismo
Federico Dal Bo
Introduzione
§ 1: I caratteri della filosofia francese contemporanea. Sulla critica del concetto
di razionalità
Secondo l’argomentazione del Prof. Jofrida, la filosofia francese
contemporanea si trova in crisi perché il modo introdotto a partire dagli anni ‘50 di
leggere i testi fenomenologici ha precluso in prospettiva una serie di opzioni
speculative, «cosicché oggi ci ritroviamo sguarniti rispetto al compito di “pensare il
nostro presente» (Jofrida, 3). La difficoltà fondamentale è quella di continuare a
ritenere che il cosiddetto pensiero della differenza possa di per sé suggerire,
indicare e dare sviluppo ad un’autentica alternativa alla realtà politica e sociale
attuale, semplicemente lavorando all’interno delle strutture razionali esistenti e
facendo «emergere e [dando] voce autonoma al loro fondamento nascosto di non
senso e di infinita energia vitale» (Jofrida, 18).
Non si tratta di affermare semplicemente che siano venuti meno i presupposti
che implicitamente sostenevano questa concezione dell’esercizio critico della
filosofia (l’autonomia della struttura rispetto al soggetto, l’assenza di un “centro
razionale”, le potenzialità della “materia” intesa in senso non oggettivista), ma
piuttosto che non li si possono disgiungere da un certo modo di interpretare la
fenomenologia che è stato introdotto, appunto, a partire dagli anni ‘50, in polemica e
in opposizione con la prospettiva “esistenzialista” avanzata da Sartre (Jofrida, 3ss).
Se è lecito riconoscere in questa lettura “epistemica” della filosofia l’esigenza di
confrontarsi e distinguersi dal “nuovo umanismo” proposto dall’esistenzialismo,
significa viceversa che oggi la critica mossa alle strutture razionali non debba più
precludere un confronto con i grandi temi della filosofia classica e, quindi, che si
tratta di chiedersi se «possano essere reintrodotti i concetti di “soggetto”, “storia” e
anche “natura”» (Jofrida, 3).
Le difficoltà maggiori a cui si trova di fronte la filosofia francese contemporanea
possono essere riassunte così:
l’indagine sulle strutture razionali condotta dalla fenomenologia francese dagli
anni ‘50 è stata perseguita con tale fermezza, che l’istanza del soggetto (quale polo
dell’esercizio critico e filosofico) è rimasta del tutto “secondaria” rispetto alla
questione del sapere epistemico, per cui uno dei tratti tipici del pensiero francese è
quello di «partire dal non senso per indagare come da esso si generi la ragione»
(Jofrida, 7, c.m.);
la collocazione “eccentrica” (in senso proprio) del soggetto rispetto alla struttura
però ha portato alla conseguenza apparentemente contraddittoria o paradossale che
non esista la possibilità di un’altra razionalità, poiché si può «rivelare la paradossalità
del logos, ma non se ne può cambiare minimamente la struttura» (Jofrida, 13 c.m.);
la conseguenza più rilevante di una simile argomentazione è che il terreno
“empirico” o “materiale” non possa ottenere una positività se non autonomamente,
cioè proprio secondo la propria legge senza dipendere dall’esercizio del soggetto.
Senza offrire l’occasione per recuperare semplicemente le opzioni filosofiche
tradizionali e conservartici, l’esaurimento dell’impostazione di fondo del pensiero
strutturalista, dovuta in particolare alla difficoltà di sostenere un’autonomia positiva
ed effettiva della “materia” così come era stata concepita, tuttavia mette in
discussione il senso stesso della “marginalità” delle strutture soggettive rispetto
quelle epistemiche (o razionali in senso lato). Nel nostro intervento approfondiremo
attraverso l’opera dell’epistemologo belga G. Hottois la critica che il Prof. Jofrida ha
rivolto al pensiero francese contemporaneo, cercando di dimostrare che, da un lato,
l’indagine sulle strutture razionali si è tramutata in una sorta di “iperumanismo”,
tuttavia spogliato della capacità critica e “ironica” del soggetto, e, dall’altro, che
questa impostazione ha portato a trascurare i temi della tecnica, della scienza e
della materia.
Nella sua accurata ed aspra critica condotta contro la filosofia continentale
(Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty e Derrida) Hottois parte implicitamente
dall’assunto che il pensiero post-husserliano non abbia saputo cogliere il senso
proprio della fenomenologia quale ideale di una scienza che riscopra «il radicalismo
di un sapere responsabile di sé [che] faccia costantemente sua l’esigenza di non
accettare per valido nessun sapere per il quale non possa essere data una
giustificazione a partire da principi originariamente primi e perciò perfettamente
evidenti, sicché cercare dietro di essi non abbia più alcun senso» (LFT, 6). La
conseguenza più rilevante della crisi della filosofia post-husserliana è secondo
Hottois quella per cui il pensiero ha cessato di rivolgersi autenticamente alle cose
(anche in senso fenomenologico e non strettamente empirico), delegando così
l’esercizio della razionalità strumentale semplicemente agli apparati tecnici: in
profonda analogia con l’impostazione del testo della Crisi, l’opera di Hottois parte
dalla nuova divisione sancita, per così dire, tra le scienze dello spirito e della natura
per rintracciare l’origine della questione della tecnica. Proprio come Husserl poteva
scrivere che «la molteplicità, ormai quasi inestricabile, delle filosofie fa sì che essa
non si articoli più in una serie di direzioni scientifiche capaci di portare [_] l’idea
comune di una scienza unica [_] anzi tutte queste tendenze si combattono, per così
dire, secondo una comunità estetica di stili, in modo analogo alle “tendenze” e alle
“correnti” nell’ambito delle belle arti» (C, 221) – così Hottois parte dall’indagine dello
stile filosofico contemporaneo per ritrovare dietro di esso le cause più remote della
sua crisi speculativa.
§ 2: Fine e scopo de La crisi delle scienze europee
Se è lecito ridurre un testo stratificato e complesso come La crisi ad alcune tesi
fondamentali, si può affermare con una certa sicurezza che Husserl si proponga di
superare definitivamente la divisione stabilita canonicamente da Dilthey tra le
scienze dello spirito e le scienze della natura. Da un lato, la divisione tra
soggettivismo ed obiettivismo corrisponde alla possibilità che si possa demarcare
radicalmente il rispettivo ambito di indagine e di ricerca secondo un’argomentazione,
direbbe Apel, propria del mondo liberale, per cui la libertà “interiore” del soggetto
non interferisce con il rigore “oggettivo” dello scienziato, e viceversa. Ma Husserl
avverte che si tratta di cogliere «il problema più specificatamente universale, [quello]
del rapporto tra pensiero scientifico-obiettivo e intuizione [_] Siamo nell’estraneità
reciproca e assoluta: intuizione e pensiero» (C, 163). Dall’altro lato, infatti, questa
divisione e la lotta reciproca che comunque ne consegue rivelano l’incapacità
dell’uomo moderno di rendere conto della realtà nel suo insieme e, quindi, la
decadenza del concetto tradizionale di Wissenschaft quale scientia, quale ideale
onnicomprensivo di conoscenza, che coincide solo parzialmente con l’impostazione
della filosofia come gnoseologia: si tratta piuttosto di riscoprire la filosofia come
scienza, «la cui intima intenzione è quella di giungere, attraverso un chiarimento
delle sorgenti ultime di senso, a un sapere attorno a ciò che reale e al suo senso
ultimo riposto, priv[o] di presupposti e definitivamente fondat[o]» (C, 219).
È molto nota la tesi del testo della Crisi, per cui non è possibile una
convergenza tra le scienze dello spirito e della natura se non riconoscendo che la
parzialità di ciascuna corrisponde al mancato sviluppo di un’autentica filosofia
trascendentale, finalmente sganciata sia dalla tentazioni mistiche di un soggetto
completamente ritirato in sé, che dall’empirismo volgare per cui tutto si ridurrebbe ad
oggetto d’osservazione scientifica: «l’epoché [_] ci ha dato la possibilità [_] di mirare
alla correlazione trascendentale soggetto-oggetto» (C, 207). La chiarificazione del
problema della soggettività da parte della filosofia trascendentale, finalmente
articolata secondo il principio della intenzionalità, porta alla riscoperta della
metodicità speculativa, senza che questo significhi ricalcare lo schema scientistico
delle Naturwissenschaften: «le scienze a priori [_] fungono eo ipso costantemente in
senso tecnologico-normativo, ma sono pur sempre scienze e non tecnologie» (LFT,
§ 7, 39). In questo senso, anzi, è possibile leggere l’intero testo della Crisi come
un’opposizione della scienza correttamente intesa verso la tecnica: «si tratta di
problemi che concernono il mondo ovviamente essente e sempre intuitivamente
dato; ma non di problemi rientranti in quella prassi professionale e in quella téchne
che viene chiamata scienza obiettiva» (C, 140).
Se sono queste le tesi fondamentali del testo della Crisi, come è stato possibile
che questo ideale metodico e armonico tra le discipline del sapere abbia portato a
quello che l’epistemologo Hottois ritiene un “iper-umanismo”, che non solo non ha
sviluppato un concetto autenticamente fenomenologico di scienza, ma che anzi ha
coinvolto l’ideale di filosofia come scienza rigorosa in una speculazione chiusa in se
stessa e completamente referenziale? In altri termini, se si avverte il divario profondo
tra il concetto di scienza esposto nel testo della Crisi e quello implicitamente o
esplicitamente esposto da tutta la filosofia post-husserliana, che interpretazione è
possibile dare della filosofia contemporanea?
Prima parte: la polemica contro la svolta linguistica
§ 1: L’abbandono del reale
L’opera di Hottois si apre con una diagnosi del pensiero filosofico
contemporaneo: secondo Hottois, la caratteristica fondamentale dell’intera filosofia
(continentale) successiva a Husserl è «l’inflazione del linguaggio». La svolta
linguistica del Novecento sancisce secondo Hottois soprattutto la fine di una visione
armonica ed equilibrata delle due istanze linguistiche fondamentali: la referenza e la
significanza, ovvero la facoltà di riferire i segni linguistici a qualche cosa (di
extralinguistico) e la facoltà di articolare “autonomamente” (ovvero, secondo una
regola culturale propria) il sapere.
La mancanza di equilibrio tra queste due istanze e quindi l’ignoranza del senso
antropologico di fondo del linguaggio quale strumento di comunicazione ed
espressione di vita insieme porta alla mistificazione dell’attività intellettuale dell’uomo
e alla creazione di due miti particolarmente insidiosi: 1) il primo, quello di un
linguaggio assolutamente referenziale, cioè un linguaggio «divenuto vetro» (ST, 28):
«il sogno di un linguaggio che si estinguerebbe nella parola unica e definitiva: è»
(ST, 29); 2) il secondo, quello di un linguaggio ritirato in sé, dove il significato,
«l’apporto specificatamente linguistico nella relazione con il reale» (ST, 29), cancella
completamente ogni riferimento al reale e determina un linguaggio, uno stile
filosofico e uno stesso pensiero «caleidoscopici, ossia privi di ogni trasparenza
referenziale» (ST, 30, c. m.).
La filosofia contemporanea è investita da entrambi questi miti, in particolare
dall’esaltazione dell’ermeneutica quale unico trait d’union con il reale. I segni
diventano «mobili e circolano rapidamente»: questo significa che «s’impone una
priorità della comunicazione rispetto alla referenza» (IL, 318). L’inflazione del
linguaggio significa che «l’uomo non abita più il reale, ma si aggira solamente nel
linguaggio» (IL, 291).
Per descrivere questa situazione sfuggendo alle involuzioni proprie di un
linguaggio profondamente influenzato dai suoi stessi miti, Hottois conia alcuni
termini tecnici nuovi ma particolarmente interessanti:
secondarietà: si tratta, in un senso che non manca di toccare temi freudiani, del
piacere che l’uomo prova nella propria autoaffabulazione (discorsiva, scritta e
mediatica) e dell’intento proprio dell’ermeneutica filosofica di fare di ogni cosa una
questione di linguaggio;
adlinguisticità: è «l’illusione di referenza» (IL, 97) che è la filosofia stessa a
determinare. Non è altro che la pretesa di designare il reale esclusivamente in modo
“secondario”, attraverso il linguaggio stesso: la fenomenologia orientata in senso
ermeneutico non stabilisce un rapporto con il reale in senso “metalinguistico” (in tutti
i sensi della particella meta-), ma in senso ad-linguistico, come se il reale fosse in
senso stretto una sola questione di linguaggio;
metafora filologica: «la metafora filologica suggerisce in particolare [_] che il
mondo, le cose sensibili, parlino silenziosamente e originariamente [_] e che il nostro
rapporto con il mondo sia quello di un dialogo con il mondo» (IL, 101). La relazione
ermeneutica tradizionalmente intercorrente tra l’interprete e l’eredità culturale del
passato viene estesa in senso ontologico all’intero spettro dell’essere, per cui
un’articolazione culturale diviene un’articolazione ontologica (IL, 138) e il linguaggio
ne diviene (quasi) il “soggetto”: «il linguaggio parla».
Questo eclissamento della realtà assomiglia solo superficialmente alla
dissimulazione del reale che è tema comune del postmoderno: perché non sfugga a
una periodizzazione di carattere storico ed epocale, Hottois non ha dubbi nel
ritenere che questa riduzione della capacità di presa sul reale da parte della filosofia
sia un effetto di una «mistificazione» (ST, 31). A sua volta questa mistificazione è il
sintomo più evidente di un’inerzia speculativa che molti pensatori contemporanei
condividono e le cui motivazioni profonde non sono solo la volontà di fare della
tecnica un fenomeno esclusivamente linguistico, una “questione del linguaggio” (IL,
302), ma anche un certo conservatorismo. La sovraesposizione del ruolo del
linguaggio nella filosofia contemporanea è l’effetto di quell’eurocentrismo che
rivendica un rapporto ermeneutico privilegiato con il passato e la tradizione (IL, 193):
questo eurocentrismo manifesta un’autentica “etnofagia”, o volontà di assimilare
l’altro da sé (IL, 209).
§ 2: La trasformazione radicale della fenomenologia in senso ermeneutico
(Heidegger) e l’annullamento della referenza extralinguistica
In che modo si è giunti all’odierna inflazione del linguaggio?
È con Heidegger che avviene il passaggio capitale dalla fenomenologia quale
metodo di accesso al reale (culturale, empirico e tecnologico) alla fenomenologiaermeneutica, radicata attorno ai temi classici del dialogo e totalmente “rinchiusa nel
linguaggio”. I momenti decisivi di questa trasformazione sono in particolare
l’estromissione progressiva di ogni ricerca eidetico-fenomenologica (dalle prime
Vorlesungen degli anni ‘20 ad Essere e tempo) e il graduale avvicinamento ai temi
ermeneutici ed interpretativi dell’ascolto, della meditazione e del dialogo
ermeneutico, chiaramente rintracciabili nelle opere più tarde successive alla Kehre
(IL, 68). L’ermeneutica filosofica, come è particolarmente evidente nella sua variante
nel pensiero di Gadamer, che è caratterizzato dalla concezione del rapporto con la
tradizione come attualizzazione del passato attraverso il dialogo (o interpretazione),
assume un rilievo ontologico nella misura in cui lo schema fenomenologico della
riduzione eidetica viene conservato, ma rivestito di un linguaggio profondamente
sensibile al lessico romantico, letterario e ai giochi etimologici: se in Husserl l’epoché
permette di divenire «osservatori completamente “disinteressati” del mondo, del
mondo in quanto puramente soggettivo-relativo [_] e gettiamo su di esso un primo
sguardo ingenuo, che non intende indagarne l’essere e l’essere-così [ma]
considerarlo dal punto di vista del suo modo soggettivo di valere» (C, 184) – in
Heidegger la fenomenologia diviene un esercizio autentico del logos come discorso.
Con uno spostamento dovuto alla “metafora filologica” (v. supra), l’ascolto
ermeneutico dell’altro assume una valenza ontologica e viene inteso come lo Hören
dei fenomeni, senza che questo corrisponda, per Hottois, ad una rielaborazione
della teoria classica dell’oggetto: «l’oggetto del discorso fenomenologico è
“designato” in modo mediato, è secondario e metafilosofico: la sua esistenza è tale
solo in contrasto con gli “oggetti” del sapere filosofico tradizionale» (IL, 95).
Hottois ritiene che l’uomo possa stabilire una relazione particolare con
l’esistente solo tramite il linguaggio, colmando, da un lato, le manchevolezze biomeccaniche che lo lasciano svantaggiato nella lotta per la sopravvivenza e, dall’altro,
separandosi dal resto del regno animale: attraverso il linguaggio l’uomo in quanto
animale dotato di linguaggio stabilisce con il reale una “relazione teorica” (o
“speculativa”). Anche se questo assunto di una spontanea devozione dell’uomo
all’ordine linguistico e simbolico ricalca una tipica posizione metafisica che vede nel
filosofo l’uomo per eccellenza (cfr. ST, 34), tuttavia l’argomentazione di Hottois va
accolta sotto un profilo rigorosamente epistemologico: se il linguaggio è il mezzo che
storicamente ha permesso la mutazione evolutiva dai primati alla specie umana, la
struttura generale del linguaggio e l’insieme delle sue regole sono appunto criteri di
riconoscimento dell’uomo rispetto agli altri esseri viventi. «La storia naturale
dell’uomo in quanto uomo inizia dall’istante in cui il gioco delle mutazioni
dell’evoluzione genetica si trasforma in un gioco ontologicamente differente: quello
dei simboli e dei valori» (ST, 19).
Per lo squilibrio che l’ermeneutica filosofica viene a portare nel rapporto tra la
referenza e la significanza (v. supra), secondo Hottois la filosofia contemporanea
disconosce la fondamentale provenienza biologica dell’uomo che l’antropologia ha
sempre avuto davanti a sé. Quando la natura continua a venire paragonata a un
immenso libro da decifrare e quando l’uomo però diviene sempre meno capace di
gestire totalmente i mezzi tecnologici che permettono quest’indagine, l’immagine di
questo gigantesco testo cessa di essere una semplice metafora e diviene anzi il
criterio discriminante di un rapporto con il reale che porta alla «fine di ogni relazione
a ciò che è e alla chiusura nel linguaggio» (IL, 295): questa è la mistificazione
centrale della filosofia contemporanea. Questo ritiro nel linguaggio, o questa
«dissoluzione radicale [della realtà] nella discorsività pura» (IL, 114), non riguarda
solo l’uso esasperato di metafore di carattere testuale per descrivere il rapporto
dell’uomo con la realtà: la diffusione generalizzata di questa “metafora filologica”, per
cui il rapporto con il passato è conforme e speculare al lavoro di interpretazione di
un volume classico, si richiama a un’evoluzione più complessa che Hottois rintraccia
nell’opera di Merleau-Ponty.
La chiusura nel linguaggio e in un orizzonte totalmente intralinguistico non
viene meno neppure con l’accettazione formale ma non sostanziale (cioè incapace
di modificare l’atteggiamento teorico di fondo) che esista un senso non-lingustico,
indipendente e preliminare a quello prodotto dal gioco dei simboli (IL, 81). Anche se
l’indagine antropologica ha il compito di recuperare questo senso originario su cui si
strutturano conseguentemente tutte le culture umane, il linguaggio è secondario
rispetto alla natura – è una sorta di “gesto” del mondo culturale, replicato sul modello
del gesto del mondo naturale (IL, 88). Secondo questa «pregnanza universale del
senso pre-linguistico» (IL, 81), la rivalorizzazione del corpo, della gestualità e della
materia dovrebbe condurre a una revisione della stessa filosofia e del discorso
sull’uomo come è stato sinora concepito in Occidente, ma Hottois nota proprio come
questo desiderio di allontanarsi dal ritmo tipico del discorso metafisico non venga
soddisfatto, perché Merleau-Ponty riporta gradualmente la propria ricerca alle figure
classiche della filosofia: il dialogo, il discorso e la distinzione dal pensiero scientifico.
La fenomenologia di Merleau-Ponty intende certo istituire un rapporto formale, unico
e universale con la “realtà naturale” dell’uomo, ma, da un lato, non riesce ad evitare
di configurare questo rapporto come un dialogo (IL, 88) e, dall’altro, aggiunge a
questa oscillazione tra l’ambito culturale e ambito naturale l’ambigua constatazione
del primato della “scienza”. La natura umana è diversa da ciò che la scienza intende
come “naturale”: Hottois conclude che nell’economia del pensiero di Merlau-Ponty
«“gesto” e “linguaggio” siano due creature del discorso» (IL, 95). Hottois individua
nella teoria fenomenologica dell’oggetto la grande difficoltà che tocca Merlau-Ponty,
Heidegger e Gadamer: l’oggetto non è più il secondo termine extralinguistico nello
schema della referenza, ma diviene una sorta di “parola”, un elemento del grande
dialogo che l’uomo articola nel corso della sua storia.
§ 3: La fuoriuscita dall’orizzonte fenomenologico husserliano. Alcuni esempi del
fraintendimento in senso ermeneutico della fenomenologia
Per Hottois l’intera filosofia post-husserliana e il particolare lo strutturalismo
nelle sue diverse forme sono mossi dalla persuasione che il concetto di cosa
coincida, secondo una strategia argomentativa sottile e complessa, con quello di
parola: se il concetto greco di cosa è “tutto ciò che non è ni-ente”, il concetto
contemporaneo di cosa è “tutto ciò che non è sottratto al dialogo ermeneutico”,
proprio per la coincidenza di essere e linguaggio: «la concezione di un mondo del
linguaggio come totalità discorsiva e dialogica di senso si iscrive in seno ad una
tendenza generale [_] a concepire la struttura e la totalità del discorso [_] a partire
dal paradigma del discorso e non da un sistema formale» (IL, 112).
Se possiamo accettare l’interpretazione proposta da Hottois, tuttavia è lecito
chiedersi in quale misura il testo stesso di Husserl possa eventualmente aver
suggerito un’inclinazione della fenomenologia in senso ermeneutico. In questa sede
ci limiteremo a portare semplicemente alcuni esempi.
a) Il rapporto significato-intuizione è decisivo per l’argomentazione che Derrida
sviluppa nella Voce e il fenomeno. In un passo dello scritto Logica formale e logica
trascendentale (1929) che si pone già su quello che sarà il piano della Crisi delle
scienze europee (1935-37), questo rapporto viene affrontato in modo paradigmatico
e particolarmente indicativo per comprendere da un lato la posizione di Derrida e
dall’alto quella di Hottois.
Husserl sostiene apertamente la coincidenza tra linguaggio e pensiero,
considerati «due territori paralleli, che si corrispondono l’un l’altro, come quello delle
possibili espressioni linguistiche (del discorso) e quello dei sensi possibili» (LFT, § 3,
30), ma non ignora che questo rapporto si giochi sottilmente tra l’idealità del
linguaggio, una sorta di “opacità del senso” e la necessità di un rapporto “materiale”,
cioè non svuotato di un’intenzione o di un referente: «non tutta la sua vita interiore
l’uomo la esprime realmente nel linguaggio, né può esprimerla attraverso di esso
[_] Le parole portano intenzioni signitive, servono come ponti per guidare ai
significati, alle cose “con” esse intese [_] Nel parlare noi riempiamo continuamente
un’intenzione interna, che si mescola con le parole, quasi animandole. Risultato di
questa animazione è il fatto che le parole e i discorsi interi rendono in sé – per così
dire – corporea un’intenzione e la portano in sé corpificata come al loro senso»
(LFT, § 3, 28). Accanto alla conferma della necessità di correlare il significato
all’intuizione del riempimento, si accenna tuttavia al fatto che le risorse logiche non
esauriscono le possibilità espressive dell’uomo («non tutta la sua vita interiore
l’uomo la esprime realmente nel linguaggio»). Un critico francese che ha
controbattuto le tesi di Derrida ha sostenuto che almeno sin dalla sesta delle
Ricerche Logiche Husserl si sottragga al rischio (metafisico) di far coincidere
significato ed intuizione (di riempimento), e quindi che la struttura della donazione
indichi proprio che «la significazione nelle Ricerche logiche si dà senza dipendere
dall’intuizione di riempimento» (RD, 47).
In questa sede non si tratta di verificare l’esattezza dell’interpretazione di
Derrida o della critica che Marion gli muove, ma notare come le due posizioni
divergano proprio su quegli stessi argomenti di cui Hottois si serve nella sua
confutazione della fenomenologia ermeneutica: attribuendo l’errore capitale di
Derrida al fatto di aver confuso intuizione e significato (RD, 42) o, più precisamente,
di aver fatto coincidere la determinazione del significato a quella del segno (RD, 26),
Marion non fa che opporsi ad una visione fenomenologico-ermeneutica del senso,
totalmente coincidente con le strutture logico-discorsive. Riconoscere viceversa che
vita ed espressione linguistica non possano venire sovrapposti totalmente e,
secondo la tesi sostenuta da Marion, che la struttura della donazione dimostri una
extraterritorialità dell’intuizione rispetto al significato – questo significa, in altri termini,
riconoscere non solo che l’accadere dei fenomeni, o il loro donarsi, indica uno
spazio ulteriore rispetto alla struttura segnica, ma anche che il significato possa
avere una provenienza non linguistica (in senso stretto);
b) il concetto di oggetto. Il nucleo dell’argomentazione di Hottois è che la teoria
fenomenologico-ermeneutica dell’oggetto determini un’appiattimento del reale sul
linguaggio, ma che, viceversa, la prospettiva originaria di Husserl contempli ancora e
in senso rigoroso un riferimento extralinguistico, benché questo non significhi un
ritorno ingenuo al materialismo. Il nucleo di questo fraintendimento sarebbe la
complessa teoria dell’oggetto fenomenologico che la scuola francese, come sostiene
Marion, leggerebbe secondo l’assunto di una coincidenza stretta tra segno e
significato, per cui il riconoscimento dell’oggetto eidetico non sarebbe altro che la
conferma della concezione della cosa come segno (sostenuta in particolare da
Gadamer).
Husserl definisce infatti l’idealità del linguaggio come «l’oggettività che compete
alle oggettualità del cosiddetto mondo spirituale o mondo di cultura, e non quella
propria della pura natura fisica» (LFT, 26): fulcro di questa definizione è l’uso del
termine Gegenständlichkeit (tr. fr. S. Bachelard: objectité), che indicherebbe, da un
lato, gli “oggetti” in senso stretto, ma dall’altro “le forme dipendenti reali o categoriali”
(RFT, 16, n. 4). È evidente che una correlazione particolarmente stretta tra
significato e intuizione e tra segno e significato porti a trovare nella objectité non
tanto il riferimento a quello «stato di cose che è nel discorso» (LFT, 23), quanto alla
conferma che la mediazione con le cose non possa che essere adlinguistica, cioè
indistinguibile dal rapporto con il linguaggio;
c) La matematizzazione diretta ed indiretta del mondo della vita. Secondo
l’argomentazione che Husserl espone nella Crisi, il passaggio dallo spazio finito della
geometria antica a quello universale della geometria applicata ha la profonda
conseguenza di aprire alla matematizzazione del mondo inteso in senso geometrico.
Qui, è importante notare che il «passaggio metodico» «dalla geometria
all’analisi pura» (C, 74) conduca di fatto alla tecnicizzazione della scienza naturale e
che sia possibile stabilire una notevole corrispondenza tra i termini con cui Husserl
descrive questo cambiamento di paradigma del rapporto rispetto al mondo della vita
e quelli con cui Hottois critica la fenomenologia ermeneutica. Se l’ermeneutica ha il
demerito di aver rinchiuso il pensiero nel linguaggio sottraendolo così da ogni
riferimento al mondo, Husserl ritiene che con la tecnicizzazione venga a mancare
«un ritorno al senso propriamente scientifico»: «si opera con le lettere dell’alfabeto,
con segni di collegamento e di relazione [_] e secondo regole del gioco della loro
coordinazione: si procede in realtà in un modo che non è sostanzialmente diverso da
quello del gioco delle carte o degli scacchi» (C, 75).
Come Husserl, infatti Hottois ritiene che la difficoltà più grave del pensiero
contemporaneo sia quello di non cogliere la natura della tecnica moderna, incapace
di esprimere un senso propriamente scientifico, ma preoccupata esclusivamente al
funzionamento delle sue strutture. Possiamo ipotizzare che il fraintendimento dello
spirito antiscientista di Husserl in un senso meramente antiscientifico sia dovuto in
primo luogo al pregiudizio “umanista” della scuola post-husserliana. La critica che
Husserl muove a Galileo non verrebbe letta in vista della riattivazione del senso
scientifico propriamente inteso, ma piuttosto come l’invito ad attribuire
(esclusivamente) alle scienze dello spirito la gestione dello spazio “simbolico” –
determinando così quella divisione tra soggettivismo ed oggettivismo già affrontata
nella Crisi. Un passo come il seguente sembra suggerire (dal punto di vista della
fenomenologia ermeneutica) di contrastare la tecnica, non opponendole l’autentico
senso scientifico fenomenologico, ma piuttosto “riappropriandosi” del terreno
“simbolico” che la scienza applicata era giunta in qualche modo a gestire: la
tecnicizzazione causa «la trasformazione di un pensiero talora geniale, volto ad
elaborare teorie utili all’esperienza, alla scoperta, in un pensiero che adotta concetti
trasformati nel loro senso, concetti “simbolici”» (C, 77).
d) Il mondo della vita come mondo “non simbolico”. Quella che possiamo
chiamare un fraintendimento umanista dell’epoché – per cui la riduzione eidetica e
l’esclusione di tutte le nozioni (C, 183) verrebbe intesa in senso stretto come
l’invalidamento esclusivamente delle verità scientifiche – ha come effetto ulteriore
quello di ignorare il mondo della vita così come Husserl l’ha inteso: quando Husserl
afferma che «il mondo della vita invece c’è sempre stato, prima di qualsiasi scienza,
qualunque sia il modo d’essere che esso ha nell’epoca della scienza» (C, 152), è un
errore cogliere di questo passo in particolare l’impostazione per così dire
“antiscientifica” a favore di una indeterminata positività delle scienze dello spirito.
Se l’analisi di Hottois è corretta, la filosofia contemporanea ha frainteso queste
indicazioni della fenomenologia più tarda, non tanto per un’oscillazione
dell’argomentazione husserliana, quanto per la sua incapacità di assumersi quel
compito che più avanti viene attribuito alla filosofia trascendenale, ovvero quello di
fondare «una scientificità nuova», che «non è di tipo matematico e non è una
scientificità logica nel senso tradizionale» (C, 160).
Seconda parte: la polemica contro la tecno-scienza
§ 1: La tecnica come chiusura al mondo della vita
Secondo Hottois la conseguenza più rilevante dell’impostazione ermeneuticofenomenologica è appunto quella di determinare una chiusura rispetto al mondo. Se
possiamo dire con Husserl che il fraintendimento della filosofia trascendentale sia
dovuto a residui psicologisti, e cioè che ci si rivolge “allo spirito” interpretando in
senso psicologista il naturalismo scientifico (C, 226), allora non deve suscitare
sorpresa che Hottois descriva questa situazione servendosi, forse ironicamente, di
un’espressione psicoanalitica: la forclusione del cosmo (si tratta della ripresa della
traduzione in francese che Lacan fa del concetto freudiano di Verwerfung, alla
lettera “rigetto”).
Dal punto di vista epistemologico, le conseguenze della teoria del linguaggio
implicitamente sostenuta dalla fenomenologia post-husserliana sono rilevanti: il
rapporto conoscitivo non riguarda più la realtà, ma solo il linguaggio stesso, non è
più “verticale”, ma orizzontale, «totalmente laterale, interno al discorso e all’esercizio
della discorsività» (IL, 112, c.m.). Quest’ambigua inclinazione all’interno del
linguaggio e l’intradiscorsività comune a gran parte della filosofia contemporanea
non possono risolvere l’antinomia fondamentale cui conduce proprio la
fenomenologia: da un lato, esiste un mondo, una realtà materiale (un “cosmo”),
totalmente inerte al gioco del senso (IL, 42), ma dall’altro lato, il mondo, inteso in
senso heideggeriano quale Welt, è un possesso dell’uomo e dell’essere che si da
nel linguaggio. Questa antinomia fornisce ad Hottois il modello per decifrare il senso
profondo dell’epistemologia contemporanea: il mondo viene ad un tempo accolto ed
escluso dal circuito del senso, così come la tecnica moderna viene ritenuta una
nuova tappa della storia dell’essere e, insieme, l’apice del nichilismo metafisico e
della Seinsvergessenheit. La sentenza di Heidegger sulla scienza («la scienza non
pensa») è di grande importanza, perché sintomatica di questa antinomia costitutiva
del concetto fenomenologico di mondo: se l’essenza della tecnica è “filosofica”,
significa che la tecnica è interpretabile e non sfugge all’orizzonte simbolico; questa
affermazione conferma l’altro convincimento della filosofia contemporanea, secondo
cui, in senso rigorosamente ontologico, non esiste una realtà ulteriore al discorso,
perché il linguaggio copre l’intera regione dell’essere. La ricerca di un’esteriorità si
confonde con l’antico sogno di una “eterologia”, di una scienza dell’alterità, che ha
sempre contraddistinto il discorso filosofico in quanto tale.
L’epistemologia, secondo Hottois, deve denunciare la distanza radicale della
tecnica dall’ontologia e dalle possibilità di ogni discorso umano: solo in base al
riconoscimento dell’essenza «asimbolica» della tecnica, l’uomo può riconoscere
l’autentico contenuto dell’ontologia che la filosofia contemporanea ha tentato di
conservare. Il silenzio ontologico che Hottois attribuisce alla fisica contemporanea si
rivela per l’incapacità della scienza moderna di rispondere all’interrogazione
sull’essenza, che ha guidato la filosofia fin dai suoi inizi: alla domanda «che cos’è?»,
la scienza fornisce un amplissimo spettro di dati che tuttavia si lasciano sfuggire
l’essenza. L’esistenza stessa del mondo fisico e, in particolare, del mondo micro- e
macro-fisico dipende addirittura dalla stessa raccolta dei dati e, dunque, dalla
disponibilità di un immenso apparato tecnologico: «è evidentemente impossibile
rapportarci a ciò che chiamiamo, con una metafora pura, particelle, onde o campi,
nello stesso modo attraverso il quale ci rapportiamo al mondo che ci circonda.
L’uomo non più rapportarsi in modo culturale-naturale ai processi che non incontra e
non incontrerà mai se non tecnicamente e matematicamente» (ST, 63).
§ 2: Il concetto di tecnica in Hottois e la sua differenza da quello di Heidegger
Malgrado alcune affinità, Hottois però non espone la tesi tradizionale di
Heidegger: la tecnica è certamente muta al bisogno ontologico dell’uomo, ma il
primo errore del pensiero contemporaneo è quello di attendersi proprio dalla tecnica
una risposta conforme al simbolo e al discorso umano.
Questo
fraintendimento
piuttosto
nasce
dal
nichilismo
implicito
nell’ermeneutica, che annulla la possibilità di esistenza al di fuori del linguaggio e
che fa di ogni cosa (di ogni ente) una questione linguistica: la tecnica però non
appartiene in alcun modo all’ordine simbolico, perché ne è costitutivamente e
strutturalmente eterogenea. Hottois si riferisce esplicitamente all’esperienza della
microfisica novecentesca: la creazione della bomba atomica, per esempio, dimostra
l’irriducibilità di questo ordigno al concetto antropologico di “arma” e,
estensivamente, conferma la lontananza dei prodotti tecnici dall’orizzonte naturale e
culturale in cui l’uomo è vissuto sinora. L’antropologia ha chiarito che la costruzione
e l’invenzione di utensili ha avuto lo scopo pratico di affrancarsi da uno stato di
inferiorità bio-meccanica in cui l’uomo si trova rispetto le altre creature, ma ha anche
mostrato, allo stesso tempo, che quest’attività produttrice si è intrecciata e unita alla
naturale inclinazione dell’uomo a valorizzare e a interpretare l’esistente.
La tecnica moderna rende invece superflua e accessoria l’attività mediatrice del
simbolo: le apparecchiature tecnologiche non solo permettono l’indagine e lo studio
della realtà fisica, ma ne costituiscono anche la possibilità di esistenza, perché
l’intera regione dell’ente fisico è osservabile solo attraverso artifici scientifici.
Richiamandosi agli studi dell’epistemologo Stegmüller, Hottois ritiene che
l’irrappresentabilità (Unanschaulichkeit) del mondo fisico determini il carattere
asimbolico della tecnica moderna: l’incontro con il mondo microfisico e gli spazi
sterminati dell’universo è precluso all’esperienza simbolica, non tanto per la loro
inconcepibile differenza dal mondo quotidiano, quanto per l’impossibilità di riportare
ai sensi dell’uomo la percezione del mondo fisico nel suo complesso. La parola e
l’intuizione, la lettura e l’interpretazione non svolgono alcun ruolo nella descrizione
dell’universo fisico, anche se pretendono di discorrere significativamente del mondo
delle particelle elementari: «nella normale metafora, le cose esistono già prima del
trasferimento metaforico. Con la metafora del vocabolario fisico, le cose sono
letteralmente create dal trasferimento: sono delle finzioni» (ST, 80). Hottois ritiene
che questa lontananza della tecnica dalle attività umane tradizionali sia avvertibile
soprattutto ipotizzando alcune possibili applicazioni della scienza all’uomo: finché la
medicina moderna viene utilizzata per guarire e sconfiggere le malattie, si può
credere che la tecnica sia in effetti a misura e al servizio dell’uomo. Ma questo
antropologismo strumentalista è miope e precario. I trapianti di organi, la
riproduzione e la ricostruzione di tessuti perduti, l’evoluzione delle protesi e le stesse
ricerche condotte nell’ambito della intelligenza artificiale mostrano che la tecnica non
è una semplice utensile, ma che è in grado di modificare e di manipolare la natura
stessa dell’uomo, assumendo un vero e proprio ruolo ontologico: «manipolazione
ontologica: la tecnica è una contestazione della condizione naturale dell’uomo; è lo
sforzo oscuro per far uscire l’essenza umana dai suoi cardini e dai suoi limiti per
prioettarla verso un altrove che non sarebbe più né uomo né natura» (ST, 93). Il
distacco dalla scienza medica medievale, per richiamarci all’esempio precedente, è
rintracciabile quando si verifica l’abbandono delle metafore mitiche e religiose usate
per descrivere il malessere e si paragona l’organismo umano a una macchina
complessa.
La tecnica proietta l’uomo al di fuori del simbolico, lo espropria della
dimensione del futuro: «per poter parlare di un’assunzione cosciente dell’uomo della
sua evoluzione futura [_] bisognerebbe che la tecno-scienza non fosse [_] una
creatività inanticipabile, bisognerebbe poter sapere in anticipo quali sarebbero le
conseguenze e le forme di questo o quest’altro esperimento sull’uomo» (ST, 96).
L’escatologia, quale dottrina delle cose ultime, ha permesso all’uomo di
rappresentarsi il futuro secondo temi mitico-religiosi ed è sopravvissuta nel
marxismo e nelle filosofie del dialogo che auspicano un rinnovamento radicale
dell’umanità: è attraverso l’interpretazione dei segni rivelatori, il futuro era in qualche
modo anticipabile e pre-vedibile. Al contrario, la tecnica non appartiene all’ordine
simbolico dell’uomo e nemmeno i suoi risultati della sua applicazione al reale
possono venire immaginati secondo gli schemi antropocentrici: le previsioni di un
futuro totalmente tecnologizzato anzi si confondono con la bassa letteratura
fantascientifica che può solo elencare una serie di ipotetici sviluppi dei singoli
elementi tecnologici, senza consegnare all’uomo una visione di ciò che sarà. Data
l’irrappresentabilità del mondo fisico, «la questione del futuro è propriamente senza
sito» (IL, 332).
§ 3: La ripresa dello schema della Crisi: la critica alla tecnica in favore di una
“scienza” e la riproposta di una “filosofia dell’uomo”
Benché la tecnica venga descritta come una forza che sradica l’uomo dal
terreno naturale e proprio del simbolico, l’opera di Hottois non può venire riassunta
esclusivamente da questa determinazione negativa della scienza contemporanea:
l’antiumanismo costitutivo della tecnologia non va compreso semplicemente in
senso “etico”, quale minaccia all’“abitare simbolico” dell’uomo sulla terra, ma va letto
anche in senso ontologico, quale affermazione dell’esisienza di qualcosa che non è
riducilbie al linguaggio umano, di un ente extralinguistico e, in definitiva, quale
presupposto teorico di un equilibrato realismo.
La tecnica certamente mette in crisi l’impianto escatologico con cui l’uomo si
rapporta al futuro , ma proprio l’eventualità che il discorso umano possa venire
superato e messo da parte dimostra che il culturale e il simbolico sono circoscrivibili,
de-limitabili e non sono quindi eventi “centrali” nell’evoluzione biologica della specie
umana: «la nascita dell’uomo non è stata culturale o simbolica. Il culturale, il
simbolico [_] sono apparsi con l’umano. Perché dovremmo pensare che la sua fine
lo sarà?» (IL, 303). La dimensione post-istorica, estranea alla storicità intesa in
senso escatologico, si ricongiunge idealmente alla dimensione pre-istorica, che ha
preceduto cronologicamente l’affermarsi dell’uomo sulla terra (ST, 77). L’interesse
principale di Hottois è che il pensiero contemporaneo accetti che le «logoteorie»
dell’uomo, dunque ogni articolazione della ratio, non hanno una centralità strutturale
nel corso dello sviluppo umano e cosmico: lo spazio cosmico non è un “uni-verso”,
non vi sono impressi una direzione o uno sviluppo che possono venire riportati al
ritmo del discorso umano ed escatologico: «il cosmo non è a misura dell’uomo
naturale, come la terra» (IL, 355).
Dal punto di vista etico l’uomo deve avvertire che la tecnica è irridubile al
simbolico, attivando «una sorta di protezionismo attivo dell’umano» (ST, 157): alla
tecnica, Hottois oppone in modo complementare la generosità, il rispetto e il senso
di protezione che l’amore ispira. Quest’indole conservativa della filosofia di Hottois
tuttavia appare come una misura temporanea, la migliore che l’uomo possa
progettare e stabilire ora: ma il riconoscimento dell’esistenza di una esteriorità
rispetto al linguaggio e, implicitamente, dei pregiudizi epistemologici che
caratterizzano l’ermeneutica filosofica deve suggerire il nuovo orientamento della
filosofia, che non può limitarsi alla protezione dell’uomo da ciò che gli è estraneo, ma
che deve anche promuovere un rapporto inedito con il reale; lo stesso auspicio di un
equilibrio tra le logoteorie e la tecnica non è realizzabile solo attraverso una
«mediazione propriamente tecnica assicurata all’uomo in quanto tecnico», ma anche
attraverso «la mediazione simbolica» – attraverso un rinnovato legame con
l’esteriorità (ST, 163).
La filosofia di Hottois si alimenta di questo contatto continuo con l’esterno o
con il suo elemento più paradigmatico: la tecnica. È a partire dalle osservazioni
epistemologiche che Hottois critica e corregge l’ermeneutica contemporanea, ma è
anche in direzione della tecnica che Hottois orienta la filosofia in quanto tale.
L’asimbolico, il tecnico, il pre-istorico e il post-istorico sono nomi con cui Hottois
contrassegna il vuoto di senso in cui è immersa l’esperienza intellettuale dell’uomo:
collegando i risultati della ricerca biologica otto-novecentesca alle sue teorie
epistemologiche, dunque annettendo il mondo naturale e animale, interte al senso,
con l’irrefrenabile sviluppo della scienza moderna, Hottois delimita e circoscrive lo
spazio dell’avventura speculativa umana. Il profondo realismo su cui si fonda questa
complessa argomentazione impedisce di parlare di un semplice pessimismo
gnoseologico: con occhio attento si può notare come dalla filosofia della scienza di
Hottois sporga un principio classico della psicoanalisi freudiana.
Se la maturità razionale dipende dall’abbandono del principio di piacere per il
principio di realtà, così la finalità intellettuale dell’uomo moderno dipende dal
passaggio dalla secondarietà, cioé dal piacere della propria autoaffabulazione,
all’assunzione dell’esistenza di un reale extralinguistico: la «mistificazione» filosofica
di cui Hottois parla più volte sembra allora il sintomo di un disagio che l’uomo
speculativo avverte quando viene esposto all’indubitabile efficacia della tecnica, alla
sua capacità trasformartice del reale. Scacciato dalle lettere dei filosofi, il mondo
materiale ritorna con un mezzo che l’uomo non è in grado di gestire pienamente.
Da questo punto di vista, la critica alla secondarietà è assimilabile al rilancio
dello studio della referenza e del tema kantiano dell’accordo tra il linguaggio e il
mondo: l’assunzione di una realtà robusta che solo marginalmente l’uomo è
legittimato e in grado di comprendere è il fil rouge dell’intera Critica kantiana e il
tema predominante dell’epistemologia di Hottois. Tuttavia è proprio questo
radicamento nell’empirico, che Hottois ricerca, ad essere inadeguato allo spirito
autenticamente filosofico e realista della sua epistemologia. Hottois è molto attento a
demarcare il limite discriminante tra un’attività filosofica matura, che rende conto
autenticamente dell’esistenza di uno spazio extralinguistico, e la mistificazione del
pensiero ermeneutico, che dissolve il problema della realtà nell’infinita serie delle
pratiche dialogiche e logoteoriche dell’uomo: ciò che circoscrive l’uomo quale essere
biologico e parlante non è solo un mondo che in precedenza non aveva conosciuto il
simbolico e il senso, ma anche un cosmo irriducibile al ritmo dell’interpretazione
mondana dell’essere; il cosmo sfugge alla presa concettuale perché è s-misurato –
altro ed esterno ad ogni antropocentrismo. Hottois ritiene questa divisione tra
simbolico e asimbolico non solamente funzionale e relativa: non se ne serve
semplicemente per descrivere la storicità radicale di ogni discorso umano; per lui, la
distanza del dialogo e del logos dal tecnico e dal non-storico è essenziale,
sostanziale.
§ 4: Limiti e ingenuità del nuovo umanismo filosofico
Con le parole di Derrida possiamo dire che attraverso questo empirismo
antifilosofico, «i concetti transfilosofici si trasformerebbero in ingenuità filosofiche»
(SD, 370): ciò a cui Hottois mette di fronte la filosofia è un empirismo ingenuo che
pretende di delimitare e circoscrivere con sicurezza un contesto. Hottois deduce
l’asimbolicità della tecnica dal fatto che manca «la carica escatologica, finalista
tradizionale della filosofia e della teologia» (IL, 331), cioé dal fatto che il pensiero
escatologico quale previsione del futuro è incapace di rappresentare alcunché di
attendibile per il tempo a venire: anche se la demarcazione è netta, Hottois auspica
ugualmente che, attraverso una ripresa del problema della referenza e l’abbandono
della piatta intertestualità ermeneutica, l’uomo possa reinstaurare un rapporto attivo
e positivo con il reale – con il non-linguistico: «alterità e differenza irriducibile non
sono necessariamente sinonimi di mancanza di ogni interazione. Perché ci sia
relazione e influenza del simbolo sulla tecnica e viceversa serve una mediazione [_]
Attraverso l’uomo, è possibile un’inter-azione circolare e non è esclusa una sorta di
feedback globale» (ST, 162 e 163). Hottois così è a un tempo fedele e inconsistente
alle sue premesse teoriche: se il tecnico è nomen communis per tutto ciò che non è
linguistico, ma empiricamente reale, l’abbandono della secondaire si deve
accompagnare a un rapporto rinnovato con il cosmo e l’ambiente tecnologizzato;
tuttavia, questa iniziativa sembra contrastare con le osservazioni fatte in precedenza
sull’asimbolicità essenziale della scienza moderna. Il nucleo di questa difficoltà è
appunto quell’empirismo ingenuo che trasforma concetti transfilosofici in ingenuità
filosofiche: anche se la tecnica non è né simbolica né escatologica, la sua esistenza
è comunque un fatto, rispetto al quale l’uomo deve modificare la propria relazione
con il reale – un fatto in senso stretto non rappresentabile (unanschaulich), ma
tuttavia efficace e in atto.
Se si rinuncia alla divisione radicale e perciò ingenua tra simbolico e
asimbolico, è possibile verificare come l’epistemologia di Hottois si avvicini
sensibilmente alle tecniche decostruttive di Derrida, che preferiscono enfatizzare e
indagare i momenti in cui una coppia di opposti si sfibra e si confonde; quando
Hottois rifiuta di denominare la tecnica come la decostruzione dell’escatologia, vuole
impedire che la scienza moderna torni ad essere una sola questione di linguaggio,
come è stata per l’ermeneutica heideggeriana. Da questo punto di vista, è sospetta
l’affermazione di Derrida, per cui «al di là del testo filosofico [ci sia] un altro testo, un
tessuto di differenze di forze senza alcun centro di riferimento presente» (MF, 20);
questa metafora del testo e dell’extratesto filosofico, che Derrida recupera per
indicare l’enigmaticità del concetto di margine e quindi per contrassegnare un limite
alla linguisticità, tuttavia è sulla soglia di una autentica secondarietà filosofica: il
tema del reale o dell’extrafilosofico è in procinto di cadere nuovamente all’interno
della prospettiva dell’ermeneutica continentale. Per Hottois, il concetto derridiano di
scrittura è esemplare: se da un lato la grammatologia deve condurre alla
accettazione dei limiti del logos e a disegnarne i margini, dall’altro sopravvive in
Derrida una tendenza, caratteristica della seconda fase della sua speculazione, a
rinchiudere nuovamente il pensiero sul reale e sulla scienza quale plesso di nuove
scritture (genetiche, biologiche e mediatiche) nel discorso – «per salvare la postura
teoretica e l’umano» (IL, 271). Nella misura in cui la scienza moderna e la crisi
dell’idea di Libro lasciano che la forza aforistica della scrittura si liberi e si inclini alla
«operativité», il secondo Derrida riallaccia progressivamente queste figure
antimetafisiche al tema classico della discorsività, agevolando ambiguamente, per
esempio, lo sviluppo del testualismo critico americano.
Se questo è vero, nemmeno la tecnica può venire interpretata solo come una
forza doppiamente alienante, che allontana l’uomo dalla propria matrice biologica e
culturale: quell’intervento di mediazione tecno-simbolica che Hottois auspica è
filosoficamente consistente solo se si rinuncia alla dicotomia tra l’umano e il
tecnologico e si accolgono le riflessioni di Derrida intorno alla tecnica e alla
decostruzione di un meccanismo vitale e vivente. L’empirismo ingenuo di Hottois
pregiudica il ritorno all’etica dopo la lunga prolusione sulla tecnica asimbolica, e,
anzi, conferma ancora l’irriducibile eterogeneità della prima verso la seconda: per
penetrare nell’etica, l’appello alla prudenza e alla conservazione dell’umano che
Hottois sottoscrive nelle sue pagine ha bisogno di una breccia, una lacerazione, una
fessura che rompa la monolitica compattezza del corpus technicum e che riveli
proprio ciò che Hottois postula in modo aporetico – la correlazione fattuale di
simbolico e tecnico: «l’interazione complessa del simbolo e della tecnica attraverso
l’umanità è un fatto: esiste un’inter-azione spontanea, selvaggia [_] l’uomo svolge un
ruolo indispensabile come riparatore, mediatore e vettore di crescita dell’ambiente
tecnico» (ST, 163).
Al contrario dell’empirismo ingenuo di Hottois, che proietta la tecnica
radicalmente al di fuori dell’umano e del simbolico, l’empirismo decostruttivo non
ignora che, accanto a questi emergenti caratteri di novità della tecnica, ritorni una
possibilità antica, che non è stata realizzata storicamente: come Hottois, Derrida
accetta l’idea che l’uomo sia immerso in un cosmo s-misurato e che la sua origine
non sia simbolica, ma biologica e perciò eterogenea al senso. Ma l’empirismo
decostruttivo segna un passo ulteriore e illustra la “meccanicità” della macchina
logica e strutturale che ora viene messa in pericolo dalla tecno-scienza: nel
momento in cui si interrompe la via classica all’economia, alla produzione e al
senso, percepiamo questo arresto come uno stallo meccanico – come una stasi
improduttica e fatale che precede uno sviluppo inedito, energico, ma dispersivo,
antieconomico e irriducibile a ogni cultura e ideologia.
Bibliografia essenziale
Jofrida
M. Jofrida, Fin du sujet, fin de l’histoire: considerations sur la
philosophie française contemporaine, manoscritto;
IL
ST
G. Hottois, L’inflation du langage, Bruxelles, Ed. de l’Université, 1979
id., Il simbolo e la tecnica, Ferrara, Gallio, 1999
C
LFT
E. Husserl, La crisi delle scienze europee, Milano, Il Saggiatore, 1961
id., Logica formale e logica trascendentale, Roma, Laterza, 1966
RD
J.L. Marion, Réduction et donation, Paris, PUF, 1989
SD
MF
J. Derrida, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1990
id., Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 1998
ESPERIENZA PERCETTIVA E COMPLESSITA’ ORIGINARIA
di Andrea Cavazzini
Premessa
In ciò che segue non presentiamo un’analisi fenomenologica della percezione,
né una mera esegesi dei testi husserliani; cerchiamo piuttosto di ibridare le due
cose. Analizzando alcuni “luoghi” di Husserl, tentiamo una libera variazione tematica,
un percorso tra autori e questioni, legati per vari fili ai testi che commentiamo, allo
scopo di focalizzare un problema teoretico. Data l’attitudine divagante del percorso,
tale problema risulta esso stesso un ibrido, intreccio di due questioni: la prima,
riguarda l’esistenza di una legalità razionale dell’esperienza, autonoma (almeno sul
piano analitico-descrittivo) dalle operazioni intellettuali; la seconda, riguarda la
razionalità di un ordinamento circolare –e che taluni indicherebbero pertanto come
vizioso- nella costruzione del significato dell’esperienza stessa. Il problema non è
che focalizzato; da qui l’inconcludenza del presente scritto, che andrebbe visto come
radicalmente non autosufficiente, bensì parte di una ricerca, che speriamo poter
approfondire, sulle potenzialità teoretiche del pensiero fenomenologico.
1.
La cosa dell’esperienza sensibile.
Analizzare fenomenologicamente la “cosa” dell’esperienza significa esplicitare
la costituzione del significato di tale “cosa” quale si dà alla nostra esperienza
percettivo-sensibile. Dal punto di vista genealogico, uno dei primi testi in cui Husserl
affronta la problematica qui indicata, è il secondo degli Studi psicologici per la logica
elementare, intitolato: “Intuizione e rappresentanze”: «Certi vissuti psichici, chiamati
generalmente “rappresentazioni”, hanno la peculiarità di non includere i loro
“oggetti” come contenuti immanenti ( e dunque presenti nella coscienza), ma di
intenzionarli meramente in un certo modo che deve essere caratterizzato in maniera
ancora più precisa.
Per il momento basterà la seguente definizione (…) secondo cui “intenzionare
meramente” sta qui a significare: tendere, per mezzo di contenuti qualsiasi dati nella
coscienza, verso altri contenuti non dati, intenderli, rinviare ad essi con
comprensione, utilizzare con comprensione quelli come rappresentanti di questi, e
precisamente senza che vi sia una conoscenza concettuale della relazione esistente
tra la rappresentazione e l’oggetto intenzionato. Vogliamo chiamare tali
rappresentazioni rappresentanze. Di fronte ad esse stanno altri vissuti psichici –
ugualmente chiamati “rappresentazioni” nell’uso linguistico di molti psicologi- che
non intenzionano meramente i loro “oggetti”, ma che li includono realmente come
contenuti immanenti. Le rappresentazioni in questo senso noi le chiamiamo
intuizioni»18.
La rappresentanza è quella rappresentazione che ci offre mediatamente la
conoscenza dell’oggetto. Ciò significa, naturalmente, che l’oggetto stesso, la “cosa”
che appare mediante delle rappresentanze, appare come essenzialmente mediata:
che il suo significato contiene essenzialmente il momento della mediazione ad opera
delle rappresentanze. L’esempio portato da Husserl è tratto ovviamente dalla sfera
della percezione visiva: «Del nostro teatro io ho un’intuizione quando lo vedo; infatti
credo in quel caso di avere una rappresentazione reale di ciò che di volta in volta
intende l’espressione “nostro teatro” (…) la coscienza naturale crede di cogliere in
uno sguardo, in un atto semplice di intuizione, la cosa obiettiva stessa, (…) come ciò
che è e com’ è intenzionata. Noi sappiamo che ciò è una mera parvenza. Solo una
piccola parte di ciò che presumiamo di intuire è realmente intuita; solo pochi tratti del
contenuto fattuale sono presenti in questo atto così come sono intenzionati nella
rappresentazione della cosa che quel contenuto media e nella maniera in cui
coesistono realmente nella “cosa stessa”.
L’intero contenuto della rappresentazione della cosa diviene intuitivo solo in un
decorso continuo di contenuti, nel quale vi sono certi atti psichici che accompagnano
le successioni di intuizioni parziali che s’impongono, che identificano quelle che si
riferiscono l’una all’altra per rimando e che, scorrendo all’interno di un atto continuo,
fanno emergere l’unità obiettiva»19.
La cosa in se stessa, la cosa “in carne ed ossa” nella sua interezza, dunque ci
è data solo in modo mediato; alla coscienza essa appare piuttosto “per procura”,
attraverso le rappresentanze, attraverso le intuizioni di singole “parti” del suo
contenuto, le quali svolgono un ruolo di luogo-tenenza nei riguardi dell’oggetto
completo.
Ma il rapporto tra ciò che viene intuito –ciò che è presente in atto alla
coscienza- e ciò che invece si dà tramite esso –come oggetto transattuale,
oggettualità mediata offerta attraverso le intuizioni immanenti- è così unilaterale?
Si tratterebbe di una relazione che va dall’immediato al mediato in modo del
tutto semplice e monodirezionale?
Husserl pare suggerirlo talvolta: « la nuova rappresentazione ha dunque (…)
un’intenzione che rimanda al di là del contenuto immanente dell’atto» 20.
18 Edmund Husserl, Logica, psicologia, fenomenologia. Gli Oggetti intenzionali e altri scritti, a cura di
Stefano Besoli e Vittorio de Palma, il Melangolo, Genova, 1999, p. 70.
19 Ivi, p. 66
20 Ivi, p. 67
Il “movimento” dell’apprensione dell’oggetto sarebbe allora presto individuato
nella sua direzionalità: rappresentanze - oggetto (o l’equivalente: “parte” intuita oggetto trascendente totale).
Si tratta di un passaggio dal semplice, dall’immediato, al complesso e mediato;
da una presenza pura ed assoluta alla coscienza, al prodotto di una successiva
complicazione: l’oggettualità completa come “termine” cui mira il riferirsi intenzionale
delle rappresentanze non sarebbe che un derivato rispetto all’immediatezza di
queste ultime. Senonché, il quadro dei rapporti tra rappresentanze ed oggetto,
emerge dalle analisi husserliane come molto più articolato. Perché il movimento
dell’intendere non va solo dalla rappresentanza all’oggetto, ma anche, viceversa,
dall’oggetto alla rappresentanza. Non è solo il succedersi delle rappresentanze, cioè
il “decorso continuo dei contenuti” parziali in cui si delinea la cosa –e che sono di
volta in volta “dati immediati” della nostra coscienza- a determinare il senso
dell’oggetto completo; anche la presunzione del senso dell’oggetto totale è sempre
presente in anticipo, in modo presuntivo, nell’intuizione dei contenuti parziali; ed è
questa presenza anticipata del “tutto” nelle sue “parti” che impone a queste ultime il
loro senso e, quindi, anche il modo della loro connessione in un decorso continuo.
Tale connessione è scandita da una regola imposta dalla presenza, per così
dire in sorvolo, dell’intero nel fluire orizzontale dei contenuti parziali.
È ciò che Husserl intende quando afferma che noi intuiamo «una piccola parte
di ciò che presumiamo di intuire»: la presuntività del tutto è a monte dell’apprensione
del senso della parte, ed in pari tempo il tutto è delineato dalle connessioni tra parti,
che sono dominate dalla presenza anticipata del tutto, e così via all’infinito.
Se ne conclude, dunque, che non solo l’oggetto è mediato dalla
rappresentanza, ma, a sua volta, la stessa rappresentanza è mediata dall’oggetto.
Ognuno dei due lati, l’oggetto appreso presuntivamente ed il contenuto attualmente
intuito, presuppone l’altro. Il che ha delle conseguenze decisive, le quali potranno
meglio venire affrontate a partire dall’analoga trattazione del rapporto tra la “cosa”
sensibile ed i dati sensibili presente nella V Ricerca ed in Idee I.
2.
L’eterogeneità dei “lati” della cosa.
«Noi comprendiamo quindi anche, come un fatto essenziale e generale, che
l’essere del contenuto sensoriale è del tutto diverso dall’essere dell’oggetto
percepito, che viene presentato dal contenuto, ma che non è realmente (reell)
cosciente»21.
Il termine “reell” viene attribuito da Husserl a ciò che appartiene alla coscienza,
senza essere però vissuto intenzionale.22
D’altronde ciò che è “reell” si distingue anche da ciò che è “real” nel senso della
“realtà” trascendente proprio della res, della res realis, che non entra in alcun modo
nella coscienza, a differenza della “realtà” immanente degli elementi non intenzionali (reell). La “cosa” sta sempre aldilà della soglia della coscienza, mentre
l’ambito della materia ( hyle ) non – intenzionale ne è aldiqua.
Ora, come nota Jacques Derrida, la hyle reale –immanente, cioè la materia
non –intenzionale, che è una “mediazione tra il reale (real) trascendente e
21 E. Husserl, Ricerche Logiche, Il Saggiatore, Milano, 1988, vol. II p. 171
22 «Per Erlebnis in senso amplissimo intendiamo tutto quanto è reperibile nella corrente d’
Erlebnisse: dunque non solo gli Erlebnisse intenzionali, le cogitationes attuali e potenziali, prese nella
loro piena concretezza, ma anche qualunque momento reale (reeller) sia reperibile in questa corrente
e nelle sue parti concrete» (E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia
fenomenologia, Einaudi, Torino, vol. I, § 36, p. 77 )
l’intenzionalità” ( intendendo quest’ultima come “coscienza-di-qualcosa”),
corrisponde alle “sensazioni stesse”. 23
Se, quindi, la materia “reell” coincide con i dati sensibili, essa deve differire toto
genere da ciò che tali dati offrono : « Bisogna tenere ben presente che i dati sensibili
i quali esercitano la funzione di adombramenti di colore, di levigatezza, di figura (la
funzione della “rappresentazione”) ecc. devono essere tenuti rigorosamente distinti
dal colore, dalla figura, dalla levigatezza, in breve, da tutte le specie di momenti
fisici: l’adombramento (…) non è per principio del medesimo genere di ciò che viene
adombrato. L’adombramento è Erlebnis. Ora, il vissuto è possibile solo come
Erlebnis e non come spazialità. L’adombrato invece è possibile soltanto come
spazialità (è appunto spaziale nella sua essenza) e non come Erlebnis»24.
Possiamo aggiungere a questi passi di Idee I, analoghe affermazioni della V
Ricerca Logica allorché Husserl parla delle «differenze tra l’esserci del contenuto nel
senso della sensazione cosciente, che non è tuttavia divenuta essa stessa oggetto
della percezione, e nel senso, appunto, di oggetto della percezione»25. Anche qui,
se ne conclude che « il contenuto vissuto, in linea generale, non sarà dunque esso
stesso l’oggetto percepito»
Possiamo a questo punto sottolineare come i vissuti reali (reell), o, nella quinta
ricerca, i “contenuti” reali (reell) della coscienza, corrispondano all’incirca alla
funzione delle rappresentanze citate dagli Studi psicologici: si tratta di ciò che,
dall’interno della coscienza, rimanda fuori di essa, verso l’oggetto. Nei testi posteriori
agli Studi, Husserl accentua la differenza radicale tra ciò che nella coscienza è
presente realmente (reell) e ciò che, invece, si manifesta mediante le componenti
iletico-immanenti: « L’oggetto intenzionale in generale non cade nel contenuto reale
dell’atto corrispondente, ma differisce interamente (corsivo nostro, N. d. A ) da
esso»26.
Però, il nostro interesse, come già mostrato nel paragrafo 1, non va solo ad
una determinata caratteristica, messa in luce dall’analisi,
della costituzione
dell’esperienza, ma anche alla sua caratteristica opposta. In questo caso, poiché
abbiamo visto l’insistenza di Husserl sull’eterogeneità tra vissuti ed oggettualità, la
tesi opposta a tale eterogeneità si avrà prendendo in esame l’inseparabilità di
principio dei due lati eterogenei. Dobbiamo quindi richiamare la bilateralità della
relazione tra vissuti ed oggetto già analizzata al punto (1); dunque l’unità delle due
determinazioni opposte in (1) funge da opposizione alla tesi iniziale di (2), cioè la tesi
della loro eterogeneità.
Come abbiamo visto, la prima “direzione” della relazione vissuti/oggetto,
consiste nell’esser mediato, da parte dell’oggetto, dai vissuti immanenti in qualità di
rappresentanze. La seconda “direzione”, invece, riguarda viceversa il ruolo
dell’oggetto nella costituzione sensata dei vissuti. Se la prima direzione è già stata
implicitamente esposta (“L’essere del contenuto sensoriale è del tutto diverso
23 Jacques Derrida, Il Problema della Genesi nella filosofia di Husserl, Jaca book, Milano, 19, pag.
180 sg. Derrida riporta a pagina 180 (trad. italiana) questa citazione dal § 36 di Idee I (p. 77)che
riproduciamo, senza seguire però la traduzione di Erlebnis con “vissuto” (seguiamo dunque Enrico
Filippini nel mantenere Erlebnis come termine tecnico): « Non tutti i momenti reali (reell) della concreta
unità di un Erlebnis intenzionale posseggono il carattere fondamentale dell’intenzionalità, cioè la
proprietà di essere “coscienza di qualcosa”. È il caso per esempio di tutti i dati della sensazione (
Empfindungsdaten ), che hanno una funzione così importante nell’intuizione percettiva delle cose»
24 Husserl, Idee I, §41, p. 89
25 E. Husserl Ricerche Logiche, p. 170
26 Ivi, p. 187
dall’essere dell’oggetto percepito, che viene presentato dal contenuto”), la seconda
è tematica nella seguente descrizione: « L’appercezione è per noi l’eccedenza che
sussiste nel vissuto stesso, nel suo contenuto descrittivo, di fronte all’informe esserci
della sensazione, si tratta del carattere d’atto che, per così dire, anima la sensazione
e per sua essenza fa sì che noi percepiamo questa o quella oggettualità»27.
Dunque, la sensazione rimanda sì, si riferisce all’oggetto; ma senza
presupporre l’oggetto essa è informe. Essa deve essere animata dall’oggettualità
appercepita per poter fungere da tramite verso di essa. Questo nesso peraltro ci è
già noto da (1). Qui va però ribadito in riferimento alla tesi dell’eterogeneità tra vissuti
ed oggetto.
Questa eterogeneità, come si vede, è relativa. Essa entra in gioco sempre nel
contesto di una relazione tra i suoi due termini, nel senso per cui l’uno si manifesta in
“qualcosa” d’altro da sé, e l’altro manifesta il primo che a sua volta si manifesta in
esso, e così via. Ma questo significa che i due “lati” della percezione sensibile non
sono veramente due “realtà” disparate atomisticamente definite di per sé e poi in
qualche modo associate dall’esterno. La loro relazione circolare, per cui la cosa è
sempre predelineata in anticipo rispetto ai vissuti che la manifestano, è la matrice
della distinzione di due ambiti relativamente eterogenei. Il fatto che tale distinzione
rimandi ad una più originaria relazione, naturalmente, impedisce di considerare i
vissuti immanenti come immagini della cosa.
In questo senso fa testo la trattazione lucidissima di Giovanni Piana, che
rivendica l’impossibilità di interpretare nel senso di un’immagine-copia (ad esempio
un ritratto) le “immagini”fenomeniche ( nel gergo di Piana), vissute, di un’oggettualità
che in esse si dà “in carne ed ossa”28.
A Piana è chiarissimo che, la differenza tra un vissuto fenomenico in cui si dà
un oggetto ed una fotografia di quell’oggetto, sta nella “presenza percettiva” della
cosa stessa nel vissuto: « Nulla ci impedisce allora di parlare della immediatezza
della percezione, di indicare anzi come una vera e propria caratteristica degli atti
percettivi il fatto che in essi le cose sono presenti “ in se stesse”[…] Ciò non si trova
affatto in contrasto con la tesi delle mediazioni fenomeniche della percezione. Infatti
il termine “immediatezza” viene qui impiegato in un senso relativo che ha di mira, per
opposizione, la mediazione operata dalle raffigurazioni» 29.
L’immediato, direbbe Hegel, è in pari tempo essenzialmente risultato. Se la
presenza della cosa stessa nei suoi adombramenti in qualità di terminus ad quem
impedisce di concepire questi ultimi come raffigurazioni, per converso, il riferirsi dei
vissuti all’oggetto(che è solo l’altra faccia della “presenza”di questo “nei” primi)
impedisce di autonomizzare la cosa dai contenuti immanenti riducendola ad uno
statuto puramente noumenico.
2 bis. Il noumeno
Che un momento noumenale sia implicito nella struttura della percezione non
lo si può certo misconoscere.Seguiamo qui l’autorevole posizione di Enzo Melandri:
27Ivi, p. 174
28 Giovanni Piana, Elementi di una dottrina dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano, 1979: «Non vi è
dubbio che la distinzione elementare che deve essere fissata in rapporto alle raffigurazioni sia quella
tra l’oggetto che viene rappresentato, l’ originale, e un altro oggetto che lo rappresenta, la sua copia»
(p. 22)
Ma: «Le immagini di cui parliamo a titolo di mediazioni fenomeniche non sono affatto calchi delle cose
che si presentano in essi» (p. 23)
29
«La percezione è un’operazione complessa, che schematicamente si può
considerare articolata in due livelli: uno osservativi e uno interpretativo. Per rimanere
nei limiti della fenomenologia classica della percezione –che, sebbene inadeguata
dal punto di vista della psicologia moderna, è più che sufficiente ai fini della nostra
analisi- possiamo dire che il primo livello comprende il mondo sensibile o
fenomenico in senso stretto, e il secondo il mondo intelligibile o noumenico in senso
lato. (Già nella percezione di una cosa, la “cosa” rappresenta il noumeno, poiché è il
prodotto di un’interpretazione che reifica il dato fenomenico). Che l’interpretazione
percettiva sia inconscia, e apparentemente innata non modifica il fatto del suo
carattere noumenico»30.
Dunque la “cosa”, la sua unità, è un momento noumenico, in quanto appunto
transfenomenico e, per tornare alle parole di Husserl, «non del medesimo genere»
degli adombramenti vissuti (i quali sono il lato fenomenico in senso stretto). È chiaro
perché Melandri parla qui di una noumenicità “in senso lato”; la “cosa” non è un
costrutto convenzionale o un vero e proprio ens rationis. Il suo carattere intelligibile
non è dello stesso genere dell’intelligibilità di un concetto; attribuirle l’appellativo di
“noumeno” significa semplicemente opporla al fenomeno; cioè, in termini husserliani
contrapporla ai vissuti immanenti. Si ricordi che lo stesso concetto husserliano di
“trascendenza” della cosa ha un significato tecnico e non rimanda che al fatto di
porsi oltre la soglia del vissuto da parte dell’oggetto percepito (non è lecito dunque
lasciarsi suggerire da questo vocabolo indicazioni a speculare sulla trascendenza di
Dio). Del resto, dal discorso di Melandri emerge chiaramente come il “noumeno” sia
comunque un aspetto della struttura della percezione. Proprio a questo proposito è
importante il concetto di interpretazione.
Qui l’interpretazione non è altro che il rimando dai vissuti alla cosa, dagli
adombramenti all’oggetto adombrato, dal fenomeno al noumeno. Ciò significa che
tra questi due piani non si dà una separazione, ma solo una distinzione all’interno
però di una relazione. Vedremo anzi come sia tale relazione ad essere primaria
rispetto ai suoi termini distinti. Tuttavia, il carattere noumenico della “cosa” può
prestarsi ad una interpretazione che lo voglia del tutto estraneo alla stessa
“vita”percettiva. Tale, ad esempio, la lettura data da Descartes del rapporto tra il
flusso diveniente delle percezioni e l’unità della “cosa” che, in esse si mantiene.
Nelle “ Meditazioni metafisiche”, Cartesio tratta questo problema nel famoso
esempio della cera. La cera, a contatto col fuoco, muta nel tempo; per cui, di fronte
alla sua mutabilità, Descartes si chiede: « Rimanet ne adhuc eadem cera?» E
risponde:« Rimanere fatendum est; nemo negat, nemo aliter putat».
Da qui sorge spontanea l’ulteriore domanda:« Quid erat igitur in ea quod tam
distinte comprehendebatur?»31.
Cioè: nel flusso mutevole dei vissuti, che cosa mi permette di identificare un
polo di permanenza, tale per cui posso parlare di vissuti riferentisi al medesimo
oggetto, e, quindi, di mutamento continuo del medesimo oggetto?
Qual è l’elemento sintetico che mi abilita a dire aldilà di ogni dubbio che la cera
è sempre la stessa pur nel mutamento delle percezioni di essa (ovviamente la
stessa domanda sarebbe valida se si prendesse in considerazione, non la fusione
della cera lungo il decorso temporale, ma ad esempio, la sua rotazione: il problema
30 Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, il Mulino, Bologna, 1968, p.
557
31 René Descartes, Meditationes de prima philosophia, « Meditatio secunda : De mente humana,
quod ipsa sit notior quam corpus », tr. it. Laterza, Bari, 1997, p. 48
è sempre quello di sapere cosa garantisce l’unità del molteplice vissuto in una
sintesi oggettuale)?
Ora, per Descartes, l’unico momento sintetico in grado di garantire il
permanere della cosa nel tempo è la sua estensione.
La risposta alla domanda: « Quid erat in ea quod
tam distincte
comprehendebatur?» suona: «Certe nihil eorum quae sensibus attingebam; nam
quaecunque sub gustum, vel odoratum, vel visum, vel tactum, vel auditum
veniebant, mutata iam sunt; remanet cera»32.
Dunque, i vissuti tramite cui la cera mi è offerta oggettualmente portano tutto il
peso del solo mutamento; il momento della permanenza, per cui i vari vissuti sono
una serie unitaria di percezioni dello stesso oggetto, va ricercata altrove, appunto
nell’estensione: «Attendamus et, remotis iis quae ad ceram non pertinent, videamus
quid supersit: nempe nihil aliud quam extensum quid, flexibile, mutabile»33.
Ma, come fa notare Cassirer, l’estensione di cui qui parla Descartes non è
l’estensione che si dà sensibilmente, non è una spazialità pura pensabile come
passaggio al limite dell’intuizione di oggetti spaziali concreti: è una determinazione
puramente intelligibile: « Superest igitur ut concedam me nequidem imaginari quid
sit haec cera, sed sola mente percipere»34.
Si tratta, cioè, di una “solius mentis inspectio”, tale da escludere “visio”, “tactio”,
“imaginatio”.
La permanenza e l’identità dell’oggetto risiedono nella sua pura intelligibilità,
nel suo carattere di sostanza intelligibile estesa. L’identità dell’oggetto è quindi colta
per una via totalmente divergente da quella dei vissuti sensibili; questi ultimi non
costituiscono una via d’accesso all’oggetto ad essi eterogeneo, non vi è relazione
alcuna tra fenomeno e noumeno. In questo modo, le proprietà della sostanza
possono essere determinate solo dal pensiero già determinato nel modo
dell’atteggiamento teoretico-scientifico, mentre l’esperienza, essendo solo
apparenza ingannevole dietro la quale giace la realtà intelligibile, non ha alcuna
oggettività propria.
Come commenta Cassirer: «Tutto l’esserci (Dasein) del corpo è ritratto indietro
nel puro pensiero»35. La sostanza intelligibile può essere ora considerata
razionalmente, indagata nelle sue leggi strutturali di comportamento; la dimensione
sensibile, l’oggettualizzarsi per noi di un mondo sensibile nella percezione, non è
suscettibile di alcuna regolarità ed oggettività: è pura illusione, contingenza e
pertanto ineffabilità. La noumenizzazione della “cosa” si paga con il trasferirla in un
in-accessibile aldilà transfenomenico. Ma proprio il suo essere separata da ogni
struttura del mondo sensibile ne permette la totale riducibilità nello “spazio” di una
coscienza attiva. Priva di momenti sensibili, la “cosa” non è che una cosa-dipensiero, e come tale posseduta in modo esaustivo dalla coscienza. 36
32 ibidem
33 Ivi, p. 50
34 Ibidem
35 Ernst Cassirer, Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, Elwert, Marburg, 1902
(tr. it. Cartesio e Leibniz, laterza, Bari, 1986, p. 27)
36 Questo ideale, lo vedremo tra poco, è stato con buone ragioni imputato allo stesso Husserl,
specialmente per quanto riguarda Idee I. Ricordiamo che il problema dei “due” Husserl -il realista e
l’idealista- , si gioca interamente a livello di questa domanda: qual è il rapporto tra l’oggettività e la
coscienza che è possibile averne? Si tratta di un problema che contiene bensì il dualismo come un
possibile esito, ma che è suscettibile di soluzioni differenti.
3.
L’incompletezza essenziale della “cosa”.
Un altro luogo husserliano "classico" dedicato ai problemi della costituzione
della “cosa” offerta alla percezione sensibile è il ben noto Idee I.
In esso è tematica l’essenza dell’oggetto dato nella percezione, un’essenza
che include la necessità della “cosa” di darsi per adombramenti: «Per necessità
essenziale, ad una esperienza, “onnilaterale” e confermatesi unitariamente e
continuamente in se stessa, della medesima cosa, appartiene un sistema di
molteplici apparizioni ed adombramenti, in cui, quando valgono attualmente, tutti i
momenti oggettivi, che si trovano nella percezione. Con il carattere della datità in
carne ed ossa, nella coscienza dell’identità si rappresentano o si adombrano in
continuità determinante»37.
Questo richiamo alla “necessità essenziale”, indica che il darsi della “cosa” per
adombramenti non le è accidentale, ma inerisce alla struttura della percezione in
quanto tale. Questo modo di datità è dunque una legge38 percettiva, fondata a priori
nell’essenza di questo ambito d’indagine. Significativo, quindi, è che tale legge
implichi di necessità sia l’eterogeneità tra Erlebnisse e oggetto trascendente, sia il
loro coimplicarsi essenziale:«L’adombramento è Erlebnis. Ma l’Erlebnis è possibile
solo come Erlebnis e non come spazialità. L’adombrato invece è possibile solo come
spazialità (è appunto spaziale nella sua essenza) e non come Erlebnis»39.
Lo scarto tra adombramento e adombrato, come in parte abbiamo già visto, è
anche uno scarto tra immanenza e trascendenza rispetto alla coscienza. Di tale
scarto Husserl qui afferma la necessità essenziale, apriori: «Dalle meditazioni
precedenti risulta chiara la trascendenza della cosa dall’esperienza sensoriale
rispetto alla percezione, anzi rispetto a qualunque forma di coscienza relativa ad
essa, e non soltanto nel senso che la cosa non è reperibile di fatto come elemento
realmente costitutivo della coscienza.40 La situazione ha piuttosto carattere eidetico.
Diremo dunque che, in maniera incondizionatamente universale e necessaria, un
cosa non può essere data come realmente immanente in nessuna possibile
percezione o altra modalità di coscienza in generale. Si stabilisce così una diversità
fondamentale tra l’essere come Erlebnis e l’essere come cosa. All’essenza regionale
“Erlebnis”, all’essenza “soggettivo” in generale e Erlebnis soggettivo […], appartiene,
per principio, di essere percepibile in una percezione immanente, all’essenza di una
cosa spaziale di non esserlo […] »41.
Stante il principio dell’assoluta necessità dello scarto tra adombramento e
adombrato -che non è solo uno scarto tra l’immanenza del vissuto e la trascendenza
dell’oggetto-, ma anche tra le molteplici apparizioni parziali e l’unità della cosa in cui
esse da un lato presuntivamente si compongono mentre dall’altro ne sono
37 E. Husserl, Idee I, § 41, p. 88
38 Ricordiamo che il concetto di “legge” qui è differente da quello invalso nella scienza galileiana; in
ambito fenomenologico la legge è la struttura invariante di un fenomeno che gli è prescritta dalla sua
appartenenza ad un certo “tipo” di entità; ha dunque più a che fare con le legalità della razionalità
aristotelica, in cui le “cose” si comportano secondo la propria “natura”, che non con la correlazione
calcolistica di dati quantitativi in una struttura matematica.
39 Ivi, p. 89
40 Ma anche nel senso che la cosa è sempre un’ulteriorità rispetto alla molteplicità degli
adombramenti e dunque rispetto alla coscienza esperiente, la quale non possiede mai la cosa “a tutto
tondo” ed in maniera esaustiva. Ovviamente, parlare di “ulteriorità” significa presupporre un confine
oltre il quale spingersi. Ed è in funzione di ciò che la trascendenza della cosa rispetto alla coscienza
non significa mera eternità, ma appunto un essere- oltre che ha già- sempre superato (e per ciò anche
conservato) il limite dell’internità alla coscienza.
41 E. Husserl, op. cit. § 42 p. 90
determinate anticipatamente come apparizioni di quella cosa –è particolarmente
importante l’affermazione di Husserl per cui «la diversità di principio delle modalità
dell’essere» equivale alla «diversità più cardinale che si possa dare, quella tra la
coscienza e la realtà»42
Questa diversità è già implicita nel fatto che i vissuti immaginati sono
attraversati da una tendenza al “prendere-di-mira” un’oggettualità trascendente, o,
volendo esprimerci a partire dall’altra estremità del circolo, nel fatto che il vissuto è
sempre-già subordinato- nella sua specificità- all’esser-già-dato della cosa di cui
esso è un’esperienza vissuta: «Mentre la cosa è l’unità intenzionale, ossia ciò che è
consaputo come unitario ed identico nel continuo flusso delle percezioni che
passano l’una nell’altra, come essenti nella concordanza della continuità percettiva e
come percepite con questa o quest’altra compagine, sensibilmente intuitive, di
contrassegni, queste molteplicità percettive hanno pure una loro determinata
consistenza descrittiva subordinata essenzialmente a quell’unità». (Idee, pag.88)
In questo passo emerge nuovamente con chiarezza il meccanismo della
“doppia mediazione” che abbiamo già in precedenza descritto.
Il vissuto è mediato, e mediatore nei confronti dell’oggetto (la rappresentanza lo
è nei confronti del rappresentato); gli adombramenti, le molteplicità percettive, sono
mediatrici e mediate nei confronti della cosa-che-si-adombra. Vissuto/oggetto,
molteplicità/unità, sono poli della costituzione dell’oggetto presi in un rapporto
circolare: ogni “polo” non si dà che annunciandosi nell’altro.
Questa circolarità è, inoltre, essenziale, cioè non riconducibile ad un limite della
conoscenza umana, ma piuttosto a strutture fondamentali dell’esperienza in ciò che
essa ha di più fondamentale: il delinearsi di un “mondo”, o di un “ambiente”(Umwelt),
oggettivo.
L’apparire-per-noi di questo mondo, secondo la definizione di Piana, la
«costituzione percettiva di un mondo per noi» (Piana, pag.20), avviene secondo una
legge strutturale necessaria, che, come abbiamo visto, e come Husserl stesso ci
dice, è la legge della fondamentale non-coincidenza tra coscienza e realtà. Prima
però di discutere tematicamente questa non-coincidenza, dobbiamo prendere in
esame un’altra serie di determinazioni di questa legge strutturale: quelle afferenti
alla temporalità implicata nel costituirsi di un mondo percettivo.
4) La sintesi passiva.
Tutti i nodi che finora abbiamo cercato di delineare nell’esame del testo
husserliano ricevono una trattazione estesa e per certi versi profondamente
innovativa nelle Analysen zur passiven Synthesis.
L’ Introduzione di questo fondamentale inedito richiama le affermazioni
sull’essenziale incompiutezza della cosa spaziale: «È necessario innanzitutto
richiamare l’attenzione sul fatto che l’aspetto (Aspekt), l’adombramento prospettico
in cui ogni oggetto spaziale inevitabilmente si manifesta, porta a manifestazione
quest’ultimo solo unilateralmente. Per quanto compiutamente una cosa possa
essere percepita, essa non coincide mai con la totalità delle proprietà che nella
percezione le spettano e che la costituiscono in quanto cosa sensibile
(sinnendinglich). Parlare di lati dell’oggetto che giungono effettivamente a
percezione è inevitabile.
Ogni aspetto, ogni continuità di singoli adombramenti, per quanto ampiamente
proseguita, dà solamente lati, e questo, ce ne convinciamo facilmente, non è un
42 Ibidem
mero fatto; una percezione esterna che esaurisca il contenuto sensibile-cosale di ciò
che viene percepito è impensabile, così come è impensabile che un oggetto
percettivo in una percezione conclusa possa darsi, in senso stretto, da tutti i lati,
secondo la totalità delle sue note caratteristiche intuibili sensibilmente»43.
Dunque, la percezione attuale “afferra” e “possiede” solo alcuni lati dell’oggetto;
ma affinché si possa parlare di un oggetto, appunto, che viene percepito, e non solo
di un dato sensibile, è necessario (di una necessità ovviamente inferita dai riscontri
della descrizione, e non kantianamente postulata per risolvere il nostro imbarazzo) 44
che quanto viene effettivamente percepito sia accompagnato da “qualcosa” che non
appartiene alla datità attuale eppure è costitutivo del senso di quest’ultima.
Questo “qualcosa” può venir caratterizzato in due modi intrecciati ma distinti. In
primo luogo, come oggetto, cioè come oggettualità trascendente totale di cui ciò che
è effettivamente esperito è un lato (e come lato di un oggetto è effettivamente
esperito): «È chiaro che ciò che caratterizza il lato effettivamente visto in quanto
mero lato e fa sì che non venga preso per la cosa stessa, ma vi sia la coscienza di
qualcosa di percepito che lo oltrepassa e di cui è effettivamente visto solo questo
lato, consiste in un rimandare al di là (Hinausweisen), in un additare di natura non
intuitiva»45. In secondo luogo, come possibilità di nuove percezioni, di avere quindi
in piena datità evidente quei lati che non sono parte di una percezione attuale ma
sono indicati, annunciati a livello subliminale, da ciò che invece è in atto come un
dato percettivo pieno: «Ogni percezione(noematicamente: ogni singolo aspetto
dell’oggetto) rinvia in se stesso ad una continuità, a molteplici continua di nuove,
possibili percezioni nelle quali un medesimo oggetto si mostrerebbe da sempre
nuovi lati»46.
Ora, la coscienza attuale è sempre determinata nella sua effettività dall’alone di
non-attualità che accompagna i suoi contenuti: «La percezione, detto in maniera
molto generale, è coscienza originale. Nella percezione esterna abbiamo tuttavia un
peculiare contrasto: la coscienza originale è possibile solo nella forma di un effettivo
e originale aver coscienza di lati e in quella di un co-aver coscienza di altri lati che
non sono dati originalmente. Dico co-coscienti perché anche i lati non-visibili sono
tuttavia in qualche modo dati alla coscienza, “co-intenzionati” in quanto co-presenti.
Propriamente tuttavia, essi non si manifestano affatto» 47. In altri termini, la
percezione di un lato di un oggetto, lo possiede come tale, cioè non come
sensazione informe ma appunto come aspetto di un’oggettualità, in quanto assieme
a tale aspetto è co-dato un “intorno” di altri lati non presenti alla coscienza come tali,
ma che, dalla loro posizione di “sfondo” determinano il senso del lato percepito
effettivamente. Ma, ciò è possibile solo in quanto i lati presenti e quelli solo
“allusivamente” dati sono congruenti tra loro sulla base della specifica oggettualità di
cui sono aspetti.
Dunque non solo il dato immanente ha bisogno, per essere determinato nel
significato con cui appare alla coscienza, di un “complemento” semiimmanente, dato
sì ma per così dire in obliquo; ancor più rilevante è il fenomeno per cui l’oggetto è
43 E. Husserl, Analysen zur passiven Synthesis, (trad. it. Lezioni sulla sintesi passiva, Guerini e
Associati, Milano, 1993, p. 33 sg.)
44 Per una netta demarcazione tra il procedimento apagogico di matrice kantiana e quello puramente
descrittivo di Husserl si veda naturalmente E. Melandri, Logica ed esperienza in Husserl, Il Mulino,
Bologna, 1960.
45 Ivi, p. 35
46 Ibidem
47 Ivi, p. 34
già-sempre “presente” nella struttura dei dati sensibili: «In ogni momento il senso
oggettuale è il medesimo rispetto all’oggetto tout court che è intenzionato e coincide
nella serie continua delle manifestazioni momentanee» 48.
Quindi possiamo dire che la cosa anticipa sempre, come un orizzonte di
comprensibilità, gli adombramenti nel cui decorso è offerta, e questa sua
anticipazione è una predelineazione del senso degli adombramenti stessi: l’oggetto,
dandosi in anticipo come quel particolare tipo di oggettualità, prescrive il senso della
scena percettiva in ogni momento data in piena evidenza come pure quello del suo
“contorno” nebuloso, non-pienamente-evidente, ed infine le forme ed i modi della
loro connessione, del loro richiamarsi e collegarsi in una struttura percettiva.
Particolarmente notevole nelle Analysen è inoltre la descrizione del ruolo della
temporalità nella costituzione dell’oggetto. Infatti, il richiamarsi e connettersi
vicendevole delle scene percettive è caratterizzato dal loro legame temporale;
legame formale –nel senso che per certi versi si limita a produrre la continuità tra il
prima ed il poi nello scorrere delle percezioni- ma sempre riempito
contenutisticamente, e precisamente da contenuti fondati in legami qualitativi tra le
scene percettive, legami a loro volta subordinati al senso complessivo d’oggetto che
attraversa i dati prescrivendo loro uno “stile” unitario specificato in particolari
modalità connettive. Di tutta questa problematica, a noi interessa però solo la forma
connettiva del tempo, strutturata in una dialettica tra ritenzione e protenzione: «Nel
continuo procedere della percezione abbiamo, come in ogni percezione, protenzioni
che si riempiono costantemente grazie al sopraggiungere di nuovi elementi, che si
fanno avanti nella forma di “ora” originariamente impressionali (…) In ogni procedere
della percezione esterna la protenzione ha la forma di continue attese anticipatrici
(Vorerwartungen) che si riempiono, vale a dire: del sistema di rinvii dell’orizzonte si
attualizzano continuamente certe linee di rinvio in quanto attese che si riempiono
continuamente in aspetti più precisamente determinati» 49.
Le protenzioni, è chiaro, rimandano, nel senso dell’anticipazione, ad altre
possibili esperienze attuali congruenti con il dato presente (di nuovo ricordiamo che
tale congruenza è prescritta dalla predatità dell’oggetto, la quale determina il senso
della scena percettiva attuale e dunque anche delle scene non-attuali cui essa
“allude”). Il loro complemento è ovviamente la ritenzione delle scene percettive
appena trascorse: «Appena un nuovo lato diventa visibile, un altro che lo era appena
divenuto, diventa mano a mano non più visibile, per divenire infine completamente
invisibile. Ma ciò che è diventato invisibile non è perso per la nostra conoscenza»50.
In ogni presente effettivamente esperito è conservata la traccia dei momenti passati,
ed è implicita la tensione verso quelli futuri. Il presente quindi è, per usare
un’espressione platonica, un miktòn, una mistione, un composto di passato, che
svanisce ma continua a durare in forma modificata, e di futuro, che non è ancora ma
già si annuncia. Possiamo dire che questo modo di connessione sintetica dei vissuti
è una modalità orizzontale della sintesi, in quanto presente passato e futuro si
connettono nel decorso di un flusso ininterrotto; tuttavia, si può parlare anche di un
movimento verticale della sintesi: è il rapporto di ogni “parte” del flusso (il quale è
chiaramente un complesso di parti non-indipendenti, dato che ciascuna di esse è già
in quanto tale frutto di una sintesi) al senso complessivo dell’oggettualità che
predetermina lo stile delle scene percettive ed i loro rapporti sintetici.
48 Ivi, p. 35 sg.
49 Ivi, p. 38
50 Ivi, p. 39
C’è quindi sintesi temporale dei vissuti tra loro, ma si tratta di una sintesi
interna al senso di un oggetto presuntivamente dato. In virtù di tale pre-datità
dell’oggetto la dialettica ritenzione-protenzione riceve un ampliamento del proprio
significato sistematico: infatti, l’assunzione che ciò che stiamo vedendo sia un
particolare e determinato oggetto, viene confermata progressivamente dal decorso
di ciò che effettivamente vediamo, cioè gli adombramenti dell’oggetto stesso. Ed è
perciò ovvio che in questo decorso tale assunzione può venire altrettanto bene
smentita. Ogni protenzione, ogni spingersi-avanti della coscienza percettiva, va per
così dire in cerca di un significato determinato, la cui fisionomia è delineata dalla
ritenzione dei precedenti vissuti e dall’assunzione preliminare del senso oggettuale
complessivo: «la percezione esterna è un deflusso temporale di vissuti nel quale le
manifestazioni passano in maniera coerente l’una nell’altra nell’unità della
coincidenza, cui corrisponde l’unità di un senso. Abbiamo imparato a comprendere
questo flusso come una struttura sistematica di progressivi riempimenti di intenzioni
a cui corrisponde, dall’altro lato, un progressivo svuotamento di intenzioni
precedentemente piene. Ogni fase momentanea della percezione è dunque in se
stessa una struttura di intenzioni parzialmente piene e parzialmente vuote. In ogni
fase abbiamo infatti una manifestazione propria, cioè un’intenzione riempita, anche
se solo gradualmente, data la presenza di un orizzonte interno 51 della non pienezza
e di un’indeterminatezza ulteriormente determinabile. Ad ogni fase appartiene inoltre
un orizzonte esterno completamente vuoto che tende verso il riempimento e che, nel
procedere secondo una determinata direzione di sviluppo, si protende verso la meta
nel modo della attesa anticipatrice vuota»52.
Che le percezioni successive siano proprio come ce le aspettavamo equivale
ad un riempimento (Erfüllung) dell’intenzione anticipante. Ma tale intenzione –
suscettibile di essere confermata o meno- non intende soltanto la successiva scena
percettiva: ciò che è inteso è l’oggetto stesso, cioè il senso oggettuale in cui vanno a
coincidere i vissuti, o meglio ancora, la coincidenza dei vissuti in un’unità di senso
oggettuale. Una siffatta unità di senso è in anticipo sui vissuti in quanto assunzione
predelineante, ma può venire confermata (o meno) solo da essi e dal loro decorso
temporale.
Ciò significa che il senso della realtà percettiva, il suo strutturarsi in un “mondo”
che ci è dato, è inscindibile dal suo sintetizzarsi nel tempo: il senso della percezione
esterna è sempre e comunque un senso dotato di una propria temporalità. Rispetto
alla temporalità del flusso delle scene percettive, il senso dell’oggetto trascendente è
51 Per “orizzonte interno” di indeterminatezza Husserl intende le infinite caratteristiche sensibili del lato
della cosa effettivamente esperito, le quali però possono venire alla luce solo gradualmente e
mediante un approfondimento dell’osservazione, nonostante esse siano già presenti in forma
inadeguata anche nel “colpo d’occhio”: «La separazione tra ciò che è propriamente percepito e ciò che
è solo co-presente opera, all’interno delle determinatezze dell’oggetto, una distinzione tra quelle che si
presentano in carne ed ossa e quelle che sono predelineate in maniera ancora interamente vuota ed
ambigua; alla stessa maniera bisogna notare che anche ciò che si manifesta effettivamente è
caratterizzato da una simile differenza. Anche per il lato effettivamente visto risuona il grido: avvicinati
sempre di più, guardami modificando la tua posizione, cambia la direzione dello sguardo, ecc.;
riceverai da me ancora qualcosa di nuovo da vedere, del legno precedentemente visto in maniera
generale ed indeterminata vedrai sempre nuove parziali colorazioni, strutture prima non visibili, ecc.
(Ivi.p. 37)». L’orizzonte interno differisce dall’orizzonte esterno di anticipazione –che è dato
protenzionalmente- in quanto quest’ultimo è privo di “intelaiatura intuitiva”, vale a dire che è anticipato
solo dai vissuti precedenti e dalla presuntività dell’oggetto che ne fonda la congruenza, ma non è
affatto contenuto in maniera nebulosa nell’esperienza attuale. In ogni caso, va notato che anche il
fenomeno delle anticipazioni interne è riconducibile ad un ritardo della coscienza “adeguata” rispetto a
ciò che viene effettivamente di volta in volta esperito.
52 Ivi, p. 38 sg.
in una posizione duplice: da un lato esso, in quanto assunto preliminarmente,
prescrive in anticipo a tali scene le loro determinatezze e connessioni; dall’altro,
siffatto senso d’oggetto può manifestarsi come tale solo alla fine del decorso dei
vissuti.
Questo “sdoppiamento” dell’oggetto è sintomo di uno scarto irriducibile tra
intenzione e riempimento nella costituzione del senso. L’oggetto potrebbe riunificarsi
solo se fosse possibile esperirlo “a tutto tondo”, ma questo comporterebbe la
perfetta coincidenza tra esperienza e trasparenza a sé della coscienza desta 53.
Al contrario, da quanto fin qui visto emerge non solo come la coscienza abbia
sempre a che fare con un mondo sempre-già-dato, ma anche come questa
eccedenza della realtà sulla coscienza implichi una radicale incertezza della
coscienza stessa rispetto a ciò che essa presume in merito alla realtà: incertezza
che può essere attenuata solo in modo incompleto ed alla fine di un processo, di un
lavoro di approssimazione ad una ragionevole evidenza. La determinatezza del
materiale sensibile non può mai essere separata dal conseguimento di un’adeguata
“coscienza d’oggetto”; cade dunque implicitamente ciò che abbiamo visto conseguire
dalla impostazione cartesiana: il riassorbimento della cosa nella trasparenza della
coscienza. Ci si può chiedere se questo non confligga con il “cartesianesimo” in
certa misura rivendicato da Husserl, e con l’affermazione, spesso identificata con la
vera ed autentica filosofia del fondatore della fenomenologia, del carattere “assoluto”
della coscienza. A questo nodo dedicheremo le nostre conclusioni.
Conclusioni
In ciò che precede, abbiamo esposto analisi tratte da disparati luoghi
husserliani, considerando i vari passi come dotati di un’unità tematica lungo la quale
i contenuti analitici si arricchiscono progressivamente fino a trovare una definita
collocazione sistematica nel quadro della teoria della sintesi passiva. Ora, la
continuità del materiale qui presentato è indubbiamente, almeno in parte, frutto della
nostra esposizione; ma poiché non ci interessava un approccio filologico, bensì la
focalizzazione teoretica del problema del rapporto coscienza/realtà, non dovrebbe
creare problemi il carattere a sua volta non “storico” ma sistematico del nostro
commento.
Si potrebbe però obiettare che è appunto l’unità sistematica a difettare nei
passi da noi riportati; è infatti possibile sostenere l’esistenza di una forte
discontinuità teorica tra le prime opere da noi prese in considerazione e le Analysen
considerate da ultimo, una discontinuità che impedirebbe di parlare nei nostri termini
di un tema costante: il rapporto di non-coincidenza essenziale tra la coscienza e la
realtà.
La tesi della discontinuità si appoggia naturalmente all’introduzione massiccia
della coscienza trascendentale in Idee I ed al suo caratteristico ruolo “fondante”
dell’intero universo dell’esperienza, gnoseologicamente basato a sua volta
53 Ovviamente, questa è una riformulazione nel quadro della analisi della sintesi temporale, di quello
che abbiamo definito “incompletezza essenziale della cosa”. Anche in queste lezioni Husserl sottolinea
tale fenomeno: «Non è immaginabile un modo di manifestazione che dia compiutamente l’oggetto che
si manifesta (…) ogni manifestazione porta infatti con sé, nel suo orizzonte vuoto, un plus ultra (Ivi, p.
42)». La novità consiste nel fatto che il rapporto dialettico tra unità dell’oggetto e molteplicità degli
adombramenti è esplicitamente temporalizzato; gli adombramenti divengono un flusso unificato da
protenzioni/ritenzioni, e l’oggetto, già determinato come orizzonte trascendente di unificazione del
molteplice materiale vissuto, risolve interamente la sua posizione circolare (in quanto dato “attraverso”
gli adombramenti eppure tale da esserne il presupposto) nello scarto temporale che separa
l’anticipazione dal riempimento.
sull’asserito primato della percezione interna rispetto a quella interna. Questo nodo è
evidenziato ottimamente in un articolo di Vittorio De Palma 54, che è uno dei migliori
contributi italiani allo studio delle Analysen husserliane. Secondo DePalma: «Nella
prima fase del suo pensiero, quella cosiddetta “statica”, Husserl concepisce la
costituzione dell’oggetto sensibile come il prodotto di un’ “apprensione” (Auffassung)
o “interpretazione” (Deutung) oggettivante dei dati sensoriali, cioè dei vissuti
immanenti alla coscienza, che, in sé informi e neutrali, vengono in tal modo “animati”
e resi “rappresentanti” dell’oggetto. L’atto originariamente istitutivo del senso
oggettuale si configura come “appercezione” (Ricerche logiche) o “conferimento di
senso”(Idee I). Abbiamo così il cosiddetto “schema apprensione/contenuto
apprensionale” (…). In base ad esso, i vissuti o sensazioni sono le datità più
immediate ed originarie, anzi le uniche in senso proprio, in quanto realmente
immanenti alla coscienza, e costituiscono come tali il contenuto apprensionale; ma
solo l’atto apprensionale conferisce loro una funzione rappresentante. Nei vissuti
come tali l’oggetto non è ancora dato; infatti lo stesso complesso sensoriale può
essere appreso in modi diversi e stare quindi in rappresentanza di oggetti diversi. Si
crea così una dicotomia, interna al “fenomeno”, tra l’ “apparire”, cioè i vissuti
immanenti che costituiscono il contenuto dell’apprensione, e “ciò che appare”, cioè
l’oggetto trascendente che ne è invece il prodotto. L’oggetto è irriducibile ai vissuti,
ma si dà solo in essi; è trascendente, ma si costituisce come tale solo
nell’immanenza, cioè in elementi che, per statuto fenomenologico, sono eterogenei
rispetto ad esso. Di qui le domande che ricorrono in tutta l’opera di Husserl: come
può l’unico, identico oggetto costituirsi in una molteplicità continuamente mutevole di
vissuti? Come, nel fluire dei vissuti, nell’immanenza coscienziale, può darsi qualcosa
di identico e di trascendente?»55.
Da questo schema al “cartesianismo” il passo è giustamente riconosciuto come
breve: «La percezione interna conquista così inevitabilmente una preminenza
metodologica: la risposta a queste domande è possibile solo tematizzando i vissuti
in cui gli oggetti si costituiscono, per comprendere come possano trascendere se
stessi e mettere capo a qualcosa di diverso e di irriducibile ad essi (…) Esemplare, a
tal riguardo, l’esposizione di Idee I, che sviluppa del resto quanto era già implicito
nella teoria della rappresentanza delle Ricerche logiche. In Idee I, Husserl teorizza la
fenomenologia come scienza della coscienza pura e concepisce quest’ultima come
sfera di reell immanente Erlebnisse, di cogitationes materialiter spectatae. La via
d’accesso alla coscienza pura è la riduzione fenomenologia, che viene introdotta a
partire dalla dicotomia tra percezione immanente (di Erlebnis, cioè percezione
interna) e percezione trascendente (di Raumding, cioè percezione oggettuale in
senso proprio) e concepita appunto come esercizio della percezione interna. Se
infatti l’oggettuale si costituisce mediante l’apprensione dei vissuti immanenti, la
quale, animandoli intenzionalmente, conferisce loro senso, allora l’immanente (la
coscienza come compagine o flusso di vissuti e sede dell’intenzionalità) è
trascendentale
rispetto
al
trascendente
(l’oggettuale).
Lo
schema
contenuto/apprensione si presenta ora sotto forma di dualismo tra hyle sensuale
(materiale informe che viene animato apprensionalmente ) e morphé intenzionale
(momento apprensionale che opera in modo indipendente dalle caratteristiche di ciò
che esso anima. Quest’impostazione “introspettiva” contiene in sé il “dogmatismo
cartesiano” di Husserl (…) e conduce inevitabilmente alla dissoluzione dell’oggetto
nell’atto, della realtà nella coscienza, poiché riduce completamente l’elemento
54 Vittorio De Palma, “Genesi e struttura dell’esperienza”, in Discipline filosofiche, 1994, 1: 191-227.
55 Ivi, p. 200 sg.
noematico-oggettuale a quello noetico-apprensionale: l’oggetto sensibile è infatti
pensato come il prodotto di un processo tutto interno alla coscienza, la quale
racchiude in sé sia il materiale (sensazioni) sia il principio della donazione di senso
(intenzionalità)»56. A queste conseguenze strutturali dell’ “analisi statica” si oppone
quella “genetica”: «L’analisi genetica segue invece un’altra strada, che conduce al
superamento dello schema contenuto/apprensione e del cartesianesimo ad esso
sotteso: quella della scomposizione strutturale dell’oggetto nella sua interna
stratificazione e dell’analisi del senso percettivo nella sua peculiarità. Ciò comporta,
tra l’altro, che le apparizioni non siano più concepite come materiale poetico
immanente alla coscienza, ma come costituenti nomatici dell’oggetto stesso» 57.
Non si tarderà a notare come nella nostra analisi abbiamo sistematicamente
omogeneizzato le problematiche “statica” e “genetica” di cui qui invece viene
sottolineata la reciproca irriducibilità.
Tuttavia, non c’è dubbio che si debba concordare con l’articolo citato sia per
quanto riguarda la ricostruzione degli snodi teorici sia per quello che concerne il
“superamento” da parte dell’impostazione genetica delle conseguenze cartesiane di
quella statica. Il problema è intendersi sul significato di “superamento”. È nostra
opinione infatti che si debba parlare di inconciliabilità tra il “dogmatismo cartesiano”
e le Analysen, ma non tra queste ultime e le descrizioni di Idee I e delle Ricerche
logiche (e degli Studi psicologici) in merito alla percezione delle oggettualità
trascendenti; piuttosto, avanzeremmo l’ipotesi che sarebbe più prudente attribuire a
tali descrizioni una sorta di indeterminatezza, tale da rendere possibile il loro
sviluppo lungo linee teoretiche divergenti: l’una, in cui il concetto sistematico
cardinale –che unifica tutto il complesso descrittivo- è il primato della coscienza,
della percezione immanente come spazio assoluto della fondazione ultima di ogni
senso; l’altra, in cui tale concetto è invece la forma della temporalità passiva, che
permette di mettere in discussione tale primato. In questo senso, una volta che si sia
assunto il secondo quadro teorico come quello più fecondo, dovrebbe essere
possibile, come noi abbiamo tentato di fare, ricomprendere nel suo orizzonte quelle
descrizioni apparentemente più compromesse con gli esiti “cartesiani”. Ma perché
tale operazione sia plausibile, è necessario presupporre che il primato della
coscienza non sia analiticamente contenuto come l’unica soluzione possibile nelle
analisi dedicate alla percezione nelle Ricerche, negli Studi e in Idee I, e che, al
contrario, vi si trovino elementi descrittivi sviluppabili nel senso delle Analysen.
Vorremmo giustificare brevemente questa presupposizione. Il cartesianesimo
sarebbe, nelle analisi “statiche”, implicito nello schema apprensione/contenuto
apprensionale: prima vi sarebbe un senso riposto all’interno della coscienza; poi si
presenterebbero dei dati sensibili amorfi; infine la coscienza darebbe a questi dati la
forma del senso già racchiuso nella propria immanenza. Senonché, la “donazione di
senso” è qualificata dell’attributo “intenzionale”. E l’intenzionalità non è
necessariamente interpretabile come soggettiva, cioè come un “voler-dire” che la
coscienza esteriorizza in un atto di attribuzione di significato a ciò che in sé non ne
56 Ivi, p. 201 sg. Secondo l’Autore dell’articolo citato, sintomo delle carenze dell’analisi husserliana
della percezione è l’uso, in tale analisi, di termini e concetti tratti dalla sfera conoscitiva ed attiva della
vita di coscienza, cioè la «trasposizione della modalità di costituzione degli oggetti linguistico-culturali,
cioè dei segni, a quelli sensibili, la cui apprensione viene designata appunto come “rappresentanza” o
“interpretazione”» (p. 202). Abbiamo visto in precedenza come il concetto di “interpretazione” possa
essere utilizzato anche nell’ambito percettivo, intendendo il “passaggio” mediato dal fenomeno al
noumeno; in seguito cercheremo di mostrare come questo significato non sia in contrasto con la
struttura essenzialmente passiva della vita coscienziale-percettiva.
57 Ivi, p. 203
avrebbe alcuno. L’intenzionalità è in primo luogo riferimento all’oggetto, in-tendere in
direzione di un’oggettualità. Allora, la Deutung oggettuale dei dati sensibili, può
anche non significare l’imporsi alla loro materialità bruta di ciò che la coscienza
vuole-dire, intende-dire, di loro. Può significare invece riconoscimento di ciò che
essi, nella loro struttura peculiare, vogliono-dire, cioè già-da-sempre intendono: cioè
l’oggetto stesso.
Quindi, il rapporto della coscienza con l’oggetto non sarebbe più un rapporto
unidirezionale, mediato dal tramite neutro dei vissuti; i vissuti immanenti uscirebbero
da se stessi verso l’oggetto trascendente, trasportati da loro stessi oltre se stessi,
trasportati oltre sé dal proprio in-tendere l’oggetto, tendere verso l’oggetto; intendere che struttura preliminarmente i vissuti e li fa apparire come vissuti di questo
oggetto: sempre-già pre-interpretati dalla predatità intenzionale. L’interpretazione
allora si rivela funtore di trascendenza, non di immanenza. La Deutung intenzionale
è l’autotrascendimento dei vissuti in virtù della propria stessa struttura che li qualifica
come manifestazioni di un polo oggettuale. Che tale polo sia già sempre pre-dato in
carne ed ossa è la chiave del rifiuto husserliano di ogni teoria dell’immagine: ma
tale rifiuto regge solo se, in qualche modo, i vissuti-mediatori contengono già
l’oggetto stesso, di modo che non possano mai essere confusi con una sua
raffigurazione. Una tale raffigurazione infatti implicherebbe un’attribuzione volontaria
di senso che ne fonderebbe la somiglianza, o almeno lo stare-per, nei confronti
dell’originale: in altri termini, implicherebbe la riduzione dell’intenzionalità al suo
senso soggettivo. Ma è appunto una tale riduzione che il concetto di intenzionalità
non permette. L’ “interpretazione” in senso intenzionale non è necessariamente da
intendere nei termini di una coscienza attiva che interpreti i vissuti grezzi quali
rappresentanti oggettuali; è anche possibile parlare di un’ interpretazione che i
vissuti danno di se stessi, che contengono in sé, e che costituisce la forma del loro
in-tendere verso l’oggetto. In questa accezione, non è più ammissibile una
scansione in tre fasi discrete del rimando intenzionale: la coscienza non si accosta ai
vissuti per ottenerne il passaggio all’oggetto, ma i vissuti –già da sempre intendenti
l’oggetto- escono da sé verso la trascendenza in un processo che ha sì momenti
distinti, ma non realmente discreti, appunto.
Analogamente cade la scissione tra un momento iletico ed uno morficointenzionale. La “forma” che conferisce significato al vissuto non può essere
realmente disgiunta dalla “materia” che costituisce il rapporto con le cose
trascendenti; e ciò per il fatto che la forma significante di un vissuto è appunto il suo
riferirsi alle oggettualità trascendenti, e, viceversa, che tale riferimento costituisce
l’intenzionalità significativa del vissuto.
La morphé scaturisce dunque dalla tendenza della hyle a proiettarsi fuori di sé,
ma questa tendenza è la morphé stessa: tendere e in-tendere si identificano nel
rapporto oggettuale, del quale la coscienza può dirsi costituente solo nella misura in
cui, in un contesto teorico rivolto alla genealogia dell’oggettività, “soggetto” ed
“oggetto” si coappartengono a monte della loro contrapposizione, in uno “spazio”
neutro di esperienza in riferimento al quale non ha alcun senso parlare di un “in sé”
(posto che lo abbia altrove) privo di rapporti ad un “esperiente”.
Che la distinzione tra un “polo” coscienziale ed uno oggettuale debba
mantenersi non può essere messo in dubbio; questa necessità vale anche, infatti,
per le Analysen. Come non si dà il contrario, l’oggetto non può riassorbire nella
propria struttura la coscienza che di esso ci si forma nella percezione. La
permanenza di tale scarto tra coscienza e realtà non mette fuori causa solo il
cartesianismo ma anche il realismo ingenuo: è uno scarto irriducibile nei due sensi,
per nessuno dei quali esso consente che si pervenga ad una coincidenza tra Io e
Mondo. Abbiamo visto come l’autonomo dispiegarsi dell’oggetto nelle Analysen vada
sempre correlativo ad un’anticipazione sull’effettiva manifestazione percettiva,
anticipazione certo oggettualmente motivata, ma comunque sempre tale da rendere
l’errore immanente ad ogni presunzione sul senso del nostro mondo percettivo. In
altri termini, la passività implica che noi siamo sempre-già consegnati ad un mondoper-noi, ma non implica affatto –anzi, in certo senso esclude- che questo mondo ci
sia una volta per tutte e dall’inizio dato come interamente chiaro e perspicuo: esso è
piuttosto il mondo delle presupposizioni incerte, motivate ma in modo insufficiente,
sempre aperte e suscettibili di rettificazione, eppure predelineate nelle loro
alternative prima di ogni nostra presa d’atto di una loro eventuale verità. È possibile
ipotizzare che sia questo scarto, la sua necessità sistematica, a motivare l’utilizzo da
parte di Husserl della distinzione tra noesi e noema nell’analisi della costituzione
genetica: «Dal punto di vista noetico il percepire è un miscuglio: vi è una
presentazione effettiva, che rende intuibile ciò che presenta nel modo della
presentazione originale, ma vi è anche un vuoto indicare che rimanda a possibili
nuove percezioni. Sotto l’aspetto noematico ciò che viene percepito si dà invece per
adombramenti, e quindi in modo tale che ciò che di volta in volta è dato rimanda a
qualcosa di non dato, in quanto non dato che appartiene tuttavia a quel medesimo
oggetto»58. Dunque, il piano noematico è quello in cui l’oggetto si costituisce
sempre in modo “impuro” e incompleto; mentre il piano noetico è quello della
coscienza che segue questa costituzione, ma in questo seguire è anche spinta dalle
predelineazioni ad anticipare sulla manifestazione effettiva. La genesi dell’oggetto, il
processo temporale del suo obiettivarsi secondo le strutture della temporalità
noematica, è intrecciato indissolubilmente ad un movimento temporale noetico: il
tempo della coscienza dell’oggetto, del formarsi in essa di assunzioni e presunzioni,
costantemente da commisurare al progredire dell’esperienza effettiva; si tratta di una
temporalità inscindibile ma distinta dalla prima: non c’è tempo dell’obiettivazione
senza tempo della coscienza che si rapporta all’apparire dell’oggetto obiettivantesi,
né viceversa; eppure l’uno è sempre in ritardo od in anticipo sull’altro, i due tempi
non possono divenire coestensivi in virtù del permanere di uno scarto che si
manifesta ora come precedenza del reale sulla coscienza, ora come anticipazione
della coscienza sulla realtà, e, a partire dalla necessità di confermare la validità di
tale anticipazione, come riaffermazione della predatità del mondo, il quale però non
può mai essere esaurito e posseduto in un’evidenza assoluta, e così via all’infinito.
Sarà chiaro, perciò, per quale motivo non è possibile trascurare, anche una volta
riconosciuta l’importanza della prospettiva delle Analysen, le descrizioni di Idee ,
delle Ricerche e degli Studi; sul piano teorico, le distinzioni tra intuizioni e
rappresentanze, tra adombramenti ed adombrato, tra vissuti immanenti ed oggetto
trascendente, non possono essere obliate senza pregiudicare gravemente la
comprensione del “dispositivo” che presiede all’obiettivarsi per-noi di un ambiente
percettivo. E questa mancata comprensione pregiudica a sua volta la possibilità di
affrontare alcune tematiche cruciali di cui faremo breve menzione. In primo luogo,
senza mantenere quelle distinzioni, diventa impossibile fondare una teoria della
genesi della coscienza, e quindi lo stesso rifiuto del cartesianismo ne viene
indebolito, in mancanza di un complemento teoretico positivo. Infatti, nel “dispositivo”
che abbiamo tentato di ricostruire, non c’è spazio per una coscienza autistica che
tenta di rapportarsi dall’esterno ad un mondo inaccessibile; la coscienza e la realtà
piuttosto vengono differenziate ed identificate proprio a partire dalla loro
correlazione. Riprendendo il discorso di Melandri precedentemente citato, possiamo
dire che la distinzione tra coscienza e realtà è frutto di un’obiettivazione simultanea
58Husserl, op. cit. , p. 35
dei due poli (Io e Mondo) prodotta a sua volta da un’interpretazione (passiva ed
inconsapevole) dei fenomeni sensibili. Per mezzo di tale interpretazione, «il mondo
fenomenico diventa un piano di simmetria ermeneutica, al di l’ del quale si ha la
costituzione dell’oggetto dell’esperienza e al di qua del quale, con perfetto
enantiomorfismo, la costituzione del soggetto esperiente» 59. In altri termini, la
percezione in quanto situazione percettiva non deriva dal fronteggiarsi di un reale e
di una coscienza; piuttosto, è in tale situazione che i due termini giungono a
costituirsi ed a contrapporsi: «Se dalla divisione si risale alla matrice, si vede bene
come (…) alla realtà dell’ oggetto O debba corrispondere la virtualità del suo antioggetto o soggetto O', e come reciprocamente alla realtà del soggetto S debba
corrispondere la virtualità del suo anti-soggetto od oggetto S' (…) In altre parole,
qualsiasi semiologia che consenta di riferirci a una realtà al di là del mondo
fenomenico, ci autorizza parimenti a riferirci a una realtà al di qua di esso; e di
questo sdoppiamento speculare può render ragione solamente un’ermeneutica
estesiologica antecedente all’alternativa categorica fisica/psicologia» 60.
Qui si vede chiaramente come termini quali “interpretazione” od anche
“semiologia” non vadano intesi come riferentisi all’attività di una coscienza su un
materiale inerte: l’interpretazione è piuttosto il processo della genesi della coscienza,
in cui a partire da una situazione di indifferenziato “esserci” percettivo la coscienza
distingue sé (costituendosi come tale) dalla realtà obiettiva, tracciando la linea
divisoria, in alcun modo presupposta alla percezione stessa, tra immanenza del
vissuto e trascendenza dell’oggetto.
Si può tranquillamente ipotizzare, a questo punto, che tale linea divisoria sia
tracciabile in virtù dello scarto temporale che inerisce alla situazione percettiva
originaria: cioè in virtù del gioco tra anticipo e ritardo, del reale sulla coscienza e
viceversa; la coscienza “impara” a differenziarsi dalla realtà (ed a contrapporvisi
come ad un “esterno”) facendo esperienza della non-coincidenza tra sé ed il mondo,
dell’eccedenza delle “cose” sulle attese e delle assunzioni sulle presentificazioni:
eccedenza, e dunque asimmetria, che non viola la legge di simmetria, anzi, la
presuppone, in quanto il manifestarsi di un’asimmetria (di uno scarto tra “mente” e
“mondo”) conduce ad una procedura di rettifica in cui la simmetria violata si
riproduce a livello superiore. La distinzione tra immanenza e trascendenza allora
diventa indispensabile per pensare l’accrescimento –e la modificazione- del “sapere”
nel corso dell’esperienza; e per pensare lo statuto fisiologico dell’errore e
dell’incertezza, correlativi alla temporalità in cui accade ogni progresso “conoscitivo”
(in un senso ampio valevole anche per la mera esperienza percettiva).
59 Melandri, La linea e il circolo, p. 357 sg.
60 Ivi,p.359 sg. Questo dispositivo “ermeneutico” è dominato da una “legge di simmetria”, definita
anche “quella ineliminabile tautologicità di fondo, senza di cui non potremmo mettere in correlazione la
mente e il mondo” (p. 360). In un altro fondamentale volume, L’analogia, la proporzione, la simmetria
(ISEDI, Milano, 1974) queste tematiche vengono sviluppate da Melandri in riferimento al rapporto tra
l’ampliamento dell’esperienza (assicurato dall’ermeneutica e dalla semiologia) e la sua obiettivazione
mediante costrutti intellettuali all’interno di un plesso semantica (definizione di un significato) /ontologia
(definizione degli oggetti congruenti con quel significato). È qui che l’esperienza subisce la
“sustruzione” ad opera delle produzioni intellettuali, e che la passività viene coperta dall’attività
razionale.
In effetti, è solo al livello di questa obiettivazione intellettuale che si definisce la reciprocità di soggetto
ed oggetto stabilmente individuati come momento psichico e momento fisico. Tuttavia, in virtù della
simmetria che governa il rapporto esperienza/intelletto, siamo autorizzati a parlare di genesi
enantiomorfa di “soggettività” e “oggettività” (non ancora racchiuse in ambiti definiti e obiettivi) già al
livello dell’ampliamento “interpretativo” (nel senso finora da noi usato) dell’esperienza.
Concludiamo indicando i problemi che questi risultati implicano e consegnano
alla riflessione futura:
1)
il problema del rapporto tra esperienza e conoscenza intellettuale;
2)
il problema della determinazione dei due lati, soggettivo ed oggettivo,
una volta conclusa la rispettiva obiettivazione. Questo problema è legato al primo
(vedi la nota 43); solo l’intervento della costruzione attiva di oggetti intellettuali
permette di “fare la teoria” di tali oggetti e del soggetto che li conosce –in quanto al
livello fenomenologicamente precedente, di cui abbiamo scritto finora, “soggetto” e
“oggetto” sono termini usati in senso analogico, non essendoci ancora la possibilità
di ricondurli ad ambiti autonomi categorialmente. La stessa eterogeneità dei lati della
cosa è una distinzione categoriale tra vissuto ed oggetto, non una autonomizzazione
del soggetto da parte dell’oggetto. Vero è che, per descrivere il piano in cui un
soggettivo ed un oggettivo iniziano a divergere, abbiamo dovuto implicitamente
assumere come Leitfaden il soggetto e l’oggetto completamente obiettivati: solo così
abbiamo potuto innanzitutto distinguere vissuto ed oggetto, quindi mostrarne il
rapporto “circolare”, e infine descrivere lo “scenario” passivo-genetico di tutto il
rapporto. Ma se a monte dell’analisi vi è l’obiettivazione piena dei costrutti
enantiomorfi, evidentemente è in gioco una più ampia circolarità che ci obbliga a
rimettere in gioco tutto quanto;
3)
il problema costituito da quei temi significativi che reperiamo nei vissuti
e che in-tendono verso l’oggetto (guidando il decorso dei vissuti stesso). Se, come
abbiamo visto, la “cosa” è già presente nei vissuti come una tendenza intrinseca
verso l’oggetto trascendente, ciò implica che tale presenza non è un semplice
“significato”, ma un “tema”, cioè una determinatezza qualitativa, contenutistica,
capace di persistere nella propria identità lungo uno svolgimento. La sintesi passiva
ha allora a che fare con la comprensione di temi, cioè di contenuti “sensati” (ciò che
divide la fenomenologia da ogni pur raffinato logicismo). Ma sorgono allora due
domande: in primo luogo, qual è l’origine fenomenologica di tali temi? In secondo
luogo: dove poter reperire, al di fuori della mera percezione, siffatte significatività
tematiche? O, in altri termini, dove si nascondono i contenuti, non esattamente
intellettuali, ma nemmeno propriamente sensibili, di cui si struttura la nostra
esistenza?
La questione della ratio scientifica in Husserl e Adorno.
Michelangelo Cianciosi
I.
Il percorso della Krisis ha inizio allorché Husserl pone la domanda
fondamentale che guiderà poi tutto il procedere della sua riflessione fino
all’esposizione del metodo della fenomenologia trascendentale: “Si può seriamente
parlare di una crisi delle nostre scienze in generale ? Questo discorso, oggi
consueto, non costituisce forse un’esagerazione? La crisi di una scienza comporta
nientemeno che la sua peculiare scientificità, il modo in cui si è proposta i suoi
compiti e perciò in cui ha elaborato la propria metodica, siano diventati dubbi” 61.
Pare improponibile mettere in discussione la veridicità delle scienze positive che, pur
avendo subito numerose variazioni di struttura nel corso dei secoli, fondano la loro
autorità sulla capacità dimostrata di poter compiere previsioni assolutamente esatte
sulla realtà e sulla possibilità quasi infinita di dar luogo ad applicazioni tecniche che
costituiscono il lato maggiormente visibile del progresso dell’umanità. Il rispetto più
volte mostrato da Husserl nei confronti dei procedimenti e dei risultati delle scienze
non costituisce, a nostro avviso, un atto semplicemente formale: egli non vuole
mettere in alcun modo in dubbio la validità delle scienze stesse. Tenta così un
percorso indiretto che possa portare alla riconsiderazione radicale dei princìpi che
stanno alla base della formazione delle scienze, in modo da non intaccare quel
valore metodologico ch’è loro proprio.
Per comprendere in che modo possa essere messo in discussione il senso
proprio delle scienze, il padre della fenomenologia intraprende un percorso
interpretativo che lo porta a considerare lo sviluppo storico–genetico delle stesse. La
nascita delle scienze in senso moderno viene da lui fatta risalire al Rinascimento:
“Com’è noto, l’umanità europea attua durante il Rinascimento un rivolgimento
rivoluzionario. Essa si volge contro i suoi precedenti modi di esistenza, quelli
medievali, li svaluta ed esige di plasmare se stessa in piena libertà” 62. L’uomo
rinascimentale prende a modello il pensatore della grecità classica formato dalla
filosofia intesa come conoscenza della verità ultima, dalla quale dovevano scaturire
tutte le scienze particolari. Husserl investe tutto il patos di cui è capace nel
rivendicare alla filosofia il ruolo centrale di noús ordinatrice e télos della conoscenza
stessa: in essa, nell’idea limite che essa rappresenta, egli intravede l’entelechia
propria dell’umanità europea, ciò che ne costituisce il vero elemento sostanziale, la
cui riattivazione costituirebbe il momento imprescindibile per la costituzione di una
scientificità vera. Appare evidente, tuttavia, che tale ideale è miseramente fallito. Di
fronte al progetto di una umanità nuova vivificata dalla filosofia come elemento
propulsore in quanto conoscenza di tutto l’essere, infatti, che ne è delle odierne
scienze positive, che si presentano piuttosto come disjecta membra? “Il concetto
positivistico della scienza è dunque- da un punto di vista storico- una scienza
residuale”63. Per comprendere la situazione contemporanea, Husserl traccia una
mappa grandiosa del movimento ideale compiuto dalla filosofia moderna (che basta
da sola a rimettere in discussione le accuse di antistoricismo che ad Husserl sono
state spesso mosse). Anzitutto bisogna osservare che la ripresa compiuta dal
Rinascimento del compito proprio della filosofia greca di procedere in modo unitario
allo sviluppo delle conoscenze, si apre sotto auspici diversi da quelli della metafisica:
il ruolo costitutivo di matrice ideale e formale, viene assunto dalla matematica “La
grande novità è costituita dalla concezione di quest’idea di una totalità infinita
dell’essere e di una scienza razionale che lo domina razionalmente. Questo mondo
infinito,questo mondo di idealità è concepito in modo tale che i suoi oggetti non
possono essere colti singolarmente, imperfettamente e come casualmente dalla
nostra conoscenza: esso può essere raggiunto solo da un metodo razionale,
sistematicamente unitario nel procedere infinito…”64. Prendeva così avvio l’idea di
una mathesis universalis in cui la matematica e la geometria venivano ad assumere
61 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, op. cit., p.33.
62 Ivi, p. 37.
63 Ivi, p. 38.
64 Ivi, p. 52
un ruolo differente da quello che la tradizione aveva loro riservato fino a quel
momento. A partire da un’antichità che precede le formazioni teoretiche e la nascita
della filosofia, l’uomo ha avvertito, per le esigenze pratiche che il vivere quotidiano
comporta (agrimensura, misurazione delle distanze, ecc.), il bisogno di costituire un
metodo unitario che permettesse una considerazione obiettiva della realtà che
andasse al di là della valutazione approssimativa dei singoli. Il mondo reale, quello in
cui si muove e si sviluppa la vita quotidiana, è qualcosa che c’è già sempre e in cui
si è immersi. “Nella vita dell’esperienza prescientifica siamo immersi nel fiume
eracliteo delle datità sensibili-cosali, nella cui evoluzione abbiamo la certezza, per
quanto nell’evidenza ingenua dell’esperienza, di conoscere una cosa identica nelle
sue proprietà, vedendola, toccandola e palpandola, ascoltandola, ecc., … ma
evidentemente tutto ciò che noi riteniamo di attingere attraverso la conoscenza della
cosa è, in tutte le sue determinazioni identificabili, qualcosa che rimane
inevitabilmente nel pressappoco”65. Le conoscenze acquisite tramite l’esperienza
soggettiva risultano dunque non solo modificabili e perfezionabili per mezzo di una
sperimentazione più precisa, ma subiscono un’evoluzione già per il semplice fatto di
essere attuate in una comunità di soggetti, tutti egualmente esperienti: viene a
formarsi pian piano, dunque, un mondo della vita comune ritenuto oggettivo. È
chiaro che in tal modo ci si muove ancora sul terreno della dòxa, della mera opinione
soggettiva, ma proprio questo costituisce, per Husserl, il luogo teorico da cui occorre
partire per comprendere il passaggio alla epistéme. È a partire da un processo
continuo di astrazione tendente ad una sempre maggiore precisione e raffinatezza
che si sviluppano quegli enti ideali che costituiscono la base delle scienze, un
mondo scientifico-obiettivo valido per chiunque si sottoponga alle regole metodiche
per avvicinarlo: “…sulla base della prassi del perfezionamento, nella libera
penetrazione negli orizzonti di un perfezionamento pensabile, nel «sempre di
nuovo», si delineano continuamente forme-limite verso cui tende, come a un polo
invariabile e insieme irragiungibile, qualsiasi serie di perfezionamenti” 66. Nel corso
dei secoli si sviluppano vertiginosamente e la progressiva idealizzazione della realtà
oggettiva, e una prassi che permetta il passaggio dalle semplici operazioni della vita
pratica ad una metodologia teoreticamente sempre più
adeguata ad una
considerazione scientifica del mondo. La complessità raggiunta alle soglie della
modernità dalle “strutture architettoniche” che costituiscono il corpus di scienze quali
la matematica e la geometria si basa sul presupposto della possibilità di costruire
nuove conoscenze sul solido fondamento di quelle precedentemente acquisite, il che
rende quasi impossibile agli scienziati la costante riattivazione del loro senso.
La geometria e la matematica che l’epoca moderna prendeva in
considerazione come fulcro per una considerazione onnicomprensiva del reale,
erano dunque già frutto di una lunga ed elaborata tradizione che aveva ormai
perduto ogni coscienza dei propri legami con la datità prescientifica. Dal successo
del procedere matematico, inteso come costruzione sulle forme intuite di una
oggettività ideale, sempre di nuovo applicabile all’empiria, agli oggetti stessi, doveva
nascere l’idea di una sua estensione al mondo nella sua globalità. Geniale esecutore
di tale esigenza, fu Galilei, che con successo allargò alle scienze della natura la
metodologia geometrico-matematica. Tale applicazione, tuttavia, non può più, per
Husserl, essere considerata pacifica. Egli insiste con dovizia di particolari sulle
implicazioni per lo più inindagate che essa comporta. L’immissione della realtà,
percepita quotidianamente esclusivamente in modo soggettivo-relativo, all’interno di
65 Ivi, p.372.
66 Ivi, p. 55.
una imbracatura teorica di tipo matematico (che costituisce un livello ulteriore di
astrazione degli enti oggettivamente idealizzati) presuppone, in effetti, un mondo
considerato come l’insieme dei corpi esistenti, organizzati secondo i criteri della
spazio-temporalità e della causalità: “…l’obiettività esatta è un’operazione
conoscitiva che, innanzitutto, presuppone il metodo di una idealizzazione sistematica
e determinata capace di produrre un mondo di ideali determinati e di costruirlo
sistematicamente all’infinito e che, in secondo luogo, rende evidente l’applicabilità di
queste idealità costruibili al mondo dell’esperienza”67. I corpi esperiti sono dotati di
diverse qualità. Nell’ambito di un’astrazione che tende ad avvicinare
progressivamente i corpi ai modelli geometrici e, viceversa, ad un affinamento
continuo dei modelli medesimi che permetta una loro migliore “aderenza” al reale,
propria di una considerazione di tipo obiettivistico della realtà, alcune di esse si
presentano come direttamente passibili di matematizzazione come l’estensione e il
movimento; le altre, o si presentano come indirettamente matematizzabili, venendo
a costituire una sorta di rimando segnico alle qualità del primo tipo (così come, ad
es., il suono prodotto dalle vibrazioni di una corda tesa rimanda alla lunghezza della
corda medesima), oppure vengono eliminate dall’ambito della conoscenza,
considerate come mere accidentalità68. Di qui la svalutazione del momento
qualitativo-sensibile della realtà e della facoltà ad esso correlata 69. Nella
matematizzazione geometrica e scientifico-naturale, noi commisuriamo così al
mondo-della vita – al mondo che ci è costantemente e realmente dato nella nostra
vita concreta che si svolge in esso- nell’aperta infinità di un’esperienza possibile, un
ben confezionato abito ideale, quello delle verità obiettivamente scientifiche. “La
matematizzazione indiretta del mondo, che avviene ora sotto forma di
un’obiettivazione metodica del mondo intuitivo, dà come risultato formule numeriche
generali, le quali, una volta trovate, possono essere applicate e possono realizzare
l’obiettivazione di fatto di quei casi singoli che devono essere sussunte sotto di
esse”70. Raccolta da Descartes, l’eredità galileiana ottenne quella sistematizzazione
metodica che doveva restare il fondamento implicito e spesso nascosto a se stesso,
di tutta la speculazione successiva.
Mai più la scienza fisica sarebbe tornata indietro per riflettere su questi suoi
presupposti inindagati e considerati assodati. Husserl considera l’ipostatizzazione
del mondo obiettivo-fisicalistico come mondo reale, alla stregua di una vera e propria
alienazione di senso, come una sustruzione posta sull’unico mondo realmente
esistente, che non è quello obiettivo delle scienze, bensì quello soggettivo relativo;
ogni sovrapposizione del mondo fisicalistico alla Lebenswelt costituisce, dunque,
una falsificazione71. Il mondo-della-vita, abbiamo visto, con la sua esperienza
67 Ivi, pp. 375-376
68 A partire dalla filosofia cartesiana, e soprattutto con lo sviluppo che la sua teoria gnoseologica
conoscerà nell’empirismo inglese di Locke, Berkeley e Hume, i distinti tipi di qualità qui descritti
diventeranno noti come qualità primarie e qualità secondarie.
69 “I fenomeni sono soltanto nei soggetti; sono in essi soltanto in quanto conseguenze causali dei
processi che hanno luogo nella vera natura, processi che dal canto loro esistono soltanto nelle
proprietà matematiche… La natura è nel suo vero «essere-in-sé», matematica” . E. Husserl, La crisi
delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, op. cit., p. 83. Il fatto che il processo di
matematizzazione comporti al contempo la perdita di un’ampia gamma di qualità “soggettive” e il
tentativo di recuperarne l’impotanza, non è molto lontano da ciò che anche Adorno aveva in mente.
70 Ivi, p. 70. Nella critica husserliana alla metodologia matematica è già presente un punto di
convergenza con quella che sarà la critica adorniana al procedere metodico delle scienze.
71 “Galileo, lo scopritore della fisica e della natura fisica, …è un genio che scopre e insieme occulta”.
Ivi, p. 81.
sempre in divenire, è il mondo quotidianamente esperito, in cui si svolge ogni prassi
umana, dalla più semplice delle operazioni pre-scientifiche alle più complesse
costruzioni teoretiche. Il suo status costantemente fluente sembrerebbe scoraggiare
per parte sua la possibilità di ottenere un qualsiasi tipo di conoscenza salda e
accettata da tutti, e tuttavia, afferma Husserl, anche la Lebenswelt possiede delle
strutture generali costanti in cui tale divenire si organizza: compito della
fenomenologia sarà dunque quello di indagare e rendere esplicite proprio tali
strutture generali in cui gli Erlebnisse del mondo della vita si offrono. Ovviamente il
nostro interesse per questo nuovo ambito non può essere diretto verso le “datità”,
così come le considera il pensiero positivistico (l’obiettività in quanto tale, infatti,
come idealizzazione costruita a posteriori, non è mai ciò che è direttamente
esperibile), né i procedimenti per accedervi possono essere quelli propri delle
scienze (che costituiscono, anzi, ciò di cui si fa questione), per la neutralizzazione
dei quali Husserl adotta la prima epochè. “Il problema dell’essere-già-dato del
mondo dev’essere dapprima inteso in un senso che è accessibile a chiunque sulla
base dell’atteggiamento naturale; cioè come esser-già-dato di un mondo di cose
essenti nella costante evoluzione dei modi relativi di datità: il mondo che per
essenza in qualsiasi vita naturalmente fluente si dà come ovviamente essente,
essente in una pienezza inesauribile di sempre nuove ovvietà, le quali tuttavia sono
sempre costantemente nell’evoluzione delle apparizioni e delle validità soggettive.
Noi lo rendiamo ora conseguentemente tematico, in quanto terreno di tutti i nostri
interessi, dei nostri progetti di vita, di cui le scienze teoretiche e obiettive
costituiscono soltanto un gruppo particolare”72. Si attua il sorprendente paradosso
per cui le teorie scientifiche non possono condurre ad una conoscenza adeguata del
mondo-della-vita, chè anzi questo è proprio il terreno che esse non possono
raggiungere; al contrario, proprio le formazioni teoriche non solo possiedono in
quello il proprio Grund, ma ad esso sono costrette ad attingere il crisma della loro
scientificità, quella verificabilità che è possibile solo nell’ambito soggettivo-relativo
della Lebenswelt. Pur essendo impegnato costantemente a sottolineare le differenze
che sussistono tra il reificato mondo fisicalistico e il mondo-della-vita, Husserl è
altresì costretto a richiamarne sempre la connessione: qui infatti, nel mondo
soggettivo-relativo, si colloca la scoperta di quella istanza unitaria fondante che,
come istanza che precede tutte le altre, raccoglie in sé la totalità delle scienze,
costituendone il presupposto e che può rivitalizzare per parte sua la ricerca
filosofica, donandole quella centralità che le si addice in quanto entelechia
dell’umanità europea73. Per raggiungere la sua meta, il padre della fenomenologia
propone l’esplorazione del regno ignoto della madre della conoscenza, della
soggettività anonima, dell’io ultimo e nascosto, dell’io originario (Ur-ich), di cui la
Lebenswelt costituisce il correlato. Attraverso la via della epochè trascendentale e
della riduzione (elementi centrali delle tematiche husserliane che non tratteremo in
modo specifico perché esulano dalla nostra indagine) che Husserl elabora, è
possibile cogliere le due regioni pure del mondo-della-vita e dell’egoità
trascendentale che fornisce senso alla Lebenswelt stessa, e che è sempre fungente
72 Ivi, p. 181.
73 “ Ma in definitiva, il senso teleologico unitario che attraversa tutti i tentativi sistematici della storia
della filosofia non è forse il tentativo di rendere evidente come la scienza in generale sia possibile solo
in quanto filosofia universale e come questa, nonostante tutte le scienze, sia un’unica scienza, come
sia possibile solo in quanto totalità di tutte le conoscenze? E ciò non implica forse il fatto che tutte le
scienze si basano su un unico fondamento, un fondamento che va indagato scientificamente prima
degli altri- e questo fondamento, aggiungo io, può essere altro dalla soggettività anonima?” . Ivi, p.
142.
in linea definitiva e perciò assoluta: “L’esperienza, l’Erlebnis come presenza, è alla
base; questa base non è un essere «qualunque», ma «essere immanente»: cioè il
punto di partenza dopo l’epochè sono proprio io…La materia, l’hyle, appartiene al
mio proprio io:… il noetico ha in sé una materialità soggettiva che viene esperita
direttamente”74. La riduzione trascendentale, intesa in senso radicale, conduce alla
scoperta di due poli, quello oggettuale (il mondo-della-vita) e quello soggettivo
(l’egoità fungente), i quali necessitano di peculiari trattamenti per le singole
tematizzazioni. È evidente, tuttavia, data la sua struttura relativa (quindi il suo
costante rinvio al momento soggettivo, che pone il senso), che la Lebenswelt debba
essere in ultima istanza considerata “come una mera «componente» della concreta
soggettività trascendentale”75. Solo in tal modo si può intendere correttamente
l’affermazione di Husserl che “il primum reale è l’intuizione «meramente soggettivo
relativa» del mondo-della-vita prescientifica nel mondo”76, la cui dimenticanza ha
causato la perdita di senso delle scienze stesse. Diventa altresì chiaro il significato
dell’espressione di forte sapore idealistico (e Adorno insisterà molto su questo
aspetto nella sua critica a Husserl) “ Lo spirito e soltanto lo spirito è essente in se
stesso e per se stesso; lo spirito è autonomo e soltanto in questa autonomia può
essere trattato in modo veramente razionale e in modo radicalmente scientifico…per
quanto riguarda la natura nella sua verità scientifico-naturale, essa è soltanto
apparentemente autonoma, e soltanto apparentemente può essere conosciuta
razionalmente per sé attraverso le scienze naturali. Poiché la vera natura nel senso
delle scienze naturali è un prodotto dello spirito che la indaga e presuppone quindi la
scienza dello spirito”77. Al di qua dell’obiettivismo scientifico, contro ogni ipertrofia
intellettualistica, in virtù del superamento dell’atteggiamento naturale e della
riduzione egologica di ogni interesse mondano, nasce il progetto di una ontologia e
di una tipica dell’ego primitivo, che siano insieme una tipica e una ontologia della
Lebenswelt, perché l’opera prima dell’ego è un’opera pre-scientifica che coincide col
donarsi originario del mondo-della-vita.
II.
Ciò che ci preme sottolineare prima di intraprendere un’analisi delle riflessioni
di Adorno sulla scienza è l’importanza che esse hanno costantemente rivestito nel
complesso del suo pensiero. Sin dalla prolusione accademica del 1931 78, Adorno
dimostra grande interesse al tema della connessione/contrapposizione tra pensiero
filosofico e pensiero scientifico e una viva attenzione alle teorie che le correnti
74 E. Paci, Per una interpretazione della natura materiale in Husserl, in «Aut-aut», 1967, n. 100, pp.
47-48.
75 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, op. cit., p. 202.
76 Ivi, p.154.
77 Ivi, p. 356.
78 Th. W. Adorno, L’attualità della filosofia, in Utopia, n.7/8, 1973, pp. 3-11.
positivistiche più avanzate (e in particolar modo il Circolo di Vienna), andavano
elaborando79. In quello scritto, dopo aver ammesso la straordinaria importanza di
questa scuola, Adorno ne individua il merito principale proprio nel fatto di aver
indicato con molta precisione la differenza tra ciò che è scienza e ciò che non lo è
nel modo differente che esse hanno di trattare la datità, che la scienza assume
come un fondamento ultimo oltre il quale non si può procedere, mentre la filosofia la
considera come un elemento ulteriore da interpretare. Nelle opere più tarde è ancora
possibile imbattersi in dichiarazioni come queste “ …[la filosofia] consiste nella
riflessione della scienza, con la quale deve essere incessantemente nel più stretto
contatto, e a cui tuttavia non si può abbandonare del tutto.[…] L’argomentazione,
che mette sullo stesso piano la fede in un dogma e la fede nella scienza riducendole
entrambe alla categoria formale del ritenere-una-cosa-per-vera, io la considero
radicalmente falsa; poiché non si tratta già del fatto che la coscienza soggettiva
ritenga vera una cosa qualsiasi, ma si tratta, in verità, della connessione immanente
dell’evidenza … un pensiero che si sottrae a quel momento dell’evidenza, per cui si
verifica se ciò che si crede è vero e non è invece una mera opinione che ci viene
spacciata per verità, che quindi non si impone quella forma di disciplina che è insita
nella scienza in quanto protesta contro la pura opinione, è lontano dal pensiero
filosofico esattamente nella stessa misura in cui ne dista un pensiero che viceversa
dichiara che la scienza è semplicemente il modello della filosofia…”80. Con il brano
sopra riportato, non balza agli occhi solo la concezione dialettica di Adorno del
rapporto tra filosofia e scienza, ma vengono anche messe a tacere quelle illazioni
che vedono nel pensiero del nostro una pericolosa deriva irrazionalistica. Allorchè
Husserl affermava: “anch’io sono persuaso che la crisi europea affonda le sue radici
in un razionalismo erroneo. Ma ciò non significa che la razionalità come tale sia una
calamità o che rivesta un’importanza soltanto limitata per l’umanità.”81, intendendo
voler porre mano ad una critica della razionalità per mezzo della ragione stessa,
Adorno gli riconoscerà questo merito e si porrà sulla sua stessa scia.
Per comprendere come si sviluppa la polemica adorniana contro lo scientismo
e il tipo di ratio che quello presuppone, ci rifaremo ad un concetto centrale di tutta la
sua filosofia, quello di “mito”, inteso come coazione all’identità, soprattutto così come
esso si configura nell’opera scritta in collaborazione con Max Horkheimer, la
Dialektik der Aufklärung82 sebbene già nelle sue prime opere, ne L’idea di storia
naturale come nel testo della Abilitationschrift su Kierkegaard, è possibile trovarne
un’ampia tematizzazione. Poiché esso, come molti dei concetti di Adorno, ha la
tendenza a non rimanere rinchiuso in un solo ambito teorico, ma a svolgere un ruolo
interpretativo che scavalca le tradizionali divisioni, tenteremo per quanto possibile di
attenerci agli elementi che di esso ci interessano maggiormente. Il concetto di mito
79 Petrucciani ci sembra mettere molto bene in rilievo il rapporto che Adorno pone in essere con le
correnti neoempiristiche: nella sua critica serrata delle derivazioni scientistiche, egli non cerca mai di
screditarle come un’errata descrizione dei procedimenti scientifici. Sembra anzi accettarle come la
descrizione più adeguata delle stesse e vede la possibilitàdi usarle proprio per una critica delle stesse.
S. Petrucciani, Ragione e dominio. L’autocritica della razionalità occidentale in Adorno e Horkheimer,
Roma, Salerno editrice, 1984, p. 306.
80 Terminologia filosofica, I vol., Torino, Einaudi, 1965, p. 85.
81 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, op. cit., p. 349.
82 Esso deriva ad Adorno da Benjamin, che aveva utilizzato il concetto di mito in alcuni dei suoi saggi
più importanti come Per la critica della violenza e Destino e carattere e che attorno ad esso aveva
edificato la sua interpretazione delle Affinità elettive di Goethe.
deriva ad Adorno dalla riflessione di Benjamin 83: in essa, “…il concetto di mito
detiene il posto centrale come contraltare della conciliazione…La critica del dominio
della natura, che l’ultimo aforisma di Einbahnstrasse programmaticamente annuncia,
rimuove il dualismo ontologico di mito e conciliazione: questa è quella dello stesso
mito. Nel progresso di tale critica il concetto di mito viene secolarizzato. La sua
teoria del destino come nesso colpevole del vivente trapassa in quella del nesso
colpevole della società: «Finchè c’è ancora un mendicante ci sarà mito».” 84 Tutta la
Dialettica tende alla dimostrazione che l’Illuminismo (termine usato in una accezione
molto più ampia di quella storicamente accettata, e preso come sinonimo di ratio
occidentale), autointerpretantesi come lotta contro ogni tipo di mito, mantiene in
realtà con esso una certa segreta complicità85. Il pensiero illuministico ha sempre
avuto il compito, come pensiero in continuo progresso, di eliminare la paura e di
rendere l’uomo da essere soggetto agli eventi naturali, loro padrone. La mentalità
mitica considerava specularmente il mondo naturale così come quello sociale,
sottoposti a leggi, imponderabili e indissolubili per l’uomo, stabilite e fatte rispettare
da quelle entità superiori che erano gli dei. Nell’ambito della natura tali leggi si
mostravano sotto la forma di forze elementari, dotate di un movimento ciclico,
ciascuna presieduta da una divinità; nell’ambito della sfera sociale, a regolare la vita
degli uomini era il cieco destino, che si svolgeva sopra le loro teste con la stessa
inesorabilità delle forze naturali e con la medesima impossibilità di interferire nel suo
meccanismo. “Il nucleo del pensiero mitico è la cieca ripetizione, il chiuso ciclo
dell’immanenza da cui nulla conduce fuori”86. Il mito è storia del nesso destinato
della colpa e della espiazione. L’azione dell’eroe si svolge sotto il segno di un
destino che non è tanto la disgrazia fatale che gli dei inviano a colui che ha
commesso la colpa, quanto piuttosto un ordine superiore che condanna alla colpa,
“un ordine i cui soli concetti costitutivi sono infelicità e colpa e per entro il quale non
è concepibile via alcuna di liberazione”87. Secondo Adorno, tuttavia, nella
concezione mitica della realtà, soprattutto così come essa si configura in tarda
epoca greca, sono già presenti i germi dai quali scaturirà la ratio occidentale.
Rispetto alla precedente Weltanschaaung magica, infatti, che presupponeva ancora
la possibilità di agire sulle forze naturali solo rendendosi a loro simili, mediante
mimesi, e che quindi non ancora soggiaceva al desiderio di dominio sulla natura
medesima, il mito si dimostra già potenza “illuministica” nell’atto di personificazione e
nominazione (sotto forma di divinità) degli eventi, che presuppone già sia un
approccio conoscitivo (“Le divinità Olimpiche non sono più direttamente identiche
agli elementi, ma li significano”88), sia la possibilità di intervenire manipolativamente
83 Per nominare solo alcuni lavori in cui il concetto di mito viene trattato da Benjamin indicheremo Per
la critica della violenza, Destino e carattere e il saggio sulle Affinità elettive di Goethe. Ma in generale
anche il testo sul Dramma barocco, così come tutte le riflessioni di Benjamin sulla storia contengono
riflessioni sul concetto di mito.
84 Th. W. Adorno, Profilo di Walter Benjamin, in, Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Torino,
Einaudi, 1972, p. 238.
85 Nel testo appena pubblicato a cura di Stefano Petrucciani che contiene il capitolo
sull’interpretazione ell’Odissea di Adorno così com’era prima dei numerosi tagli subiti prima della
pubblicazione ( Th. W. Adorno, Interpretazione dell’Odissea, Roma, Manifestolibri, 2000), Adorno
riconosce il proprio debito per la concezione dell’affinità tra mito ed illuminismo (o, per meglio dire tra
epos, il momento più maturo del racconto mitico, ed illuminismo) a Borchardt.
86 S. Petrucciani, Ragione e dominio, op. cit., p. 229.
87 W. Benjamin, Angelus novus, tr. it., Torino, Einaudi, 1997, p. 32
88 M. Horkheimer e Th. W. Adorno, La dialettica dell’illuminismo, op. cit., p. 16.
sul reale mediante rapporti con gli dei immortali (i riti sacrificali), che sono già un
primo tentativo di imporre la Herrschaft sulla realtà. Esempio di come il mito si ponga
ad un certo punto come tentativo di “spiegare”il reale, è dato dal racconto mitologico
del ratto di Persefone, teso ad illustrare il movimento dell’incedere delle stagioni e il
manifestarsi di quel fenomeno che appare come l’avvicendarsi di vita e morte nel
mondo naturale: se dapprincipio la credenza popolare riteneva l’evento
costantemente rinnovantesi, si pose più tardi l’avvenimento come episodio
archetipico che costituiva la base del processo ogni volta in atto 89. Ecco che il
racconto mitico non coincide più immediatamente con la realtà, ma da essa si
distacca come rappresentazione simbolica. Esso è già, in nuce, la legge generale
che spiega il singolo accadimento.
Ma caratteristica fondamentale del pensiero illuministico, è la possibilità
intrinseca di costante autocorrezione ed autosuperamento in base ai propri princìpi
di razionalità. È così che ben presto si fanno avanti i primi critici della religione
olimpica, come Senofane, che pur conducendo la sua polemica per ripristinare
l’antica teogonia, fa già uso con molta disinvoltura degli strumenti propri
dell’illuminismo, come l’ironia e la lotta contro l’antropomorfizzazione 90. In seguito,
“con le idee di Platone, anche le divinità patriarcali dell’Olimpo sono investite dal
logos filosofico. Ma nell’eredità platonica ed aristotelica della metafisica, l’illuminismo
riconobbe le antiche forze e perseguitò come superstizione la pretesa di verità degli
universali”91. L’illuminismo presenta sin dal principio una struttura edipica, in quanto
le nuove e più evolute “generazioni” teoretiche distruggono continuamente quelle
che le hanno precedute poichè in quelle riconoscono sempre ancora tracce della
soggezione alla natura, per poi subire a propria volta la medesima sorte. Nel suo
stesso corso, torna dunque a ripetersi la catena mitica, cui soccombono via via i
concetti di sostanza, attributo, e, per ultima, la causalità, evidentemente una
secolarizzazione della diade di colpa e pena. Per assolvere adeguatamente al
compito di trainare l’uomo al di fuori della paura mitica, la ratio illuminista non ha
alcun bisogno di perseguire la verità: ad essa è sufficiente giungere alla costituzione
di un metodo che permetta di istituire la Herrschaft sulla natura e sugli altri uomini.
“L’Illuminismo riconosce a priori, come essere e accadere, solo ciò che si lascia
ridurre ad unità; il suo ideale è il sistema, da cui si lascia dedurre tutto ed ogni
cosa”92. In tal modo il dominio stesso si presenta come il sostrato comune che
caratterizza la cosalità e che si mantiene sempre identico. Esso fonda e costituisce
l’unità della natura, dalla quale sparisce ogni differenza sotto lo sguardo padronale
dell’uomo. Appare evidente, a questo punto, come per Adorno, se è vero che il mito
costituisce già un primo passo verso l’Illuminismo, questo, nel suo sviluppo in ambito
tecnico-scientifico, resti d’altra parte comunque legato al mito. Il problema della
struttura necessariamente astraente della forma sistema, propria dell’illuminismo in
ogni stadio del suo processo evolutivo fino a quello scientifico, è un tema costante
della riflessione di Adorno. Nella Metacritica della gnoseologia, ad esempio, ne
descrive così il meccanismo: il sistema tende a ridurre tutto ciò che deve cadere
sotto di lui all’identità; questo perché esso parte necessariamente da un principio
esplicativo, un primum da cui tutto il resto dovrebbe necessariamente derivare. La
realtà qualitativamente determinata sempre riottosa a lasciarsi inglobare dall’Uno,
dal principio unificante, viene ben presto determinata come molteplicità: essa non è
89 Ivi, p. 35
90 Th. W. Adorno, Interpretazione dell’Odissea, op. cit. , p. 40.
91 Ivi, p. 14.
92 Ivi, p. 15.
ancora identica al Primo, dice Adorno, e tuttavia “ecco che già gli rassomiglia”93. La
numerabilità e la possibilità di una mathesis universalis così come Leibniz l’aveva
sognata, costituiscono semplicemente lo stadio più avanzato raggiunto dalla ratio
occidentale, che era tuttavia già ravvisabile nella trasformazzione delle idee in
numeri nella dottrina dell’ultimo Platone, così come, più tardi, nel precetto
cartesiano, poi ritenuto valido da ogni filosofia che voglia presentarsi come scienza,
che non venga saltato alcun termine medio nel procedere analitico (principio che di
per sé prefigura già la numerabilità)94. “Mercè la metafisica dei numeri viene
compiuta in maniera esemplare l’ipostasi dell’ordine col quale lo spirito tesse intorno
alle cose ridotte in suo potere una rete sempre più fitta, finchè sembra che il tessuto
sia il contenuto stesso che vi è nascosto…Tanto più impenetrabile diventa però il
velo dinanzi allo spirito, quanto più questo, in quanto imperante- come accade nel
numero- assume l’aspetto di una cosa”95. Del resto era stato già lo Hegel della
Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito e poi della Logica a vedere nel
procedere matematizzante (caratteristico dell’intelletto separante) una imposizione
metodica aggiunta dall’esterno, assolutamente incapace di raggiungere il momento
sostanziale della cosa in quanto non si abbandona ad essa ed al suo movimento, e
che ne considera invece solo le determinazioni astratte della grandezza e della
quantità96. Ciò che sfugge sempre alla scienza come sistema allorchè si muove alla
conoscenza dell’individuale, è proprio la particolarità stessa, il quid specifico che fa
della cosa una cosa determinata: la classificazione, la schematizzazione, il processo
ordinativo, rimangono come tali estranei all’oggetto singolo e ciò che riescono a
coglierne è sempre e soltanto ciò che vi hanno già immesso a priori, cosicchè il
sapere viene a configurarsi come una enorme tautologia97. La critica al procedere
illuministico di Adorno vuol muoversi sul principio della negazione determinata, e non
sulla base di un astratto irrazionalismo: ad esso infatti, non si rimproverano tanto il
metodo analitico, la riduzione agli elementi, la riflessione dissolvente, quanto il fatto
che in esso “il processo è deciso in anticipo”98. La riflessione astratto calcolante è
dunque sottoposta a critica non in quanto liquidi la vecchia metafisica ma, al
contrario, perché più metafisica della metafisica stessa; l’ordine che essa viene
erigendo è ancora più astorico ed immutabile di quello della vecchia ontologia: nel
principio che la fonda deve poter rientrare tutta la realtà, in modo che proprio quello
si dimostri, infine, come l’unico autentico reale. Esso fa propria la stessa angoscia
mitica nei confronti dell’ignoto e si pone come principio esplicativo universale. Anche
per questo motivo all’interno del suo movimento, viene a crearsi proprio quel circolo
cieco che costituiva la caratteristica dell’impianto mitico: “Ma quanto più scompare
l’illusione magica, e tanto più spietatamente la ripetizione, sotto il nome di legalità,
fissa l’uomo nel ciclo avendo oggettivato il quale nella legge di natura egli si crede
93 Th. W. Adorno, Sulla metacritica della gnoseologia. Studi su Husserl e le antinomie della
fenomenologia, Milano, Sugar, 1964, p.17.
94 Ivi, p. 18.
95 Ivi, pp. 16-17.
96 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, tr. it., Milano, Rusconi, 1999, pp. 101-103.
97 “La dialettica come critica in atto è avversa costitutivamente alla logica dell’identico, la quale riduce
il sapere a tautologia, provocando così la rimozione continua di ciò che potrebbe metterla in crisi. La
conoscenza che in tale logica trova il proprio fondamento, si riduce a incessante conferma e convalida
del già noto, escludendo da sé quell’alterità il confronto con la quale il pensiero classificatorio è
impegnato ad ogni costo ad eludere”. T. Perlini, Dialettica e utopia, in «Aut-aut», nn.119-120, 1970,
ann. IXX, p. 135.
98 M. Horkheimer e Th. W. Adorno, La dialettica dell’illuminismo, op. cit., p. 32
garantito come libero soggetto. Il principio d’immanenza, la spiegazione di ogni
accadere come ripetizione, che l’illuminismo sostiene contro la fantasia mitica, è
quella stessa del mito. L’arida saggezza per cui non c’è nulla di nuovo sotto il sole,
perché tutte le carte dell’assurdo gioco sono già state giocate, tutti i grandi pensieri
sono già stati pensati, le scoperte possibili si possono costruire a priori, e gli uomini
sono condannati all’autoconservazione per adattamento, quest’arida saggezza non
fa che riprodurre la fantastica che respinge: la ratifica del destino che ripristina
continuamente, per contrappasso, ciò che già era”99. È evidente che tali
considerazioni sulla ipostatizzazione di un concetto apriorico sul reale, sulla sua
ricezione come natura astorica e sovraindividuale, derivino ad Adorno anche dalla
tradizione marxista: era stato lo stesso Marx, nel capitolo sul feticismo delle merci
(proprio nell’ambito di una critica “dell’economia politica”, di una concezione
scientifica del reale, dunque) a mostrare che il momento sociale dello scambio di
merci basato sul valore, doveva apparire a coloro che partecipavano allo scambio
stesso, come momento naturale, così come il valore, prodotto dagli uomini e dal loro
lavoro, doveva apparire come una proprietà degli oggetti stessi. Lukács aveva
chiamato questo momento della reificazione sovrapposto al reale “seconda natura”.
In tal senso, dunque, abbandonarsi ad una concezione del reale come immer
wieder, come ripresentazione del sempre uguale, equivale a dare dell’ordine
esistente una interpretazione ontologica che lascia ben pochi spiragli alla speranza
che l’orrore attuale sia in qualche modo superabile. “Nella pregnanza dell’immagine
mitica, come nella chiarezza della formula scientifica, è proclamata l’eternità di ciò
che è di fatto, e la bruta realtà è proclamata il significato che essa occlude” 100.
Nella necessità di dire ciò che non può essere detto (che, malgrado la formulazione
esoterica, rinvia semplicemente al problema della possibilità del concetto, anch’esso
espressione del principio d’identità e procedente come tale per astrazione, di
cogliere la particolarità, il suo momento più puramente iletico ), Adorno vede il
compito stesso della filosofia: “L’identico, teso ad affermare assolutisticamente se
stesso, rappresenta il trionfo dell’astratto e, di fronte ad esso, l’utopia è tesa a far
valere le umili ragioni della concretezza obliata e nascosta…Ideologia e realtà
tendono a fare tutt’uno, reprimendo ogni impulso che mostri di voler riafferrarsi alla
dimensione soffocata e nascosta della vivente concretezza”101.
Conclusioni.
Nello stilare alcune conclusioni, nella misura in cui ciò è possibile, in base alle
considerazioni sin qui viste, ci avvarremo del testo della Metacritica in cui Adorno
muove alcune critiche fondamentali alla filosofia husserliana. Bisogna tener
presente, tuttavia, che proprio nella monografia del 1956, è assente ogni riferimento
alla Krisis. Per procedere su questa via, dunque, dovremo presupporre la possibilità
di una certa “arbitrarietà” (sempre nell’ambito di una stretta aderenza ai testi e allo
spirito della critica adorniana) che ci permetta di allargare lo spettro delle nostre
osservazioni anche a questo testo.
99 Ivi, p. 20.
100 Ivi, p. 35.
101 T. Perlini, Dialettica e utopia, in «Aut-aut», nn.119-120, 1970, ann. IXX, p. 138.
È impossibile non notare come molte delle argomentazioni analizzate, pur nelle
enormi differenze che caratterizzano i due autori, avvicinino il francofortese allo
spirito della critica husserliana alla ipostatizzazione del procedimento matematicofisicalistico sul mondo-della-vita. Tanto più che lo stesso Adorno a più riprese
riconosce ad Husserl di essere stato uno dei pochi ad essersi reso conto della
sterilità del procedimento astrattivo e di aver tentato con l’intuizione eidetica di uscire
da questa coazione. Certo, l’autore della Dialettica negativa non avrebbe mai potuto
accettare il carattere soggettivo della Lebenswelt husserliana, in quanto ciò che la
sustruzione matematica veniva a coprire era per lui, come abbiamo visto, piuttosto il
lato qualitativo della cosa, il momento imprescindibile della materialità di ogni
momento oggettivo e soggettivo che alla conoscenza di tipo scientifico-matematica è
esclusivamente d’ostacolo. Nella Metacritica della gnoseologia, il francofortese
(riferendosi però alle opere precedenti, come le Ricerche logiche e le Idee) poneva
Husserl sullo stesso piano del procedere positivistico da lui criticato in quanto
anch’egli, nel tentativo di evitare alle proprie categorie ogni tipo di contatto con
l’empiria, con la fatticità, non aveva esitato a procedere ad una idealizzazione delle
stesse (le leggi logiche nei Prolegomeni, le essenze nelle opere successive) e a
giungere infine a quella egoità assoluta che dà senso alle formazioni reali e ne
costituisce il fondamento ultimo. In tal modo essa si dimostra alla stregua di tutta la
filosofia precedente, come prima philosophia, come quella sottoposta al sortilegio
incantatore della ricerca del Primo e della riduzione ad esso di tutto l’esistente. Non
è un caso che la polemica adorniana contro la prima philosophia sia posta proprio al
principio della monografia dedicata ad Husserl. “… il metodo deve sempre arrecare
violenza alla cosa sconosciuta, per amore della cui conoscenza esso unicamente
esiste, deve modellare l’altro secondo se stesso; è la contraddizione primaria nella
costruzione della incontraddittorietà della filosofia prima… Il dominio dello spirito
crede a se stesso soltanto in quanto sconfinato…Il processo di demitolopgizzazione
che percorre lo spirito ricongiungentesi in una seconda mitologia rivela la non-verità
dell’idea stessa di mito”102. In tal senso, la filosofia di Husserl soggiaceva
anch’essa al giudizio che Nietzsche aveva dato di ogni degenerazione del pensiero
a ricerca dell’origine, e che Adorno sembra sottoscrivere in pieno: “L’altra
idiosincrasia dei filosofi” affermava quegli nel Crepuscolo degli idoli “ non è meno
pericolosa: essa consiste nello scambiare l’ultima cosa con la prima. Essi pongono
al principio come principio quel che viene in ultimo… i «concetti sommi», cioè i
concetti più generali e più vuoti, l’ultimo fumo della svaporante realtà. Ciò è ancora
una volta soltanto l’espressione del loro modo di venerare: il superiore non può
crescere dall’inferiore, non può in generale essersi sviluppato… Tutti i valori
superiori sono di primo grado, tutti i concetti sommi, l’essere, l’assoluto, il bene, il
vero, il perfetto- tutto ciò non può essere divenuto, deve quindi essere causa
sui”103. La ricerca dell’origine come immediato indeterminato ed universale, inoltre,
era già stata criticata in modo esemplare, per Adorno, da Hegel al principio della
Logica allorchè cominciava con l’affermare che il concetto di essere assolutamente
indeterminato, proprio in quanto tale, è nulla, si identifica col nulla. Al francofortese
non interessa quale sia l’istanza che viene posta come sostrato ultimo: è impossibile
tanto porre il soggetto come primo, quanto il tentativo di dare statuto ontologico
all’oggettività o al momento della mediazione tra le due istanze: la sola presenza di
102 Th. W. Adorno, Sulla metacritica della gnoseologia. Studi su Husserl e le antinomie della
fenomenologia, op. cit., pp.19-21.
103 F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, tr. it., Milano, Adelphi, 1983, p. 42. A mettere in luce questa
tematica di Nietzsche in modo davvero brillante è un saggio di Foucault: Nietzsche, la genealogia, la
storia, pubblicato in Italia dalla Feltrinelli nell’«Archivio Foucault».
una istanza oggettiva non fagocitabile dalla soggettività assoluta, è sufficiente infatti
a scalzare il soggetto, la cui pretesa è il tutto, dalla sua posizione predominante 104,
mentre porre la mediazione come fondamento significherebbe scambiare “un
concetto di relazione con un concetto di sostanza. La mediatezza non è una
asserzione positiva sull’Essere bensì una direttiva data alla coscienza a non fermarsi
a tale positività”105
Crediamo che, nell’ottica di Adorno, erede della filosofia dell’origine Husserl lo
sarebbe ancora nella Krisis, allorchè vede nel recupero di un senso originario (quello
della filosofia come elemento unificante proprio della grecità e presupposto ancora
nel Rinascimento) il compito della ragione, e in quanto la individua come teleologia
interna della stessa cultura europea. Se in effetti “la Krisis, affrontando il tema della
storia e della storia scientifica dell’uomo europeo, costringerebbe a una maggiore
cautela le critiche rimaste alla interpretazione ‘platonica’ di Husserl” 106, è anche
vero che non si vede a quale tipo di storicità possa aspirare una ricerca che,
rifiutandosi ostinatamente ai fatti (in polemica con un certo storicismo deteriore, è
vero, contro il quale il fenomenologo vuol far valere la sostanzialità della verità, ma
ciò può costituire al limite un’attenuante…) si dedichi alla ricerca di quell’apriori
storico-universale che ne deve costituire internamente l’intero sviluppo. Diventa
palese che proprio il merito di solito riconosciuto alla Krisis, di aver introdotto il tema
della storia nella fenomenologia, diventa illuminante delle grandi difficoltà che essa
incontra in quest’ambito. In realtà pare ravvisabile anche all’interno della posizione
adorniana una certa considerazione in senso teleologico della storia, seppure in
senso negativo. Il processo di progressiva razionalizzazione, basato sul dominio
della natura, non è forse anch’esso un elemento intrinseco al movimento della
storia? Le prefigurazioni che alcuni stadi danno di quelli a venire, non indicano forse
una certa continuità nello sviluppo? E infine, la struttura mitica come matrice comune
ai differenti livelli dello sviluppo della ratio occidentale, non ne costituisce forse il
momento teleologico? In un certo senso potremmo affermare che solo all’interno
della società del dominio è possibile scorgere un movimento di tipo teleologico, che
si concretizza come ripresentazione del sempre uguale, da cui una società giusta
dovrebbe essere risparmiata. All’autore della Dialettica negativa pare congeniale
una interpretazione della storia sul modello di quella benjaminiana, dove il
movimento progressivo appare piuttosto come “un’unica catastrofe, che ammassa
incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi”107.
La strada dell’intuizione, inoltre, così come Husserl l’aveva intesa, non doveva
apparire ad Adorno percorribile. Pur accomunando talvolta Husserl a Bergson (e
sottolineando l’ironia di tale accostamento, in quanto il filosofo francese poteva
essere proprio uno di quei filosofi della Weltanschaaung contro cui il fenomenologo
aveva spesso polemizzato), come abbiamo visto autori che, avendo avvertito
l’insufficienza euristica della forma concettuale, ne avevano tentato l’aggiramento
mediante il ricorso all’intuizione, Adorno considera in modo differente i due approcci:
“Il tentativo husserliano di abbattere con la meditazione filosofica la tirannide della
reificazione” scrive infatti nella Metakritik “e di «avere a portata di mano», come
amavano dire i fenomenologi, le «cose stesse» in una «visione originalmente
offerente» rimane, contrariamente a quello che accade in Bergson, d’accordo con la
104 Th. W. Adorno, Dialettica negativa, Torino, Einaudi, 1970, pp. 157 e sg.
105 Th. W. Adorno, Sulla metacritica della gnoseologia. Studi su Husserl e le antinomie della
fenomenologia, op. cit., p. 32.
106 A.Guerra, La Krisis di E. Husserl, in «De Homine», I, 1962, n.23, p. 183.
107 W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino, 1997, p.37.
scienza nel suo intento”108. Questo perché Husserl cercava nell’intuizione, non una
via di fuga irrazionale, bensì un mezzo che portasse ad una chiarezza ostensiva,
visiva l’oggetto dell’esperienza di cui andava occupandosi, alla stregua del concetto
di datità dei positivisti, che Adorno considerava per parte sua tutt’altro che pacifico.
Non che il francofortese voglia eliminare del tutto per parte sua la possibilità delle
intuizioni: il loro infrangere con repentinità la catena delle deduzioni, ricorda anzi al
pensiero ciò che nel procedere sistematico va irrimediabilmente perduto; e tuttavia
“non costituiscono quegli atti una fonte assoluta della conoscenza, separata dal
pensiero discorsivo da un abisso ontologico”109, e quindi non è possibile
ipostatizzarli come fonti autonome di conoscenza. Inoltre il tentativo di approdare ad
un immediato conoscibile senza utilizzare il mezzo del concetto (in modo critico,
ovviamente, in quanto il concetto come tale, strumento della logica tradizionale,
sottostà anch’esso alla coazione all’identità) doveva apparire ad Adorno un modo di
affrancarsi dall’Arbeit des Begriffs di hegeliana memoria. Occorreva operare con il
concetto nella consapevolezza della sua inadeguatezza a rappresentare la cosa
nelle sue differenti determinazioni, dunque facendolo giocare dialetticamente con
essa.
Per parte sua, Husserl avrebbe sottoscritto, come abbiamo visto, la critica che
Adorno muove al procedere matematico come puro momento tecnico, non
consapevole di se stesso e quasi incapace di comprendersi. Tuttavia il padre della
fenomenologia appare piuttosto restio a mettere in discussione la metodologia
matematica e la correttezza del suo procedimento (Adorno afferma nella Metakritik
che anzi il suo modello della conoscenza resta ancorato strettamente a quello
scientifico-matematico). Non per nulla egli aveva cercato spesso di assimilare gli
Erlebnisse di coscienza a datità ultime così come le concepiscono le scienze
positive e le operazioni della fenomenologia ad un puro stare-a-guardare (non
dimentichiamo che ancora nelle Idee faceva vanto di essere più positivista dei
positivisti stessi, i quali possedevano una concezione troppo ristretta proprio del
concetto di datità). In tal modo egli si poneva, secondo Adorno, nella schiera di
coloro che consideravano la verità come un concetto residuale (nel senso in cui
Hegel l’aveva stigmatizzata nella sua Fenomenologia dello spirito), quella cioè che la
identificava con il risultato del processo razionale, dopo avervi sottratto tutto ciò che
la ragione soggettiva vi aveva immesso: per Adorno, che possedeva invece una
concezione dialettica della verità, come costellazione tra i poli di soggettività ed
oggettività, quella non poteva che essere un impoverimento.
A questo punto, ci sembra inutile insistere ancora sulle differenze tra i due, che
vi sono e, date le formazioni culturali così eterogenee, non possono che essere
assolutamente profonde. Allo stesso tempo, però, non possiamo chiudere gli occhi
di fronte alle affinità che nel corso dell’esposizione mi pare siano apparse piuttosto
evidenti nell’ambito di una comune critica al procedere scientifico e alla sua
razionalità in genere. Può sembrare stupefacente, ad esempio, che, dall’interno del
proprio procedimento, Husserl si ponga in una prospettiva molto simile a quella di
Adorno per quel che riguarda la rivalutazione dell’aspetto qualitativo della realtà
rispetto a quello puramente quantitativo, che costituiva l’interesse esclusivo delle
scienze matematiche. Egli sembra anzi porsi agli antipodi di Hume che aveva
decretato l’eguale inconsistenza sia delle qualità primarie che delle qualità
secondarie: grazie all’analisi degli atti intenzionali, esse acquisivano pari dignità.
108 Th. W. Adorno, Sulla metacritica della gnoseologia. Studi su Husserl e le antinomie della
fenomenologia, op. cit., p. 56.
109 Ivi, p. 54.
Questo perché, una volta raggiunto il tanto vagheggiato mondo-della-vita si vengono
a trovare posti sull’identico “piano d’immanenza” (per dirla alla Deleuze), sia la prassi
pre-scientifica e soggettivamente orientata della percezione quotidiana, con tutta la
sua molteplicità ed asistematicità, sia le teorie scientifiche, con tutto il loro apparato
obiettivo ele sue oggetività ideali. Allo stesso modo, Husserl perviene alla critica
della metodologia delle scienze matematiche che, privata del suo riferimento al
senso, diviene autoreferenziale e si risolve per lo più in un vuoto gioco di simboli
privi di referenza. “Agiscono ora soltanto quei modi di pensiero e quelle tecniche che
sono indispensabili ad una tecnica come tale. Si opera con lettere dell’alfabeto, con
segni di collegamento e di relazione (+, , =, ecc.) e secondo le regole del giuoco
della loro coordinazione; si procede in realtà in un modo che non è sostanzialmente
diverso da quello del giuoco delle carte o degli scacchi. Il pensiero originario, che
conferisce propriamente un senso a questo procedimento tecnico e una verità ai
risultati ottenuti…è qui escluso”110. Ancora nell’ambito dell’analisi del metodo, il
padre della fenomenologia sembra attestarsi se non sulla soglia di una critica
esplicita, per lo meno sulla chiara consapevolezza del carattere necessariamente
astraente del procedimento, che per parte sua si ferma alle strutture generali senza
mai poter cogliere la singolarità111.Ma soprattutto, con la critica della
ipostatizzazione della obiettività del mondo della natura, Husserl sembra giungere in
modo del tutto peculiare alle soglie di una critica all’ideologia in un senso molto
vicino a quello adorniano: non tanto di mero inganno, quanto di illusione pienamente
funzionale: “L’abito ideale che si chiama «matematica e scienza naturale
matematica», oppure l’abito simbolico delle teorie simbolico matematiche abbraccia,
riveste, tutto ciò che per gli scienziati e per le persone colte, in quanto «natura
obiettivamente reale e vera», rappresenta il mondo-della-vita. L’abito ideale fa sì che
noi prendiamo per il vero essere quello che invece è soltanto un metodo, un metodo
che deve servire a migliorare mediante «previsioni scientifiche» in un «progressus in
infinitum», le previsioni grezze, le uniche possibili nell’ambito di ciò che è realmente
esperito ed esperibile nel mondo-della-vita; l’abito ideale potè far sì che il senso
proprio del metodo, delle formule, delle teorie, rimanesse incomprensibile e che
durante l’elaborazione ingenua del metodo non venisse mai compreso. Così non si
presentò mai alla coscienza nemmeno il problema radicale…di come potesse
sorgere un metodo effettivamente orientato verso un fine, quello dell’adempimento
sistematico di un compito scientifico infinito, un metodo che indubbiamente continua
a maturare sicuri risultati…”112. Non tanto le incontrovertibili congruenze che
avvicinano i due autori su queste tematiche, sono stupefacenti, quanto il fatto che lo
stesso Adorno non abbia riconosciuto nello Husserl di queste pagine della Krisis un
valido alleato nella sua critica alla conoscenza di tipo scientifico.
110 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, op. cit., p. 75.
111 Si legge ancora a p. 70: “L’intero metodo ha fin dall’inizio, infatti un senso generale per quanto
abbia sempre a che fare con qualcosa di individuale fattuale. Per es. fin dall’inizio il metodo non mira
al particolare caso di questo corpo; il fattuale individuale è soltanto un esempio nella concreta tipologia
complessiva della natura intuitiva…”.
112 Ivi, pp. 80-81.
Relazione sul gioco tra simbolo e mondo della vita
nella Crisi di Husserl
di Marco Maria Sponga
Nel saggio del professore Iofrida la corrente filosofica presa in considerazione
elude il soggetto e la storia ricorrendo all'opposizione tra senso e non-senso come
motrice del divenire. Questo "gioco del mondo" (per riprendere il Derrida della
Grammatologia) scivola attraverso il soggetto rendendolo funzione del caso, del
coup de dés. Una struttura aleatoria cui non si può attribuire alcuna responsabilità.
Una struttura aleatoria perché infondata (insensata), ma pur sempre una struttura
nel senso tradizionale, moderno, simbolico-matematico, anche se sempre
minacciata dalla possibilità del random. Tale struttura, per quanto di discendenza
fenomenologica, pone come sinonimi senso e significato relegando al non-senso il
vuoto di significazione aperto dalla crisi.
Questa corrente post-strutturalista, che qui esemplifico con la decostruzione,
trova, appunto, una delle sue radici nella fenomenologia di Husserl, da cui mutua il
proprio concetto di struttura, concetto che si forma a partire dall'intenzionalità, dalla
relazione tra soggetto e oggetto. Tuttavia non coglie la nuova razionalità richiesta
dall'opera del 1935. Tale razionalità non coincide con strutture logico-simboliche, ma
con il lavoro di ricerca di senso di tali strutture di significazione (e sottolineo qui il
fatto che si tratta di un'azione, poiché il testo husserliano per quanto continui a
portare come ideale una definizione sistematica delle strutture a-priori del mondo,
non può che affidarsi, per sua stessa ammissione all'azione, nel suo particolare
caso, all'agire filosofico). Per la decostruzione la struttura, la razionalità trova il
proprio modello nel fungere simbolico, nella significazione, nella struttura di
linguaggio. In tal modo mantiene il senso all’interno del significato, oscurando il
rovesciamento operato da Husserl nella Crisi.
Nel decorso dell'opera husserliana la struttura stessa dell'intenzionalità subisce
delle modificazioni seguendo la differenziazione tra significato e senso, passando
dall'indifferenza della Prima ricerca, al gioco di specchi di Idee, per giungere nella
Crisi a una nuova impostazione della relazione. Tralasciare il fatto che vi sia una
relazione, che il senso non è interno alla significazione, ma un polo, relega al nonsenso tutto ciò non ha una propria significazione logica, tutto ciò che non è
logicamente articolato. Relega il mondo al silenzio; mentre l'ultima fenomenologia
pone come senso questo mondo costituito da «un'atmosfera di validità mute».
Le mie considerazioni si limiteranno a La crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale. L'opera in cui la differenza tra significato e senso
sfocia in una crisi simile, per alcuni aspetti, alla nostra attuale. Crisi aperta da una
globalizzazione della cultura europea (nel nostro caso occidentale) che si affida ad
un procedere tecnico, ossia, meramente simbolico (dato nel significare senza
riempimento), di sistemi che poggiano semplicemente su criteri interni, sulle regole
del gioco: siano essi la matematica o l'economia di mercato. Crisi, appunto, che
prende forma nel vuoto di senso di un procedere meramente tecnico, regolato dal
gioco dei simboli, nell'oblio dell'intervento da parte di un soggetto che agisce, capace
di prendere su di sé la responsabilità del senso che si intravede nella storia. Infatti è
in un'analisi genealogica che si potrà recuperare il senso dei simboli. Tuttavia, tale
analisi richiede una decisione: il conferimento teleologico di un fine, di un senso alla
storia. Lo scopo che porrà Husserl sarà una ricerca infinita dei termini, degli
orizzonti. Questa infinità non è un Assoluto insensato, ma il compito infinito di
riempire di senso le strutture di significato (le strutture tecnico-simboliche). La logica
qui richiede senso non lo dà: è essa che cerca una fondazione, non il mondo.
L'unico luogo di senso nella Crisi è il mondo. Mondo che si recupera solo
passando per il soggetto e la storia. Questo passaggio richiederà una nuova forma
di struttura, una nuova razionalità. Razionalità nuova rispetto all'obiettivismo
moderno. E' in questo pensiero che Husserl trova l'origine della crisi. Galileo, che lo
fonda, perde di vista il senso: perde di vista il mondo della prassi da cui ha origine la
sua ipotesi rivoluzionaria: quella che pone il mondo come pienamente descrivibile
dal linguaggio matematico-simbolico. In questa ipotesi il mondo è interamente
esteso e causale, non vi è alcun luogo per la soggettività se non in un parallelo con
la struttura matematica della natura, il che porta all'inevitabile dualismo sviluppato
dalla filosofia cartesiana. L'obiettivismo moderno sostituisce all'essere del mondo
una sostruzione logica (quella logico-matematica) e pone i propri assiomi come
fondamento del reale. Il tentativo di Husserl, nell'opera presa in considerazione, è di
tornare al mondo al di là della verità ad esso sovrapposta dai moderni, dimostrando
che l'origine del pensiero matematico sta nella storia. Storia che ha il suo senso nel
divenire del mondo.
Come si può recuperare questo senso?
La via di Husserl passa attraverso una serie di epoché. La prima sarà la
sospensione delle validità obbiettive, del mondo esteso oggettuale descrivibile col
linguaggio matematico. Poi dello stesso mondo-della-vita coi suoi fini pratici per
isolare un soggetto che contiene in sé il mondo. Tuttavia questo soggetto nel
paradosso del corpo proprio troverà un mondo che ad esso si oppone, un mondo in
cui si manifestano altri corpi-propri, altri io-mondo da esso diversi, non solo
esternamente a sé, ma internamente alla propria struttura temporale e internamente
alla propria costituzione come concrezione di un io trascendentale. L'uscita dalla
contraddizione è intravista nell'entropatia, l'analogia che fa degli altri altri soggetti.
Con l'epoché delle entropatie, col renderle tematiche, il soggetto va oltre sé per
recuperare il mondo come correlato della comunità dei viventi. Comunità nella storia,
nella temporalizzazione dell'io trascendentale, nel divenire: il che rende la sua
descrizione o meglio la sua comprensione un compito infinito. E in tale compito il
filosofo assume la sua responsabilità storica. L'assunzione di responsabilità,
l'affermazione del soggetto in quanto soggetto, sta nel tentativo di risoluzione della
crisi: nel portare la significazione al senso.
La crisi
Soffermiamoci a considerare in cosa consiste questa crisi; al paragrafo
secondo leggiamo: «L'esclusività con cui, nella seconda metà del XIX secolo, la
visione del mondo complessiva dell'uomo moderno accettò di venir determinata dalle
scienze positive e con cui si lasciò abbagliare dalla "prosperity" che ne derivava,
significò un allontanamento da quei problemi che sono decisivi per un'umanità
autentica. Le mere scienze di fatto creano meri uomini di fatto» (Die Krisis der
europäiscen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Martin
Nijhoff’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, L’Aia 1959, trad. It. di Enrico
Filippini La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, il
Saggiatore, Milano, 1961, p. 35 – ora in poi questo testo verrà indicato con “K”). La
crisi consiste in quest'esclusività, nel dominio di un'unica visione del mondo, di un
ipotesi (nella "Crisi" una visione univoca, monodirezionale, non data in un intreccio di
prospettive, non può che essere un'ipotesi). L'ipotesi moderna da cui avrà origine la
crisi esclude il significato della scienza per l'esistenza umana, la allontana dai
problemi decisivi: «i problemi del senso e del non-senso dell'esistenza umana nel
suo complesso [...], essi concernono l'uomo nel suo comportamento di fronte al
mondo circostante umano ed extra-umano, l'uomo che deve liberamente scegliere,
l'uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda»
(K p. 35-36). Il soggetto è tale solo in virtù della capacità di plasmare sé e il mondo,
di agire sul mondo agendo su di sé, un sé che si costituisce solo nel suo intreccio col
mondo. La scienza, adagiata nel progresso tecnico, che è anche "prosperity", ossia
sviluppo economico, elude la domanda "su noi uomini in quanto soggetti di questa
libertà" (K p.36). Il "mero uomo di fatto" esiste insensatamente come elemento di
una storia che si forma e si dissolve «come onde fuggenti»(K p.36). Nella
prospettiva positivista contro cui si scaglia Husserl L'uomo non è se non una
propaggine parallela della res extensa. Egli si comporta come le cose, e come cosa
è interno allo spazio-tempo matematico e alla legge causale della fisica; quindi privo
di libertà: assolto dalla responsabilità. Responsabilità che si può recuperare solo
attraverso una teleologia.
Palare di "telos", di "fine" e di "ragione" della storia ci porta a caminare sulle
funi, di ragionare ai limiti, sempre a rischio di cadere in un assolutismo teoretico che
ne giustifica uno politico. Infatti questo limite lo si percepisce nel sesto paragrafo,
dove il telos della storia si identifica con l'entelechia greca, con l'umanità europea. Il
porre il nostro concetto di "umanità", come concetto in cui si debba identificare ogni
altra umanità non ha alcuna giustificazione. Tuttavia, ciò non rende il pensiero
occidentale «una mera follia storico-fattuale, un conseguimento casuale di
un'umanità casuale in mezzo ad altre umanità e ad altre storicità completamente
diverse»: l'obiettivismo moderno, generato nel logos, internamente alla ragione
greca, è oggi il pensiero dominante, globalista, se non ancora globale, e ciò che
Husserl gli ha imposto con la "Crisi" nel 1935 e di indagare la propria storia alla
ricerca dell'origine, di un senso in base al quale possa porsi come responsabile.
Il risvolto teoretico della crisi si può inserire come tematica della relazione tra
senso e significato. Come detto sopra, nell'arco dell'opera husserliana il rapporto tra
questi due termini muta. Nel 1901, nella Prima ricerca logica, Husserl usa
indifferentemente questi due termini. Nel 1913, al paragrafo 126 di Ideen, opera la
distinzione: Il termine "senso" è riservato all'intera sfera noetico noematico, il termine
"significato", che si origina nel linguaggio, è riservato al «medium intenzionale», al
«medium logico»; per mezzo di esso si esprime, si articola formalmente il senso; con
quest'ultimo, invece, Husserl indica l'intera sfera noetico-noematica, ad esclusione di
quella espressiva. Lo strato del senso viene esemplificato dalla percezione che
questo è bianco senza che "questo è bianco" sia pensato; è una «pura percezione»
e, in quanto tale, pre-espressiva. Questo senso costituisce il sottostrato fondante
che la significazione è portata ad articolare; per mezzo di quest'articolazione si
ottiene la «chiarificazione», ossia, «l'elemento vitale della scienza». Nel 1935 il
rapporto tra i due termini muta ancora. Il significato rimane linguistico, simbolico,
logico, scientifico; mentre il senso viene a trovarsi nella Lebenswelt, nel mondodella-vita, nel mondo quotidiano della prassi. La crisi è proprio la frattura alienante
che tra i due si instaura, seguita dal dominio di un significato, di un procedere
simbolico-tecnico che ha perso senso proprio nel suo istituirsi come dominante. Il
problema che pone Husserl al paragrafo 34f è di rovesciare questo dominio: «esso
[il problema] si presenta dapprima come il rapporto tra pensiero scientifico-obiettivo
e intuizione; abbiamo cioè, da un lato, il pensiero logico in quanto pensiero attorno ai
problemi logici [...]. Dall'altro lato abbiamo un intuire e un intuito che rientrano nel
mondo della vita prima di qualsiasi teoria. Proprio qui sorge l'apparenza di un
pensiero puro il quale, indifferente, in quanto puro, all'intuizione, ha già una propria
verità evidente, addirittura una verità del tipo di quella propria del mondo» (K p.163).
La crisi è, appunto, questo arrogarsi la verità propria del mondo da parte di una
verità parziale, interna ad un sistema. Per Husserl i nostri matematici e fisici
matematici si muovono «nella dimensione di una simbologia remota dall'intuizione»
(K p. 53). Simbologia che per mezzo dell'ipotesi galileiana sovrappone alla verità del
mondo la propria.
Per indagare la crisi stabiliamo intanto i due termini del problema: significato e
senso.
Il significato
Veniamo al sorgere del pensiero puro che porta con sé questa verità. Esso al
§9a si delinea sulla base di una «prassi di perfezionamento» in forme-limite. Le cose
del mondo intuitivo non hanno di per sé un'identità a sé, «sono immerse in generale
nelle oscillazioni della mera tipicità», la loro «permanenza nell'uguaglianza» è
«temporanea», «approssimativa». Solo in base al soddisfacimento di uno «speciale
interesse pratico» esse vanno verso una perfezione. «Ma nella vicenda degli
interessi ciò che per un interesse è soddisfacente non lo è per altri, il che pone un
limite alla facoltà di perfezionamento tecnico» (K p. 55). La limitazione
all'idealizzazione sta nell'interesse in quanto prassi; se ci eleviamo al di sopra del
mondo diamo un orizzonte infinito all'astrazione, eludiamo i limiti: infatti: «è però
possibile - ed è stata questa la scoperta da cui è nata la geometria - costruire grazie
ad esse [le forme-limite incarnate], che sono generalmente disponibili, forme
elementari privilegiate e non soltanto, mediante operazioni attuabili con esse,
sempre nuove forme univocamente e intersoggettivamente determinate grazie al
metodo che le genera» (K p. 56-57). Per istituire il regno dell'ideale, empiricamente
illimitato, basta avere un metodo capace di generare simboli dai simboli, capace di
dare autonomia al linguaggio logico. «Attraverso il metodo dell'idealizzazione e della
costruzione che storicamente è stato già da tempo elaborato e che va praticato
nell'accomunamento intersoggettivo, esse sono diventate prodotti abituali e
disponibili mediante i quali è sempre possibile elaborare qualcosa di nuovo: il campo
di lavoro di un mondo, infinito e tuttavia in sé concluso, di oggettualità ideali»
[sottolineature mie] (K p. 56-57). Pur dato storicamente e praticato
nell'intersoggettività di una comunità vivente, l'idealizzazione porta ad un mondo in
sé concluso, avente in sé il proprio criterio. Non si opera più con cose del mondo,
ma con costruzioni ideali, con significati che non abbisognano di alcun interesse
pratico, di alcun soddisfacimento per poter funzionare, perché possono adempiere la
sola funzione di rimando simbolico: «come tutti i prodotti culturali nati dal lavoro
umano, esse rimangono obiettivamente conoscibili e disponibili anche senza che la
formazione del loro senso debba venir esplicitamente rinnovata» (K p. 56). Tuttavia,
continuano ad esigere una presenza nel mondo: è infatti «in base ad
un'incarnazione sensibile, per es. attraverso la lingua e la scrittura, [che] esse
vengono colte appercettivamente e trattate operativamente» (K p.56). E' ciò che si
coglie appercettivamente, per mezzo del segno, ossia l'operazione, che interessa
qui. Ed è a questo punto che Husserl sottolinea l'analogia tra il significato ed altri
oggetti culturali quali le tenaglie, i trapani ecc. appunto per mettere in luce che vi è,
ed è intrinseco, un uso puramente strumentale del linguaggio, che anzi, tale uso ne
è all'origine. Però il fatto che le «forme sensibilmente intuitive» a cui si applica il
significato siano «arbitrariamente isolate» allontana maggiormente la necessità di
rinnovamento di senso per il segno, rispetto ad oggetti culturali, quali per es. le
tenaglie, portandolo verso la semplice (e pura) funzione di rimando interno, verso la
formula che porta in sé il rischio dell'obliterazione del senso, del mondo-della-vita.
«Sotto questa forma di prodotti da sempre noti, nella prassi metodica dei
matematici, funzionano i significati che, per così dire, sono sedimentati nelle loro
incarnazioni» (K p. 56).
Il primo passo storico verso l'idealizzazione, verso la produzione del significato
come oggettualità con cui poter operare, per Husserl, è costituito dall'intuizione
geometrica che trova la propria origine nella pratica dell'agrimensura. Uno ulteriore
verrà compiuto dall'applicazione delle designazioni algebriche alla geometria dando
luogo all'analisi pura. La geometria, col suo riferimento spaziale manteneva ancora
un nesso col mondo reale, mentre nell'analisi il riferimento spaziale è mediato da
quantità numeriche, spostando ancora più in là il limite. «Questa aritmetizzazione
della geometria porta da sé, in certo modo a uno svuotamento del suo senso» (K §9f
p. 73). Ora il matematico può procedere semplicemente con delle formule, con
proposizioni simboliche da cui ne deduce direttamente delle altre, senza dover
passare per la realtà, procedendo «con un senso "simbolico"». Tale
aritmetizzazione, attraverso Leibniz colpirà la stessa logica. A questo punto la logica
può chiudersi in sé e ragionare semplicemente su di sé, sicura di giungere a risultati
certi secondo i propri criteri. Tuttavia l'aritmetizzazione venendosi a sviluppare in
un'epoca dominata dall'ipotesi gallileiana della descrivibilità del mondo per mezzo
del linguaggio matematico, porterà a credere che basti descrivere tale linguaggio
(che ora è anche il linguaggio della logica) per avere una metodica descrittiva
generale, una logica del mondo. Al §9g leggiamo: «Come già era avvenuto
nell'aritmetica, elaborando la sua metodica secondo regole d'arte, essa subisce
un'evoluzione attraverso la quale diventa addirittura un'arte; diventa cioè l'arte di
giungere, attraverso una tecnica del calcolo e secondo regole tecniche, a certi
risultati, il cui reale senso di verità può essere attinto soltanto da un pensiero cosaleintellettivo (sachlich-einsichtig) che si eserciti veramente sui suoi temi stessi.
Agiscono ora soltanto quei modi di pensiero e quelle tecniche che sono
indispensabili a una tecnica come tale. Si opera con lettere dell'alfabeto, con segni
di collegamento e di relazione (+, x, =, ecc.) e secondo le regole del gioco della loro
coordinazione; si procede in realtà in un modo che non è sostanzialmente diverso da
quello del gioco delle carte o degli scacchi. Il pensiero originario, che conferisce
propriamente un senso a questo procedimento tecnico e una verità ai risultati
ottenuti conformemente alla regola [...], è qui escluso» (K p. 75). Segno e regole,
simbolo e sistema... ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale...
arbitrario... irresponsabile, poiché il riferimento è interno al gioco simbolico. Tale è il
cammino della tecnicizzazione, dell'autonomia del significato: l'operare di formule
non indagate nella loro origine pratica in un tradizionalismo storicamente
incosciente.
Nel momento in cui scindiamo il significato dal senso, nel momento in cui lo
rendiamo autonomo, le formule assumono il senso da sé. «Il senso delle formule sta
nell'idealità, mentre tutto il faticoso processo di ricerca che porta ad esse ha soltanto
il carattere di mezzo verso un fine», dove questo fine è il dare vita ad altre formule.
Tale tipo di pensiero adotta «concetti trasformati nel loro senso», «concetti
simbolici», opera una meccanizzazione che occulta il senso proprio, reale in quanto
pratico, e si svolge in un «orizzonte di senso trasformato», ossia trasforma, trasfigura
il mondo. Infatti al §9h si parla di una «sovrapposizione del mondo
matematicamente sustruito delle idealità all'unico mondo reale» (K p. 77). Il mondo
viene investito di un abito ideale e «l'abito ideale che si chiama "matematica e
scienza naturale matematica", oppure l'abito simbolico delle teorie simbolicomatematiche, abbraccia, riveste tutto ciò che per gli scienziati e per le persone colte,
in quanto "natura obiettivamente reale e vera", rappresenta il mondo-della-vita.
L'abito ideale fa sì che noi prendiamo per il vero essere quello che invece è soltanto
un metodo» (K p. 80). Qui l’immagine del mondo segue i dettami di un unico metodo
descrittivo, che in quanto metodo è atto a certi scopi, scopi che trovano
soddisfazione solo nella prassi. Tuttavia tale metodo è stato ritenuto capace di dare
una descrizione totale al reale, obliando il fatto che ebbe origine nella prassi, e che
solo qui assume il proprio senso. Il pensiero scientifico, come qualsiasi forma di
pensiero, ha come propria base delle credenze, «certe ovvietà, per es. la certezza
che il mondo è, che è già sempre preliminarmente, e che qualsiasi rettifica di
opinione, [...], presuppone sempre il mondo in quanto orizzonte di ciò che senza
dubbio è e vale, o, compresa in questo mondo, una compagine di dati noti e
indubbiamente certi con cui ciò che eventualmente è stato svalutato e ritenuto
irrilevante era entrato in contraddizione [...] essa, come qualsiasi prassi presuppone
il suo essere». Il metodo simbolico delle scienze moderne come descrizione dei
significati del mondo lo aveva posto come proprio problema parziale: come campo
da descrivere. La Crisi mette a nudo il fatto che su tale campo essa si base e ivi
rientra in quanto prassi particolare.
Il Senso
Il procedere di qualunque scienziato dà come scontate, come ovvie una lunga
serie di credenze sulle quali basa le sue teorie e in cui successivamente le verifica.
Tuttavia, gli strumenti con cui opera, le idealità, rientrano esse stesse, a loro modo,
nel mondo; vi rientrano come un particolare tipo di prassi: come prassi teoretica. «Le
loro teorie, le formulazioni logiche, non sono naturalmente cose del mondo-della-vita
nel senso in cui lo sono i sassi, le cose, gli alberi. Sono totalità logiche e parti logiche
costituite da elementi logici ultimi. Per parlare con Bolzano: sono "rappresentazioni
in sé", "proposizioni in sé", conclusioni e dimostrazioni "in sé", unità ideali di
significato [...] Ma anche questa idealità, come qualsiasi altra, non muta nulla al fatto
che sono formazioni umane connesse per essenza alle attualità e alle potenzialità
umane, e che quindi rientrano nella concreta unità del mondo-della-vita, la cui
concrezione dunque ha una portata maggiore di quella delle "cose"» ( K §34e p.
158). Questo loro rientrare in quanto oggettualità «costituite attraverso un
progressivo strutturarsi di attività» le pone come elemento del mondo, ad esso
interne. Le idealità obiettive si pongono come parte del mondo, come parte di ciò
che c'è da descrivere e sono da descrivere in quanto elementi di un progetto pratico.
Non costituiscono la totalità descrittiva del mondo, ma una parte di esso che va a
sua volta descritta.
Queste formazioni del mondo danno vita comunque a «qualcosa di nuovo e di
diverso», ai significati, che trovano un loro uso nella concretezza, ma che non
possiedono a differenza delle altre cose del mondo alcuna esperibilità. «Il contrasto
tra l'elemento soggettivo del mondo-della-vita e del mondo "obiettivo" e "vero" sta
semplicemente in questo: che quest'ultimo è una sustruzione teoretico-logica, la
sustruzione di qualche cosa che di principio non è percettibile, di principio non
esperibile nel suo essere proprio, mentre l'elemento soggettivo del mondo-della-vita
si distingue ovunque e in qualsiasi cosa proprio per la sua esperibilità. Il mondo della
vita è un regno di evidenze originarie [...] Qualsiasi verifica pensabile riconduce a
questi modi dell'evidenza, perché l' "esso stesso" (dei singoli modi) sta in queste
intuizioni come un elemento realmente esperibile e verificabile in modo
intersoggettivo, e non è una sustruzione concettuale; mentre d'altra parte, qualsiasi
sustruzione concettuale, almeno in quanto pretende di essere vera, può attingere la
sua reale verità soltanto riportandosi a queste evidenze» (K §34d p. 156).
Nel mondo abbiamo a che fare con delle datità che si esperiscono in modo
soggettivo-relativo e che, tuttavia, costituiscono i criteri di verificazione dell’obiettività.
Una tale affermazione pare paradossale.
Per superare tale paradosso dobbiamo tornare al paragrafo 9a dove si descrive
l'origine della geometria pura, i primi passi, secondo Husserl, della società
occidentale verso l'idealizzazione. Essa «rimanda alla metodica esercitata già nel
mondo circostante pre-scientifico-intuitivo» (K p. 57), ossia alla misurazione. Nel
mondo le «formazioni sensibilmente esperibili [...] si connettono continuamente. In
questa continuità essi riempiono la spazio-temporalità (sensibilmente intuitiva) che è
la loro forma» (k p. 57). Tale forma è «priva di obiettività, perciò non è determinabile
intersoggettivamente da chiunque [...] né comunicabile» (K p. 57). L'esperienza
direttamente intuita non è comunicabile, non esiste intersoggettivamente. Per poterla
portare a tale esistenza ci vuole una prassi, condivisa o condivisibile. Ciò che per
Husserl portò lo spazio occidentale all'intersoggettività fu la misurazione: «La
misurazione scopre praticamente la possibilità di scegliere come misura certe forme
fondamentali empiriche [...] e, mediante i rapporti [...] tra queste misure ed altre
forme corporee, cerca di determinare intersoggettivamente e in modo praticamente
univoco queste forme» (K p. 57). Ciò che si vuole sottolineare qui è il fatto che ciò
che rende lo spazio determinabile è una prassi della comunità. Tale intersoggettività
non è una sustruzione ma un mezzo dell'attività umana. La «mera sensibilità»
incomunicabile non coglie gli «oggetti dell'esperienza», v'è dietro «un'operazione
spirituale» (cfr. K §25). Quando Husserl parla di fenomeni soggettivi (l'esperienza è
essenzialmente privata: una mia esperienza non può essere tua) non parla dei
processi psicofisici dei dati sensibili. La soggettività che interessa alla fenomenologia
è una «operazione spirituale» la cui funzione e di «costituire forme di senso» (K
§29); non si parla qui di significati, ma di pratiche, di usi iterabili che sanciscono la
materia su cui si sedimentano quale oggetto di esperienza. Si tratta sempre di una
mia esperienza (non a caso l'epoché all'ego primordiale, solipsista riveste una
grossa rilevanza fenomenologica), ma il mondo dell'esperienza è «comune a tutti»
(K §34b). Vi è un unico mondo che noi tutti percepiamo, per quanto possano variare
i modi di esperienza.
Nell'unico mondo, tuttavia, v'è un duplice fungere dell'intelletto: da un lato esso
si esplica in un'auto-considerazione, in una riflessione su di sé; dall'altro v'è un
intelletto che «agisce nascostamente, in quanto intelletto costitutivo di quella forma
di senso (Sinngestalt) che è già sempre divenuta e che, nella sua costante mobilità,
continua a divenire, e che è "il mondo circostante intuitivo"» (K §28 p. 133). Il mondo
intuitivo agisce come sfondo, come ovvietà presupposta, come già-dato. Questo già
dato è il campo delle esperienze possibili, il campo di ciò che si può esperire e su
tale campo, internamente al mondo, si esercita l'intelletto della riflessione,
dell'idealizzazione. Dal sorgere della misurazione, dall'avvento di una prassi umana
comune, tale intelletto è una parte costituiva del mondo, vi rientra. «Nei termini del
mondo-della-vita: noi siamo oggetti tra gli oggetti». D'altra parte siamo soggetti in
quanto le esperienze non possono che essere esperite da un soggetto. La via
d'uscita per Husserl sta nella riflessione del soggetto su di sé, ma su sé in quanto
luogo dei modi di datità del mondo, in altre parole nella riflessione fenomenologica.
Nella Crisi l'insieme dei modi di datità coincide con il campo dell'esperibile, ossia col
mondo. E tale campo si può descrivere solo guardando alle attività svolte dal
soggetto.
Corrispettivamente al doppio fungere dell'intelletto vi sono due modi di
tematizzare il mondo, ossia di considerare il mondo quale datità soggettiva. Da un
lato «la vita normale» diretta sugli oggetti e che mantiene come sfondo l'orizzonte
del mondo; dall'altro una «capace di dirompere la normalità di questo vivere-verso»:
una tematizzazione che non veda gli oggetti come onta irrelati, ma che li tematizzi
nel loro «come», nei loro modi di datità.
Per indagare il «come» dobbiamo tornare al soggetto esperiente, perché solo
qui l'oggetto si dà all'interno di un modo di datità. Inoltre, è da tener presente che il
singolo oggetto non si dà in un singolo modo di datità: «la singolarità - per la
coscienza - in sé non è nulla; la percezione di una cosa è percezione della cosa nel
suo campo percettivo» (K §47 p. 189). La datità rimanda ad altre rappresentazioni
percettive, rimanda ad un orizzonte percettivo interno al soggetto di fronte al quale
v'è un orizzonte esterno «appunto perché la cosa è in un campo di cose; e ciò
rimanda infine al mondo nel suo complesso» (K p. 189). Il mondo non si dà in uno
squarcio esperito, ma vi si manifesta. La soggettività capace di cogliere il mondo
nella sua totalità non è più quella personale dell'epoché primordiale, ma una
soggettività trascendentale. Come il mondo non si dà in uno squarcio, così questa
soggettività non si dà nella soggettività di un singolo uomo: «la soggettività si
obiettivizza in soggettività umana, che diventa un elemento del mondo. Qualsiasi
considerazione obiettiva del mondo è considerazione di qualcosa di "esterno" e
coglie solo "esteriorità", oggettività. La considerazione radicale del mondo è una
considerazione sistematica ed interna della soggettività che si "esteriorizza"
nell'esteriorità.» (K §29 p. 143)
Di che soggettività si tratta se quella personale non è che una obiettivizzazione,
un oggetto tra gli oggetti dal punto di vista del mondo?
La soggettività trascendentale si dà come «soggettività molteplice» (cfr. K §38).
La soggettività umana singola non può essere travalicata, poiché solo attraverso
essa il soggetto trascendentale può esibirsi «attraverso un dispiegamento
dell'orizzonte» (cfr. K §46) e rivelare nuove limitazioni e altri orizzonti. L'intero mondo
e con esso il soggetto trascendentale fluisce, si muove perché costantemente
percepito da molteplici soggetti che si muovono nel mondo e si scambiano
esperienze e visioni del mondo e riflettono e creano nuovi oggetti e nuove prassi:
«noi, nella percezione del mondo costantemente fluente, non siamo isolati, [...]
siamo bensì legati agli altri uomini [...] nella vita in comune ognuno può partecipare
alla vita degli altri» (K §47 p. 190). Nella «reciproca comprensione», «attraverso
rettifiche vicendevoli», le esperienze degli altri entrano in connessione e formano
un'«evoluzione di validità». Il soggetto si "sa" inserito nell'orizzonte del mondo e in
quello degli altri. Addirittura ciò che sancisce la realtà è il «costante movimento delle
rettifiche» (cfr. K §38), il momento di adeguazione del soggetto al mondo; mentre la
possibilità della riflessione, di rendere tematici i modi di datità, si dà nel relarsi agli
altri soggetti: «nel rilievo della differenza tra ciò che è "originariamente proprio" e ciò
che è offerto dall' "entropatia" di fronte all'altro nel come dei modi di apparizione [...]
ciò che da ognuno è esperito in modo veramente originale, la cosa della percezione,
si trasforma in una "mera rappresentazione di", nell' "apparizione di" ciò che è
obiettivamente essente» (K §47 p. 41). La soggettività trascendentale si fonda
sull'intersoggettività, ma, metodologicamente, la fenomenologia che trova la sua
fonte di evidenza nell'esperienza pone come punto di partenza il soggetto relativo: è
a partire dalla sfera primordiale che ha luogo la possibilità della riflessione sui modi
di datità e anche la «percezione dell'estraneità» ha metodologicamente luogo
innanzitutto nell'auto-temporalizzazione in cui l'io si costituisce come unità di io
passati e futuri rispetto a quello attuale esperiente (cfr. §§50 e 54b). Ed è in analogia
a quest'auto-estraniazione e nella scoperta del corpo-proprio come luogo esperiente
che trova una possibilità fenomenologica l'entropatia: la comprensione dell'altro.
Solo in virtù della comprensione, della condivisione con l'altro possono aver luogo
quelle sintesi intersoggettive «attraverso cui tutti i soggetti egologici (e non soltanto
attraverso le loro peculiari molteplicità individuali) si dirigono verso il mondo comune
e verso le cose che sono in esso, cioè verso il campo di tutte le attività connesse nel
noi generale, ecc.» (K §50 p. 199). E il senso risiede nel mondo.
Il senso come luogo di una nuova razionalità
Il «punto di partenza», l'oggetto della nostra considerazione quando volgiamo il
nostro sguardo al mondo dato in una soggettività molteplice è il comportamento
umano di fronte al mondo circostante (cfr. K §71). Ma il comportamento non si può
ridurre a semplice attualità. Infatti alla nota 20 al §71 leggiamo che il senso del
comportamento «è appunto conferito dall'entropatia, dalla comprensione
dell'espressione». La comprensione ha luogo solo nel portare a coscienza
l'orizzonte. Coscienza in cui «l'auto-coscienza e la coscienza dell'estraneo sono
inseparabili a-priori». Ogni singolo soggetto esperisce il mondo in quanto orizzonte
dell'esperibile, in quanto mondo reso comunicabile, esprimibile, da prassi praticate in
comune, in un «presente co-umano». Tuttavia, come il singolo soggetto si autoestranea nella temporalizzazione, così il soggetto trascendentale si vede mutare col
sorgere di nuove prassi nel movimento delle rettifiche che portano a nuovo
contenuto la realtà del mondo. Per quanto riguarda le prassi consolidate, già date,
nell'analisi dell'orizzonte esse si esplicano in «un legame generativo nel flusso
unitario della storicità», la cui linearità è pari allo zigzag della struttura della
temporalizzazione. Il mondo unico si dà solo internamente a questi orizzonti, nel
commercio con gli altri, nel variare delle validità a seconda dei movimenti di rettifica:
«nell'intenzionalità vivente fluente che costituisce la vita di un soggetto egologico
sono già preliminarmente implicati, intenzionalmente, tutti gli altri io nel modo
dell'entropatia e dell'orizzonte dell'entropatia» (K p. 274). L'entropatia nel suo essere
rapporto con altri io si dispiega anche storicamente, in quanto ogni io si fa altro nel
suo essere passato. Ciò implica che ogni io porta in sé come presupposti l'umanità
nella sua generalità e storicità. Li porta in sé, ossia, interiormente come elementi
della propria costituzione, in quanto l'entropia mette in relazione delle soggettività,
delle intenzionalità, non degli oggetti: la sua operatività consiste nella messa in
funzione dei modi di datità, nella possibilità stessa di esperire gli oggetti. Tuttavia
essa si esibisce solo nel comportamento, ma è a questo punto che è importante
rilevare l'atteggiamento fenomenologico: l'oggetto, ora, nella considerazione
entropatica sorge, appunto, come oggetto di esperienza, ossia scaturisce dalla vita
in comune: «ciò che è un rapporto di esteriorità per l'atteggiamento naturalemondano della vita nel mondo anteriore all'epoché, e che deriva dall'incorporazione
delle anime nei corpi, si trasforma attraverso l'epoché in un'inerenza pura
intenzionale. Così il mondo che semplicemente è, e quindi anche la natura, si
trasforma nel fenomeno "mondo" a noi tutti comune, "mondo per tutti i soggetti reali
e possibili"; nessun soggetto può sottrarsi all'implicazione intenzionale per cui rientra
nell'orizzonte di tutti i soggetti» (K p. 275). In questa riduzione gli altri da corpi propri,
da anime, diventano alter-ego, altri luoghi di esperienza del mondo, altre possibili
forme di datità. Dunque, viceversa io lo sono per loro. Le validità che io accordo al
mondo sono comprensibili per un altro che me le attribuisce come mie forme di
intenzionalità.
Per essere comprese queste stesse entropatie devono essere messe in
epoché: devono essere rese tematiche e le loro validità sospese. Si deve operare
«un'epoché nell'epoché». A questo punto nel gioco di attribuzione di validità
reciproche, le forme intenzionali da me attribuite e a me attribuite assurgono a
validità intesoggettive: «Se io accordo la validità alle entropatie [...], esse diventano
strutture essenziali di qualsiasi alter-ego, e allora si presentano i problemi della
comunità globale prodotta dall'entropatia e dalle sue forme essenziali particolari appunto quelle che nella considerazione naturale del mondo si presentano
obiettivate» (k §72 p. 278). Le forme che scaturiscono dall'entropatia sono quelle
entro cui si esperiscono gli oggetti del mondo. Tali oggetti non sono ovviamente solo
corpi, infatti, Husserl prosegue esemplificando: «la famiglia, il popolo, la comunità
popolare, che diventano così strutture essenziali della storicità umana» (K §72 p.
278). Ridotte ulteriormente si giunge alla «storicità assoluta» di una «comunità
trascendentale, la quale [...] ha in sé il mondo come un correlato intenzionale di
validità e continua a produrlo» (K p. 278). Il mondo in questi termini fluisce in un
costante divenire.
Nel paragrafo successivo Husserl conclude ponendosi la domanda sulla
possibilità, in questo mondo a «fiume eracliteo», di una verità definitiva. L'unica
verità che possiede un fenomenologo è quella della datità dell'esperienza che non
può che essere soggettiva-relativa: possiedo solo un supposto-con-certezza la cui
«mera conferma, costitutiva dell'esperienza reale, non esclude la possibilità
dell'apparenza [...]. L'esperienza, l'esperienza della comunità e le vicendevoli
rettifiche, come del resto la propria esperienza e le proprie auto-rettifiche non
eliminano la relatività dell'esperienza, che è relativa in quanto esperienza della
comunità» (K §73 p. 258). Nel confronto con altre comunità e nel suo divenire storico
anch'essa si deve considerare una di una molteplicità di comunità passate e future.
Nemmeno l'intersoggettività si può dire definitiva.
«L'uomo della vita quotidiana [...] ha una lingua, può compiere descrizioni,
passaggi conclusivi, egli interroga la verità, verifica, argomenta e decide
razionalmente - ma l'idea di una "verità in sé ha un senso per lui?» (K p. 258)
Torna il problema del senso e ora tale problema mina l'idea stessa di verità in
sé che non trova alcun appiglio nell'esperienza, nella realtà.
E' possibile che sia solo un'invenzione filosofica?
Husserl conferma: «Eppure non è una finzione, un'invenzione irrilevante e
superflua, bensì una scoperta che innalza, o è chiamata ad innalzare l'uomo ad un
livello più alto, in una nuova storicità della vita umana» (K p. 258). Al di là del vizio
gerarchico di porre la propria disciplina al di sopra delle altre, l'idea filosofica di una
verità in sé pone come le altre idealità un telos, un fine nel mondo che determina
una certa prassi. La prassi teoretica di cui si parla qui è la filosofia che trova nel telos
di una verità in sé una prassi atta a costituire una nuova storicità.
Tale storicità si delinea come storia della costituzione delle idealità che entrano
a formare la nostra visione del mondo nella ricerca del senso, ossia della prassi per
la quale furono ideate. Storicità messa in pratica da Husserl nel delineare l'origine
della geometria. Ciò che al ricercatore è qui richiesto e di risalire alle situazioni
concrete in cui si istituirono nuovi modi di datità, nuove forme di esperienza, che al
presente si danno come ovvie. Ma porre un origine significa anche determinare un
fine, o dei fini per ciascuna idealità, un loro senso d'essere al mondo. Un'operazione
simile richiede una presa di «responsabilità definitiva», in quanto la responsabilità
sta nel determinare un telos come verità. Le verità non si danno più come entità
statiche che ci troviamo dinanzi, ma come idealità che hanno un'origine e un fine.
Questo genere di verità si dà solo attraverso l'analisi degli orizzonti in cui gli oggetti
del mondo si esperiscono: attraverso l'auto-considerazione del soggetto in quanto
soggetto trascendentale.
«La vita umana personale ha diversi gradi di auto-considerazione e di
responsabilità di sé: dal grado degli atti singoli e occasionali a quello dell'autoconsiderazione e della responsabilità universali, fino al grado in cui la coscienza
coglie l'idea dell'autonomia, l'idea di una determinazione della volontà di plasmare la
vita personale nell'unità sintetica di una vita nella dimensione di una responsabilità
universale di sé» (K p. 287)
Una tale auto-considerazione, capace di aprire infinitamente gli orizzonti del
mondo, non può non essere consapevole del fatto di agire su un mondo che
continuamente si plasma insieme al correlativo plasmarsi della soggettività.
Dunque la razionalità che fuoriesce dalla nuova storicità «è una razionalità che
scoprendo sempre di nuovo l'insufficienza della sua relatività, si sforza di pervenire a
una vera è piena razionalità» (K p. 288).
Infine, però, essa scopre che questa razionalità è un'idea disposta all'infinito, e
che di fatto è in divenire. Lo scopo pratico della filosofia diventa dunque quello di
indagare infinitamente gli orizzonti alla ricerca del senso.
L’invisibile della carne.
Luce Irigaray lettrice di Merleau-Ponty in Etica della differenza
sessuale (1985)
Monica Fiorini
Luce Irigaray, filosofa e psicanalista di origine belga, ha studiato filosofia a
Lovanio e psicologia a Parigi dove ha fatto parte, per un certo periodo, dell’Ecole
Freudienne di Jacques Lacan. I suoi testi, tra i quali L’etica della differenza sessuale
(1985) da cui è tratto lo scritto di cui mi occuperò principalmente, sono stati quasi
tutti tradotti in italiano e la sua opera, segnata da numerosi passaggi e articolazioni
nonché da molte letture differenti in cui possono venir privilegiate la psicanalisi, la
filosofia o strumenti di indagine di tipo socio-psicologico, è conosciuta in Italia. Non
mi sembra inutile, però, far precedere il commento dell’Invisibile della carne, il
saggio dell’Etica dedicato a Merleau-Ponty, da una breve presentazione del suo
percorso che vede un momento di passaggio proprio nella rottura con la scuola
lacaniana in occasione della pubblicazione, nel 1974, di Speculum. De l’autre femme
(Paris, Minuit ; trad. it. Feltrinelli, 1975).
Speculum è il primo libro importante di Luce Irigaray ed è un testo complesso
che si compone di varie parti. Le tre sezioni in cui si divide raccolgono differenti
capitoli, alcuni dei quali costituiti interamente da una scelta di citazioni, un gesto che
indica la presa di distanza oltre a ricordare che colei che scrive, e dunque prende la
parola con autorità, risulta, per il suo sesso, esclusa dai testi che cita (testi fondatori
della cultura occidentale), ovvero inclusa in essi solo in posizione di oggetto 113. La
prima sezione, Il luogo cieco di un antico sogno di simmetria, è dedicata
principalmente a una lettura decostruttiva di Freud. La psicanalisi è infatti il
riferimento principale, e anche lo strumento teorico di cui Luce Irigaray si serve in
quegli anni, pur mettendone in discussione profondamente i presupposti, in quanto
la psicanalisi è il discorso (scientifico, teorico) che nel novecento mette in primo
piano la sessualità e la corporeità del soggetto, un “Io-corpo” che si trova ad essere
una formazione di confine costituita da una parte (Dio sa quanto importante!,
esclama Freud) destinata a restare inconscia114. Per queste ragioni inoltre prende
in considerazione la differenza sessuale in modo nuovo, salvo tuttavia ricondurre poi
la sessualità femminile a quella maschile, assunta ancora una volta come
paradigma, tanto da modellare le sue fasi di sviluppo su quelle maschili invertendole
di segno. Irigaray si sofferma soprattutto su quello che per Freud è il passaggio
obbligato nello sviluppo della bambina: la trasformazione dell’attaccamento alla
madre in odio verso di lei per rivolgersi al padre e “entrare nel suo desiderio” (un
termine chiave per Irigaray, come per Lacan che attraverso una teoria del desiderio
propone una traduzione dell’opera freudiana). Su questo punto lavorerà in seguito
sia per dare elaborazione a questo rapporto madre-figlia, figlia-madre, sia perché
individua in queste rappresentazioni della donna e del femminile e nelle rimozioni
che ad esse si accompagnano i fondamenti della razionalità occidentale. Ovvero sia
della filosofia che della psicanalisi. La seconda sezione del libro, intitolata Speculum,
è una sorta di lungo intermezzo che attraversa testi di Platone (in particolare per
evidenziare l’appropriazione della materia da parte del logos), Aristotele, Plotino,
Cartesio115, Kant, Hegel. Ciò che evidentemente le preme ribadire in ogni lettura è
che vi è una stretta associazione tra il privilegio dello spirito e della forma rispetto al
corpo e alla materia e una differenza sessuale pensata (spesso in luoghi marginali
nelle opere dei singoli filosofi e comunque non posta come centrale questione
ontologica) in termini di stretta associazione del femminile con il corpo, con la
natura, con la materia e l’animalità. Immagine invertita di un maschile associato a
razionalità, mente, cultura, ecc. Tutte dicotomie che si intrecciano con quelle che
contrappongono soggetto e oggetto, attivo e passivo. La terza sezione, infine,
intitolata L’ύστέρα di Platone, ritorna a Platone e al mito della caverna concludendo il
libro con una specie di rovesciamento temporale – parte da Freud e finisce con la
filosofia greca, ovvero, si potrebbe dire, con la filosofia –, che sostiene tutta la sua
prospettiva di ricerca, influenzata non solo dalla psicanalisi, ma anche da tutto ciò
che si veniva elaborando in quegli stessi anni nel movimento delle donne. Per
questo motivo la sua autrice viene accusata di mancare di etica 116, di mescolare la
psicanalisi con la filosofia, e soprattutto con altri discorsi, di tipo politico, provenienti
appunto dal contesto femminista. Queste (insieme allo scontro diretto con Lacan)
sono le ragioni per le quali Irigaray perde anche l’incarico di insegnamento a
113 In particolare si può vedere l’elenco di citazioni tratte da testi platonici nel paragrafo intitolato
“All’indice delle opere di Platone: la donna” (p. 145 e segg. della trad. it.) e quelle tratte dalle Enneadi
di Plotino, “Una madre di vetro” (p. 160 e segg.).
114 Cfr. S. Freud, L’Io e l’Es, in Opere, vol. 9, Torino, Bollati Boringhieri, 1989; “L’Io è innanzitutto
un’entità corporea, non è soltanto un’entità superficiale, ma anche la proiezione di una superficie”, p.
488; cfr. anche l’inizio di Al di là del principio di piacere, in Opere, vol. 9, cit. Per l’io come formazione
di confine ved. anche i Tre saggi sulla teoria sessuale, Opere, vol. 4, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
115 Nel successivo Etica della differenza sessuale Irigaray leggerà il Cartesio “fisiologo” del trattato
delle passioni da un altro punto di vista.
116 Questa accusa viene lanciata dalle pagine della rivista “Ornicar” che appunto afferma che il testo
manca di etica cioè “di fedeltà a un solo discorso”.
Vincennes, dove lavora dal 1969. Da allora non insegnerà più se non in seminari
liberi proposti all’interno dell’Ecole de Haute Etudes en Sciences Sociales di Parigi o
in cattedre universitarie aperte al contributo di studiosi spesso stranieri e esterni
all’accademia. L’influsso del cosiddetto “contesto femminista” è ciò che determina
per Irigaray una svolta, nel senso di indicare la necessità di un pensiero in cui la
differenza sessuale e dunque il sesso del soggetto che conosce, che enuncia, e non
solo entra in relazione con il mondo ma si dà in una relazione (con il mondo, con altri
soggetti), il suo essere donna, non sia un elemento indifferente117.
In Speculum Irigaray utilizza soprattutto una strategia ironica, una strategia che
ha lo scopo di mostrare come una donna non sia l’immagine speculare di ciò che gli
uomini mettono in scena di se stessi. Non propone un’immagine del femminile o
della donna. Cerca di “fare spazio” a qualcosa che va oltre, che eccede, le
rappresentazioni e le figure in cui “la donna” è presa.
L’obiettivo di Speculum, è quello di ascoltare ciò che è censurato, rimosso, e
che tuttavia insiste e hante il logos (il fallologocentrismo).
Un’alterità (un'altra) che non è (solo riducibile a) altro-del-medesimo, altro
speculare.
Etica della differenza sessuale
Se Speculum è il primo testo di Luce Irigaray ad aver suscitato un notevole
dibattito, Ethique de la différence sexuelle, che viene pubblicato in francese dieci
anni dopo (Paris, Minuit, 1984) e tradotto in italiano, come il precedente, a distanza
di un anno dall’edizione originale (Feltrinelli, 1985), provoca ulteriori, differenti,
discussioni perché viene letto (in particolare in Italia) come un momento di svolta, di
trasformazione, in quanto presenterebbe “il tentativo di far accedere le donne alla
posizione di soggetti, di liberare la differenza femminile intesa come valore
autonomo”, e aprirebbe in questo senso una prospettiva nuova, “anche rispetto agli
scritti precedenti della stessa autrice”118.
Al centro della sua riflessione resta comunque il rapporto pensiero-corpo, corpo
sessuato, una corporeità non pensabile come in qualche aspetto “neutra”119
rispetto alla differenziazione sessuale miticamente iscritta nella nostra cultura come
taglio, divisione che ha luogo in un certo momento, posteriormente alla “creazione” e
risulta accessoria o supplementare. Insieme all’elaborazione simbolica della nascita,
che si configura come rapporto del soggetto con la sua “origine” e dunque porta a
pensare un “soggetto femminile”, ma implicando una trasformazione della
“soggettività”. Di quella teoria del soggetto che in Speculum Irigaray dice essere
sempre appropriata al maschile.
Fondamentale resta anche il rapporto tra “soggetto” e linguaggio, discorso,
logos; l’autrice interpreta l’attuale crisi del linguaggio (facendo riferimento a
117 Per una riflessione su questo aspetto nei termini di una “tentazione del neutro”, di una tentazione
di appropriarsi di un linguaggio che si vuole per definizione neutrale come spazio di maggiore libertà –
e in realtà mostrato come spazio di silenzio, o di ripetizione per una donna – cfr. Wanda Tommasi, La
tentazione del neutro, in Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, Milano, La tartaruga, 1987.
118 Anna Maria Piussi, Linguaggio e differenza femminile, in Il filo di Arianna. Letture della differenza
sessuale, Roma, Utopia, 1987, p. 118.
119 “Certo il neutro potrebbe significare un luogo alchemico della sublimazione della “genitalità”, la
possibilità della generazione, della creazione dei e tra i generi. Bisognerebbe però che esso fosse
disposto ad accogliere l’avvento della differenza, che si pensasse come attesa, al di qua, e non come
al di là, in particolare etico” Etica, op. cit., p. 17.
Nietzsche120, Heidegger121, Lacan) come crisi epocale legata alla mancata
accoglienza nel linguaggio della differenza (crisi del soggetto e crisi del linguaggio
sono strettamente legate e hanno quindi la medesima origine) 122.
In Speculum Irigaray compie le sue operazioni critiche soprattutto sulla
psicanalisi, come già detto. In Etica della differenza sessuale il terreno è quello della
filosofia, e tocca luoghi chiave del pensiero filosofico: il soggetto, l’oggetto, l’altro, il
tempo, lo spazio, il corpo, la morte, il divino, attraverso un discorso che si rapporta
con la tradizione filosofica per interrogarla e rimodellarla.
L’Etica è composta da una serie di lezioni tenute presso l’Università Erasmus di
Rotterdam nell’ambito della cattedra “Jan Tinbergen” che viene occupata ogni anno
per un semestre da uno studioso straniero. Le viene affidata per la filosofia nel
secondo semestre del 1982; il tema: un’etica delle passioni.
Le conferenze sono quattro, seguite ognuna da due seminari di lettura di testi
filosofici.
La prima conferenza, intitolata La differenza sessuale, è seguita dalla lettura
del “Discorso di Diotima” nel Simposio platonico, e da quella di un passo della Fisica
di Aristotele (IV, 1-5) – intitolata “Il luogo, l’intervallo”. In quest’ultima lettura Irigaray
parte dalla distinzione aristotelica tra luogo e involucro per articolare la differenza tra
il corpo della donna, o la donna come corpo – in relazione al suo essere corpo – (il
“luogo”) e la donna come madre (involucrante-avvolgente per il bambino). In tal
modo non solo si propone di iniziare a pensare il corpo femminile senza confonderlo
immediatamente con il corpo materno (e riducendolo quindi a corporeità-in-quantomaterno, a matrice) ma affronta una questione molto attuale, tutto un dibattito che
sta facendo, intorno a una nozione sempre più mostruosa come quella di “vita”, del
corpo della donna un “luogo pubblico”123.
La seconda conferenza, dedicata a L’amore di sé, è seguita da una lettura di
Cartesio, Le passioni dell’anima art. 53 sull’ammirazione, e da un seminario
sull’Etica di Spinoza, parte prima, “Dio”.
La terza, L’amore del medesimo, l’amore dell’Altro è invece seguita da un
seminario su Hegel (Fenomenologia dello spirito, VI, Lo spirito, A-a, “Il mondo etico;
la legge umana e la divina, l’uomo e la donna”) e da una riflessione sull’etica della
differenza sessuale.
La quarta infine, consacrata all’Amore dell’altro, è completata dal saggio
L’invisibile della carne, una lettura di L’intreccio – il chiasmo, in Il visibile e l’invisibile
di Merleau-Ponty, e da una lettura di Levinas, per la precisione del paragrafo
“Fenomenologia dell’eros”, in Totalità e infinito, dal titolo Fecondità della carezza.
120 Cui dedica il saggio dal titolo Amante marine, Paris, Minuit, 1980 (trad. it., Feltrinelli, 1981).
121 Cui dedica L’oubli de l’air, Paris, Minuit, 1983 (trad. it., Bollati Boringhieri, 1996).
122 Cfr. Giannina Longobardi, Soggetto femminile e sessuazione del discorso, in Il filo di Arianna.
Letture della differenza sessuale, op. cit.; il saggio si muove tra una lettura dell’Etica dela differenza
sessuale e molti riferimenti a testi precedenti poi raccolti in un volume dal titolo Parler n’est jamais
neutre, Paris, Minuit, 1985.
123 Cfr. Barbara Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico, Torino, Bollati Boringhieri, 1995
(l’orig. ted. è del 1991). Duden cerca di fare una storia, o meglio, in senso foucaultiano, un’archeologia
del modello di corpo femminile oggi dato per scontato, attraverso la rappresentazione della
gravidanza. Molto interessante è ciò che dice sugli effetti di una maggiore “visibilità” resa possibile
dall’uso di sempre più sofisticate protesi tecnologiche. In questo modo segue la nascita e l’evoluzione
delle nozioni di embrione e di feto e indaga l’impatto simbolico della tecnica sulla “esperienza del
corpo”.
La prima conferenza comincia con una frase spesso citata in seguito: “la
differenza sessuale rappresenta uno dei problemi o il problema che la nostra epoca
ha da pensare. Ogni epoca – secondo Heidegger - ha una cosa da pensare. Una
soltanto. La differenza sessuale, probabilmente, è quella del nostro tempo” (p. 11).
Facendo ancora eco a Heidegger si potrebbe dire dunque che il più considerevole è
che non abbiamo ancora cominciato a pensare la differenza sessuale. La differenza,
come scarto di un’alterità irriducibile a altro(a) dal medesimo. A complementarità
(eventualmente suscettibile di sintesi dialettica). A gerarchia.
L’attacco è molto forte ed è da questo che si deve cominciare. Tutto è allora da
“reinterpretare”. I rapporti tra “soggetto” e discorso, “soggetto” e mondo (un soggetto
che si è sempre scritto al neutro-maschile). E di conseguenza il concetto stesso di
un soggetto che si costituisce in un certo rapporto col mondo – ciò che chiama
natura, i corpi, e il linguaggio.
Nelle righe seguenti l’autrice sintetizza la direzione del suo lavoro:
Un cambiamento di epoca esige una mutazione nella percezione e nella
concezione dello spazio-tempo, dell’abitazione dei luoghi e degli involucri
dell’identità. Suppone e introduce un’evoluzione o trasformazione delle forme, dei
rapporti materia-forma e dell’intervallo tra: trilogia della costituzione del luogo. Ogni
epoca iscrive un limite nella figura trinitaria di: materia, forma, intervallo, potenza,
atto, intervallo-intermediario.
Il desiderio occupa o designa il luogo dell’intervallo. Darne una definizione
permanente equivale a sopprimerlo come desiderio. Desiderare richiede
un’attrazione: la modificazione dell’intervallo, lo spostamento del soggetto o
dell’oggetto nei loro rapporti di prossimità o distanza.
La mutazione di un’epoca accompagna una modificazione nell’economia del
desiderio” (p. 13).
E’ chiaro che questa apertura epocale apre una “crisi” socio-culturale
investendo sapere scientifico e filosofico. Il pensiero della differenza sessuale è
(ri)pensamento dello spazio, del tempo 124, nonché del rapporto con la “natura” e
con la corporeità. E del rapporto di un sesso con sé e con l’altro (sesso). Tentativo di
pensare l’incontro tre i “due” (non tra l’Uno e (il suo) altro)125.
Per Irigaray l’uomo prende al femminile la tessitura della spazialità, inventando
infiniti sostituti del soggiorno prenatale in un’economia della nostalgia dell’origine
proiettata in un venire eventualmente da un’origine trascendente rispetto ai corpi –
da Dio.
“Avvolge lei in muri” (o veli – carcerari e mortiferi quando ogni soglia si chiude)
“lui si avvolge nella carne di lei” (p. 15).
124 La problematica dello spazio e del tempo nel testo kantiano dove tempo e spazio vengono
associati all’interiorità e all’esteriorità non è subito anch’essa leggibile in termini di differenza sessuale
laddove il soggetto è padrone del tempo, e al femminile e associato lo spazio? Versioni moderne di
una tradizione molto antica.
125 Irigaray interpreta in questo modo la famosa affermazione lacaniana: il rapporto sessuale non
esiste. Tenta invece di pensare un desiderio come apertura verso l’altro-differente non appropriato,
non riconoscibile perché “simile” o “complementare” attraverso la nozione di ammirazione, anzi la
passione dell’ammirazione nel seminario dell’Etica dedicato a Cartesio e al suo trattato delle passioni.
Per passare a un’altra epoca della differenza, dice allora, occorre meditare
tutta la problematica del luogo [del corpo-luogo] e costruire un’etica delle passioni
modificando “le relazioni tra forma, materia, intervallo, limite”. Dato che il limite,
aggiunge, non è mai stato “posto” in modo da permettere il rapporto tra due soggetti
amanti “di sessi differenti”126.
Per giungere a un’etica della differenza sessuale (rapporto tra differenti) fa
ritorno su un testo del Cartesio “fisiologo”, il Trattato delle passioni, notando
innanzitutto la necessità di pensare il rapporto tra fisica e metafisica:
Conviene meditare (…) sul fatto che tutti i filosofi – salvo gli ultimi? perché? –
sono sempre stati dei fisici, hanno sempre sorretto o accompagnato le loro ricerche
metafisiche con ricerche cosmologiche. Che si tratti di macrocosmo o microcosmo.
Questo terreno di studi è stato abbandonato solo in epoca molto recente. In seguito
all’autonomo costituirsi di un’epistemologia delle scienze? Questa scissione tra
scienze fisiche e pensiero rappresenta, indubbiamente, ciò che minaccia il pensiero
stesso in quanto scinde la nostra vita, il nostro corpo, il nostro linguaggio, il nostro
soffio, in più mondi. (…) Né filosofia prima né Dio assicurano il tetto della nostra
possibilità di abitare in quanto mortali. E spesso riusciamo a sopravvivere
regredendo a schemi anteriori all’ideazione, al paziente lavoro dell’architettura
dell’idealità: le stratificazioni socio-familiari del desiderio sotto forma di io ideale o
ideale dell’io, che provocano il ritorno alla religiosità, agli slogan, alla pubblicità, al
terrore, ecc. Tutte forme di passioni passive e subite nelle quali il soggetto è
imprigionato, costretto, privato delle sue radici vegetali e terrene, ideali e celesti.
Senza più lingua circolante tra il principio e la fine della sua incarnazione. E nessuna
finestra, nessun senso restano aperti su o con il mondo, l’Altro, l’altro. Per abitarlo,
trasformarlo. Manca, tra le passioni, l’ammirazione” (p. 60)
Si sofferma poi sull’ammirazione per affermarne l’importanza nel rapporto
d’amore - affinché esso sia pensabile non più solo in termini di attrazione, o peggio
avidità, possesso, consumazione o anche disgusto… L’ammirazione è quella
passione che ci permetterebbe, secondo Irigaray, di ammirare l’altro anche se ci
guarda (anche se così ci mette in uno stato di passività). Anche se non ci
“conviene”, perché se ci convenisse l’avremmo ridotto a noi. Lo spostamento che
Irigaray fa subire a Cartesio riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto. Cartesio non
lascia all’“oggetto” ammirato il suo carattere attraente, quel carattere che non
permette al soggetto di dirsi come completamente e solamente attivo. Ed è uno
spostamento importante per la stessa concezione del “soggetto”; una “incipiente
posizione del soggetto” (a venire? in formazione? mai del tutto formato e chiuso su
di sé, inalterabile?) che “vede ancora come auspicabile ciò che il soggetto non
conosce. Ciò che ignora. Gli rimane estraneo. La differenza sessuale potrebbe
trovare posto qui” p. 66.
L’ammirazione non afferra mai l’altro come proprio oggetto, l’altro resta
irriducibile, imprendibile. L’ammirazione è la passione (qualcosa di attivo e di passivo
insieme, un essere attratti, un andare verso, un restare distanti per contemplare,
ecc.) che tiene aperto un intervallo come spazio di separazione e alleanza. Un
intervallo che è il luogo del desiderio (anche nel caso del rapporto che ci muove
126 E anche: tra due “soggetti” amanti? ovvero entrambi amanti, “attivi” – come si dice?
Contemporaneamente attivi e passivi? Per la dicotomia di attività-passività, che supporta quella di
soggetto-oggetto passa una dinamica del desiderio costretta in questi limiti. Questi sono i limiti entro i
quali la differenza sessuale è stata “pensata” (o dimenticata in quanto differenza, rapporto, incontro tra
differenti).
verso la conoscenza, e dunque nel movimento del pensiero) mai completamente
oltrepassabile in una consumazione completa. C’è sempre un resto e un eccesso.
L’apertura di questa etica dell’ammirazione spezzerebbe per Irigaray la
ripetizione e la circolarità di un discorso che annienta la differenza. “La società, la
cultura, il discorso essendo allora riconosciuti come sessuati e non come il
monopolio di valore universale di un sesso che misconosce le impronte del corpo e
della sua morfologia sulle creazioni immaginarie e simboliche” (p. 57) 127.
L’invisibile della carne
La lettura che Irigaray fa del frammento del Visibile e l’invisibile intitolato
L’intreccio – il chiasmo è complessa perché cerca di instaurare un dialogo attraverso
una lettura attenta ad ogni passaggio. Per questo non è possibile ripercorrere in
sintesi ogni sua articolazione.
Nell’ambito del suo percorso nell’Etica, che culmina nelle pagine appena
evocate sull’ammirazione, Irigaray considera evidentemente con molta attenzione il
tentativo di Merleau-Ponty di affrontare la questione della corporeità – di pensare la
corporeità – con estremo rigore fenomenologico. E’ proprio questo rigore, però, che
richiede attenzione e pazienza nella lettura, a spingerla “salvo restarne presi(e), a
porre la questione del contatto con e dell’altro”, del contatto di corpi
morfologicamente differenti e irriducibili. Un altro, aggiunge subito sotto forma di
domanda, con un movimento caratteristico di tutto il suo testo che è percorso da
incessanti interrogativi, “il cui corpo avrebbe uno statuto ontologico differente dal
mio?” (p. 121).
Muovendo verso una ontologia, un pensiero dell’essere che tenga conto dei
differenti corpi sessuati, Irigaray interroga allora la parzialità non dichiarata da cui
scrive Merleau-Ponty, e dalla quale il filosofo si propone di “riprendere tutto”, come
dice all’inizio dell’Intreccio – il chiasmo:
Se è vero che la filosofia, non appena si dichiara riflessione o coincidenza,
pregiudica ciò che troverà, è necessario che ancora una volta riprenda tutto,
respinga gli strumenti che la riflessione e l’intuizione si sono date, si installi in un
luogo in cui esse non si distinguano ancora, in esperienze che non siano ancora
state “elaborate”, che ci offrano contemporaneamente, mescolati, il “soggetto” e
l’“oggetto”, l’esistenza e l’essenza, e forniscano quindi alla filosofia i mezzi per
ridefinirli128.
Questa ripresa radicale, si confronta anche con la scienza contemporanea e
cerca appunto di riportare l’attenzione e la domanda sul corpo, e sulla physis, ma in
che modo, si chiede Irigaray? Con quali limiti lo fa? Qual è il suo punto di vista (e di
cecità)? Dalla sua di prospettiva, è altrettanto fondamentale riprendere tutto,
riprendere le categorie di apprendimento delle cose, del mondo, non tanto per
collocarsi in un luogo in cui soggetto e oggetto siano ancora mescolati, quanto,
attraverso una simile messa in discussione del soggetto e dell’oggetto, per esempio,
127 Come vedremo si tratta per Irigaray di fare spazio a creazioni immaginarie e simboliche che
portino l’impronta di corpi differenti.
128 Il visibile e l’invisibile, Milano, Bompiani, 1969, p. 155 (ed. francese, Paris, Gallimard, 1964 – coll.
Tel, 1995); cit. all’inizio del seminario di Irigaray, L’invisibile della carne, op.cit., p. 117..
per “far rientrare il femminile materno nella lingua” (p. 117). Non solo come tema,
anzi forse non tanto come tema, non come “oggetto” (per quale soggetto?), ma
piuttosto per farlo rientrare in tutte le sue articolazioni, nella grammatica, nella
sintassi, ecc. Operazione che mette anche in discussione le leggi del discorso
intrecciate strettamente a quelle del “genere”, ma che non trova spazio nel testo di
Merleau-Ponty, come mostra per l’autrice la centralità che nel suo discorso assume
l’idea di reversibilità.
La nozione di reversibilità, su cui si appunta nelle pagine seguenti tutta la
lettura di Irigaray, è quella intorno alla quale ruota L’intreccio – il chiasmo, è la sua
“ipotesi”, ed è, come si legge nell’ultima riga, “verità ultima”.
La reversibilità fa da un lato intravedere un tipo di relazione che non è un
rapporto a senso unico tra soggetto e oggetto, soggetto e mondo, pre-dati. L’uno e
l’altro polo in tal senso si scambiano continuamente i ruoli, anzi non esistono prima
della relazione. Corpo senziente e corpo sentito sono così due segmenti di un
percorso circolare e vi è inserimento o intreccio dell’uno nell’altro. Attraverso questa
ipotesi di reversibilità Merleau-Ponty interroga la relazione tra attività e passività,
materia e forma.
Ma come nasce questa ipotesi? Come funziona nel testo? E che cosa dice a
una lettrice come Irigaray nel suo svilupparsi, articolarsi, collegare e separare
differenti questioni?
L’ipotesi nasce in riferimento al piano del tangibile e con un esempio che arriva
abbastanza presto nel testo di Merleau-Ponty, quello delle due mani che si toccano.
Non solo, in questo toccarsi delle mani, ogni mano è contemporaneamente
soggetto-e-oggetto, è toccante e toccata, ma, in quanto toccata, la mano che tocca
prende posto tra le cose che tocca, è una di loro, in un certo senso, è apertura verso
un essere tangibile di cui fa parte; per via di questo incrocio, in lei, di toccante e
tangibile, dice Merleau-Ponty, i suoi movimenti si incorporano all’universo tangibile
che interrogano. Come le due metà di un’arancia.
Il presupposto di reversibilità emerge innanzitutto attraverso questa parentela
tra le mani e il mondo tattile.
Dal piano del tattile o del tangibile però, come nota Irigaray all’inizio del suo
commento che segue linearmente lo svolgimento del saggio di Merleau-Ponty, viene
subito spostato a quello del visibile. Merleau-Ponty afferma infatti che lo “spettacolo
visibile” appartiene al tatto, e che ogni essere tattile è “promesso alla visibilità”.
Per questo motivo vi sarebbe chiasmo, “enjambement” è la parola francese che
si legge in questo passaggio, non solo tra toccante e toccato, ma anche tra tangibile
e visibile – quel visibile “incrostato in lui” – e tra visibile e tangibile – un tangibile che
“non è mai un niente di visibilità”.
Da qui muovono le domande di Irigaray che nel contatto, per esempio nel
contatto tra mano e mondo, ma non solo, vede l’incontro, che non lascia intatti, di
enti differenti, di carni irriducibili, e tutte le sue critiche a questo “raddoppiamento
incrociato”, che mirano ad affermare che non tutto del tangibile è promesso alla
visibilità, e viceversa. La non sostituibilità dei corpi esperita per lei nella divergenza
del tatto, non può essere recuperata in una reversibilità tra vedente e visibile. Niente
prende completamente il posto dell’invisibile della carne.
Dal suo punto di vista Merleau-Ponty fondando il visibile sul tangibile pone così
le basi per riaffermare un privilegio o un primato del visibile sul tangibile; è il
tangibile, di fatto, che non è mai un niente di visibilità. Irigaray al contrario afferma in
tutta la sua opera, che pensa il “soggetto corporeo” come soggetto che nasce, che
viene alla luce (e dunque alla visibilità) attraverso un altro corpo, una soglia di carne,
che il tangibile resta primo nella sua apertura, senza avere un “primato”, tuttavia,
piuttosto consentendo di pensare che “le due carte del visibile e del tangibile non si
danno il cambio in maniera completa” (p. 126), non solo non si confondono e non si
sovrappongono ma non sono le due metà di un’arancia, o le due mani giunte di un
medesimo corpo, ma “mondi” tra i quali vi è scarto. Una irriducibile differenza separa
le due “carte”.
Se una carta rilevasse l’altra, infatti, questa sarebbe per l’autrice il tangibile,
ma, è l’aggiunta è importante, esso rimane piuttosto come (s)fondo disponibile per
tutti i sensi, “paesaggio molto più vasto ma mai chiuso in una carta” (p. 126).
L’invisibile della carne indica allora un invisibile che non è l’inverso del visibile,
un elemento non rilevabile dal visibile: “non vedo mai ciò in cui tocco e sono toccato”
scrive, “nella carezza c’entra qualcosa che non si vede” (così come vi sono parti del
corpo che tocco e non posso vedere, a partire dal volto, che vedo solo nello
specchio, uno specchio che è accesso a un altro ordine del visibile, e in cui “mi ci
vedo come l’altro” (p. 131)), “il tra due, il mezzo, il medium della carezza non si vede.
Così e diversamente, io non vedo ciò che mi permette di vedere (…) Visibile e tattile
non obbediscono alle medesime leggi o ritmi della carne. E pur potendo, senza
dubbio, fare una lega delle loro potenze, non posso ridurre l’uno all’altro. Non posso
rilevare visibile e tangibile in chiasma” (p. 125).
Che cosa accade in questo rilevamento?
Ad essere dimenticato è proprio un medium carnale che non si vede. E questo
rischia di far “dimenticare” in qualche modo, ancora una volta, il corpo. Quale corpo?
Il tangibile viene pensato come ritagliato secondo alternative che non rispettano le
sue soglie, i suoi accessi, le sue bocche (p. 126). Differenti in corpi differenti. Nel
“rilevamento” Irigaray vede una volontà di padronanza che si sostiene da sempre sul
primato della visione e che nega in primo luogo “l’apertura dell’una e dell’altra carta”,
la non sovrapponibilità dei due ordini, in secondo luogo, come si vedrà,
l’“irreversibilità” che sarebbe in gioco in un ordine “visibile” in cui non si potrebbe
parlare come fa Merleau-Ponty di “identità di vedente e visibile”. Un’identità che
ancora una volta non tiene conto delle differenze dei corpi.
Per Irigaray la nozione di reversibilità tra vedente e visibile (del mondo e dell’io,
in una sorta di economia chiusa – cfr. le pp. 132-133 del testo di Irigaray) non solo
non elimina una distinzione soggetto/oggetto (attraverso il primato del vedentesoggetto) (per affermarlo analizza con attenzione tutti i minimi passaggi
dell’argomentazione iniziale di Merleau-Ponty alle pp. 118-119), ma ribadisce il
carattere solipsistico di questo vedente:
Due membrane del corpo e due membrane del mondo sembrano escludere
che un’altra carne sia visibile e vedente, tra l’uno e l’altro. La finezza di ciò che si
dice del visibile e del suo rapporto con la carne non esclude il carattere solipsistico
di questo contatto tra mondo e soggetto, di questo contatto del visibile e del vedente
nel soggetto medesimo.
Tutta l’analisi di Merleau-Ponty è segnata da questo solipsismo labirintico.
Senza l’altro, e soprattutto l’altro della differenza sessuale, impossibile uscire da
questa descrizione del visibile, ripetuta e rinforzata con la descrizione del tattile tra le
mani? Ma questo approccio fenomenologico rigoroso e denso obbliga, salvo
restarne presi(e) a porre la questione del contatto con e dell’altro. (p. 121) (corsivo
mio)
Torniamo un momento all’esempio delle mani. Irigaray lo cita per esteso dal
testo di Merleau-Ponty e lo commenta in questo modo:
la mia mano e il suo “inverso”, l’universo e il suo “inverso” s’inscriverebbero nel
medesimo orizzonte, mescolerebbero le loro conoscenze, le loro assimilazioni, nel
medesimo ciclo o nella medesima orbita, ciascuno(a) mettendo l’altro dentro-fuori,
fuori-dentro? Il che è impossibile? Né la mia mano né il mondo sono un “guanto”,
non si riducono al loro rivestimento. Né la mia mano né il mondo sono così
reversibili. Non sono puri fenomeni attuali, pure pellicole prendibili l’uno dall’altra,
fosse anche per empatia. Hanno le loro radici, non si riducono all’istante visibile. Le
loro radici e il loro ambiente. Rigirarli, invertirli così l’uno nell’altra equivale a
distruggerli nella loro vita (p. 124).
Per continuare, a proposito del paragone finale dell’arancia, che raddoppia e
rilancia quello delle mani spostandolo verso il rappporto tra corpo-carne e carne del
mondo, chiedendosi: “Valido solo se le due mani fossero giunte? Il che opera
qualcosa di molto particolare nel rapporto senziente-sentito. Senza oggetto né
soggetto. Senza passivo né attivo, e nemmeno medio-passivo. Una specie di quarto
modo? Né attivo, né passivo, né medio passivo. Sempre pià passivo del passivo.
Eppure attivo. (…)” (p. 124)
Ciò che Irigaray vuole porre in evidenza è la questione che verrebbe sollevata
dall’incontro con un altro/a, con un’alterità che è tale in maniera irreversibile; che è
altro(a) vedente-visibile per cui tra i due vedenti-visibili (e, diversamente, secondo
diverse articolazioni e modalità non sovrapponibili, toccanti-tangibili) non vi può
essere reversibilità.
Una simile reversibilità vi potrebbe essere solo nel caso di un altro speculare,
messo “tra l’altro e me”, “a sconcertare la prova di lateralità invertita dell’altro” (p.
131) altro “la cui mano sinistra può prendere la mia destra, per esempio. Facendomi
più passivo di ogni passività del e nel mio proprio toccare. Costringendomi a un al di
qua e a un aldilà del mio orizzonte” (p. 131) – l’ordine della carne non è
sovrapponibile a quello speculare. Nel contatto si aprono “buchi di invisibile”, diversi
dall’invisibilità della “vita intrauterina” e del “rapporto carnale in senso stretto”, e il
solo fatto non solo di vedere, ma di essere visti, apre varchi.
Irigaray legge L’intreccio – il chiasmo come un complesso esercizio di
sostituzione.
Ma prima di vedere questo aspetto più in dettaglio, vorrei ritornare ancora alla
reversibilità di vedente e visibile che poggia su una supposta reversibilità del
toccante e del tangibile.
Merleau-Ponty, nota che il vedente, colui che vede, “possiede” il visibile solo se
“ne è posseduto”, s’il en est un, se è uno dei visibili. Tuttavia il vedente ha questo di
particolare, è capace di vederlo, lui, che è uno di loro. Emerge qui la particolare
posizione del soggetto umano – solo umano? – rispetto alle “cose”, al mondo, alla
natura – di cui peraltro fa parte. Che anche “è”.
A venire in primo piano è sempre la visione di un vedente che si raddoppia: io
stesso, dice il filosofo, visto da fuori come un altro mi vedrebbe. Come un altro mi
vedrebbe? Si tratta di un’altra questione su cui evidentemente Irigaray si sofferma in
tutto il suo testo. L’altro (soprattutto l’altro della differenza sessuale?) mi vede, dice
infatti, non come io mi vedrei da fuori – se riuscissi a uscire da me – ma proprio
come io (che non posso, per via del mio corpo, per via dell'ordine della carne, uscire
da me) non posso vedermi, ed è visto da me come lui/lei non può vedersi (prima ha
parlato di “buchi di invisibilità”). Sguardo “consegnato” all’altro(a), “che detiene senza
saperlo il mio sguardo che lo vede, e che vede ciò che io non posso guardare di me”
(p. 131).
All’identità di vedente e visibile (che all’inizio del suo percorso Merleau-Ponty
dice di non poter esaminare a fondo, per vedere se ne abbiamo una esperienza
piena o se manca ad essa qualcosa e che cosa ma che postula di fatto) Irigaray
oppone il “posto di un altro sesso che mi vede senza che anch’io possa vederlo e
viceversa, specialmente in nome del tangibile e dell’inversione, non reversibile, dello
sguardo, in una carne insostituibile” (p. 127-128).
Se la reversibilità di vedente e visibile, così come la reversibilità di tangibile e
visibile (primo passaggio dell’argomentazione di Merleau-Ponty) è legata per lei alla
mancata considerazione di corpi differenti, che cosa farebbe subire, questa
considerazione, alla nozione di soggetto tradizionale che è ancora per Irigaray
chiaramente all’opera nella nozione di “vedente”?
Scrive Merleau-Ponty: “Il corpo ci unisce direttamente alle cose in virtù della
propria ontogenesi, saldando l’uno all’altro i due abbozzi di cui è fatto, le sue due
labbra: la massa sensibile che esso è e la massa del sensibile da cui nasce per
segregazione, e alla quale, come vedente, rimane aperto” (cit. da Irigaray, p. 128 –
corsivo mio).
Irigaray si sofferma sul paragone delle due labbra collocate tra “la massa
sensibile che esso [corpo] è” e “la massa sensibile da cui nasce per segregazione”
(un’ontogenesi che è quasi una partenogenesi o una nascita analoga alla divisione
cellulare, del “corpo”, dal resto della carne?).
Il paragone delle labbra spinge Irigaray, autrice di un testo dal titolo Quando le
nostre labbra si parlano129, a interrogarsi a fondo su questa immagine, su queste
labbra non appartenenti, da un lato, allo stesso sensibile (e dall’altro indice di una
identità tra il sensibile-corpo e il sensibile-mondo), che non si ritoccano come le
labbra del “nostro corpo”. Ma: il nostro, di chi?
Per Irigaray la singolarità del corpo femminile si scrive proprio nel
raddoppiamento delle labbra, in alto e in basso. Così il sensibile-corpo femminile
ritocca il sensibile da cui emerge (non: “il mondo” ma un altro corpo). “La donna
essendo donna e potenzialmente madre, in lei – scrive – le due labbra di cui parla
Merleau-Ponty possono ritoccarsi, in lei e tra loro, senza passare per il vedere. Le
due dimensioni di cui parla Merleau-Ponty sono nel corpo di lei” (p. 128). E’ in
questo modo che qui come altrove introduce differenze di corpi – o corpi differenti –
per mettere in evidenza le relazioni tra pensiero, discorso e morfologie dei corpi: “E
sarebbe una delle differenze tra uomini e donne, che queste labbra [quelle di
Merleau-Ponty] – continua infatti – non si congiungono seguendo la stessa
economia” (p. 128). Più economie, e la possibilità di una logica differente, sono in
gioco. Nascoste o rimosse dalla “reversibilità” intesa come verità ultima.
L’ipotesi di reversibilità di Merleau-Ponty è dunque letta come illusione di
reversibilità, profonda illusione della carne.
“Tradizionalmente l’uomo pretende di essere colui che vede, nel cui orizzonte,
da parte a parte, né la sua ‘propria’ visione dell’altro né lo sguardo dell’altro che lo
vede” – altro uomo/altro donna (l’altro del medesimo rispetto all’uomo) –
“aprirebbero alcuna apertura. Questa credenza, questa volontà di padronanza,
costituisce probabilmente una delle più fondamentali illusioni della carne. Lo
schermo o la corazza che vieta il postulato amoroso. E il postulato di un Dio al
tempo stesso invisibile e onnivedente, che supplisce allo sguardo cieco dell’altro” (p.
131) (Irigaray parla qui e soprattutto nei testi successivi di una “trascendenza”
corporea, carnale).
Luce Irigaray interpreta la reversibilità tra mondo ed io come evocazione e
ripetizione (è questo l’esercizio di sostituzione cui accennavo più sopra), “qualcosa
come una ripetizione del soggiorno prenatale, in cui l’universo e l’io sono
129 Cfr. Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso, Milano, Feltrinelli economica 1990 (ed.
originale Minuit, 1977), pp. 170-180.
un’economia chiusa, in parte reversibile [in parte: il cordone collega e separa, tiene
insieme separati, non c’è identità] (ma quasi in senso inverso, se la reversibilità ha
un senso: in utero il donante, l’hypokeimenon, è piuttosto dalla parte del maternofemminile, il futuro “soggetto” o vedente dalla parte del mondo o delle cose”) (p. 1323).
Bisogna ricordare che all’inizio del suo testo Merleau-Ponty, e Irigaray è una
lettrice molto attenta al lavoro retorico della lingua e alle metafore utilizzate, parla di
un vedente che “partorisce”, o “cova” le cose visibili130, in esso si esprime allora
qualcosa “di un lutto mai preso per la nascita, per il taglio della reversibilità
attraverso qualche cordone ombelicale (…) Mai solo, questo vedente [questo
soggetto] rimane continuamente nel suo mondo. Vi trova eventualmente dei
complici, non v’incontra mai altro/i” (ibid.).
Per la sua lettrice Merleau-Ponty individua qualcosa di importante, soprattutto
attraverso l’esplicitazione di un modo di esistere che definisce (benché con
prudenza e mettendo i termini tratti dal linguaggio psicanalitico, tra virgolette)
“incestuoso prenatale”. Indica qualcosa – anche: il luogo di questioni ancora da
pensare – ma ribadendo, il tradizionale privilegio della visione nella nostra cultura
può forse credere di accostarsi all’altro “senza essere immediatamente aperto dai
suoi sensi, di lui, di lei” (ibid.)
La visione per Irigaray consente a Merleau-Ponty di chiudere il circuito delle
relazioni e (p. 134) la sua analisi di essa risulta di fatto essere più approfondita e più
bella per un privilegio che gli viene conferito riprendendolo da una fenomenologia
del tattile.
Acquisisce così aspetti che la filosofia di solito trascura. Ma non viene meno
questo privilegio di chiudere che ne fa un “compimento dell’idea, dell’idealismo,
dando loro aspetti materiali carnali” (p. 134).
Si tratta allora di un parlare della “carne” che ne annulla le componenti più
potenti e creatrici. Che non sono di chiusura, fusione, totalizzazione.
L’UOMO, IL SOGGETTO, LA SOGGETTIVITA’
Un percorso possibile-pensabile?
(fra Husserl e Heidegger)
1. Fenomenologia, storia di un dissidio 1927
Gadamer parla di un “dialogo fra Heidegger e Husserl” che non sarebbe “mai
stato realizzato”. E’ a partire da qui che la nostra riflessione vuole prendere le
mosse, e lo vuol fare nel tentativo di cogliere una possibilità d’apertura della
riflessione fenomenologica ed ermeneutica.
130 Irigaray commenta: “Avvolgendo le cose con il proprio sguardo, il vedente le partorirebbe e/ma
sussisterebbe, in esse, il mistero del suo averle partorite. Esse contengono, ora, quel mistero di notte
prenatale in cui egli era palpato senza vedere. Passivo per sempre senza attivo. Più passivo di ogni
passività presa in una coppia passivo-attivo. Passività che tenta di rivoltarsi in attività modellando,
muovendo, la totalità del mondo in una reversione del soggiorno intrauterino. Tra questi due estremi
c’è interruzione. Il luogo dell’altro. Il vedente cerca di rimettere insieme il più passivo e il più attivo (…)
ma non può riuscirci. Soprattutto senza memoria di quell’avvenimento primo in cui e avvolto-toccato
da un invisibile tangibile dal quale di formano anche i suoi occhi ma che egli non vedrà mai: senza
vedente né visibile né visibilità in quel luogo” (p. 119).
Per fare ciò, noi prenderemo in esame inizialmente il testo Fenomenologia,
storia di un dissidio (1927). In esso, infatti si trova una sorta di “diario” degli eventi
che portarono alla frattura fra Husserl e Heidegger.
W. Biemel, nel 1950, portò l’attenzione della critica su questi materiali. La loro
pubblicazione nell’Husserliana risale al 1962 (vol. XI).
Questo aspetto non è di secondaria importanza in quanto già molto era stato
scritto sul rapporto fra i due, ma non ci si era mai soffermati direttamente sul “punto
di svolta” del rapporto. Vedremo in seguito di chiarire questo aspetto analizzando in
modo sommario la letteratura critica coeva e quella successiva.
Prima di tutto e, preliminarmente, è necessario appuntare il nostro interesse
sull’indicazione dell’anno riportata nel titolo: 1927.
A questa data la fenomenologia ha già posto le basi delle analisi successive e,
con le Ricerche logiche (1900-1901) e Idee I (1913), si è data le fondamenta
teoretico-metodologiche. E’ altrettanto vero che intorno agli anni ’20 si può collocare
una sorta di spartiacque nella fenomenologia stessa. Infatti fino ad allora si può
correttamente parlare di una fenomenologia descrittiva (analisi delle strutture della
coscienza ed elaborazioni metodologiche); dagli anni ’20 ci troviamo di fronte alla
determinazione di una fenomenologia genetica (emerge sempre più la necessità di
un confronto con il mondo-ambiente prima e con il mondo-della-vita dopo).131
Parallelamente, Heidegger sta concludendo l’insegnamento a Marburgo (dal
1928/29 sostituirà proprio Husserl a Friburgo). Qui vengono elaborati una decina di
corsi universitari che, partendo dalla stessa fenomenologia la radicalizzano aprendo
orizzonti di ricerca impensati. E’ da questo humus che proprio nel 1927 viene dato
alle stampe Essere e tempo.132 Ci troviamo quindi di fronte all’anno della
“consacrazione” di Heidegger ed ,ovviamente, la successione sulla cattedra di
Friburgo fa sì che si uniscano ai motivi teoretici anche motivi più strettamente
accademici.
Posti questi elementi come chiave di volta, vediamo di cogliere cosa si cela
dietro questo dialogo mai realizzato. Per fare ciò mi rivolgo qui proprio ad Heidegger.
Egli ha sempre considerato la fenomenologia come metodo filosofico e quindi, in
ultima istanza, come possibilità; essendo questa una “determinazione originaria”, va
da sé che essa rappresenti il fondamento stesso di ogni analisi.133 Lo stesso
silenzio134 calato sulla fenomenologia non è mai divenuto distanza od opposizione.
Anzi, proprio al termine della propria speculazione (fine anni ’60, inizio anni ’70),
Heidegger ha più volte affermato il proprio profondo legame con la fenomenologia e
Husserl. Cito qui due esempi: l’intervista a Der Spiegel (1966) dove Heidegger
definisce Husserl il suo «maestro»; il seminario di Zähringen (1973) dove scrive:
“Analogamente a come nel 1968 e nel 1969 si è tentato di accedere al problema
131 Per questo aspetto e soprattutto per le definizioni di fenomenologia descrittiva e fenomenologia
genetica si rimanda allo studio di R. Bernet – I. Kern – E. Marbach, Edmund Husserl, Bologna, il
Mulino, 1992
132 Per un’approfondita disamina di questo periodo si rimanda a Heidegger, a cura di F. Volpi, Milano,
Laterza, 1997
133 Per comprendere l’importanza della fenomenologia nella speculazione heideggeriana si rimanda a
M. Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1988 capitolo II, § 7 in cui si parla espressamente
del “metodo fenomenologico della ricerca”. Su questo aspetto torneremo anche in seguito.
134 A tale problema sarebbe necessario dedicare specificamente un lavoro, in quanto apre anche
tutta la controversa relazione fra Heidegger ed il nazionalsocialismo.
dell’essere partendo da Hegel e da Kant, questo accesso deve ora essere cercato a
partire da Husserl.”135
Ora, se è vero che la “questione del pensiero” è ciò che determina il “colloquio
con un pensatore”136, allora ci troviamo di fronte alla possibilità di un dialogo.
Per meglio comprendere il dissidio come possibilità di dialogo è necessario,
però, anche ripercorrere la critica che ha tentato di chiarire il rapporto fra Husserl e
Heidegger.
Breve storia della critica
Molto schematicamente possiamo dire che si possono individuare due linee
interpretative fondamentali137:
l pensiero di Heidegger come approfondimento interno della fenomenologia
l sempre più netto separarsi della riflessione husserliana da quella heideggeriana.
Questo sviluppo critico si viene determinando soprattutto dopo la fine del
secondo conflitto mondiale. Prima però di fare una breve carrellata su alcuni degli
esponenti più importanti di questo dibattito, vorrei soffermarmi sul testo di G. Misch,
Lebensphilosophie und Phänomenologie138. Innanzitutto, questo testo risale al
1930 e ciò è indicativo di come questo rapporto, subito dopo la rottura, avesse
determinato un motivo di riflessione. Ovviamente in quel contesto non potevamo che
trovarci di fronte ad una ricostruzione storico-filosofica, ma l’appartenenza di Misch
allo storicismo ci ha consegnato un lavoro che “cerca di analizzare i due pensieri da
una prospettiva diltheyana”.139 Questo è estremamente interessante perché, forse,
il debito che Husserl e Heidegger hanno nei confronti di Dilthey potrebbe fornire
elementi nuovi per la determinazione del problema del soggetto e della soggettività.
Tornando alla bipartizione di cui parlavamo prima, in ambito tedesco, troviamo
autori come O. Pöggeler140, il quale “ritiene che Heidegger abbia radicalizzato il
metodo fenomenologico e che il suo pensiero successivo, quello secondo lui
propriamente autentico, pur abbandonandolo per raggiungere una completa
autonomia, ne conservi almeno le tracce di principio. Heidegger si innesterebbe
sulla carenza ontologica della fenomenologia”.141
Di parere assolutamente opposto è H. Spiegelberg, 142 il quale sostiene che
“Heidegger inizialmente si confronta e si contrappone a Husserl, adottandone il
metodo per trasformarlo però completamente, ma nel periodo successivo alla
«svolta» abbandonerebbe in forma definitiva l’impostazione fenomenologica.” 143
135 M. Heidegger, Seminario di Zähringen, in Aut-Aut, Firenze, La nuova Italia, 1988, n° 223-224, p.28
136 M. Heidegger, Identità e differenza, in Aut-Aut, Firenze, La nuova Italia, 1982, n° 187-188
137 Per ciò che qui viene detto si rimanda al saggio di R. Cristin, La voce «fenomenologia» e gli anni
del dissidio, in E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, Milano, Unicopli, 1990
138 G. Misch, Lebensphilosophie und Phänomenologie, Bonn, Choen, 1930
139 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 16
140 Di O. Pöggeler ricordiamo qui: Heidegger und die hermeneutische Philosophie,
Freiburg/München, Alber, 1983 ed il fondamentale Il cammino di pensiero di Martin Heidegger, Napoli,
Guida, 1991
141 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit., p. 17
142 H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, 2 voll., Nijhoff, The Hague, 1982
143 Ivi p. 16-17
I
I
E veniamo a H. G. Gadamer, il quale, a buon diritto, è considerato il
continuatore della speculazione heideggeriana. Egli è convinto che “il tentativo
heideggeriano di superare la metafisica oltrepasserebbe di slancio anche la
fenomenologia trascendentale di Husserl, il cui «concetto dell’essere […] è proprio
quello della metafisica». E’ in questo quadro inoltre che Gadamer legge la Crisi delle
scienze europee come il tentativo di fornire «un’implicita risposta a Essere e
tempo».”144
In questa panoramica meritano un riferimento due allievi di Husserl: L.
Landgrebe e E. Fink.145
La posizione del secondo, che è andato via via allontanandosi dal sentiero
tracciato dal maestro, è comunque decisamente critica nei confronti di Heidegger
infatti “egli vede nell’Esserci un polo decisamente opposto a quello rappresentato
dalla fenomenologia della coscienza intenzionale, della quale non sarebbe una
sovrapposizione concettuale bensì una metamorfosi esistenziale radicalmente
diversa.”146
Discorso leggermente diverso va fatto per Landgrebe il quale tenta di porsi in
una prospettiva di “equidistanza valutativa” che, a mio parere, può consentire una
maggiore penetrazione nel rapporto fra Husserl e Heidegger. Infatti, da un lato critica
il modo semplicistico di Heidegger di sbarazzarsi della riduzione come retaggio
cartesiano ed anzi ne propone la sua utilizzazione come “appoggio di metodo” per le
riflessioni esistenziali di Essere e tempo; dall’altro critica l’assenza di “spessore”
esistenziale nel concetto di «essere» elaborato da Husserl.
La riflessione su Husserl e Heidegger ha varcato i confini tedeschi molto
rapidamente.
Uno dei luoghi in cui ha avuto larga diffusione è sicuramente la Francia. Qui la
cultura di un cinquantennio ha subito l’influsso di questi filosofi.
Contemporaneamente, però, il contesto culturale francese ha determinato una
“deriva” della fenomenologia e della ontologia fenomenologica assolutamente
particolare. Questa “deriva” potremmo definirla «esistenzialistica».
Vediamo di chiarire questo concetto.
Innanzitutto gli esponenti di maggior spicco possono essere identificati in: E.
Lévinas, M. Merleau-Ponty, J. P. Sartre e J. Derrida.147
Posto di riguardo spetta sicuramente a E. Lévinas il quale ha il merito di
dedicare, per primo in Francia, uno studio a E. Husserl: La théorie de l’intuition dans
la phénoménologie de Husserl.148
E’ però sicuramente in Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger (la cui
prima edizione in Francia risale per altro al 1949) che si delinea la prospettiva di
144 Ivi p. 18 Per le citazioni si rimanda a H. G. Gadamer, “Die phänomenologische Bewegung”
Philosophische Rundschau, ½, 1963
145 Per ciò che concerne le problematiche di cui ci stiamo occupando si rimanda a: L. Landgrebe,
Itinerari della fenomenologia, Torino, Marietti, 1974. Id., Die Bedeutung der Phänomenologie Husserl
für die Selbstbesinnung der Gegenwart, in AA. VV., Husserl et la Pensée Moderne/Husserl und das
Denken der Neuzeit, Nijoff, Den Haag, 1959. Inoltre E. Fink, Welt und Geschichte, in AA. VV., Husserl
et la Pensée Moderne/Husserl und das Denken der Neuzeit, cit.
146 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p.19
147 Mi rendo conto che con questa elencazione si perdano tante sfaccettature dell’approccio culturale
francese al pensiero di Husserl e Heidegger. L’intento, però, qui, è quello di tracciare un percorso
minimo e quindi ci limitiamo a questi “nomi propri”
148 Di E. Lévinas, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Alcan, 1930; e
soprattutto in riferimento al rapporto Husserl – Heidegger: Id. Scoprire l’esistenza con Husserl e
Heidegger, Milano, Raffaello Cortina, 1998
Lévinas. Infatti “fenomenologia e ontologia vengono rielaborate all’interno di una
filosofia dell’«alterità» con spiccate connotazioni etiche.”149
Per quel che concerne M. Merleau-Ponty150 possiamo dire che inscrive la
riduzione trascendentale “in un quadro ontologico-esistenziale, dove la riduzione
conduce all’anti-idealistica dimensione del vissuto.”151
E’ sicuramente J. P. Sartre152 che, con L’essere e il nulla e L’esistenzialismo è
un umanismo, introduce una lettura dell’Esserci in chiave «esistenzialista». Con
essa polemizzerà lo stesso Heidegger.
Discorso leggermente diverso bisogna fare per Derrida. Egli intanto appartiene
alla generazione successiva e la sua riflessione, pur essendosi nutrita di questo
humus, ha sicuramente assunto prospettive differenti. Mi riferisco qui specialmente a
la différance e Fini dell’uomo.153 Sicuramente, ciò che è maggiormente
interessante, e che ha caratterizzato soprattutto l’inizio della speculazione
derridiana, è il tentativo di una lettura parallela e reciprocamente chiarificante di
Husserl e Heidegger.
Arriviamo così al panorama della critica in Italia. Tanti sarebbero i nomi, ma per
una più chiara esposizione mi limito qui a considerare P. Chiodi, E. Paci e L.
Pareyson.
La grande importanza di Chiodi154 è indiscutibilmente legata alla traduzione di
Essere e tempo, alla quale facciamo tuttora ricorso essendo l’unica disponibile in
italiano. La posizione di Chiodi, però, si innesta in quella direzione esistenzialista
“che sostiene l’inseparabilità di fenomenologia ed esistenzialismo”. 155 Va da sé che
ci troviamo di fronte ad un serio problema interpretativo.156
A questa lettura possiamo affiancare quella di Pareyson, il quale sostiene che
“la dimensione esistenzialistica costituirebbe l’allargamento di senso della
fenomenologia, superata nel suo razionalismo; l’esistenza e l’accesso ermeneutico
al suo orizzonte sarebbero i poli della riflessione filosofica.” 157 E’ superfluo far
notare come proprio dagli studi di Pareyson, Vattimo inizierà il suo cammino di
pensiero che si affermerà nella prospettiva del “pensiero debole”.
149 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p.21
150 Di M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano, il Saggiatore, 1965; e Id., Il filosofo
e la sua ombra, in Id., Segni, Milano, il Saggiatore, 1967
151 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p.21
152 J. P. Sartre, L’essere e il nulla, Milano, Mondadori, 1958; Id., L’esistenzialismo è un umanismo,
Milano, Mursia, 1963
153 J. Derrida, la différance e fini dell’uomo, si trovano in Id., Margini della filosofia, Torino, Einaudi,
1997
154 Di P. Chiodi, Esistenzialismo e fenomenologia, Milano, Edizioni di comunità, 1963; ed inoltre Id.,
Husserl e Heidegger, in Rivista di filosofia, n° 52, 1961
155 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 22
156 Mi riferisco qui ad un dibattito apparso su Informazione filosofica nel mese di maggio del 2000. In
essa sono presenti due articoli che si occupano specificamente della traducibilità del pensiero di
Heidegger. Nel primo, che è un’intervista a K. Held presidente della Deutsche Gesellschaft für
phänomenologische Forschung si parla espressamente del problema della traducibilità del detto
heideggeriano ed husserliano; nel secondo di A. Marini, La nuova traduzione di Essere e tempo, si
afferma esplicitamente la necessità di giungere ad una nuova traduzione di questa opera, in cui si torni
a Husserl, a Nietzsche ed all’ambiente culturale in cui si è formato Heidegger.
157 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p.23
Per quel che concerne Paci158, invece, la posizione è quella fenomenologica
più ortodossa e quindi di critica alla speculazione heideggeriana, tant’è che egli
pensa a quest’ultima come ad una “caduta nello psicologismo e nell’antropologismo,
dove la tematica dell’essere sarebbe una «feticizzazione dell’intenzionalità
husserliana». L’esistenzialismo dovrebbe quindi essere ricondotto al suo piano
originario; quello della fenomenologia trascendentale.”159
Con ciò possiamo dire di aver ultimato questo breve excursus sulla “critica
storica” ad Husserl ed Heidegger. Dagli anni ’80 è venuta maturando una nuova
impostazione del problema che ci sembra assolutamente più ricca di possibilità
d’apertura per la riflessione. Proprio su questa ci concentreremo ora. Essa non
presuppone più una totale rottura, una incomunicabilità totale, ma, stimolata dallo
stesso Heidegger, tende a ricercare “il dialogo sotterraneo in tutta la sua doppia
struttura, ascoltando con attenzione entrambe le fonti”. 160
In questa prospettiva acquisiscono un’importanza capitale proprio quei corsi di
Marburgo di cui abbiamo parlato precedentemente. E’ nel loro sviluppo, nelle loro
articolazioni, che forse è possibile cogliere quel dialogo mai realizzato.
Per quanto concerne questa linea interpretativa ci rivolgiamo qui
espressamente a F. W. von Herrmann. Allievo ed assistente di E. Fink, che è stato
poi collaboratore personale di Heidegger e curatore della Gesamtausgabe. Questo
aspetto è fondamentale in quanto von Herrmann ricevette l’incarico dallo stesso
Heidegger di pubblicare, come primo volume dell’edizione definitiva delle sue opere,
I problemi fondamentali della fenomenologia. Questa indicazione che diverrà
pubblica nel 1975 è ovviamente oggi una prospettiva di ricerca, un sentiero tracciato
al quale non possiamo sottrarci.
Ora, se è necessario riannodare questi fili, nel tentativo di ridefinire una
riflessione che non vuole più scindere fenomenologia husserliana ed ontologia
heideggeriana, è chiaro che la linea interpretativa dovrà essere rivolta al reciproco
chiarimento concettuale. Va da sé che il dissidio diverrà possibilità di dialogo e di
chiarificazione.
In questa prospettiva von Herrmann ne Il concetto di fenomenologia in
Heidegger e Husserl161 scrive: “la nuova determinazione che Heidegger fornisce
dell’oggetto tematico della filosofia, delimitandolo nei confronti di Husserl, conduce
anche ad un nuovo disegno del concetto di «metodo fenomenologico», nella
salvaguardia però di un ambito comune.”162
Questa tendenza si è manifestata anche sul versante husserliano della ricerca,
tant’è che “le Phänomenologische Forschungen, vale a dire i quaderni della
Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung hanno proposto nel 1983
un numero dedicato a Zeit und Zeitlichkeit bei Husserl und Heidegger”163. Esso
voleva essere un avvicinamento complessivo alle tematiche dei due filosofi. Proprio
da questi presupposti, lo stesso W. Biemel ha tentato di strutturare una
«connessione complessiva» fra Husserl e Heidegger.
158 Di E. Paci, Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl, Bari, Laterza, 1961; Id., Idee per una
enciclopedia fenomenologica, Milano, Bompiani, 1973; e Id., In margine ad Heidegger, in Aut-Aut, n°
45, 1958
159 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 23
160 Ibidem
161 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, Genova, il Melangolo,
1997
162 Ivi., p. 28
163 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 27
E’ da qui che vuole prendere le mosse il lavoro sul dissidio che presentiamo.
Il dissidio: soggetto ed esserci
F. W. von Herrmann in Subjekt und Dasein scrive: “Nella misura in cui la
fenomenologia di Husserl […] è certamente un approfondimento, ma non un
superamento della moderna impostazione del problema della soggettività, Essere e
tempo deve anche essere interpretato come confronto con l’impostazione
coscienzialistica di Husserl.”164
Con questa riflessione vorrei portare l’attenzione sul fatto che proprio sul
soggetto, la soggettività e la possibilità stessa di ripensarle, si è giocata gran parte
della vicenda relativa al dissidio fra Husserl e Heidegger.
Nel 1916 Heidegger si reca a Freiburg per studiare con Husserl, ma solo nel
1919 il rapporto si intensifica. Da questo momento, e fino alla fine del 1928, vi è una
costante collaborazione.
E’ molto complesso chiarire ogni aspetto della vicenda, in quanto non vi è una
completa documentazione di tutti gli eventi. Vi sono però una serie di elementi che
possono servirci da guida.
Innanzitutto Husserl. Con il 1913, data di pubblicazione di Idee I, il pensiero
fenomenologico ha assunto importanza internazionale. Inizia così un periodo di
grande elaborazione personale delle proprie acquisizioni che sappiamo porterà ad
uno spostamento della fenomenologia: da quella descrittiva a quella genetica. Vi è
però un evento importante: la pubblicazione separata della VI Ricerca logica (1921),
che va ad ampliare e ridefinire l’opera pubblicata nel 1900. A volere fortemente
questa pubblicazione sono gli allievi ed amici di Husserl ed in particolar modo
Heidegger. Dobbiamo arrivare al 1928 per trovare una nuova pubblicazione: la
raccolta delle Lezioni sulla coscienza interna del tempo di Gottinga. Qui il curatore è
lo stesso Heidegger. Non dobbiamo però farci trarre in inganno da questo dato.
Sicuramente Heidegger, subito dopo la pubblicazione di Essere e tempo non poteva
che essere interessato alla prospettiva husserliana, ma la genesi dell’opera,
accuratamente ricostruita da R. Boehm, ci mostra anche il distacco già in atto. Infatti
se da un lato Heidegger decide di curare tale edizione, è altrettanto vero che
dichiara un’impossibilità ad operare una vera e propria rielaborazione dei materiali,
questo causato dagli impegni gravosi di ricerca apertisi dopo Essere e tempo.165 Si
decide quindi di utilizzare il materiale già approntato anni prima da E. Stein.
Anche per ciò che concerne Heidegger le pubblicazioni sono quasi inesistenti
fra il 1916 ed il 1928, ma si sta sviluppando un intenso lavoro di ricerca e
seminariale che lo porterà ad un sempre più serrato confronto proprio con Husserl.
Questa intensa attività culmina con il periodo di Marburgo (1923-1928) in cui, in
una serie di corsi universitari, “soggetto, tempo, verità, concetto di fenomeno: tutti i
capisaldi della fenomenologia subiscono una puntigliosa critica e una radicale
trasformazione.”166 Inoltre, da questo orizzonte di ricerca prenderà forma proprio
Essere e tempo (1927).
164 F.W. von Herrmann, Subjekt und Dasein, Frankfurt/Main, Klostermann, 1974
165 Per un approfondimento relativo a tali problematiche si rimanda a R. Boehm, Introduzione, in E.
Husserl, Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, Milano, Franco Angeli, 1992
166 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 30
Apparentemente potremmo pensare ad un progressivo distanziarsi dei due, in
realtà vi è tutta una serie di lettere e testimonianze che invece escluderebbero
questa modalità di decorso. Infatti, Husserl fino al 1928 usa espressioni come: “Lei
(Heidegger) e io siamo la fenomenologia” o ancora “La fenomenologia, siamo io e
Heidegger.”167 Questo farebbe pensare ad un Husserl convinto che, nonostante le
divergenze, l’allievo sia ancora a tutti gli effetti inserito nella corrente
fenomenologica, anzi ne sia uno degli esponenti più importanti.
Contemporaneamente Heidegger, pur procedendo criticamente, imposta tutto il suo
lavoro a partire da presupposti fenomenologici. Senza dimenticare che proprio
Essere e tempo, nella sua prima edizione, sarà pubblicato con la dedica a Husserl.
Si potrebbe così pensare ad una frattura improvvisa, ma anche questa
interpretazione non rende appieno questo periodo molto denso dal punto di vista
speculativo sia per Husserl che per Heidegger.
Veniamo così a quello che è il vero e proprio punto di rottura: la stesura della
voce fenomenologia per l’Encyclopaedia Britannica.
Nella primavera del 1926 Husserl e Heidegger discutono insieme, a
Todtnauberg, le tesi di Essere e tempo che verrà pubblicato nel 1927. In quello
stesso anno Husserl da corso al progetto di redigere, a quattro mani e proprio con
Heidegger, la voce fenomenologia. Già qui si aprono diverse problematiche che non
possono che suscitare illazioni. Per quale ragione Husserl sceglie, ancora nel 1927,
dopo la chiara deriva heideggeriana, di lavorare con il proprio “allievo eretico”? E’ un
tentativo di ricondurre Heidegger sui sentieri fenomenologici ortodossi, o Husserl ha
colto degli aspetti non trascurabili nella riflessione dell’allievo? Sicuramente la prima
ipotesi è la più plausibile; ma non possiamo scartare completamente la seconda.
Per prima cosa Husserl redige un testo provvisorio in due momenti successivi.
Su questo Heidegger riflette e rimanda ad Husserl un elaborato che introduce “la
problematica da un’angolazione diversa da quella husserliana.” 168 Questa risposta
ha un titolo significativo: L’idea della fenomenologia e il ritorno alla coscienza. A
questo punto Husserl cerca di ricomporre i materiali suoi e di Heidegger, ma ad una
ulteriore verifica, decide di redigere una terza versione, che avrebbe dovuto essere,
negli intenti dell’autore, quella definitiva; in realtà risolve “ apparentemente senza
dubbi, di impostare l’articolo in maniera tale che possa costituire un «filo conduttore
utilizzabile per la serie delle pubblicazioni a seguire, soprattutto per le parti di Idee
II». Della stratificazione concettuale che la successione dei testi lascia vedere,
l’articolo nella sua forma definitiva non reca alcuna traccia visibile.”169
E’ con questo atto che Husserl prende su di sé l’intera responsabilità della
fenomenologia ed esclude dalla redazione della voce per l’Encyclopaedia Britannica
qualsiasi influenza esterna.
Per chiarire una tale decisione citerei qui due passaggi di due lettere. Nella
prima del 16 ottobre 1927 scritta da Husserl a R. Ingarden, è lo stesso Husserl ad
augurarsi che almeno Heidegger giunga a “cogliere il complesso delle mie
intenzioni.”170 A questa fa quasi da contrappunto quella scritta pochi giorni dopo da
Heidegger a Husserl (22 ottobre 1927) in cui l’allievo chiede al maestro un confronto
proprio su Essere e tempo per “fissarne i punti essenziali” e far emergere la diversità
d’impostazione. E’ quindi qui, fra queste lettere che si concretizza il dissidio.
167 Espressioni riportate da D. Cairns, Conversation with Husserl and Fink, The Hague, Nijhoff, 1976;
e H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, 2 voll., The Hague, Nijhoff, 1982
168 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 33
169 Ivi., p. 33-34
170 Ivi., p. 32
Concludendo, è proprio in questi documenti che si concretizza storicamente il
fra, il frammezzo, la differenza fra Husserl e Heidegger. Essa diverrà per anni, vera e
propria impossibilità di dialogo.
dio nel suo darsi teorico-teoretico
Dopo aver sondato l’orizzonte storico in cui si colloca tale problematica,
vediamo di chiarire le divergenze teorico-teoretiche. Esse ovviamente si concentrano
tutte in quei documenti preparatori che oggi costituiscono il volume IX
dell’Husserliana.171
Vorrei concentrarmi qui su alcuni passaggi che ritengo fondamentali per le
problematiche che ci siamo posti. Dobbiamo prima di tutto precisare che ci stiamo
riferendo alla seconda versione di E. Husserl, Der Encyclopaedia Britannica Artikel.
In esso troviamo il vero e proprio dipanarsi del dissidio in una sorta di
contrappuntistico confronto fra l’impostazione husserliana e le note heideggeriane.
Husserl scrive: “«[la mia impostazione del problema] esige la riduzione al piano
di validità che presuppone questo problema come tale: la soggettività pura in quanto
fonte del senso e della validità. Io non ho dunque, in quanto fenomenologo
trascendentale, il mio ego come psiche, parola che già presuppone nel suo senso
un mondo essente o possibile, ma possiedo quell’ego trascendentalmente puro in
cui anche questa psiche, con tutto il suo senso trascendente, ottiene, a partire da
nascoste operazioni di coscienza, il senso e la validità che essa ha per me»”. 172
Quindi ci troviamo di fronte ad una riduzione eidetica volta al conseguimento di una
soggettività trascendentale, unica via d’accesso al senso ed alla validità in quanto
tale. Validità e senso che sono per me. E’ quindi solo da qui, secondo Husserl che
mondo, psiche, storia assumono il loro senso. Heidegger commenta: “«ma
all’essenza dell’ego puro non appartiene forse un mondo in generale? Cfr. il nostro
colloquio di Todtnauberg [1926] riguardo all’«essere-nel-mondo» (Essere e tempo
vol. I, § 12, § 69) e alla differenza essenziale con l’essere semplicemente presente
«all’interno» di un tale mondo».173
Si concretizza in queste poche righe tutta la distanza heideggeriana e
soprattutto la diversa impostazione del problema. Infatti l’idea dell’ego puro, per
Heidegger, diviene una dimensione di semplice presenza «all’interno» del mondo
come orizzonte. E’ solo reimpostando la riflessione a partire dall’esserci ed al suo
de-finirsi come essere-nel-mondo che si può ripensare una relazione reale (real) fra
soggetto e mondo, fra soggetto ed oggetto, se questi termini hanno ancora un
significato. E’ quindi evidente che l’impianto riduzionistico è per Heidegger un punto
debole della riflessione fenomenologica. Con esso viene criticato indirettamente e
direttamente il soggetto trascendentale.
A questa presa di posizione Husserl risponde: “«l’ego ridotto è certamente il
mio io nella totale concrezione della mia vita […] ma è anche il presupposto assoluto
per qualsiasi trascendenza per “me” valida»”.174 Questa risposta di Husserl, che è
171 E. Husserl, Phänomenologische Psychologie, Husserliana vol. IX, Den Haag, Nijoff, 1962
172 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 36
173 Ibidem
174 Ivi., p. 37
rivolta a riaffermare una relazione fondante e significante fra la “mia vita” e la
possibilità “per me” della trascendenza, in realtà è anche la dichiarazione che pone
in essere una relazione d’essere e sulla quale non si pone un’interrogazione
fondamentale. Infatti Heidegger obietta: “Come può il soggetto fattuale perdere i suoi
contorni esistenziali, psychisch wie somatisch, arrivare all’ego puro ed essere
[sottolineatura mia] ancora «nella totale concrezione della vita»?” 175 E’ chiaro che
per Heidegger “il mistero della soggettività non è indagabile per via chirurgica: il
senso del suo essere va colto a partire dall’essere stesso.” 176 In altre parole è
espressa qui la necessità di porre nuovamente il problema a partire dall’essere, da
quell’ontologia fondamentale che ha nella fenomenologia il suo metodo, la sua
possibilità, ma che a partire da essa deve risalire al “detto originario”.
Su questo aspetto, il dialogo continua nel tentativo reciproco di chiarimento,
che si traduce in esplicitazione del metodo riduzionistico da parte di Husserl e
tentativo di mostrare, proprio nella riduzione, la ricaduta nella metafisica della
presenza da parte di Heidegger.
"E' in questo modo [mediante la riduzione] che io posso e devo ottenere scrive Husserl - perfino la mia attività psicologica, il mio intero lavoro scientifico, in
breve, tutto ciò che mi è inerente in maniera pura dal punto di vista soggettivo. Ma
nell'abitualità dell'atteggiamento psicologico, che noi definiamo la positività di tale
atteggiamento risiede appunto il fatto che [...] viene realizzata l'appercezione del
mondo"177
Heidegger obietta: "Semplicemente presente! [Vorhandenes]. Ma l'Esserci
umano «è» tale che, sebbene sia un ente, non è mai solo semplicemente
presente"178
Di nuovo ci troviamo su sentieri "divergenti" (che nel tra-dursi si fraintendono?).
La riduzione trascendentale che Husserl vuole applicata anche al soggetto per la
fondazione della psicologia pura, secondo Heidegger è impraticabile. Essa infatti,
oltre al fatto che non farebbe altro che condurre ad un'ostensione della soggettività
pura come semplice presenza, farebbe perdere quello "spessore imponente" che
l'Esserci ha nel suo essere come non-mai semplicemente presente, ma sempre
gettato nel-mondo e coimplicato con la temporalità. Parlando di "semplice presenza"
o di "esistenza", si apre un orizzonte di riflessione su cui molto è stato detto, ma
ancora molto vi è da dire. Infatti non è forse così che emerge in tutta la sua
enigmaticità il problema del tempo, della temporalità e della temporalizzazione? La
semplice presenza, infatti, non è che una modalità di temporalizzazione. Ma in essa
l'orizzonte è come ridotto ad un'unica dimensione, schiacciato, perso, obliato.
In questo contesto quindi si impone - secondo Heidegger - la necessità di
"ripensare «in modo più originario» la fenomenologia e a partire da qui, confrontarsi
con il pensiero occidentale."179
E' evidente quindi che i due filosofi appaiano su "sentieri" completamente
diversi.
Vi è però qualcosa di più in queste pagine, infatti anche la critica lapidaria
mossa ad Husserl è tutt'altro che conclusiva, tant’è che nell'ultima (la quarta) stesura
della voce fenomenologia lo stesso Husserl scrive: “L'epoché universale riguardo a
175 Ibidem
176 Ibidem
177 Ivi., p. 38
178 Ibidem
179 Ivi; p. 44
quel mondo che diventa presente alla coscienza (la sua «messa fra parentesi»)
esclude dal campo fenomenologico il mondo semplicemente essente per il soggetto
in questione, e al suo posto subentra il mondo presente alla coscienza in maniera
determinata «come tale», il «mondo fra parentesi» (il mondo percepito, ricordato,
giudicato, pensato, valutato, ecc.) o, il che è lo stesso, al posto del mondo (ovvero
della singola cosa meramente mondana) subentra il singolo senso della coscienza
nei suoi diversi modi (senso della percezione, senso del ricordo ecc.)”. 180
In esso è evidente come Husserl non parli del subentrare di un mondo
“semplicemente presente”, tutt'altro, egli ci dice del “mondo presente alla coscienza"
e specifica che esso è "il mondo percepito, ricordato, giudicato, pensato, valutato
ecc.” E' quindi evidente un tentativo di reinserire uno spessore che forse l'epoché di
Idee I aveva schiacciato. Inoltre, come in una sorta di prefigurazione ci viene
anticipata quella che sarà la determinazione del rapporto fra soggettività ridotta ed il
suo mondo-della-vita, argomento centrale nella Crisi.
A questo punto appare evidente che le due prospettive divengono inconciliabili
e questo porta ad un irrigidimento di entrambi sulle proprie posizioni. Il dialogo
diviene così irrealizzabile. Da un lato Heidegger si arrocca sulla sua traduzione/fraintendimento della riduzione fenomenologica; dall’altro Husserl rimane
invischiato in una lettura antropologica di Heidegger.
Il 26 dicembre 1927 Husserl scrive ad Ingarden: “Heidegger non ha colto il
senso complessivo del metodo della riduzione fenomenologica”.181 E Heidegger,
facendo un bilancio di quel periodo nell’intervista a Der Spiegel dice: “Le differenze,
oggettivamente, si accentuarono. All’inizio degli anni ‘30 Husserl liquidò
pubblicamente Max Scheler e me in termini che in quanto a chiarezza non
lasciarono nulla a desiderare.”182
Nel dicembre del 1927 è a tutti gli effetti conclusa la collaborazione fra Husserl
e Heidegger.
Restano ora due punti importanti da analizzare per comprendere meglio il
dissidio. Da un lato le glosse che Husserl scrive sulla sua copia di Essere e tempo;
dall’altro, per tentare un possibile dialogo a posteriori fra Husserl e Heidegger il
saggio di F. W. von Herrmann su Il concetto di fenomenologia in Husserl e
Heidegger.
1.
Le glosse a Heidegger
Come abbiamo già detto in precedenza, rifacendoci a testimonianze epistolari,
Husserl ricevette copia di Essere e tempo nella primavera del ’26. E’ però solo nel
1929 che procede ad una lettura sistematica apponendo le glosse a margine del
testo. Solo alcune di queste, infatti, risalgono al 1927.
Questo elemento è un problema dal punto di vista filologico. Infatti, per quale
ragione Husserl riprende solo nel 1929 il lavoro di Heidegger? Si è reso conto solo a
posteriori della distanza e “pericolosità” del testo per la fenomenologia? Quale senso
profondo hanno queste glosse?
Per ciò che concerne i primi due interrogativi credo che qualsiasi risposta ci
farebbe comunque rimanere nel campo delle supposizioni. Per ciò che concerne la
terza, invece, credo che dalla stessa lettura si possa tentare di formulare qualche
risposta significativa.
180 Ivi; p. 86
181 Ivi, p. 42
182 M. Heidegger, Ormai solo un Dio ci può salvare, Parma, Guanda, 1992, p. 117
Premetto che tutta la lettura di questo documento è interessante e sarebbe
opportuno farla in parallelo con quella di Essere e tempo. Dati i limiti di tempo e
spazio, però, mi concentrerò qui su alcuni passaggi significativi per questo lavoro.
Innanzitutto il concetto di fenomenologia. Heidegger in Essere e tempo scrive:
“Il termine «fenomenologia» non denota l’oggetto delle sue ricerche, né caratterizza
il titolo di ciò in cui consiste il suo contenuto reale. La parola si riferisce
esclusivamente al come viene mostrato e trattato ciò che costituisce l’oggetto di
questa scienza. Scienza dei fenomeni significa: un afferramento dei propri oggetti
tale che tutto ciò che intorno ad essi è in discussione sia mostrato e di-mostrato
direttamente.”183
All’interno del § 7, accanto a questa definizione che indica “il metodo
fenomenologico della ricerca” e nello specifico “il concetto preliminare di
fenomenologia”, Husserl, dopo aver sottolineato da “«fenomenologia»” a “ricerche”,
annota: “Fenomenologia però in quanto scienza universale dei fenomeni in generale.
Se si intende il fenomeno come apparizione-di (Erscheinung-von), la scienza
universale dei fenomeni, che diviene necessariamente scienza universale di ciò che
appare in quanto tale, è allora al contempo equivalente alla fenomenologia nell’altro
senso, o il che è lo stesso, all’ontologia (dato che Heidegger definisce il fenomeno
«positivamente»)”.184 Quello che fa emergere qui Husserl, e che in parte
caratterizza la critica ad Essere e tempo è proprio, a suo avviso, una sorta di
“indifferenziato” nel senso di non tematizzato, di una complicazione legata ad una
scarsa definizione concettuale ed una prospettiva iniziale differente: la definizione
del fenomeno di tipo «positivo».
Questa problematica è ancor più evidente se si considera la nota che affianca
le prime pagine dell’analitica esistenziale. Infatti accanto al passo heideggeriano che
cita: “Ma in quanto l’esistenza determina l’Esserci, l’analitica ontologica di questo
ente richiede sempre una considerazione preliminare dell’esistenzialità. Ma questa è
da noi intesa come la costituzione d’essere dell’ente che esiste. Ma nell’idea di una
costituzione d’essere di questo genere, si trova già l’idea dell’essere. Di
conseguenza, anche la possibilità dell’espletamento dell’analitica dell’Esserci viene a
dipendere dall’elaborazione preliminare del problema del senso dell’essere in
generale.”185 Husserl commenta: “Heidegger traspone o travasa la chiarificazione
fenomenologica-costitutiva di tutte le regioni dell’ente e dell’universale, la regione
totale «mondo», sul piano antropologico; l’intera problematica è una trasposizione
(übertragung): all’ego corrisponde l’esserci ecc. Tutto diviene qui profondamente
oscuro e perde il suo valore filosofico.”186 Ecco quindi come Husserl, da un lato
sottolinei questa “oscurità” del detto heideggeriano, questo “scarso valore filosofico”,
dall’altro tenti di far emergere come tutte le problematiche heideggeriane siano state
semplicemente “trasposte” dalla fenomenologia. La fenomenologia aveva già posto
questi temi senza cadere nel vizio dell’”oscurità” concettuale.
Vi è però qui un passaggio molto importante: Husserl scrive: “all’ego
corrisponde l’esserci”. Husserl è quindi convinto che fra l’ego fenomenologico e
l’esserci vi sia una vera e propria trasposizione, una corrispondenza. In realtà tale
prospettiva è dettata dalla differenza d’impostazione che già abbiamo rilevato
proprio relativamente alla tematizzazione del soggetto, della soggettività e del loro
rapporto con l’esserci. Più in generale si può dire che è proprio la possibilità del
183 M. Heidegger, Essere e tempo, Torino, UTET, 1986, p. 95
184 E. Husserl, glosse a Heidegger, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 68-69
185 M. Heidegger, Essere e tempo, Torino, cit., p. 67
186 E. Husserl, glosse a Heidegger, cit., p. 64
rapporto fra soggetto e oggetto, ed in particolare il “come” di tale possibilità, che
diviene il punto di scontro fra i due. Infatti nell’apertura del secondo capitolo
(L’essere-nel-mondo in generale come costituzione fondamentale dell’esserci)
Heidegger scrive: “L’affermazione, oggi molto in uso, che «l’uomo ha il suo mondoambiente», non significa nulla ontologicamente finché questo «avere» rimane
indeterminato. Quanto alla sua stessa possibilità, l’«avere» è fondato nella
costituzione esistenziale dell’in-essere. Soltanto perché in possesso di questa
essenziale costituzione, l’Esserci può scoprire esplicitamente l’ente che incontra nel
mondo-ambiente, saperne qualcosa, disporne e avere un «mondo».”187 E Husserl
annota: “Ma si può incontrare solo ciò che si è costituito, e ciò offre le strutture più
profonde di un avere-il-mondo, di un essere mondano, di un io.”188 Quindi il
tentativo è quello di una lettura che riporti l’esserci in una dimensione
coscienzialistica, che riduca l’esserci ad io. Questa prospettiva è ancor più chiara
poche righe dopo. Infatti quando Heidegger definisce la costituzione fondamentale
dell’Esserci come “esser già sempre aperto alla propria comprensione d’essere in
virtù del proprio essere stesso”,189 poche righe dopo afferma che è mediante tale
costituzione d’essere dell’Esserci che, l’Esserci stesso, “comprende ontologicamente
se stesso (e quindi anche il proprio essere-nel-mondo) innanzi tutto a partire
dall’ente (e dall’essere di esso) che esso non è e che esso incontra «all’interno» del
suo mondo.”190 Husserl è assolutamente lapidario: “Nella costituzione dell’uomo, in
quanto costituzione di una realtà che è in sé personale, risiede quella difficoltà che
può essere superata solo grazie alla chiarificazione della costituzione (Kostitution) e
della riduzione fenomenologica.”191 Di nuovo, si afferma come per giungere alla
costituzione dell’uomo sia necessario approdare a quella riduzione fenomenologica
tanto avversata da Heidegger.
Penso risulti evidente anche da questi pochi passaggi, come il parlare di
“trasposizione” del pensiero sia assolutamente riduttivo, infatti credo che qui sia in
gioco molto di più, ossia il differire del pensiero stesso che è possibilità di apertura
della riflessione, meglio ancora compito stesso del pensiero.
A questo proposito uno degli allievi di Husserl, E. Fink, è molto chiaro: “Si
spiega volentieri il concetto heideggeriano dell’Esserci umano come una
“concretizzazione” dell’astratto concetto di coscienza di Husserl. In tal modo
vengono fraintesi entrambi i pensatori. L’essenza umana è pensata da Heidegger in
un modo radicalmente diverso. Non si tratta innanzitutto del rapporto intenzionale di
un soggetto conoscente con gli oggetti circostanti, ma dell’apertura preliminare
dell’uomo all’essere.”192
E’ evidente quindi che ci troviamo di fronte a due modi differenti di porre il
problema del soggetto e della soggettività. Da un lato Husserl ci porta a privilegiare,
nella relazione soggetto-oggetto, il primo elemento, che però ha attraversato la
riduzione fenomenologica e pone e si pone sempre intenzionalmente nei confronti
dell’oggetto. Dall’altro, Heidegger, posta sotto accusa proprio la riduzione
187 M. Heidegger, Essere e tempo, Torino, cit., p. 127
188 E. Husserl, glosse a Heidegger, cit., p. 72
189 M. Heidegger, Essere e tempo, Torino, cit., p. 128
190 Ibidem
191 E. Husserl, glosse a Heidegger, cit., p. 72
192 E. Fink, Welt und Geschichte, in AA. VV., Husserl et la Pensée Moderne/Husserl und das Denken
der Neuzeit, cit.
fenomenologica, non pone più un soggetto o il soggetto, ma la possibilità di questo
di darsi come apertura preliminare sull’essere. Allora il soggetto non potrà più essere
semplicemente un io ma diverrà un Esserci.
Di fronte a tutto questo è ancora possibile parlare di dialogo? A mio avviso sì. E
sono gli stessi Husserl e Heidegger a fornirci una indicazione in tal senso.
Infatti, Heidegger, come abbiamo visto, al termine del suo Denkweg riapre il
confronto (forse mai concluso) con il “maestro”;193 e Husserl, in una lettera a K.
Löwith “dove precisa il proprio sforzo filosofico, spiega come proprio la lettura della
Crisi potrà chiarire come mai «Scheler, Heidegger e tutti i primi “allievi” non hanno
né compreso il senso autentico e profondo della fenomenologia, e precisamente
della fenomenologia trascendentale come l’unica possibile, né quanto dipenda da
questo senso».”194 E’ chiaro che proprio nella Crisi si svela una sorta di risposta
indiretta proprio alle critiche di Heidegger, ma soprattutto la fenomenologia assume
tutto il proprio senso a partire dal suo ultimo darsi. In questo stesso darsi vi è quindi
l’estremo tentativo di chiarire ai propri “allievi” i loro fraintendimenti, le loro traduzioni,
e, forse, di riaprire ermeneuticamente un confronto con loro.
2.
Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl
Fenomenologia della coscienza e fenomenologia dell’esserci. Così potremmo
sintetizzare a questo punto le posizioni di Husserl e Heidegger. Questa distinzione ci
dice due cose fondamentali: da un lato vi è una apertura prospettica comune, la
fenomenologia; dall’altro il pensiero diverge indirizzandosi o sulla coscienza o
sull’esserci.
Questa puntualizzazione è da un lato indispensabile, ma può anche divenire
fuorviante se colta semplicisticamente. Infatti si tende sbrigativamente a considerare
la fenomenologia husserliana come l’”analisi intenzionale dei vissuti (Erlebnisse) di
coscienza”195, e contemporaneamente la fenomenologia heideggeriana come
“analisi esistenziale dell’esserci”196. Considerate in questi termini dovremmo
ammettere l’esistenza di almeno “due fenomenologie”, in quanto si pone una
distinzione nell’oggetto tematico stesso. Ma con il termine fenomenologia non si
intende un oggetto tematico, bensì il metodo di ricerca con cui si deve indagare il
cercato, meglio ancora una metodologia d’indagine dell’oggetto tematico stesso. Per
questa ragione von Herrmann può scrivere: “La fenomenologia non è una disciplina
filosofica accanto all’ontologia, alla gnoseologia o all’etica, perché in quanto metodo
essa non ha un proprio territorio tematico concreto, accostabile a quello
dell’ontologia, della gnoseologia o dell’etica. Ciascuna di queste discipline infatti
potrebbe caratterizzarsi come fenomenologia, se solo cioè volesse comprendersi
fenomenologicamente sotto l’aspetto metodologico.”197 Portando l’attenzione sulla
fenomenologia come modo d’indagine ci accorgiamo immediatamente che è
possibile determinare la radice comune del pensiero husserliano ed heideggeriano.
E’ proprio da qui che dobbiamo tentare di ripercorrere i due sentieri per vedere se è
possibile aprire un “altro” dialogo.
193 M. Heidegger, Seminario di Zähringen, in Aut-Aut, cit.
194 E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, cit. p. 58
195 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, Genova, il melangolo,
1997 p. 29
196 Ivi, p. 30
197 Ibidem
L’impostazione metodologica husserliana è espressa in due testi fondamentali:
Idee I e le Ricerche logiche. Nel primo Husserl scrive: “noi partiamo da ciò che sta
prima di tutti i punti di vista: dalla sfera complessiva del dato visibile anteriore ad
ogni pensare teorizzante, da tutto ciò che si può immediatamente vedere e
afferrare.”198 A tal proposito il passaggio delle Ricerche logiche che qui riportiamo
diviene quasi un chiarimento ulteriore. In esso, esplicitando l’assenza di ogni
presupposto per la ricerca fenomenologica, viene anche implicitamente posta la
libertà del punto di vista. Tale impostazione si concretizza nell’indipendenza da
qualsiasi “corrente”.
“Una ricerca gnoseologica che voglia essere realmente scientifica deve
soddisfare il principio dell’assenza di presupposti. Ma a nostro avviso, questo
principio non può voler dire altro che la rigorosa esclusione di tutti gli enunciati che
non possono essere interamente realizzati sul piano fenomenologico.”199
Questi stessi concetti sono il fondamento del § 7 di Essere e tempo, che
sappiamo essere il paragrafo della fondazione metodologica di tutto il percorso
successivo. E’ solo attraverso questi presupposti che si chiarisce come mai
Heidegger scriva: “le ricerche che seguono sono state possibili solo sul fondamento
posto da E. Husserl, le cui Ricerche logiche hanno dato i natali alla
fenomenologia.”200 Ecco quindi che la fenomenologia, in qualsiasi modo noi la
intendiamo (husserliana o heideggeriana che sia) non può prescindere da questi
punti forti: assenza di presupposti e libertà del punto di vista. Ora se è vero che “la
filosofia fenomenologica vuole fondarsi come filosofia scientifica, prescindendo
esplicitamente dai punti di vista e dalle correnti filosofiche già esistenti, e in quanto
scienza che diventa filosofica, essa non vuole, né all’inizio né nel suo sviluppo, fare
alcun uso delle prospettive e delle correnti già date” 201; sarà altrettanto vero che il
divergere dell’impostazione non potrà che essere connaturato con la fenomenologia
stessa.
Questo orizzonte, che implica in sé identità e differenza, deve essere tenuto
sempre presente, perché è proprio sulla base di ciò che Heidegger potrà, operando
fenomenologicamente, e quindi criticamente, aprire un confronto proprio con la
fenomenologia stessa.
Vediamo di chiarire. Come interviene Heidegger sul metodo fenomenologico?
Se Husserl volgeva la sua ricerca fenomenologica in direzione di qualsiasi vissuto di
coscienza, Heidegger de-limita la fenomenologia. Ossia, la fenomenologia come
metodo della filosofia ha come oggetto tematico l’essere, meglio ancora l’essere
dell’ente, l’esserci.
Prima di approfondire le problematiche inerenti la determinazione dell’oggetto
tematico, dobbiamo comprendere il senso di questa de-limitazione o de-finizione
heideggeriana.
Noi sappiamo che nella riflessione husserliana si pone un primo principio
metodico o principio dell’evidenza202: “alle cose stesse!” Questa prospettiva,
nell’orizzonte delle Meditazioni cartesiane, ha questo senso: “io nel corso della mia
198 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Torino, Einaudi,
1970, p. 45
199 E. Husserl, Ricerche logiche, Milano, il Saggiatore, 2 voll., 1988, vol. I, p. 283
200 M. Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1988, p. 59
201 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, cit. p.31
202 Questo elemento è importantissimo perché si riscontra dalle Ricerche logiche, ad Idee, alle
Meditazioni cartesiane costituendo così un elemento di continuità in tutta la riflessione husserliana così
caratterizzata dalle “distinzioni essenziali”.
ricerca filosofica, «non posso dare o lasciar valere alcun giudizio che non abbia
attinto all’evidenza o alle esperienze in cui le cose e i contesti correlativi al giudizio
mi siano presenti essi stessi». Husserl concepisce infatti l’evidenza come un
pervenire-della-cosa-stessa-alla-vista-spirituale
[Die-Sache-selbst-geistig-zu203
Gesicht-bekommen].”
Questo primo principio non possiamo considerarlo svincolato dal contesto della
riflessione husserliana; va da sé che diviene necessario collegarlo ad un altro
elemento essenziale: la riduzione fenomenologica. Ora se io procedo alla riduzione
fenomenologica dell’io per giungere alla soggettività trascendentale, con questo atto
non mi sono già precluso il darsi del mondo e di conseguenza ogni possibile prassi?
Questo domandare ci porta direttamente dinanzi ad una problematica che
Husserl aveva colto ma non mai pienamente radicalizzato: l’eccedenza.
Siamo di fronte cioè, ad uno dei concetti che hanno maggiormente a che fare
con la determinazione del rapporto soggetto-oggetto. Ossia vi è qualcosa, nella
determinazione fenomenologica di questo rapporto, che sfugge, che eccede. Meglio
ancora, lo spostamento della prospettiva sul soggetto nella dimensione eidetica della
soggettività trascendentale, permette sì di porre un mondo per la coscienza e della
coscienza, ma contemporaneamente s-vela un orizzonte di alterità assoluta,
noumenica.
E’ proprio sulla differente impostazione del rapporto soggetto-oggetto e la
differente attribuzione di senso al soggetto stesso che si pone il differire del pensiero
husserliano ed heideggeriano.
Infatti se il principio “alle cose stesse” è accolto da entrambi nella sua
accezione formale, una volta deformalizzato, ossia una volta che si è posta la
“determinazione contenutistica dell’oggetto tematico che deve essere
scientificamente dimostrato ed afferrato nel modo di incontro di ciò che si mostra in
se stesso”204, si dischiude tutta la de-limitazione heideggeriana della
fenomenologia.
Quando Husserl procede alla deformanlizzazione, indica, quale oggetto
tematico, la vita della coscienza. Questo significa che l’indagine fenomenologica si
occupa dei vissuti o atti della coscienza. Impostata in questo modo, la riflessione
deve porsi a partire da una soggettività, da un io assolutamente dato a se stesso e
presente. Infatti “Io non sono forse colui che in qualsiasi istante della sua vita vigile
di coscienza è dato a se stesso nei molteplici vissuti di coscienza?” 205 In base a
questo presupposto, che costituisce un filo conduttore dalle Ricerche logiche alla
Crisi, possiamo determinare la deformalizzazione della fenomenologia husserliana:
ciò che “si mostra in se stesso e diventa quindi fenomeno, è l’essenza pura degli atti
e il loro rapporto essenziale con gli oggetti. In questo atteggiamento fenomenologico
di ricerca, gli atti di coscienza si mostrano nella loro essenza generale speciale. La
loro essenza generale è racchiusa nella loro intenzionalità. Questo significa che ogni
atto di coscienza è, per essenza e non sulla base della comparsa casuale degli
oggetti, un riferirsi a qualcosa. L’essenza speciale degli atti significa che ciascun tipo
di atto, in modo conforme alla propria essenza tipica, si riferisce in modo
presentante ad una presenza in carne ed ossa; l’atto di rimemorare si riferisce in
modo presentificante ad un elemento presente-passato in carne ed ossa.”206 Dall’io
quindi si passa alla determinazione dell’intenzionalità come fondamento della
203 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, cit. p. 35
204 Ivi, p. 40
205 Ivi, p. 54
206 Ivi, p. 55
possibilità del riferimento fra atto di coscienza ed oggetto. Tale percorso determina
comunque e sempre una presentificazione.
Sulla base di questi passaggi si determina il fenomeno come “ciò che appare”.
Ma questa determinazione va specificata, in quanto “in conformità alla differenza fra
atto di coscienza e oggetto dell’atto, Husserl distingue fra ciò che si mostra (in
quanto oggetto dell’atto) e il suo apparire, ovvero i suoi modi di apparizione negli atti
di coscienza.”207 E’ chiaro quindi che nei concetti di «apparenza» e «mostrazione»
si determina uno spostamento coscienziale, ossia l’io, la soggettività trascendentale
divengono possibilità di presentificazione e contemporanea perdita dell’eccedenza.
Heidegger scardina letteralmente questa impostazione, e per farlo utilizza
proprio la libertà del punto di vista. Per comprendere meglio questa prospettiva mi
riallaccio al Seminario di Zähringen, dove, dopo aver attribuito grande merito a
Husserl per aver determinato proprio il concetto di eccedenza, pone questo stesso
concetto al centro di un percorso che dischiude tutto un “altro” orizzonte di
riflessione.
“L’è – attraverso il quale io determino la presenza del calamaio come oggetto o
sostanza – è «eccedente» tra le altre affezioni sensibili: l’«è» non viene infatti
aggiunto alle affezioni sensibili, ma viene «visto» - pur essendo visto diversamente
da ciò che è visibile sensibilmente.”208
In questo breve passaggio sono riscontrabili tutte o quasi le differenze che
caratterizzano la deformalizzazione heideggeriana da quella husserliana.
Innanzitutto il problema dell’essere, di una fenomenologia dell’essere;
secondariamente, basandosi la fenomenologia sul vedere, sulla visione, noi
possiamo vedere un differire, che non è altro che il darsi della differenza ontologica.
Ore se essere e differenza ontologica sono i fondamenti della riflessione
heideggeriana e contemporaneamente il suo divergere da Husserl, vediamo come si
determina la deformalizzzazione.
Prima di tutto dobbiamo qui ricollegarci ai concetti di «apparenza» e
«mostrazione». In proposito Heidegger utilizza l’esempio del rossore come indice
della malattia: questi due elementi, contemporaneamente, s-velano una differenza
irriducibile.
“La profonda differenza tra il fenomeno inteso come ciò che si mostra in se
stesso e l’apparizione intesa come ciò che si annuncia, che non è solo, come
parvenza, un modo privativo del mostrarsi, ma che non è nemmeno un mostrarsi
vero e proprio, questa differenza viene chiarita da Heidegger con la definizione di
fenomeno come un modo privilegiato di incontro di qualcosa, mentre l’apparizione
non è un modo di incontro, ma solo un rapporto ontico di rimandi nell’ente
stesso.”209 Ora, se Husserl attribuiva alla mostrazione la possibilità di lasciar
vedere l’oggetto in quanto oggetto dell’atto; Heidegger, attraverso la mostrazione
come “modo privilegiato di incontro di qualcosa”, apre una possibilità di relazionalità
fra interno ed esterno, fra soggetto e oggetto. Dobbiamo però fare molta attenzione
a non attribuire a questa prospettiva l’idea di una riproposizione dell’oggettività
assoluta in chiave empirista o neo positivista. Infatti questo modo privilegiato
d’incontro è sì dato, ma a partire dalla differenza ontologica fra essere ed ente,
quindi in definitiva a partire proprio da quell’eccedenza di cui parlavamo prima.
Veniamo così al punto centrale della fenomenologia heideggeriana: la
riflessione sull’essere nel suo darsi come essere dell’ente, come esserci.
207 Ivi, p. 56
208 M. Heidegger, Seminario di Zähirngen, in Aut-Aut, Firenze, La nuova Italia, n°223-224, 1988, p. 31
209 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, cit. p. 38
Dal punto di vista fenomenologico, quindi, non dobbiamo andare alla ricerca di
una presenza piena, oggettiva/oggettuale, ma di qualcosa che non si mostra, che
resta nascosto. Vediamo dalle parole di Heidegger come viene caratterizzato in
Essere e tempo questo qualcosa: “si tratterà, evidentemente, di qualcosa che
innanzitutto e per lo più non si manifesta, di qualcosa che resta nascosto rispetto a
ciò che si manifesta innanzitutto e per lo più, e nel contempo di qualcosa che
appartiene, in linea essenziale, a ciò che si manifesta innanzitutto e per lo più, in
modo da esprimerne il senso e il fondamento.”210
Ora, se questo passo e quello del seminario di Zähringen vengono letti
parallelamente ci accorgiamo immediatamente che ciò che Heidegger cercava nel
1927 è lo stesso cercato del 1973, ossia: l’essere.
Esso però è tale solo a partire dall’ente, è l’ente che nel suo mostrarsi s-vela
l’essere, e l’essere è sempre essere di un ente. Ed è in questa prospettiva che
dobbiamo leggere la mostrazione del fenomeno.
L’essere dell’ente, poi, caratterizza l’ente stesso a seconda della modalità
d’essere con cui si dà. E’ in questo contesto che l’essere che già sempre noi siamo
si determina a partire dall’esistenza. Accanto ad essa sappiamo che vi sono
moltissimi altri modi d’essere dell’ente.
Esistenza ha però, nella riflessione heideggeriana, un senso specifico, infatti io
sono l’ente “per cui ne va del suo essere di questo essere stesso.” 211 Il che in altre
parole vuol dire: “nel mio essere, io mi rapporto al mio essere. L’esistenza, in quanto
modo d’essere, è un rapporto con l’essere. Nel mio essere io mi rapporto al mio
essere nella misura in cui mi comprendo nel mio essere. Il rapporto con l’essere del
mio essere è il modo della mia comprensione dell’essere, il modo cioè in cui io
comprendo il mio proprio essere.”212 Ora, se questo è vero, non è forse un principio
circolare, ermeneutico, che apre, non più al soggetto o alla soggettività, ma alla
possibilità di un soggetto e di una soggettività che si comprendono a partire
dall’esistenza, meglio ancora dall’esserci? L’esserci non diviene nel suo –ci come
insistenza [Inständigkeit] possibilità di un coglimento soggettivo del sé e “apertura
orizzontale” in cui si dà il mondo? Io credo che sia questa la direzione in cui va la
riflessione di von Herrmann, infatti scrive: “L’ente che io stesso sono e che non è,
come altri enti, utilizzabile o semplicemente sottomano, ma esiste, conserva la
definizione ontologica di «esserci», perché, nell’apertura soggettivo-estatica della
sua esistenza, esso è aperto e incluso nell’apertura orizzontale dei modi d’essere
dell’ente non conforme all’esserci. Il prefisso «esser-» nella parola «esser-ci» pensa
l’essere come esistenza, mentre il suffisso «-ci» significa l’apertura complessiva, non
solo quella dell’essere come esistenza, ma con essa anche l’apertura dei modi
d’essere di tutto l’ente non conforme all’esserci. L’apertura complessiva è dischiusa
in modo che io, nella mia apertura soggettivo-estatica (esistenza), sia incluso
nell’apertura orizzontale (essere dell’ente non conforme all’esserci).” 213 E’ in questa
prospettiva che penso si possa ripensare il soggetto “a partire da Heidegger”.
In conclusione vediamo di tracciare un possibile orizzonte di ricerca.
La riflessione husserliana fornisce il contesto e la metodologia per la
determinazione dell’apertura della possibilità del differire come esubero, come
eccedenza. Tale prospettiva assume un senso antimetafisico solo se viene delimitata e de-finita la soggettività trascendentale. A tal fine assume una valenza
210 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 55-56
211 Ivi, p. 28
212 F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl, cit. p. 48
213 Ivi, p. 52
fondamentale l’analitica esistenziale dell’esserci. Contemporaneamente la
dimensione dell’esserci come apertura estatica, come insistenza assume un senso
antimetafisico a partire dall’esubero o eccedenza che decostruiscono la prospettiva
onto-teo-logica e teleologica della piena presenza.
Parallelamente, però, non possiamo dimenticare, se ci poniamo il problema
della soggettività, che la determinazione dell’esserci, nella prospettiva della
fenomenologia ermeneutica di Heidegger è sempre e solo un io. Siamo quindi
sempre rinviati ad una dimensione solipsistica, pur permanendo, come abbiamo
visto, una dimensione della soggettività e del soggetto.
Lo stesso problema si pone nei confronti della fenomenologia husserliana,
infatti non si può forse dire che la fenomenologia della coscienza inclini anch’essa
tendenzialmente verso il solipsismo determinato dalla prospettiva della riduzione
egologica?
Se questo è vero si potrà considerare il soggetto e la soggettività come sentieri
pensabili-possibili fra Husserl e Heidegger, ma resterà sempre indeterminata la
possibilità intersoggettiva.
Non può essere questo un problema di perdita della dimensione «vitale» e
«storica»?
A. Marini, in un saggio dedicato a W. Dilthey scrive: la “vita che si può opporre
al pensiero è vita pensata (tigre di carta): nel caso peggiore, essa sarà una
mistificazione ideologica (o, con Nietzsche, denigrazione, diffamazione) della vita
«[…] il problema non si risolve esattamente senza resto, poiché nel processo vivente
posso sì distinguere dei fattori, ma non posso, collegandoli, creare la vita.»” 214 La
vita quindi divine un orizzonte immediato in cui si danno le antinomie. Esse non sono
mai ricomposte dialetticamente, ma attraverso la struttura dell’analogia è possibile
«gettare dei ponti» che consentono l’attribuzione di senso e significatività. Ora è
chiaro che in questo contesto “il problema dell’individuo e della persona umana nella
società e nella storia non si riduce a un problema gnoseologico né specificamente
psicologico, ma riguarda in senso lato la sua autonomia e la sua libertà.” 215 E’
chiaro che in questa prospettiva il Sé acquista una dimensione fondamentale e
fondante, ma contemporaneamente de-limitata e de-finita dall’essere nella vita.
Con questo non abbiamo certo trovato delle soluzioni, perché la prospettiva
diltheyana non è priva di «spigoli» ed «asperità». Ciò ci pone dinanzi al fatto che “sia
l’analitica esistenziale di Heidegger che la riduzione husserliana alla Lebenswelt
appaiono come esperienze più rigorose di questa.” 216 Ma in questo rigore qualcosa
è andato perso.
214 A. Marini, Alle origini della filosofia contemporanea: Wilhelm Dilthey, Firenze, la nuova Italia, 1984,
p. 85
215 Ivi, p. 88
216 Ivi, p. 91
Bibliografia essenziale
E. Husserl – M. Heidegger, Fenomenologia, storia di un dissidio, Milano,
Unicopli, 1990
E. Husserl, glosse a Heidegger, Milano, Jaca Book, 1997
F. W. von Herrmann, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl,
Genova, il melangolo, 1997
Lo spirito incarnato
(Merleau-Ponty e l’Origine della geometria di Husserl)
L’eredità di Husserl
Merleau-Ponty manifestò più volte il suo interesse per il tardo testo di Husserl
sull’origine della geometria. Egli lesse questo scritto molto presto, poiché lo si trova
già menzionato nella Fenomenologia della percezione. In seguito ne iniziò un
commentario a cui seguì il suo corso al Collège de France del 1959-60, intitolato
Husserl ai limiti della fenomenologia.
Il titolo di queste lezioni rivela già l’intento originale del filosofo francese: egli
invita a leggere in filigrana il testo husserliano per sforzarsi di continuare a pensare
ai margini della fenomenologia, là dove essa, anche senza realizzarlo pienamente,
si oltrepassa, là dove essa è apertura verso un nuovo tipo di pensiero.
Si tratta quindi di un’"eredità", con le varie sfumature che questa parola può
contenere in un discorso fenomenologico, e perciò di un rapporto complesso che
non si esaurisce in una semplice interpretazione.
Merleau-Ponty nelle prime pagine delle sue note sull’Origine della geometria
afferma: “Non propongo un’interpretazione d’insieme coerente di Husserl e non l’ho
mai fatto”. Più avanti egli continua: “Dunque questa non sarà un’interpretazione
obiettiva di Husserl opposta ad altre. Noi non diciamo che Husserl fu questo, ma
Husserl non fu solamente ciò che se ne dice, fu anche un altro, titolare di un
impensato”.
Merleau-Ponty rileva quindi un “impensato” di Husserl, un’ombra di implicazioni
laterali che le parole esplicite del filosofo non esauriscono, egli ravvisa nell’opera di
Husserl delle questioni irrisolte che vanno risollevate e che si possono aprire a varie
e diverse interpretazioni. Il filosofo francese intende riprendere il movimento di
pensiero, “lo stile”, delle ricerche husserliane, che non si presentano sotto la forma
di un insieme di significati già fatti e conclusi, ma si sviluppano grazie ad un
processo di “autosedimentazione” di senso, in cui ogni nuovo testo di Husserl
eredita una meditazione anteriore che richiede di essere riattivata aprendo così
percorsi nuovi e inaspettati.
Non è un caso che l’interesse di Merleau- Ponty si focalizzi soprattutto attorno
alle ultime opere del pensatore tedesco. Secondo lui, infatti, nei suoi scritti più tardi
Husserl non considera più l’essenza fuori del fatto, l’eternità fuori del tempo o il
pensiero filosofico fuori della storia, ma qui la pratica rigorosa della riflessione
radicale scopre finalmente dietro di sé l’irriflesso come sua intima condizione di
possibilità, un irriflesso senza il quale questa riflessione non avrebbe alcun senso.
Aderendo a questa prospettiva si possono cogliere i motivi che hanno spinto
Merleau-Ponty a dedicare un corso sui limiti della fenomenologia proprio all’Origine
della geometria: qui, infatti, si trovano poste, senza che Husserl le sviluppi oltre, le
premesse di un tutt’altro pensiero della lingua e del corpo.
L’origine del senso ideale
Un confronto con l’opera di Husserl sull’origine della geometria implica un
confronto col tema della genesi. In questo testo, infatti, Husserl inizia col porre
l’interrogativo dell’origine dell’idealità geometrica, ma poi finisce per mettere in
campo la questione della genesi del senso in generale.
La fenomenologia vuole rendersi responsabile della propria decisione
inaugurale e di tutto ciò che essa comporta e rivendica esplicitamente l’intenzione di
svilupparsi come disciplina scientifica del cominciamento; il filosofo tedesco quindi,
sin dall’inizio della sua meditazione, non cessa di riflettere sulla questione della
genesi, non senza manifestare una certa inquietudine: genesi non psicologica della
logica nelle Ricerche logiche, genesi trascendentale in Idee e nelle Meditazioni
cartesiane, genesi prescientifica della scienza nella Crisi.
Merleau-Ponty rileva appunto nel tema delle origini una delle tensioni irrisolte
del pensiero husserliano; egli tuttavia, pur interrogandosi ossessivamente, come
Husserl, sulla questione dell’origine del senso, si rifiuta di fare della sua filosofia una
filosofia del fondamento, ossia un pensiero che ricondurrebbe ad un principio ultimo,
in grado di autofondarsi e di fondare l’essere, il sapere e il senso. La Crisi di Husserl
permette a Merleau-Ponty di porre la questione di una rifondazione della filosofia
nella descrizione non più di una coscienza costituente a fondamento di ogni senso,
ma della Lebenswelt come luogo di radicamento e di scaturigine del senso.
Ciò da cui prende le mosse l’interesse del filosofo francese per il testo
sull’origine della geometria in particolare, è lo sforzo di Husserl per trovare una via di
mezzo tra il genetismo storico e psicologico (che sarebbe ingenuo e naturalistico e
quindi empirico e a rischio di cadere in uno scetticismo) e l’oggettivismo che non
farebbe che constatare l’esistenza delle oggettività ideali senza riguardo alla loro
genesi. In quel testo, infatti, Husserl procede a zig-zag attraverso l’oggettività del
senso delle idealità geometriche e la loro storicità, il loro essere apparse per una
prima volta.
Il filosofo tedesco nota che gli oggetti della geometria non sono oggetti tra gli
altri, ma sono degli oggetti ideali e quindi devono avere una validità oggettiva, libera
dai vincoli della realtà empirica: la loro verità deve coincidere con la loro idealità. Allo
stesso tempo però la loro origine dev’essere avvenuta per una prima volta nella
storia, essi devono quindi aver avuto un concreto atto di nascita nel lavoro di un
primo geometra. Husserl, però, non si impegna in una storia empirica della
geometria, egli non mira al recupero di un inventario di fatti, ma la sua ricerca è
propriamente filosofica; la particolarità della sua indagine sta nel tentativo di mettere
in luce un nuovo tipo di storicità e di rapporti tra la storia e l’idealità. Più
precisamente, Merleau-Ponty farà notare come dal testo husserliano emerga che, se
la geometria ha una storia che è aperta e se tuttavia essa forma un sistema di
idealità atemporali, obiettive e universali, ciò non è casuale, dato che idealità e
storicità derivano dalla stessa origine. Si tratta in particolare di individuare una terza
dimensione fra la serie storica degli avvenimenti e il senso atemporale e ideale, cioè
la dimensione della “storia in profondità” o dell’”idealità in genesi”. Il problema perciò
si amplia e investe il rapporto tra storia e filosofia, tra eredità e tradizione, tra corpo e
anima, tra pensiero e linguaggio.
Merleau-Ponty affronta la questione della fondazione dell’idealità geometrica in
questi termini: senza riferimento a un fondamento trascendente, né all’idea di una
soggettività assolutamente costituente, come pensare che sia una medesima
idealità, quella presa di mira nella sua identità ed evidenza, da me e da altri, nel
passato e nel presente?
La genesi dell’idealità pone infatti dei problemi specifici: come si può pensare
la fondazione di un’idealità geometrica senza perdersi nella contingenza e nella
fatticità, nel momento in cui si abbandona l’idea di un cominciamento positivo?
Come pensare all’evidenza in una storia e all’identità nel tempo dell’oggetto ideale?
Come pensare ad una storia operante che sia contemporaneamente
sedimentazione e riattivazione di un senso? Infine, come affrontare il rapporto di
fondazione tra linguaggio e idealità, dato che Husserl indica nel linguaggio il luogo
della costituzione delle oggettività ideali?
Le risposte a queste domande porteranno ad uno slittamento dei concetti di
idealità
e
di
essenza.
Merleau-Ponty, alla stregua di Husserl, nota che la geometria, oltre ad essere un
oggetto ideale, è un oggetto spirituale, una creazione umana, perciò il suo senso
emerge, si fa, in una storia. Essa è quindi un fatto culturale, una tradizione. Ciò
indica che l’idealità geometrica deve poter passare attraverso il tempo senza
logorarsi, deve poter essere comunicata; tra me e il protogeometra ci dev’essere un
campo comune di senso, nonostante le occorrenze dell’origine empirica della
geometria siano state dimenticate, anzi, proprio grazie a questo oblio. Questa
comunicazione sotterranea umana attraverso il tempo riposa sul fatto che siamo
uomini di un’umanità trascendentale: “L’oblio dell’origine empirica (della storia in
senso empirico) dipende proprio dal fatto che il creato aveva la possibilità di
sopravvivere altrimenti che come passato che fu, di abitare tutti gli spiriti, di durare
senza logorarsi, di essere Storia. Questo oblio delle origini per sopravvivere nel
presente è la tradizionalità (…) La tradizione è oblio delle origini come origini
empiriche per essere origini eterne”. (NOG. 33, tr. mia). Il fatto che la geometria sia
una creazione umana è attestato dal fenomeno che, pur avendo dimenticato la sua
origine empirica, io ne possa in ogni momento riattivare il senso. Merleau-Ponty nota
un processo nel senso ideale della geometria: i passi inaugurali dei primi geometri
aprono un campo e instaurano dei temi che il creatore vede solo come “una linea
tratteggiata verso l’avvenire” (Urstiftung), ma successivamente essi, affidati alle
generazioni seguenti assieme alle prime acquisizioni, diventano realizzabili mediante
una sorta di creazione seconda (Nachstiftung) in cui aprono nuovi spazi di pensiero,
fino a che, essendosi lo sviluppo in corso esaurito in un’ultima ri-creazione
(Endstiftung), interviene una reinterpretazione d’nsieme, spesso tornando alle origini
o percorrendo delle strade laterali. Ciò implica che il senso non possa risiedere
interamente nell’immanenza di un fondamento statico, ma affiora la necessità di
pensare un rapporto di fondazione dinamico, che renda conto della relazione tra ciò
che fonda il senso, senza essere fondamento positivo, e il senso fondato. Per
rendere conto di ciò, Merleau-Ponty in queste note oppone al termine tedesco
Fundierung il termine Stiftung, che egli traduce con “istituzione” e che rimanda
appunto al carattere dinamico della genesi, al suo spessore, al suo essere rapporto
tra fondante e fondato. Il senso si sviluppa in un processo storico e temporale che
comporta nello stesso tempo un’anticipazione e un ritorno retrospettivo: la Stiftung
suppone un campo che la precede e su cui riposa, ma che essa deforma, ed è
indissociabile dall’idea di sedimentazione. Essa apre un campo e, nello stesso
tempo, sedimenta, persiste in una storia. Il movimento è quindi paradossale: la
genesi istituisce, scopre, nello stesso momento in cui ricopre: la crisi che nasconde il
senso originario è anche ciò che permette che questo senso venga conservato e,
quindi, riattivato. Questo movimento di trasgressione del passato nell’avvenire e
viceversa ha la stessa struttura del movimento della temporalità non oggettiva
descritta da Husserl nelle Lezioni sulla coscienza interna del tempo del 1905: non
una successione causale di istanti, ma un’invasione dell’anticipazione sulla
ritenzione e viceversa. Il tempo che esemplifica il movimento di questa apertura è il
futuro anteriore: “Futuro anteriore: il presente aperto a una vista retrospettiva che se
ne avrà quando tutto sarà stato detto” .
Il passare attraverso il tempo senza logorarsi, quindi, non rimanda ad una
piena positività: l’idealità non si logora perché richiede sempre di essere riattivata,
perché è “sempre già là”, ma non lo è mai pienamente, poiché ciò che è “già là”
necessita appunto la riattivazione continua. L’origine dell’idealità presuppone quindi
un prepossesso dell’idealità: non c’è fondazione prima senza che vi sia una
fondazione seconda che la fonda di nuovo come fondazione originaria: in realtà il
gesto di queste due fondazioni è il medesimo. Si delinea quindi una struttura
dialettica della fondazione: la genesi in quanto genesi avviene necessariamente in
due tempi: l’origine, che in se stessa non è nulla, e il suo recupero in quanto origine;
è lo scarto tra questi due movimenti a costituire un inizio.
Ma se questo processo non rinvia mai ad un’essenza positiva, perché è
sempre a-venire e sempre già costituito, che ne è dell’evidenza dell’oggetto ideale,
che, come dice Husserl, deve realizzarsi “nell’evidenza di un’effettuazione riuscita”?
Ciò che caratterizza gli oggetti ideali per Husserl, è infatti una saturazione totale e
compiuta di senso; ciò li differenzia dagli oggetti della percezione che si hanno
invece parzialmente, per adombramenti.
Il rifiuto dell’idea di essenza positiva e dell’idea di una coscienza costituente,
accanto al suo modo di concepire la percezione, impediscono a Merleau-Ponty di
pensare all’evidenza come riempimento compiuto di un’intezione. Ciò comporta uno
slittamento del senso di evidenza: mentre Husserl pensava la percezione a partire
dall’idealità, Merleau-Ponty pensa l’idealità a partire dalla percezione: in questo
modo non c’è più evidenza assoluta, ma c’è un’evidenza laterale, sottomessa alla
storicità. Ciò che preserva l’idealità dalla caduta nell’empiria, in questo caso, è la
sostituzione dell’idea di un fondamento assoluto con l’idea di “istituzione”; la genesi
dell’idealità è fondazione reiterata, ricoprimento e riattivazione di un senso originario,
anche se questo senso non si dà nell’evidenza di un riempimento totale: “ Non c’è
senso, in particolare senso fecondo, che per sedimentazione, traccia. [Qui forzare
Husserl: la Stiftung non è pensiero avvolgente, ma pensiero aperto, non mira e
Vorhabe del centro effettivo, ma mira di lato che sarà rettificata, non posizione di un
fine, non presa frontale, ma scarto laterale, alga richiamata alla luce dalle
profondità]” .
Come la percezione, l’idealità non ha senso che grazie alle sue lacune, grazie
al fatto di non poter essere mai completamente saturata. Ciò avviene, più
precisamente, grazie ad un certo scarto interiore al linguaggio.
Il linguaggio
Per un rovesciamento sorprendente della sua posizione precedente, nel testo
sull’origine della geometria Husserl arriva infatti a vedere proprio nel linguaggio la
condizione di possibilità dell’oggettività ideale, che, grazie ad esso, “si incarna, per
così dire, nel suo proprio corpo linguistico (Sprachlieb)” (Crisi, p. 384). L’oggettività
della verità, lascia intendere Husserl, si costituisce solo grazie alla sua inscrizione
nel sensibile: l’incarnazione nel corpo sensibile del linguaggio, invece di turbare la
purezza cristallina del senso ideale, gli permetterebbe al contrario di venire alla luce.
La lingua ora non è più considerata come uno strumento inerte, veicolo della
comunicazione di significazioni indipendenti dalla contingenza dei segni, ma come
un corpo vivente da cui nasce l'ideale e grazie a cui esso si costituisce. Ciò è
sorprendente, in quanto Husserl (penso soprattutto a opere come le Ricerche
logiche) aveva sempre manifestato una certa diffidenza verso il linguaggio, perché
esso si basava sull’associazione di idee e non aveva in sé i propri criteri di
legittimazione. Egli opponeva al pensiero simbolico il pensiero intuitivo, che
assicurava l’ancoraggio all’evidenza.
In questo testo invece viene sconvolta l’idea che sembrava comandare ai suoi
inizi la teoria fenomenologica della significazione: l’idea, cioè, che sotto la diversità
contingente dei linguaggi empirici, vi fosse il regno delle significazioni identiche,
l’idea di una grammatica pura logica che, separando il pensiero dal linguaggio,
arrivava a fare del linguaggio empirico la “veste” contingente del pensiero.
Seguendo Husserl, Merleau-Ponty esplicita il paradosso del linguaggio, che
ricalca il paradosso dell’origine dell’idealità geometrica: dicevamo che nel suo atto di
nascita la geometria non è che un momento della vita individuale del suo inventore;
essa però è anche oggettività ideale, accessibile a tutti e in tutti i tempi. Un
paradosso simile vale anche per il linguaggio: le espressioni sono nel mondo, nello
spazio e nel tempo, esse però esprimono delle idealità: “la parola leone esiste una
sola volta in tedesco” .
Il problema si configura allora in questo modo: come lo strato delle oggettività
geometriche acquista l’idealità al di là dello spazio contingente del suo inventore?
E’il linguaggio, parlato e scritto, che consacra l’essere geometrico nella sua idealità,
ci dice Husserl. Ma in che modo il linguaggio è questo potere?
Secondo MP ciò che Husserl intende dire è che “l’idealità non è né prima, né
seconda rispetto al Verstehen linguistico, che essa emerge in lui, che essa non si
riduce a lui come ad un contenuto positivo, ma non lo domina nemmeno come una
positività superiore. L’idealità è alla cerniera della connessione io-altro, essa
funziona in questa connessione, vi è operante, effettiva, si realizza dentro e grazie a
questa connessione. Ciò vuol dire: non ci sono qui due termini positivi: l’idealità e il
rapporto con l’altro, perché allora bisognerebbe che l’uno spiegasse l’altro. C’è,
come si vorrà, una positività del rapporto con l’altro, come rilievo e un’idealità che ne
è l’inverso, che trasuda “ai bordi delle parole”, - o una positività dell’idealità e un
rapporto con l’altro che ne è l’inverso, che trasforma l’altro in alter ego, in soggetto
d’Erzeugung come me. Queste due versioni del fenomeno non sono che una sola,
perché ciascuno dei due termini non è né il negativo né il positivo dell’altro, essi si
realizzano intrecciandosi: nel momento in cui mi apro agli altri mi faccio capace di
idealità e nel momento in cui mi apro all’idealità mi rendo capace di raggiungere gli
altri nell’Erzeugung. […] La soluzione di Husserl consiste nell’installare l’apertura
all’altro e all’idealità nella legge del percettivo-pratico, cioè a fare dell’altro l’altro lato
del mio mondo, dell’idealità l’Etwas sul quale questi due lati sono articolati, il perno
del parlare a …, un perno, cioè un invisibile grazie al quale il visibile tiene” .
Come l’idealità, il linguaggio ha un carattere dinamico, operante; riprendendo
nuovamente la metafora geologica husserliana della sedimentazione il filosofo
francese invita a comprendere la dualità non sostanziale tra il corpo e l’anima della
parola secondo la dialettica del costituente e del costituito. Egli distingue anche qui
un momento di fondazione originaria e uno di fondazione seconda: una “parola
parlante”, “istituente”, e una “parola parlata”, “istituita”. La prima rinvia alla genesi
dell’intenzione significante e la seconda alla sua sedimentazione. E’ proprio in
quanto la parola è pensata come operante tra il passato e il presente, tra me e
l’altro, che l’idealità può perdurare aldilà della contingenza di una coscienza
personale. Non c’è quindi un accesso diretto alla vita dell’altro: quando ascolto e
comprendo la questione dell’altro, attualizzo delle virtualità: l’idealità “trasuda ai bordi
delle parole”. Nel momento in cui qualcuno mi interroga, egli o ella esprime una
idealità che fa parte del dominio delle forme della parola parlata. Ma, poiché non
posso avere accesso all’anima dell’altro, allora l’idealità espressa è separata da
questa persona. L’idealità è all’asse di rotazione tra di noi. Perciò quando ascolto e
poi rispondo, ripeto delle idealità, ma devo anche creare un altro “lato” di idealità;
quando metto il mio silenzio sotto una forma linguistica derivata dalle forme già fatte
e istituite, questa inserzione ricrea il senso: ogni volta che comprendo ricreo, ogni
ricomprensione è un ricominciamento. Avendo spiazzato l’idea classica di evidenza,
è stata spiazzata anche l’idea tradizionale di idealità: questa diviene l’asse attraverso
cui avviene questa invasione, questo ricoprimento parziale tra me e l’altro, tra
passato e presente.
Per Merleau-Ponty si tratta quindi di affrancare la lingua dal suo stato di
semplice “strumento” e di vedere nei rapporti tra suono e senso non dei semplici
rapporti di esteriorità, ma dei rapporti di “inerenza”. La connessione tra suono e
senso viene quindi fondata su una “operazione originaria”, grazie alla quale un
senso viene già ad abitare un frammento di materia. Sin da La struttura del
comportamento Merleau-Ponty sviluppava questa linea di pensiero, mettendo in
discussione la rappresentazione tradizionale della lingua come accostamento
esteriore di un suono (sensibile) e di un senso (ideale).
Ovviamente questo ambito di problemi non concerne solo il linguaggio, ma
investe il rapporto tra anima e corpo, tra forma e materia, dato che la tradizione che
separa nella lingua il suono sensibile dal senso ideale è la stessa che vede nel
corpo e nell’anima dei semplici rapporti di esteriorità. Merleau-Ponty, al contrario,
suggerisce di portarsi oltre le alternative del materialismo, dello spiritualismo e del
criticismo e di sostituire alla metafora di “animazione” quella di “abitazione”. Egli
scorge tra empirismo e intellettualismo una somiglianza di fondo: la loro comune
incapacità di captare il fenomeno della parola come un tutto. Per il filosofo francese
la parola non è né un semplice involucro inerte, né un fenomeno puramente
psichico; la preesistenza del vero all’enunciato non si fonda in un cielo intelleggibile,
ma nell’ancoraggio del senso e della verità nella materia stessa, nel corpo del
linguaggio; l’essere ideale e l’incarnazione non sono due fattori distinti, ma sono due
strati dello stesso fenomeno. Merleau-Ponty ravvisa quindi una dimensione
esistenziale dove il significato non viene tradotto dalle parole, ma le abita e ne è
inseparabile, un habitus in cui pensiero e linguaggio sono avvolti reciprocamente
l’uno nell’altro.
Secondo Merleau-Ponty si tratta quindi di riportarsi oltre la parola istituita e
fissata in una rete di segni costituiti e di meditare sull’apertura primordiale al mondo,
la zona umbratile dove il senso emerge a partire da un orizzonte preoggettivo,
preriflessivo, antepredicativo, un orizzonte che è già investito esso stesso di una
sedimentazione di senso, dove l’idealità perde la sua pretesa ad ogni coincidenza e
a una fissazione in una identità a sé.
Il chiasma
Se ci si riporta all’originaria zona di penombra che caratterizza l’essere al
mondo prima di ogni razionalizzazione, non ha più significato chiedersi se sia
l’irriflesso che deriva dalla riflessione o viceversa. Si profila invece un nuovo rapporto
che non è di derivazione, ma piuttosto di reversibilità e di reciprocità.
Alla tesi di una successione di due fasi, una naturalista ed una idealista e
trascendentale, si sostituiscono i concetti di intreccio e di chiasma. Alla concezione
di un fondamento statico da cui deriverebbero causalmente le sue proprie
produzioni, si sostituisce l’idea della simultaneità tra passato e avvenire, fatto ed
essenza, pensiero e parola, essere e divenire. Secondo Merleau-Ponty bisogna
indagare sul suolo sensibile e concreto su cui questa simultaneità riposa: “(..) il
senso, lungi dall’essere idea è suolo. E’nell’archeologia del suolo, nel profondo e
non verso l’alto (le idee) che la filosofia cerca”. La discesa verso il dominio della
nostra archeologia, dice Merleau-Ponty, non lascia però intatti i nostri strumenti
d’analisi; nel momento in cui si impone un campo di presenza in cui l’essere e il
senso d’essere non possono essere dissociati, si trovano profondamente modificati
sia il concetto di mondo naturale, nel suo ideale di oggettività, sia, correlativamente,
quello di soggetto trascendentale. In questo suolo, in questo originario “essere al
mondo” l’inerzia materiale non si offre mai in maniera totalmente bruta, ma si trova
sempre già investita di un senso sedimentato, poiché sempre la passività originaria
preidividuale del mondo, nel movimento di autosedimentazione caratteristico delle
sintesi passive, apre un campo di unità aperte di senso in formazione che investe la
dimensione passiva del mondo prima che l’attività categoriale non eserciti la sua
tematizzazione a carattere predicativo (EG). Reciprocamente, il soggetto si trova
sempre già incarnato, esso è da sempre già legato ad un mondo radicalmente
diverso da quello naturalista di cui parla la scienza oggettiva. L’esperienza
antepredicativa del mondo, nel mistero del suo “esserci sempre e già” (il y a)
originario, si impone in una esperienza dell’essere (quindi ontologica) che ci
introduce direttamente al mondo come spiriti incarnati e non come “coscienze di
sorvolo”. Ancora una volta viene rifiutata l’idea di evidenza come coincidenza a sé
della coscienza: questa si trova sempre in ritardo o in anticipo rispetto a se stessa,
poiché i nodi di senso attorno a cui il mondo e l’uomo gravitano sono sempre o già
costituiti, o non ancora costituiti. L’umbratilità di questa zona di chiaroscuro
primordiale richiama l’opacità degli orizzonti percettivi, che in quanto tali non
possono mai essere presenti, ma che sono la condizione di possibilità della
percezione. Merleau-Ponty utilizza i concetti di invasione, intreccio, “serpentement”,
Ineinander, per rendere conto di questo sapere non teorico sulle cose e sul mondo,
ma più vicino alle cose e al mondo, perché più attento al loro modo di sorgere.
Questa situazione perciò non esclude una esperienza originaria dell’essere e del
senso che si impone prima di ogni tematizzazione del mondo a carattere oggettivo.
Per Merleau-Ponty il cominciamento è irriducibile all’ideale riflessivo della chiarezza
e della distinzione, ma si radica in questa sfera primordiale non tetica, della
Weltthesis, o, come il filosofo francese la denominerà nel Visibile e l’invisibile, della
fede percettiva. In questo luogo enigmatico è emblematica l’esperienza del corpo,
proiettato sui suoi dintorni, caratterizzato da uno scarto irriducibile verso ogni
tematizzazione noematica, in fase di mutazione su ciò stesso che lo rivela nel
momento stesso in cui lo muta.
Accennando a queste tematiche ci siamo già inoltrati verso problemi di cui
Merleau-Ponty tratta più approfonditamente nelle sue opere maggiori, come la
Fenomenologia della percezione e Il visibile e l’invisibile. In particolare in
quest’ultimo testo incompleto, che all’inizio egli voleva, husserlianamente, intitolare
L’origine della verità, si trovano molte indicazioni interessanti riguardo a questa
esperienza primordiale, che egli chiama la “dimensione dell’essere carnale”, in cui
visibile e invisibile, presenza e assenza, si trovano implicati l’uno nell’altro e allacciati
in uno stretto legame e dove passività e attività, soggetto e oggetto, sono ancora
indistinti e reversibili.
Merleau-Ponty ci indirizza quindi verso un nuova dimensione da conquistare,
dove la pretesa purezza del pensiero metafisico e la sua esigenza di coincidenza,
scontrandosi con questo “chiasma” primordiale, lascia spazio ad una nuova
ontologia:
“Diciamo pure che la stessa idealità pura non è senza carne, non è liberata
dalle strutture di orizzonte: essa ne vive, ancorchè si tratti di un’altra carne e di altri
orizzonti”.
Merleau-Ponty e Derrida
MP presentò il suo corso sull’Origine della geometria nel 1959-60; Derrida
pubblicò l’introduzione e la traduzione dello stesso testo nel 1962. Le relazioni dei
due filosofi hanno moltissimi punti di contatto tra loro, sia nell’interesse per i temi
trattati, che nello svolgimento delle argomentazioni e persino nella terminologia
(traccia, cavità, esperienza muta, voce che mantiene il silenzio). Tuttavia, prendendo
come punto di partenza il saggio di Iofrida, ho tentato di accennare ad alcune
differenze tra i due filosofi, soprattutto per quanto riguarda gli esiti delle loro
riflessioni, esiti che li portano a rispondere in modo diverso alla “crisi di senso”
attuale.
Innanzitutto essi elaborano in modo differente l’eredità husserliana.
Derrida oscilla tra due opposti atteggiamenti: l’adesione ad un Husserl critico,
aperto ad un nuovo tipo di pensiero, il teorizzatore della temporalità originaria o della
necessità della scrittura per la costituzione delle oggettività ideali, e il rifiuto verso un
Husserl dogmatico e razionalista, che vuole abolire la “metafisica degenerata” solo
per restaurarla nei suoi fondamenti. Egli è volto quindi a marcare lo scarto tra un
pensiero aperto, verso cui “di fatto” la filosofia di Husserl porta, e ciò che invece, “di
diritto” il filosofo afferma dogmaticamente per non andare contro alle sue intenzioni
programmatiche. C’è quindi una sorta di dualismo, un rapporto di différance tra
questi due Husserl diversi tra loro.
Come si è visto all’inizio dell’esposizione, anche Merleau-Ponty mette in
evidenza uno scarto tra ciò che Husserl padroneggiava e ciò che egli tentava di
pensare, un impensato che per il filosofo francese si tratta di sollecitare. Tuttavia, lo
Husserl di Merleau-Ponty è molto più audace di quello derridiano, è un Husserl che,
man mano, si porta a legare in maniera sempre più stretta ciò che all’inizio della sua
meditazione separava, cioè il possibile e l’attuale, l’essenza e l’esistenza, la forma e
la materia.
Sia in Merleau-Ponty che in Derrida, inoltre, per quanto riguarda il rapporto con
Husserl, non è indifferente il confronto con il pensiero heideggeriano. Rilevo questo
punto, perché ritengo interessante notare che Merleau-Ponty, in alcuni luoghi,
giudichi paradossalmente Husserl più deciso e più radicale di Heidegger
nell'integrare degli elementi irrazionali alla razionalità filosofica; ad esempio,
soffermandosi sul “soggetto” heideggeriano (termine di Merleau-Ponty), MerleauPonty nota che in Essere e tempo Heidegger non poneva alcun limite
all'adeguatezza della conoscenza filosofica e al suo potere di esplorare il concetto
naturale del mondo prima della scienza, mentre in Husserl questa rivendicazione di
una priorità della filosofia, nella misura in cui il suo pensiero maturava, veniva
sostituita da un rapporto di reciprocità con le altre scienze. Egli quindi continua:
" Husserl, che definiva la filosofia attraverso la sospensione dell'affermazione
del mondo, riconosce l'inerenza del filosofo al mondo molto più deliberatamente di
Heidegger, che vuole studiare l'Essere-nel-mondo. (….) Può essere, all'esame, che
si scopra che qui non c'è niente di inaspettato: una certa forma di dogmatismo o di
razionalismo immediato è, non solo conciliabile, ma anche profondamente
apparentata all'irrazionalismo. I migliori difensori della ragione, in pratica e anche in
dottrina, non sono quelli che, astrattamente, reclamano per essa più diritti. E,
inversamente, è nell'ordine delle cose che un filosofo particolarmente esigente in
materia di razionalità come Husserl, sia, proprio in questo, più in grado di
riconoscere il legame della ragione e dell'esistenza. Il fatto è che la razionalità non è
per lui un fantasma: egli la porta in sé, l'esercita".
Sotto questa prospettiva si può considerare Derrida più heideggeriano di
Merleau-Ponty, soprattutto riguardo agli esiti della sua riflessione che nelle sue
intenzioni esplicite. Egli, infatti, tentando di dare spazio all'irrazionale, di "renderne
ragione", lo ingloba nella razionalità invece che seguirne spontaneamente i
movimenti e, come Heidegger, crea una filosofia che per certi versi si può
considerare totalizzante, una filosofia senza vie d'uscita e senza vie d'entrata, ossia
una filosofia dove non c'è una genesi.
Un momento di differenza interessante tra la filosofia di Derrida e quella di
Merleau-Ponty mi sembra si trovi appunto nel loro diverso approccio al problema
delle origini.
L’emergenza del problema della genesi per risolvere la crisi del senso
dell’esistenza umana era stato messo in luce da Husserl: “Nelle miseria della nostra
vita (…) questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei
problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si
sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso dell’esistenza umana
nel suo complesso.” . Il problema è che il sapere si è sedimentato, fossilizzato, esso
non è più vitale, libero e costruttore di un senso, ma si è istituzionalizzato e
automatizzato. Questa “crisi”, dice Husserl, si può risolvere ripercorrendo a ritroso le
varie sedimentazioni concettuali che hanno cristallizzato la libertà della coscienza
costituente; si può risolvere, quindi, risalendo alle origini del senso. Come ha
evidenziato Iofrida nel suo saggio la “crisi” ai nostri giorni non è stata risolta, ma si è
semmai aggravata, dato che si sancisce ormai l’impossibilità di uscire dal logos o dal
sistema, l’impossibilità di trovare delle dimensioni che sfuggano all’aut-aut (o allo
scambio reciproco) tra totalmente dentro e totalmente fuori. E’ ovvio che questa
situazione coinvolge il problema della genesi, dato che per trovare “un suolo” da
dove sostenere la propria critica, o a partire dal quale poter essere criticati, è
necessario radicarsi in un terreno di senso; per avere una via d’uscita è necessaria
una via d’entrata.
E’ a partire da queste considerazioni che trovo interessante la differenza tra
Merleau-Ponty e Derrida riguardo al problema delle origini.
Essi partono da una critica comune al concetto di origine husserliano che,
com’è noto, assume un’importanza centrale in tutta l’opera di Husserl. Sia MerleauPonty che Derrida notano nell’affannarsi di Husserl alla ricerca di un’autofondazione
evidente per la fenomenologia un’inquietudine, inquietudine che si rispecchia nel suo
movimento stesso di pensiero: il filosofo tedesco procede in maniera circolare o “a
zig-zag” riconsiderando di volta in volta il suo percorso filosofico. Egli si trova
costantemente all’inizio, poiché, a causa dell’intima interdipendenza dei diversi
concetti conoscitivi, deve sempre verificare le sue analisi precedenti sulla base delle
successive e verificare queste ultime sulla base delle prime. Egli è sempre costretto
ad utilizzare i concetti che intende chiarire. La ricerca di Husserl è inquieta appunto
perché il filosofo “si lascia sfuggire l’originario assoluto man mano che ne
approfondisce il senso”. Il tentativo di isolare una forma di validità evidente originaria
sembra votato allo scacco, poiché Husserl si trova sempre di fronte ad “una specie
di circolo”: la fenomenologia non giunge mai ad un’autofondazione se non
ricostruendo continuamente ciò che presuppone sempre. La volontà di coniugare il
requisito filosofico della fondazione evidente all’intento descrittivo e operativo della
fenomenologia costringe Husserl ad una ricerca inesauribile. Si viene così a creare
un movimento paradossale e circolare: il filosofo tedesco passa di riduzione in
riduzione cercando di cogliere il momento costituente puro, ma si trova sempre di
fronte alla resistenza irriducibile dei dati passivi, dell’hylé, del tempo e della storia.
Anche nella Crisi emerge come la descrizione dell’origine del senso non possa
essere posta nei termini di un’autofondazione statica, dato che la riflessione si
origina in uno strato irriflessivo che però, a sua volta, deve venire recuperato e
rischiarato dalla riflessione.
Sia per Merleau-Ponty che per Derrida nessun fondamento si origina in
maniera immanente e assoluta, ma c’è sin dall’inizio un rapporto dinamico tra il
fondante e il fondato. Ciò li porta a criticare l’idea di un inizio radicale, anche perché
il sogno di poter isolare un’origine è solidale con un’ontologia di sole essenze
positive, guidata dal principio di ragione. Una filosofia che ricerca un fondamento
assoluto è metafisica e onto-teologica, perché questa ricerca poggia sul perché e
sulla ragione degli essenti, ragione che risiede in un assoluto privilegiato, una pura
positività che deve garantire la positività del sapere, la certezza e la verità. La ricerca
di fondamenti solidi e indubitabili, come fu quella di Cartesio, sfocia nel tentativo di
isolare una forma di validità assoluta, che Derrida bollerà come solidale alla
“metafisica della presenza”.
Tuttavia tra la posizione di Derrida e quella di Merleau-Ponty si possono notare
delle differenze significative.
Merleau-Ponty non arriverà agli esiti di Heidegger, il quale mette in discussione il concetto
di origine in quanto tale. Il suo problema è invece quello di cercare un’origine che non sia un
arché, tentando di cogliere ciò che fonda il senso, pur senza essere un fondamento positivo
assoluto.
Egli critica in particolare il fatto che Husserl veda nella coscienza costituente il
fondamento di ogni senso, considerando ogni intenzionalità come intenzionalità
d’atto, poiché una tale intenzionalità non permette di rendere conto di ciò che
precede ogni tematizzazione. Il filosofo francese concepisce allora una intenzionalità
“laterale” che non traduce una significazione conclusa e leggibile, ma offre un inizio
di senso da tentare, che niente dirige o cautela in anticipo, ma che intraprende
un’avventura nel suo movimento di esplicitazione fenomenologica. Si delinea così la
posta in gioco della ricerca di Merleau-Ponty: come afferrare ciò che crea il senso
senza essere costituzione fondamentale. Il pericolo è che, avendo constatato come
nella ricerca di un senso ci si ritrovi in una catena infinita di rinvii inscritta nel campo
della sedimentazione del mondo, il momento genetico sfugga e si venga gettati in un
circolo senza inizio né fine. Certamente si viene a creare una situazione
paradossale, che Merleau-Ponty non nega; egli, anzi, amava citare a questo
proposito una frase di Kafka, al quale le cose si presentavano: “non per le loro radici,
ma per un punto qualsiasi situato verso il mezzo” (milieu=centro e ambiente).
Tuttavia, pur rilevando l’impossibilità di scoprire un’origine prima o un termine ultimo
capace di orientare la ricerca verso la conquista di una significazione universale
comunicabile obbiettivamente, egli non rinuncia a ricercare un cominciamento.
Come la critica all’idea di fondamento assoluto non conduce a rinunciare alla ricerca
dell’origine del senso, essa non deve nemmeno indurre ad una fondazione empirica
e contingente. Il nuovo ordine di concetti di dimensione, articolazione, cerniera,
perno, Ineinander, gli permette di precisare la nozione di un’origine che si fa
dall’interno del mondo, dalla sua apertura radicata nella carne, secondo il motivo
preoggettivo del “serpentement”. Ne va di un campo più profondo dell’ordine logicoeidetico, irriducibile all’identificazione di significazioni definitive, che suscita un
appello di senso da prospettare. Nell’ambito della filosofia del sensibile di MerleauPonty, perciò, è chiaro l’interesse che riveste un testo come la Crisi, poiché qui
affiora l’idea che il senso non vada ricercato rivolgendosi verso un cielo di essenze
intelleggibili, ma come il senso si radichi nella terra, nella dimensione della
profondità.
Anche Merleau-Ponty si sofferma sulla crisi della cultura e della razionalità del
suo tempo ed esige che sia pensato il senso di una fondazione culturale e filosofica;
Nella prima nota di lavoro del Visibile e l’invisibile il filosofo scrive: “Il nostro stato di
non-filosofia. La crisi non è mai stata altrettanto radicale. Le ‘soluzioni’ dialettiche = o
la ‘cattiva dialettica’ che identifica gli opposti, che è non-filosofia, oppure la dialettica
‘imbalsamata’ che non è più dialettica. Fine della filosofia o rinascita? Necessità di
un ritorno all’ontologia (…). Occorre una Ursprungsklärung”. La sua attenzione alla
questione del “suolo” sfocerà nell’individuazione di un’esperienza originaria
dell’essere e del senso nello strato preriflessivo della percezione. Il porsi la
questione di una genesi della verità filosofica e scientifica coinvolge inoltre la
questione di una nuova filosofia della storia e di una nuova ontologia: “Noi non
proponiamo di interrompere una filosofia riflessiva dopo aver esordito nel suo stesso
modo – ciò è impossibilee, tutto sommato, una filosofia della riflessione totale ci
sembra andare più lontano, se non altro perché circoscrive quanto, nella nostra
esperienza, le resiste -, ma di esordire diversamente”.
In Derrida, invece, la constatazione della solidarietà del concetto di origine
assoluta con la “metafisica della presenza”, congiunta alla lezione di Heidegger e
alla critica alla storia di Nietzche, conduce al rifiuto del concetto di origine tout court.
Sin dai tempi della sua tesi di laurea sul problema della genesi nella filofofia
husserliana, Derrida medita sul paradosso dell’origine, che riunisce in sé i due
significati contraddittori di scaturigine assoluta e autonoma, al di fuori dello sviluppo
che essa mette in moto, e di divenire, cioè di una genesi avvolta dal contesto che
genera e da cui quindi è generata. La genesi, per essere genesi di qualcosa, è
paradossalmente sempre necessariamente in ritardo rispetto a se stessa: essa
rende possibile ciò che l’ha creata solo retrospettivamente. La constatazione della
necessità di questo scarto, assieme al riscontro di un circolo vizioso originario che
ingloba la genesi nel suo proprio movimento, si ripercuote su tutto il pensiero di
Derrida; la storia diviene così reciprocità circolare, senza inizio né fine, tra senso e
non-senso, il tempo reciprocità tra protensione e ritenzione, la différance tra
spaziamento e temporalizzazione. Derrida si trova quindi nell’impossibilità di venire
criticato, dato che criticandolo non si fa che confermare le sue argomentazioni , ma
anche, reciprocamente, nell’impossibilità di manifestare una critica netta. Egli, come
il suo interlocutore, non si trova né dentro, né fuori del suo “sistema”, ma
paradossalmente gettato in questa specie di circolo.
Alla fine de La voce e il fenomeno, il filosofo francese, ricordando il gioco di
scatole cinesi citato da Husserl in Idee I sulla galleria di Dresda, insiste
sull’impossibilità di un’uscita: “Del pieno giorno della presenza, fuori dalla galleria,
nessuna percezione ci è data né sicuramente promessa. La galleria è un labirinto
che comprende in sé le sue uscite: non vi si è mai caduti come in un caso particolare
dell’esperienza (…) contrariamente all’assicurazione che ci dà Husserl, lo sguardo
non può dimorare”.
Bibliografia:
M. Merleau-Ponty, Notes de cours sur l’Origine de la gèometrie de
Husserl, PUF, Parigi 1998 = NOG.
M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1969 = VI.
M. Merleau-Ponty, Les sciences de l’homme et la phénoménologie.
Cours de la Sorbonne.
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961 = Crisi.
J. Derrida, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, Jaka
Book, Milano 1992 = PG.
J. Derrida, Introduzione all’Origine della geometria, Jaka Book, Milano
1987.
J. Derrida, La voce e il fenomeno, Jaka Book, Milano 1968 = VF.
M. Iofrida, Fin du sujet, fin de l’histoire: considérations sur la philosophie
française contemporaine.
Mondo e Soggetto - Su "Le origini della geometria" di Michel Serres
di Claudio Baracchi
- L'invenzione 1 (invenzione del sapere: il luogo)
Nel lavoro presentato su Serres un anno fa' mi sono soffermato sui problemi
metodo-logici da lui ravvisati nella pratica della scienza. Questa pratica è risultata
ridursi ad un procedere logico-simbolico quasi del tutto irrelato con la natura della
quale essa, la scienza, si pretende produttrice di assoluta descrizione.
Nell'analisi di Serres, dunque, parlando di teoria scientifica, cioè di ciò che della
pratica dello scienziato può essere consegnato al pubblico ed alla pubblicità, il
termine "descrizione" viene sistematicamente sostituito con quello di "invenzione".
Questo, intanto, per evitare fraintendimenti connessi all'uso, alla grammatica, di
concetti come 'trovare', 'scoprire', che "designano i gesti banali compiuti quando si è
cercato un oggetto perduto". La differenza tra la prassi dello scienziato e quella del
cercatore dell'oggetto perduto sta nel fatto che, quest'ultimo, sa cosa sta cercando.
L'oggetto-forma dello scienziato, invece, è proprio ciò che non è noto. Le nature dei
due oggetti in gioco non sono commensurabili. Non hanno nulla in comune. A
differenza dell'oggetto perduto, infatti, l'oggetto dello scienziato, letteralmente, non si
trova in nessun luogo. In questo modo, non si può neanche dire, a rigore, che sia
possibile cercarlo o ricercarlo. Lo si può soltanto inventare.
La parola "invenzione" usata da Serres, per indicare il presunto "ritrovamento"
dell'oggetto da parte dello scienziato, pone allo scoperto la "natura" eccezionale di
questo oggetto e mette in guardia rispetto alle possibili complicazioni che ne
possono seguire. Le complicazioni, qui, riguardano la comprensione del concetto di
'sapere'.
In breve, con parole sue: "Non si scoprono un teorema od una legge come un
ago d'oro in un pagliaio, poiché non si sa, in via preliminare, che c'è un gioiello nella
paglia. Allora non si cercherebbe che ciò che già si sa. Ed il sapere preesisterebbe
a se stesso, come se fosse da qualche parte, al di fuori di noi"1. Ossia: la
formula matematica che descrive l'oggetto non traduce semplicemente in simboli
qualcosa che esistesse prima della stessa formula. La teoria espressa sull'oggetto
non mostra la 'scoperta', il 'ritrovamento', di una forma geometrica nascosta
nell'oggetto, piuttosto "da vita", crea, inventa questa forma. Il sapere che fa dire allo
scienziato "ho trovato!", "ho scoperto!", a pensarci, si riduce alla credenza, radicata
fino alla fede, che Dio abbia creato il mondo pensando geometricamente. Ossia, che
la struttura della natura sia, nel suo intimo più intimo, una connessione logica di
forme, dunque traducibile esattamente con lo strumento simbolico-matematico.
La concezione della natura di Galilei, insomma, cito: "La filosofia è scritta in
questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico
l'Universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e
conoscer i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri
son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a
intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un
oscuro labirinto" (Saggiatore, in Opere, VI, pag. 232).
Ciò che Galilei rifiutò caparbiamente di dire, ciò che in realtà non ammise mai,
perché mai vi credette, è che si trattasse un'ipotesi2. Il tribunale ecclesiastico
pretendeva in effetti soltanto questo. Doveva semplicemente dare pubblicamente,
all'identità postulata tra essenza della natura e struttura della legge geometrica,
valore di possibilità tra le possibilità. Al di là della messa in scena dell'abiura, anzi
forse proprio a partire dal processo come evento spettacolare, questa posizione di
Galilei non cambia e continua a dominare i modi della scienza. Cambiano le logiche,
le classificazioni, e cambiano i nomi che diamo agli elementi, ma il principio
dell'azione non cambia. Conosciamo l'universo in questo modo, e se anche a volte
gli scienziati più umili parlano delle loro teorie effettivamente come di ipotesi, il succo
non cambia, il punto resta fermo: se vi sarà verità questa avrà la forma di una
geometria.
C'è, nella posizione di Galilei, leggibile, un sapere scritto nelle cose che lo
scienziato non deve far altro che imparare a leggere; la sua prassi si riduce alla
ricerca del codice di accesso, al sistema di decodifica del mondo, il mondo in cui gli
oggetti non sono cose, ma forme. Il linguaggio matematico di queste forme è
naturalizzato. Non è più un utensile con cui "lavoriamo" le cose, è il linguaggio
stesso delle cose stesse. E questo spostamento "pone arditamente fuori di noi il
centro attivo del sapere" (G, pag. 194).
In definitiva, quindi, parlare di 'invenzione' a proposito di queste forme, equivale
a rimettere in discussione la certezza fondamentale del sistema teorico e
metodologico della scienza. Equivale ad attribuire statuto di ipotesi a questo
fondamento ed a tutto ciò che da quest'ultimo segue necessariamente. Equivale a
segnalare che vi è produzione di un mondo laddove si pretendeva esserci la
descrizione del mondo in quanto tale.
Di fatto, la teoria scientifica, tutta addossata al riferimento fisso, allo spazio ed
al tempo unico che essa stessa produce, ha pochissime probabilità di fornire una
descrizione esatta del suo oggetto. Può certo fornire descrizioni 'corrette', dove
"correttezza" indica, qui, la soddisfazione dei criteri per l'applicazione pratica,
tecnica, tecnologica. Può descrivere correttamente l'oggetto, dunque, relativamente
a questo uso. Lo fa. Lo fa da sempre. I successi della scienza sono ben al di là dal
poter essere sindacati. Il mondo ormai è pieno dei suoi successi e delle sue
applicazioni "corrette".
Ma non è questo il punto. Il punto è che il progetto generale della scienza
moderna, quello dell'applicazione di un metodo infallibile, in tutte le direzioni del
vivente, naturale e culturale, per restituire, alla fine del progresso analitico-sintetico,
un concetto di 'mondo' intercambiabile con la verità del mondo stesso, specchio
esatto e perfetto, aderente in ogni sua parte, questo progetto, dicevo, ha probabilità
quasi nulle di compiersi con successo. La probabilità non ha valore identico a zero
per il semplice fatto che l'ipotesi costituisce almeno una possibilità, ma molto
prossima al valore nullo perché da calcolarsi in rapporto ad un possibile
innumerevole.
Articolerò la questione dell'improbabilità del progetto scientifico su due punti,
schematizzando (non poco!) l'"ordine" delle argomentazioni di Serres.
1. Serres svolge queste considerazioni a proposito del progetto scientifico,
muovendo da un'alternativa visione delle cose e, allo stesso tempo, da una diversa
concezione del sapere.
Il 'sapere' in Serres è sempre e comunque fondato su di un cosmo per niente
ordinato. Il mondo delle cose, della vita, egli lo dice: "caotico", "rumoroso",
"instabile", "tigrato", "zebrato", "speziato", "screziato", "striato" e "arlecchinato"
insieme… un "Caosmos" insomma. In questo "Caosmos" le cose, gli uomini, le
pratiche degli uomini sulle cose, i rapporti delle cose con le cose, degli uomini con gli
uomini, di questi ultimi con le cose e con il resto del vivente… tutto questo e altro
ancora si mescola in una sommatoria di spazi e di tempi differenti, in una
sommatoria cioè di saperi differenti, saperi individuali, di gruppo, culture estese… In
questa mescolanza, miscuglio, i fenomeni fluttuano indifferenziati (apeiron). La
modalità del tempo di questo miscuglio è pancronica, quella dello spazio è
descrivibile come "stratificata", "accavallata", "accatastata", "stockata".
Certo, in questo disordine generale, facenti parte di esso, possono trovarsi
"isole" di relativa stabilità, equilibrio; si tratterà comunque e sempre di una stasi
immersa nel divenire. L'erosione dei mari e dei venti non smetterà di lambirla e faglie
vicine e lontane non smetteranno di spingerla alla deriva.
Si tratta di un 'sapere', quindi, quello inteso da Serres, sempre condizionato da
una temporalità quasi imprevedibile e da uno spazio non esattamente misurabile.
Le pretese della scienza, in questo contesto impervio, sono simili a quelle di
colui che abita una di queste isole e che sostiene, di fronte al mondo, di avere
trovato l'unica terra immobile e immutabile presente sul globo. Ovviamente, costui, in
virtù di questa sua ipotesi, potrebbe anche arrivare ad asserire che il vero sapere sul
mondo può avere luogo soltanto da quel punto fisso di osservazione. Epistème
appunto: "porre, mettere, sedersi su, far sosta, fermarsi… per la lingua greca,
pensare, sapere, presuppongono questo piano di appoggio basso e sicuro…
L'epistème, sapere o scienza, richiede un luogo stabile in cui il soggetto si ferma, in
riposo" (G, pag. 117)
Pitagora, Platone, e Galilei a partire da questi ultimi, vedono nel trapassare
continuo e discontinuo delle realtà fenomeniche un ordine, una realtà perenne della
quale questi continui mutamenti sarebbero soltanto apparizioni. Questa realtà stabile
è pensata in una temporalità continua, quindi al di fuori della mescolanza
"pancronica", e in uno spazio omogeneo, quindi al di fuori di una spazialità, diciamo,
"stockata". Questa è l'isola immobile della scienza, questa è l'isola al di fuori del
bailamme tale da comprendere l'ordine delle cose. Il suo tempo continuo e unico, il
suo spazio omogeneo e unico possono assorbire nella chiarezza e distinzione, la
spazio-temporalità della mescolanza. All'interno della varietà dei tempi e degli spazi,
nella varietà dei loro giochi possibili, verrebbe ritrovato un filo conduttore, un
elemento comune al quale tutti i tempi e tutti gli spazi possono essere riportati 3.
Questo assorbimento classifica l'indifferenziato e lo dispone su di una retta, o su di
una curva, o su di un'onda, non importa, si tratterà comunque di una funzione
calcolabile, matematicamente esprimibile. In questa espressione non compaiono le
cose stesse, ma le loro realtà ideali, compaiono punti, linee, triangoli, e figure
geometriche sempre più complesse. In definitiva si crea uno spazio dove sia
impossibile smarrire l'oggetto, non ci sono più caverne nel mondo, antri nascosti,
strati e sottostrati, il mondo è tutto mostrato e a portata di mano. Per quanto gli
oggetti corrano veloci, per quanto possano accellerare, si potrà sempre calcolare il
punto in cui uno di essi si trova nello spazio ad un dato momento, dunque si potrà
sempre identificare l'oggetto e darne le coordinate esatte.
Il caos è dominato. L'"oro puro della matematicità" è estratto dal caos e mostra
il cosmo. L'ago d'oro nel pagliaio è stato trovato, e anche il fluire, il movimento, il
trapassare, il mescolarsi trovano la loro logica. Anche la loro dinamica incerta è
stabilizzata, su di un movimento prevedibile.
Questa è l'ipotesi. Questa è la scommessa totale, l'azzardo irresponsabile, la
fede fondamentalista e cieca rispetto al fatto che "l'ago nel pagliaio è, ad esempio,
una cifra tra miliardi di cifre nelle rotelle di una combinazione; è, in generale, un
determinato tra un possibile innumerevole. Ciò costituisce un rapporto molto vicino a
zero che valuta, di precisione, l'improbabile" (PNO, pag. 186)
2. Vediamo ora la questione dell'improbabilità dal punto di vista del metodo:
"Per il fatto che inizialmente la scienza seleziona i suoi fenomeni, essa ha per
correlato l'improbabile" (PNO, 187).
Il metodo delle scienze matematiche, come primo gesto, seleziona i suoi
fenomeni: di questa operazione consiste inizialmente il lavoro dello scienziato
comune. Infatti: "quest'ultimo lo riconoscerete da questo indizio: egli è fatalmente
portato a dirvi, di qualcosa, ad un certo momento: questo non mi interessa. […] La
scienza è, nel suo lavoro, questa divisione, o questa partizione. Essa lavora al
negativo, innanzitutto. Elimina, sottrae, sopprime".
La selezione viene operata, come abbiamo visto, su di un terreno costituito da
molteplici stati di cose, costituisce, per così dire, ancora, "un determinato in un
possibile innumerevole".
Da precisare subito che la non numerabilità delle possibilità, in Serres, non si
riferisce alla semplice nozione classica di 'infinito', ma all'impossibilità pratica di un
inventario del possibile, all'impossibilità di un'esperienza totale e all'impossibilità
teorica di esaurimento del campo. Il "possibile innumerevole" si riferisce alle tre cose
insieme. Il tentativo è quello di portare la nozione teorica di 'infinito' all'interno dei
molteplici tempi e molteplici spazi del reale.
In altri termini, se si tratta normalmente il concetto di 'infinito' come intuibile, per
esempio, a partire dalla successione potenzialmente infinita dei numeri, o dalla retta
come prolungamento senza fine di una linea, e se questa intuizione ce ne può dare
un'immagine lineare, Serres avanza un'idea di 'infinito' esteso4 alla sua varietà
topologica, intuibile a partire dalla "struttura" frattale delle onde del mare, del bordo
tra mare e terra, tra acqua e sabbia, le conformazioni di vapore nell'aria, le nuvole, o
le lingue incandescenti di un fuoco, la mescolanza caotica delle specie vegetali e
animali, o gli sterminati comportamenti dell'uomo, pensato in altrettante sterminate
culture.
A fronte di questa "molteplicità rigogliosa di stati di cose" il gesto teorico, a
partire dalle sue selezioni, non può non essere sempre approssimato che per difetto,
e le proporzioni di questa approssimazione, nel caso della scienza, non possono
non essere che sempre spropositate.
Impossibilitata a rendere conto di questo "Multiverso" nel suo insieme, la
scienza intraprende la via analitica, la scomposizione del tutto nelle sue parti
semplici e sempre più semplici, da considerarsi separatamente l'una dall'altra. Il
rispecchiamento di questo processo è visibile, globalmente, nell'organizzazione del
mondo scientifico, quindi nella sua frammentazione interna in molteplici discipline
specialistiche (divisione del lavoro).
Localmente, nell'ulteriore selezione dei fenomeni, operata all'interno del campo
di pertinenza di ognuna di queste discipline particolari.
Infine, all'interno di questa cerchia ristretta di fenomeni selezionati, il lavoro
consiste nella ricerca dell'invarianza, dell'elemento stabilizzatore, ossia, nella
formalizzazione dei fenomeni-campione fino al raggiungimento di quell'elemento o
quella combinazione di elementi, che si presenta stabile e ricorrente, comune, per
ogni fenomeno preso in considerazione. Questo elemento comune, l'elemento
formalmente razionale ritrovato all'interno della cerchia di fenomeni selezionati, varrà
di qui in poi come forma generale valida per ogni fenomeno appartenente alla classe
dei fenomeni selezionati.
Allora, vediamola così: c'è un macro-insieme ideale, il sapere della scienza, la
struttura geometrica del cosmo, da cui si può sfogliare l'inviluppo dei sottoinsiemi
derivati.
Abbiamo un primo livello, una prima suddivisione in macro-regioni del sapere,
una prima delimitazione generale dei fenomeni di interesse, pertinenza. A partire da
queste macro-regioni, possiamo immaginare una cascata a pioggia di sotto-insiemi,
sempre più micro-insiemi, sempre più specializzazioni di specializzazioni.
Impossibile, anche qui fare l'inventario delle micro- discipline in gioco, il
prolungamento metodico dell'analisi, produce continuamente dicotomie, zone
delimitate di pertinenza. Una sorta di paradosso di Zenone in atto.
Ognuno di questi passaggi delimita escludendo i fenomeni classificati come
fuori dal campo di interesse, fuori dunque dalla classificazione particolare, per
concentrarsi su di una selezione sempre più ristretta e rigorosa.
Ogni sotto-insieme, dal più micro al più macro, produce una forma generale
della serie di fenomeni di sua competenza. Di fatto mette in ordine il suo campo.
Il progetto generale della modernità, consiste della certezza che arrivati agli
elementi ultimi, la sintesi ritrosa di ogni sapere, di ogni sotto-insieme, possa restituire
l'ordine razionale del mondo come macro-insieme ideale del sapere (vedere per
paradosso del barbiere - il metro campione di Parigi non può essere misurato),
continuo e omogeneo in ogni sua parte.
Dunque ricomporre questa apparente disseminazione rigorosa di sapere. Tutto
il mondo naturale e culturale sarebbe ricomposto a partire da questo elemento
comune.
Ora, come abbiamo visto, ogni passaggio da insieme a sotto-insieme, da sottoinsieme a sotto-sotto-insieme, e così via, determina esclusione di fenomeni. Questo
metodo esclusivo, al di là della violenza insita nell'atto, pone continuamente problemi
dal punto di vista epistemologico. Il gesto di selezione, di esclusione, nella sua
scelta, decisione di campo, nella scarnificazione fino a razionalizzazione dell'oggetto
di interesse, taglia continuamente possibilità.
Cercando un'unica forma e rigettando tutto il resto, le altre forme possibili, il
processo analitico restringe al punto, all'elemento, il suo campo di possibilità. E,
vista in questo modo, non si può chiamare questa unica forma risultante, forma
generale, dovremo dirla piuttosto "forma eccezionale". Più che particolare dunque,
eccezione di un caso eccezionale. Il caso, qui, come si dice, è che l'eccezione
produca la regola.
E una ragione che ragioni con questa unica modalità sarà da dire altrettanto
straordinaria, cioè, parafrasando Serres: poco ragionevole e poco probabile.
La sua scarsa probabilità, comunque, non le ha impedito di affermarsi e
radicarsi facendo leva sui suoi successi. Serres lo riconosce (come potrebbe non
farlo?), e descrive la situazione riesumando proprio la categoria del 'miracolo' 5: "Che
il razionale sia reale, questa proposizione è proprio altrettanto improbabile della sua
contraria. Ma entrambe designano uno stato di cose rispetto al quale non posso far
niente: che esistono forme realizzate [reificate]. Questa esistenza è miracolosa,
letteralmente. Essa è un'isola, rara, al di sopra del mare che occupa lo spazio. E la
scienza ha lo stesso statuto: il suo limite e il suo bordo sono questo reale numeroso
dove il suo linguaggio si disperde e si dissolve in rumori, il suo terreno è l'isola del
reale informato, dominio improbabile, punta di spillo dove il logos si insemina.
Questa isola è fortunata, come si diceva nei libri illustrati. E' per la precisione
che torno a dirlo: essa ha vinto il primo premio in un gioco d'azzardo in cui le vincite
sono tanto enormi quanto rare".
Ora rimane soltanto da chiarire una questione. La domanda può presentarsi
grossomodo in questa forma: dunque, la scienza, nel suo complesso, presa per ogni
singolo laboratorio di ricerca, ripeterebbe il miracolo ogniqualvolta enunciasse una
teoria? Come è possibile questo? Non sarebbe un po' troppo ricorrente, ripetitivo,
come miracolo?
La questione sta proprio nella "ripetizione": "…l'effetto capriccioso di
un'operazione a caso è regolarizzato sempre più da una ripetizione sufficiente di
questa operazione"(sottolineature e corsivi miei).
Serres descrive questa situazione ricorrendo agli assi cartesiani.
Prendiamo due rette perpendicolari che si intersecano in un punto "0", punto di
origine. A partire dalla semiretta orizzontale seguiamo il tempo, e a partire da quella
verticale seguiamo le quantità, nella fattispecie, il valore di probabilità.
Si da dunque invenzione scientifica su di un punto molto prossimo a zero. A
partire da questo punto comincia una crescita quasi verticale delle probabilità che si
protrae fino a che l'inclinazione, anche essa continua, del quasi-verticale finisce per
disegnare una curva, attraversare il suo apice per poi cominciare la lenta fase della
decrescita. Questa "curva può essere detta quella delle condizioni di produzione"
(PNO, pag. 162).
"In principio di generazione, uso questo termine di proposito, per i suoi
molteplici sensi, pochissime idee, pochissime ipotesi, o un modello a minimo di
complessità, producono un massimo di prestazioni in un tempo molto breve e si
procurano quasi altrettanto rapidamente l'adesione dei ricercatori" (PNO, pag. 161).
Il "massimo di prestazioni" è da intendere qui come numero massimo di
produzioni, 'invenzioni'. I gesti dell'invenzione, il metodo, il principio, vengono ripetuti,
applicati, spostati di campo, occupano lo spazio del sapere con la loro forma.
Informano questo spazio.
Ora, abbiamo visto quale sia il gesto essenziale del metodo scientifico:
selezione, esclusione. Ma, nella fattispecie, si tratta di esclusione di possibilità.
Attraverso la ripetizione esponenziale del metodo, il metodo stesso,
contemporaneamente al dominio progressivo esercitato sul sapere, mira al dominio
del possibile. Così un sapere improbabile, restringendo il campo di possibilità,
decidendo i propri oggetti di ricerca, decidendo cosa si deve sapere di questi oggetti,
decidendo il campo su cui verificare le ipotesi, stabilendo regole e criteri di questa
verifica, questo sapere improbabile diventa massimamente probabile. Le invenzioni
pullulano, prevedibilmente.
Si potrebbe dire che questa ripetizione lavori, innanzitutto, all'esclusione di ciò
che la rende improbabile e alla determinazione di uno spazio del possibile che le si
confaccia.
Così si può dire che "la scienza è meno il soggetto di cui l'ordine e il disordine
sarebbero i problemi o gli oggetti, che un ordine in se stessa" (PNO, pag. 198).
Il paradosso del miracolo ricorrente può dunque essere descritto in questo
modo: che una forte improbabilità possa assumere statuto di ordine del possibile,
sua regola esclusiva, questo è il miracolo. Nel contesto di questa improbabilità
compiuta, realizzata, reificata, resa anzi realtà della realtà, ogni singola invenzione è
verificata soltanto relativamente alla possibilità che essa esprime, possibilità
probabile se considerata nel campo del possibile determinato e costituito dal sapere
scientifico.
La cosa è complessa ma facilmente esemplificabile: se noi consideriamo il
mondo naturale, come complesso di stati di cose innumerevoli, e se da un mondo
così inteso, estraiamo un singolo stato di cose, per esempio, una mucca, e la
considerassimo nelle sue ulteriori possibilità intrinseche, ci rendiamo conto che una
delle ultime che ci verrebbe in mente, e che forse non ci verrebbe in mente neanche
da ultima, è che noi possiamo incontrare il caso di una mucca che mangia carne.
Infatti se un giorno si levasse, diciamo un biologo, e ci presentasse uno studio nel
quale si descrive lo stato di cose "mucca" nel caso di "carnivora" e ci spiegasse che
questo caso presenterebbe molti vantaggi dal punto di vista della produzione della
carne, del latte, sulle velocità di questa produzione… noi certamente gli
risponderemmo, prendendo in esame le carte del suo studio, che la ricerca è sì
svolta in modo corretto, ma che la sua teoria, nella migliore delle ipotesi, è soltanto
la descrizione esatta di uno stato di cose altamente improbabile, praticamente
inesistente. Dovremmo dire così, ma così facendo avremmo anche, in qualche
modo, verificato quella teoria. Che dire? La ricerca è svolta in modo corretto, le
analisi che lui ha svolto sui tessuti del bovino, le sue comparazioni con i dati relativi
alle possibili alimentazioni, mostrano che, per ciò che si sa, in proposito, nelle
scienze, per ciò che si è dunque in diritto di inferire, secondo la logica più
inoppugnabile, i suoi risultati derivano necessariamente.
Ora, l'applicazione di quella teoria esatta, ha fatto sì che l'impensabile
divenisse pensabile, la sgrammaticatura "mucca carnivora" divenisse dicibile.
E se non fosse per le gravi complicazioni insorte bisogna pensare che
l'espressione sarebbe divenuta anche normale. Di fatto per molto tempo gli allevatori
devono avere pensato a questa assurdità come a una perfetta banalità. Di fatto,
ancora, se ci aggirassimo per le stalle d'Europa, e chissà dove altro, potremmo
notare che la probabilità di incontrare mucche carnivore è aumentata a dismisura.
Rimane il fatto, in ogni caso, che questa probabilità continua a non essere
commensurabile al possibile del mondo "in quanto tale", almeno del mondo in
quanto pensato da Serres, la sua crescita è pensabile soltanto se ci riferiamo al
mondo della scienza, il mondo dunque comprensivo delle sue possibilità teoriche e
delle parti di mondo concreto, menti incluse, già forgiato a partire da queste stesse
possibilità.
Le scienze esatte, in questo modo, giustificano la propria esattezza. Il gesto è
semplice: esclusione dell'anesatto. E la sua possibilità diviene l'unica possibilità, il
resto è messo fuori dal sapere, di diritto, fuori dalle aree di dominio, fuori dall'azione
metodica e pensante del "soggetto della conoscenza", da intendersi qui come
"vacca sacra" della scienza.
- L'invenzione 2 (giustificazione del sapere: il soggetto)
L'invenzione del soggetto-forma-della-conoscenza, intimamente, spiritualmente
geometrico, giustifica questa posizione di privilegio del metodo della geometria.
Soltanto da qui in poi, il metodo delle scienze matematiche può pretendere validità di
universale applicazione a tutte le altre regioni del sapere, cito: "Quelle lunghe catene
di ragionamenti, semplici e facili, di cui i geometri si servono per giungere alle loro
più difficili dimostrazioni, mi dettero motivo a supporre che tutte le cose di cui l'uomo
può avere conoscenza si seguono nello stesso modo" (Descartes - Discorso sul
metodo).
Una volta data per buona la svolta galileiana, una volta identificata l'essenza
della natura nella sua struttura geometrica, matematica, data per valida globalmente
e universalmente questa intuizione, una volta insomma definiti i criteri per potere
chiamare qualcosa "sapere", il soggetto comincia a parlare unicamente il linguaggio
univoco dell'oggetto. Chiameremo questo linguaggio: "tecnoletto monosemico"
(PNO, pag. 111)
Con lo stesso linguaggio, il soggetto, innanzitutto, descrive il soggetto della
conoscenza stesso, se stesso, posto come primo tra gli oggetti della conoscenza. Si
può parlare d egologia.
Descartes, appunto, risponde all'emergenza di questo oggetto primo e
fondante, presenta le coordinate per il punto fisso e immateriale dell'osservazione.
Di fatto la purezza della matematica richiede che il soggetto sia soggetto
unicamente in senso formale e che, soprattutto, la sua ragione ragioni a partire dalle
regole che condizionano l'esistenza del soggetto come forma. Almeno la possibilità
di questa esistenza, per quanto improbabile, è necessaria perché i giudizi espressi
possano pretendere validità sovraregionale ed extratemporale. Validi ovunque e
sempre. Il telos, qui, del processo scientifico, evidentemente, è l'espulsione lenta e
progressiva del movimento e dell'estensione, nella fattispecie, dello scienziato.
Voglio dire che il soggetto della scienza, in quanto forma, abita un luogo, o meglio,
un non-luogo, letteralmente, un'utopia, non affine allo spazio e al tempo che lo
scienziato abita in carne ed ossa. Il soggetto è pensato al di là del suo fenomeno, al
di la della vita, dunque, nel luogo delle anime. Il telos della scienza, da questo punto
di vista, si compie in un luogo, non luogo, utopia, che ricorda quello della morte, o
ancora meglio, quello della natura morta.
Comunque si butta lo scienziato e rimane il soggetto, e le sue regole d'uso.
Queste ultime ricalcate sulla struttura del primo e viceversa. Le regole d'uso del
soggetto sono le stesse di quelle che il metodo delle scienze matematiche mostra
padroneggiare nella sua pratica e che Descartes ordina sistematicamente nel
Discorso. Sullo stesso sistema ordina il soggetto e con ciò stesso fonda il metodo
delle scienze matematiche come metodo dei metodi, regola delle regole. E ciò
significa che di qui in poi, per la scienza, la parola "soggetto", concettualmente
isolata e determinata, diventa ciò che è possibile predicare di ogni uomo, in ogni
tempo e in ogni spazio. L'elemento comune per ogni singolarità. Lo spirito oggettivo
comune per ogni soggetto possibile. Questo spirito, questa forma, è presente in tutti
gli uomini ed emerge nell'uomo quando questi abbia raggiunto il controllo totale sugli
spiriti vitali, cioè sulle forze "meccaniche" che agiscono nel corpo.
L'invenzione del soggetto è metodologicamente corretta, è conforme alla sua
forma, vediamola così: si selezionano fenomeni, tra gli uomini prendiamo a
campione una cerchia: i geometri, per esempio. E li prendiamo in osservazione per
un'attività specifica tra le molte possibili della loro vita: l'esercizio di geometria, il
processo dimostrativo, per esempio. Notiamo che essi non si rapportano agli oggetti
a partire dai sensi, che loro gli oggetti non li guardano neanche, non li toccano, non li
ascoltano, non li annusano e non li assaporano. Notiamo, ancora, che questi
geometri lavorano con forme ridotte degli oggetti, e che questi ultimi vengono
sezionati nelle loro parti semplici che verranno poi trattare ognuna separatamente.
Notiamo infine che facendo così essi raggiungono un sapere stabile su queste forme
ridotte. Quale è l'elemento che risulterà comune dunque per ognuno di questi
uomini? Non il corpo che è anzi ciò che permette di differenziarli: il corpo non ci
interessa e lo escludiamo. Tantopiù che essi mostrano non servirsene per la
conoscenza degli oggetti: escludiamo anche i sensi ed escludiamo tutto ciò che può
venire dal corpo, le affezioni involontarie, gli spiriti vitali insomma.
Cosa resta? L'anima. E come si mostra questa anima, se abbiamo buttato il
corpo?
Essa si mostra attraverso l'applicazione del metodo geometrico che non
dipende
dal corpo. Esso percepisce le cose nello spazio e nel tempo del mondo.
L'anima produce le sue cogitazioni al di fuori di noi, al di fuori del "noi", e ciò che
essa produce in questo "di fuori" lo chiamiamo "sapere", in quanto "stabile".
Come vediamo, anche qui, come nel caso di "mucca" e "carnivora", si
costruiscono connessioni grammaticali: anima-pensiero, pensiero-metodo, forma
ridotta-verità dell'oggetto, sapere-stabilità-verità, corpo-macchina… e così via.
L'analisi del soggetto, in Descartes, è prima di tutto un'analisi del senso, una
riformulazione del corpus concettuale quale nel seicento lo si era ereditato dalla
tradizione. Proprio per questo, nelle risposte ai suoi obbiettori, Descartes è chiamato
spessissime volte a chiarire i significati delle parole che egli ha usato nelle
Meditazioni; molte delle obbiezioni che non colgono il segno hanno luogo proprio a
partire dallo scarto dei due vocabolari in gioco.
L'idea di 'Dio' stessa, non è più la stessa, dopo la sei giorni di Descartes. Per
esempio, segnalo una delle operazioni sul senso del concetto di 'Dio': la scolastica
medioevale riteneva che Dio fosse ens a se e questo per dire che il principio di
causalità, regredisse quanto regredisse, di causa in causa, si sarebbe comunque
fermato a Dio, in quanto Dio era considerato come l'unico essere che non ha
bisogno di alcuna causa per esistere. Descartes parla invece di Dio come causa sui,
intendendo con ciò, positivamente, che Dio ha in sé la ragione propria dell'essere,
cito: "Sebbene non sia necessario dire che Egli è causa efficiente di se stesso,
perché non si abbia a discutere sulle parole (corsivo mio), tuttavia, poiché
intendiamo che ciò che fa sì che Egli sia da sé, o che non abbia causa diversa da
sé, non procede dal nulla, ma dalla reale e vera immensità della sua potenza,
possiamo ben pensare che Egli fa, in certo modo, riguardo a se stesso quello che la
causa efficiente fa riguardo il suo effetto; e pertanto che egli è da se stesso
positivamente". (Descartes - Risposte alle prime obbiezioni)
Quale è il bersaglio qui? Risposta: l'estensione universale della validità di
applicazione del principio di causalità, cito: "…la luce naturale ci dice che non vi è
cosa alcuna di cui non si possa chiedere perché esista…" (Descartes - Risposte alle
prime Obbiezioni)
Ecco una delle prime impostazioni di ciò che diciamo "tecnoletto monosemico".
Ecco l'operazione di selezione e di esclusione vista dal punto di vista della
linguistica, ossia, la riduzione della semantica fino alla monosemia, fino alla
delimitazione rigorosa delle possibilità logico-sintattiche del segno. Si da senso al
segno soltanto per determinate sue ricorrenze. Il resto della semantica resta assente
dal processo conoscitivo.
L'invenzione del soggetto del sapere scientifico pone sul mondo una griglia
logico-sintattica di lettura cui tutto è soggetto, anche il soggetto appunto.
Così: "L'invenzione assorbe il soggetto come gli oggetti, il linguaggio come il
mondo" (Serres - PNO, pag. 191).
Il mondo si popola di oggetti-forma e il soggetto è un oggetto di questo mondo;
di fatto la disseminazione del soggetto ha inizio proprio con la sua istituzione di
forma-limite della scienza. La scomparsa del soggetto dal mondo, terra, o mondo
della vita, fa tutt'uno con la metodologia della scienza moderna, ne è, per così dire, il
primo passo. E anche l'ultimo6.
Il paradossale fraintendimento che percorre tutto il percorso è pensare che
quando parliamo di "soggetto del sapere" stiamo parlando di qualcosa, esistente nel
mondo. La descrizione di un soggetto di questa fattura, lo abbiamo visto, mette sulla
scena, comunque, una fortissima improbabilità. E d'altra parte, identicamente, il
fraintendimento raddoppia nel pensare che il sapere di questo soggetto sugli oggetti
si riferisca a qualcosa, cioè nel pensare che i sostantivi di questa sostanza si
riferiscano a sostanze del mondo naturale. I sostantivi, i concetti del sistema teorico,
si riferiscono unicamente al sapere che li pone significanti, il loro contesto è il
discorso di questo sistema.
Derridianamente: non si esce da questa chiusura e, letteralmente, i concetti, in
quanto formali, non possono logicamente, essere pensati significanti fuori dal
sistema-contesto. Appena li consideriamo al di fuori ci ritroviamo nell'indecidibilità.
Come sospesi tra due centri, con il significato che oscilla tra la cosa e l'oggetto.
Il punto di equilibrio di questa oscillazione consisterebbe nel rinvio tra questi
due centri differenti l'uno dall'altro, rinvio incessante che riprodurrebbe il sistema
dall'interno e dall'esterno, indecidibilmente, conservando il sistema come sistemaaltro e come sistema medesimo allo stesso tempo. Insomma nell'invarianza di un
'certo' tempo.
La disseminazione del significato trova la sua regola in questa invarianza
differente. La differenza è questa invarianza, il rinvio è questa invarianza. Il 'certo'
tempo è quello dello spaziamento e del temporeggiamento, categoria di spaziotempo che sintetizza le differenze tra i vari spazi e i vari tempi che la storia delle
scienze esatte produce con le sue rivoluzioni.
L'universale è qui quello della differenza.
- La Geometria (ancora sull'invenzione: invarianza)
Si tratta, dunque, nel caso di Serres, del tentativo di andare oltre il modello
dell'indecidibilità: "In reazione violenta, ma giusta, contro antichi ideali, perversi, che
predicavano un universale quasi sempre riducibile a un dominio imperialista e
invadente, i nostri discorsi, da mezzo secolo almeno, risuonarono delle nostre
differenze.
Dominanti, le scienze umane ci insegnarono, in questo lasso di tempo ad
amarci gli uni con gli uni ma a riconoscere e a rispettare i diritti di culture, generi,
sessi, lingue e usanze, diversi. Dobbiamo essere loro grati di aver aperto queste
molteplicità disparate.
Ora, per un paradosso perverso, la differenza finisce per imporsi, a sua volta,
come un dogma universale che, dappertutto e sempre, vieta di parlare per sempre e
dappertutto. Che solo il locale possa esprimersi globalmente?" (G, pag 7).
Secondo Serres, il gesto stesso della filosofia delle differenze riproduce il
sistema della scienza lasciandone inalterato il principio strategico cardine: il modello
di una località assume dominio globale.
Il modello moderno mira alla stabilizzazione del caos attraverso la categoria
dell'identità puntuale, quello della decostruzione, per esempio, mira a questa stessa
stabilizzazione muovendo dalla differenza puntuale dei due centri. L'imprevedibile,
l'indecidibile, viene formulato. La struttura della relazione differente tra soggetto e
oggetto sostituisce la loro identità. L'invarianza viene ritrovata nel gioco ellittico tra le
parti in causa e questo gioco descrive, con la sua concettualità formale, ogni
situazione in cui si presentino due parti in causa. E la parola "indecidibile" appartiene
alla descrizione di ogni gioco possibile.
Dunque: "Lungi dal decostruire la geometria, la detta indecidibilità 7, al contrario,
ne ricostruisce, immediatamente una nuova, generalizzata dalla precedente" (G,
pag. 125)
"Generalizzata dalla precedente", dunque, di nuovo, ciò che resta comune per
ogni mutazione d'aspetto della geometria, nella storia. Con l'universale della
differenza possiamo riscrivere la storia delle scienze, riferendo ognuna di queste, in
ogni spazio e in ogni tempo a questo elemento comune che possiamo mostrare
presente. Possiamo mostrare la presenza di questa assenza, assenza "sempre e
dappertutto" presente. Cioè possiamo mostrare ciò che la scienza, da sempre e
dappertutto è, cioè un'approssimazione mai progressiva, mai avvicinamento, del
soggetto all'oggetto.
La materia rimane allo stato di forma, in tutto simile alla mitica cornucopia,
dalla quale tutto può essere estratto o sulla quale tutto può essere proiettato, senza
che la relazione tra estrazione e proiezione possa mai restituire la materia. Un gioco
insomma dove la materia è fuori gioco, letteralmente un pre-testo per il discorso.
Di questo pre-testo sconosciuto e mitico, conosciamo il discorso interminabile
svolto nell'intorno dei suoi bordi; nella decostruzione questo discorso è attraversato
da un filo continuo: la continua non chiusura totale delle sue parti. La continua
discontinuità. Si ferma qui. Descrive continuamente ed esclusivamente, il paradosso
del prolungamento analitico in scala storica. Del rapporto tra sapere e mondo viene
descritto questo unico punto, questa regola, questo passaggio, breccia, fessura, nei
margini. Il bordo, il margine tra sapere e mondo è ridotto a questo unico punto di
intersezione tra mondo del sapere scientifico e mondo in quanto tale, non meglio
specificato che come "oltrechiusura"8.
L'invarianza riscontrata è questo punto di passaggio, punto, rigorosamente, di
non contatto che apre la comunicazione tra sapere e mondo. Ovunque, nel sapere lo
si può leggere e a partire da esso ricostruire la storia dello stesso sapere. I margini
della filosofia sono sempre letti alla ricerca di questo passaggio. Passaggio che può
essere letto come una sorta di bordo del bordo.
Se infatti l'oggetto del sistema classico gode di un limite lineare, l'oggetto al
modo di Derrida ha un margine di manovra, il suo bordo ha del gioco. E in questo
gioco oggetto con oggetto, soggetto con soggetto, soggetto con oggetto, si gettano
l'uno nell'altro, attraverso questo bordo, senza cessare di esistere, ognuno, per se
stesso. Conservando margini estremi assegnabili. I bordi oscillano, fanno questo
gioco. Rispetto al sistema classico in cui la conoscenza si dava per cancellazione di
differenze, per collasso di estremità, qui la stessa conoscenza avviene proprio in
virtù di un gioco di differenze, un gioco di pieni e di vuoti, di zeri e di uno, gioco che
produce indefinitamente la presa di distanza dall'oggetto. Gioco che perpetua la
presa di distanza del sapere dal mondo.
Il dualismo più profondo dimenticato da questo discorso sul soggetto, dai
discorsi sul soggetto in generale, è quello sussistente tra modello del sapere,
scientificamente inteso, popolato dalle sole forme ideali, e il mondo della Natura,
popolato della moltitudine delle cose, degli uomini, e mosso dalle relazioni pratiche
che intercorrono tra le une e gli altri. Si tratta del dualismo che ha origine non dal
sezionamento dell'uomo in 'sostanza pensante' e 'sostanza estesa', questo resta un
dualismo apparente; si tratta piuttosto dell'origine stessa delle meditazioni,
l'isolamento dello scienziato dal mondo, la logica di laboratorio, quando l'uomo
rimane solo con l'oggetto, entrambi sradicati dal flusso quotidiano delle relazioni,
come conchiusi sotto vetrino e osservati al microscopio da una sostanza pensante,
voce narrante fuori campo. Quello stesso isolamento che permette a Descartes di
vedere, dopo soli due giorni, guardando dalla finestra, non uomini a passeggio, ma
cappelli e mantelli sotto i quali può nascondersi ogni sorta di marchingegno.
Il soggetto di Descartes nasce in questo stato di estraniazione dal mondo, dato
il quale può anche cominciare l'esercizio del dubbio sui saperi acquisiti, la messa in
scena dell'epoché.
Per cominciare, dunque, bisognerà uscire dalla stanza ben riscaldata e
camminare vagabondando per il labirinto del sapere, dove la distanza tra due punti,
non può mai essere percorsa in linea retta. Grossomodo così Serres da le
coordinate del suo "punto" di osservazione, uniformando così l'epistéme alle leggi
del caos, insensato quest'ultimo soltanto se guardato attraverso la lente di un ordine
teorico.
La questione sta proprio qui, nella teoria, sempre necessariamente forma
ridotta della realtà. La legge che una teoria enuncia, lo abbiamo visto, non soddisfa
mai le condizioni sufficienti perché si dia descrizione esatta, cito: ""Ora
dell'invenzione, propriamente, cioè della produzione, non si è ancora avuta storia,
non ne sono state poste che le condizioni necessarie, che sono ben lungi dall'essere
sufficienti". Mi spiego meglio e chiarisco l'uso che si fa qui di 'storia'.
La teoria scientifica dominante, il modello di sapere in atto, rigorosamente,
decide della matematicità o non matematicità dei sistemi precedenti, ossia,
l'esclusione, sul piano storico, dei sistemi che non soddisfano i criteri di necessità
che il sistema pone, è essenziale a garantire la continuità stessa del sistema.
Voglio dire: capita, per lo più, che un esperto giudichi non o prescientifica una
delle geometrie che precedono la sua e che egli non pratica più: semplicemente
questa non entra nella sua storia. Con ciò, ogni geometria ne proietta una tutta sua
di ritorno, ossia, ogni sintesi si presenta come la riorganizzazione dell'intera
cattedrale logica del sapere matematico. E la storia delle scienze sarà ricalcata sui
criteri di necessità di questa logica.
Ogni geometria si costituisce operando una ridistribuzione del senso: al suo
interno ogni elemento occupa una posizione precisa e con ciò si riveste di un senso
univoco; questo sul piano puramente sincronico.
Sul piano diacronico, allo stesso tempo, il sistema funziona come vero e
proprio agente traduttore: la logica, anche linguistica del sistema, attribuisce un
senso, il suo senso, all'elemento polisemico.
Tra gli elementi diacronici alcuni vengono dunque assorbiti in una temporalità
che il sistema fonda, altri invece risultanti intraducibili non raggiungono la purezza
matematica, restano fuori dalla classificazione…
"la nuova lingua fa esplodere la precedente, la ritaglia, la filtra, elimina l'impuro,
conservando di esso solo l'oro della matematicità." (G, pag. 26).
Ogni sintesi, dunque, agendo sul piano diacronico come agente traduttore,
rilegge, reinterpreta, la storia della matematica e le conferisce il proprio senso.
Produce una propria storia, coerente in ogni sua parte.
Ora, la storia della scienza, dell'invenzione, come si diceva prima, è sempre
letta a partire da una fine, la sua coerenza interna è dovuta alla fissità dei criteri di
selezione messi in opera dal sistema vigente e questi criteri mostrano la necessità
logica con cui i suoi elementi interni sono connessi. In questa storia si esibiscono le
condizioni necessarie perché si dia invenzione, "che sono ben lungi dall'essere
sufficienti". Cosa manca di descrivere la storia delle scienze? Risposta: il taglio,
l'esclusione, la decisione presa, la riduzione minimale della semantica, il criterio di
selezione. La storia tradizionale, come la scienza, esibiscono modelli già
confezionati per l'uso, occultano i mezzi, le modalità, per pubblicizzare i fini. Così
resta inevitabile lo scarto tra la descrizione scientifica e la realtà, tra forma ridotta e
cosa.
Fare la storia dell'invenzione, propriamente, significa dare conto di questi gesti
di selezione occultati, descrivere cioè l'arbitrarietà originaria dettata dalla necessità
interna della continuità e con ciò stesso porre l'orizzonte di esattezza della
descrizione scientifica. Questo è importante: non basta porre l'arbitrarietà del gesto,
questo ancora non significa niente in Serres, dire semplicemente che il gesto teorico
sia arbitrario nella sua origine, equivale a spiegare una tautologia con una tautologia.
Bisogna descrivere questo gesto nelle sue possibili implicazioni e nelle sue possibili
applicazioni. Chiarire filosoficamente insomma i movimenti di pensiero che
producono la teoria. Questo è porre le condizioni sufficienti perché si dia invenzione.
Questo è, d'altra parte, sciogliere il gesto dello storico dalla necessità di
ripetizione della classificazione scientifica, che come si è visto, è anche
classificazione storica.
Osservando la storia tradizionale delle sintesi sistematiche, prendendo come
punto di riferimento un elemento preso a caso in qualche sistema, Serres fa notare
che esso "qui in principio, diviene, là, un anello qualsiasi della catena, altrove
addirittura una scoria abbandonata, risalente a un mondo dimenticato, altrove
ancora, precisamente, un oblio ripreso, reintegrato dalla generalizzazione, ridivenuto
attivo" (G, pag. 15).
Ecco, di nuovo, cosa diremo di questo elemento? Che è sempre la stessa
forma o che si tratta sempre di un'altra? O diremo che, forse, è insieme,
indecidibilmente, altra e medesima?
La soluzione semplice sta nel descrivere questi spostamenti, prenderli ora sul
piano sincronico, ora sulla verticale diacronica; la "randonée", la scorribanda, il
passeggiare vagabondando, consiste in questa descrizione delle linee di senso
tagliate, annodate, riannodate o ritagliate nel caos. E questa descrizione può
mostrare che l'origine della geometria, può essere situata a monte del gesto di
Talete, o dello stesso teorema già in opera presso gli agrimensori egizi. Mostrare
che nelle sue origini, in ognuna delle sue origini, la geometria non è puramente
geometrica. Che ci sono continuamente presenti nel sistema, forme mutuate da altri
saperi, sgrossate, ripulite nel corso di una storia esclusiva, ma tali da permettere la
comunicazione tra le sezioni distinte del sapere, i suoi partiti.
L'opera dello storico, in questo modo, si configura come opera in senso inverso
rispetto allo scienziato: quest'ultimo esclude, il primo descrive l'esclusione, cioè
include. Include elementi dimenticati, ricompone le briciole della ripulitura, del taglio.
Così il modello del tempo che muove questa descrizione, al di là del dire che è
pancronico, diremo che comprende il tempo della storia, più il non storico fino ad
oggi.
Una definizione possibile di Natura, in Serres è, infatti: "…il mondo sempre
dimenticato nel continuo del grafismo, il mondo dimenticato dalla carta, mondo
sconosciuto e tuttavia familiare".
Il tentativo è quello di ricucire la trama disseminata del sapere a partire dalla
descrizione grammaticale dei concetti. Data però l'estensione del campo questa
descrizione mostra esempi, cuciture possibili, e lascia soltanto intravedere per
frammenti di discorso, per descrizioni locali.
L'invarianza qui è la descrizione di località, le cui regole restano regole della
località e probabilmente non valide per sempre. Cioè: "L'essenziale, l'invariante, è
appunto la varietà. Vi siamo incollati, incatenati, non la lasciamo affatto per il
globale…". (PNO, pag. 67)
Ciò che si può dire sempre e ovunque è proprio il fatto che la regola di una
località non è la regola della globalità: "Nessuno ha mai potuto integrare il locale al
globale, esistono dovunque nelle azioni umane, individuali e collettive, dei fenomeni
irriducibili di ostruzione alla loro immersione in un universale razionale. Questa
immersione è sempre solo illusoria, e questo avviene perché è un errore puro e
semplice che coloro che recitano sul palcoscenico di questo teatro monopolizzino la
violenza. La violenza è uno dei due o tre strumenti che permettono di far entrare il
locale nel globale , di forzarlo ad esprimere la legge universale, di far sì, insomma
che il reale sia razionale"(PNO, pag. 96-97).
Ultima domanda: quale è la legittimità di questa operazione? Risposta: la
legittimità sta nel fatto che essa inventa, e mostra l'invenzione. Opera nello stesso
luogo di costituzione della teoria, ma non enuncia leggi universali della natura. A
volte si serve dell'elemento mitico mostrando l'uso che ne fa, contro il suo utilizzo
muto della scienza. Dunque certo non si fonda da nessuna parte se non in un tempo
e in uno spazio complessi che non possono essere pensati come fondamenti. Non
lo sono nel senso che non sono dotati di una stabilità puntualmente centrata. Lo
sono nel senso che la descrizione prende a modello, quale invarianza, proprio la
modalità della varianza.
Per chiudere: "Se la formazione dei concetti può essere fondata su fatti di
natura (psicologici e fisici), allora la descrizione delle nostre costruzioni concettuali
non è, in effetti, una scienza naturale travestita? Non dovremmo quindi, anziché
della grammatica, di ciò che in natura sta alla sua base?
Senza dubbio ci interessa anche la corrispondenza fra la nostra grammatica e
fatti molto generali della natura (raramente espressi in parole). Ma il nostro interesse
non ricade su queste cause possibili. Noi non facciamo scienza naturale: il nostro
scopo non è quello di fare predizioni. E nemmeno ci occupiamo di storia naturale:
perché noi i fatti di storia naturale ce li inventiamo per i nostri scopi". (L. Wittgenstein
- Osservazioni sulla filosofia della psicologia, § 46)
Note:
1
"Il sapere non viene tradotto in parole quando viene espresso. Le parole non sono la traduzione di
qualcosa che c'era prima di loro" (L. Wittgenstein - Osservazioni sulla filosofia della psicologia, § 736)
2
E' tuttora in uso presso i matematici che procedono alla matematizzazione degli oggetti il
cominciamento con proposizioni del tipo "supponiamo che…", "assumiamo che…", e il resto della
dimostrazione sarà una manipolazione di simboli che deriva necessariamente dall'assioma d'origine.
La teoria che segue la dimostrazione, cancella questo suo originario statuto ipotetico.
"…La robustezza del filo non è data dal fatto che una fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal
sovrapporsi di molte fibre l'una all'altra.
Se però qualcuno dicesse: "Dunque c'è qualcosa di comune a tutte queste formazioni, - vale a dire la
disgiunzione di tutte queste comunanze" - io risponderei: qui ti limiti a giocare con una parola. Allo
stesso modo si potrebbe dire: qualcosa percorre tutto il filo, - cioè l'ininterrotto sovrapporsi di queste
fibre" (L. Wittgenstein - Ricerche Filosofiche, § 67).
3
4
"Perché chiamiamo una certa cosa "numero"? Forse perché ha una - diretta - parentela con
qualcosa che finora si è chiamato numero; e in questo modo, possiamo dire, acquisisce una parentela
indiretta con altre cose che chiamiamo anche così. Ed estendiamo (corsivo mio) il nostro concetto di
numero così come, nel tessere un filo, intrecciamo fibra con fibra" (L. Wittgenstein - Ricerche
filosofiche, § 67)
"…prendo sul serio, ma ad un nuovo prezzo, la vecchia categoria di miracolo. Già nel
diciannovesimo secolo, aveva ripreso corso nel lessico delle scienze: si parlava del miracolo greco per
l'invenzione della geometria, di quello di Pinel nell'asilo dei folli, del miracolo di Jeans nel forno
termodinamico, del miracolo delle scimmie dattilografe nella prosopopea di Borel. Qual 'è la probabilità
che un litro d'acqua si raffreddi e geli in una fornace chiusa? E' estremamente bassa, ma non è nulla.
Qual 'è la probabilità che un branco numeroso di quadrumeni che si agitano freneticamente su delle
macchine da scrivere finisca per produrre un testo sensato o geniale? E', di certo, molto vicina a zero,
ma non è uguale a zero. Tutto ciò che avviene, in questo intorno, il più possibile vicino all'impossibile,
lo chiameremo il miracolo. Questa improbabilità si può calcolare, come vediamo, ed appare lontana
quanto si vuole dal vocabolario della teologia" (PNO - pag. 187)
5
6
Il soggetto della scienza conosce l'oggetto, dunque, ma conosce che cosa nell'oggetto? Conosce
una forma, ma quale forma conosce? Se non esiste nessuna forma prima che egli ne dia una
immagine propria… quale forma conosce? La risposta è: la propria immagine dell'oggetto. Ma
conosce cosa, di nuovo, quando conosce la propria immagine? Se stesso? Il proprio metodo di
conoscenza?
No, l'oggetto. Quale oggetto? L'oggetto conosciuto. La cosa? No, la forma della cosa. Cioè? Ciò che
ha scoperto della cosa. Cioè, ancora? L'essenza, ciò che veramente la cosa è. Voglio dire: da
sempre.
Cioè… la cosa è questo in sé e per sé da sempre ma non è mai stata riconosciuta tale? Esatto? Ora
domando: cosa riconosce il soggetto della conoscenza? Una forma? Ma quale è l'unica forma che
questo soggetto riconosce? Vorrei chiedere: quale è l'unica forma che egli può riconoscere come
verità immutabile, come sapere indubitabile, comunque certo? Risposta: la forma della sostanza
pensante.
In definitiva: il soggetto nell'oggetto riconosce la propria forma, come forma propria. E viceversa. Il
telos qui è questo collasso. L'origine da le coordinate di questo punto.
7
Mostrare, ad esempio, la struttura indecidibilmente, indefinitamente intrecciata, tra 'soggetto' e
'oggetto', la loro dialettica, continua a non porre la questione dell'opportunità o meno dell'utilizzo di
queste "due" forme. Continua a leggere l'uomo conoscente attraverso una lente del tutto particolare ed
eccezionale. Comunque la si rivolti resta un bricolage di forme ideali, e in quanto tale riproduce il
gioco, lo ripete. E di ripetizione qui si può parlare. Serres sottolinea infatti che la struttura indecidibile
dei due elementi dell'antinomia, presa in generale, non è un problema che la scienza non si sia mai
posta. E' a conoscenza di questa crisi immanente praticamente da sempre. Dal primo gesto che
produce di fatto la geometria in Grecia, attribuito a Talete.
Talete è ai piedi della piramide di Cheope, ai suoi piedi l'ombra del tetraedro proiettata dal sole sulla
sabbia, sempre ai suoi piedi la sua ombra, se stesso proiettato sulla sabbia. L'intreccio tra "medesimi"
e "altri" è fittissimo, Talete e la sua ombra, la piramide e la sua, e contemporaneamente il rapporto di
ognuno degli elementi con la sua ombra, in rapporto all'altro. La soluzione lineare, per allineamento di
linee proiettive, produce il teorema delle proporzioni in cui, l'uomo Talete pur essendo totalmente altro
rispetto alla costruzione di pietra, inventa la possibilità di esserle identico. Talete non è la tomba di
Cheope, eppure… tra il suo rapporto con l'ombra propria e il rapporto della piramide con la sua non
esiste nessuna differenza. Si potrebbe quasi pensare che la geometria si fondi proprio sull'elasticità
della struttura indecidibile tra opposti.
Da notare, comunque, anche in questo caso, il soggetto-Talete identificarsi all'oggetto-piramide nello
spazio della geometria pura.
8
Le 'fessure' di Derrida, per esempio, non sono da intendersi alla lettera come qualcosa, magari uno
spioncino da cui poter gettare un'occhiata dall'altra parte. Anche la 'fessura' di Derrida resta un
concetto allo stato formale che raddoppia semplicemente la chiusura. Se proviamo a guardarci
attraverso leggiamo "oltre-chiusura" e la visione si ferma qui, come se spiando dalla toppa di una porta
chiusa qualcuno ci lasciasse vedere soltanto la chiave che permetterebbe di aprire quella porta. Il
sorriso del diavolo insomma.
Bibliografia essenziale:
-
-
M. Serres, Le origini della geometria, Feltrinelli, Milano, 1994.
M. Serres, Passaggio a nord-ovest, Pratiche Editrice, Parma, 1984.