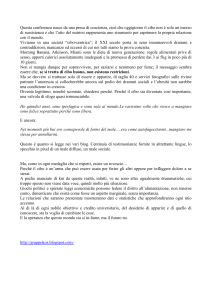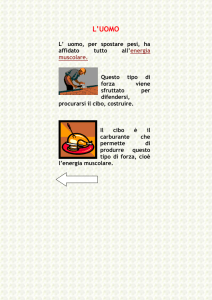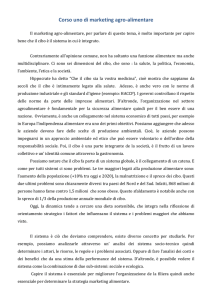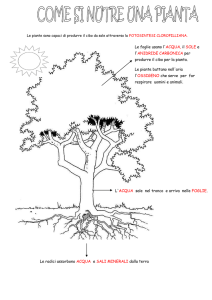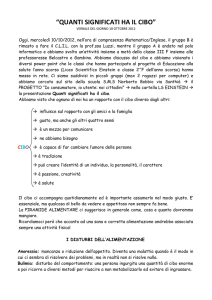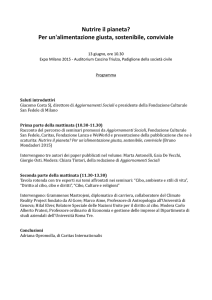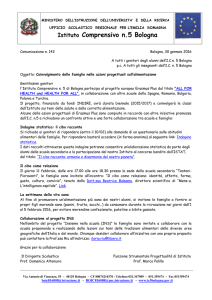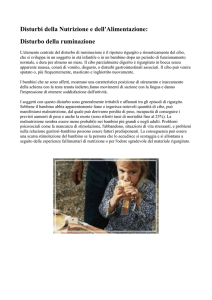Intervista a Guido Nicolosi
Università di Catania
Quale è il ruolo simbolico e materiale del cibo nel definire identità e alterità culturale, in un
contesto di globalizzazione connotato dalla progressiva perdita di riferimenti collettivi e da
spaesamento? Che dinamiche culturali e politiche si attivano nei contesti consumisti e di
“abbondanza” del cibo e quali nei contesti di “carestia” e di dipendenza dall’aiuto del cibo?
La nutrizione è un processo biologico fondamentale. Per molti versi, essa è più rilevante
della stessa sessualità, che pure ha ottenuto nelle scienze umane e sociali molto più onore
ed attenzione. Come sostenuto già nel 1932 dall’antropologa Audrey Richards in Hunger
and Work in a Savage Tribe: «un uomo può vivere senza soddisfazioni sessuali, ma senza
nutrirsi inevitabilmente morirà».
Però, sarebbe un grave errore ridurre la nutrizione ad un fatto meramente biologico. Infatti,
se è vero che per vivere noi ingeriamo delle sostanze nutritive, è altrettanto vero che
possiamo farlo soltanto dopo avere trasformato tali sostanze in alimenti, ovvero in elementi
naturali culturalmente elaborati e consumati nell’ambito di pratiche sociali codificate. Anzi,
sia dal punto di vista individuale che collettivo, ciò che mangiamo e, forse ancor più il modo
in cui lo facciamo, può spiegare ciò che noi siamo. L’identità di un singolo, così come quella
di un gruppo, di una collettività o di un’epoca, dunque, sono fortemente “legate” alle
caratteristiche alimentari che le definiscono.
Da questo punto di vista, la società occidentale capitalistica è stata spesso rappresentata
metaforicamente con un’immagine alimentare assai pregnante: la società obesa. In Francia
già negli anni novanta del secolo scorso, Claude Fischler ha mostrato come tale metafora
fosse orientata ad esprimere la dimensione negativa dell’obesità (ne esiste anche una
positiva), rappresentata dal fatto che l’obeso è simbolicamente colui che non è disposto a
dividere il cibo con gli altri membri del gruppo sociale. Non è casuale che, spesso, il
capitalista o il capitalismo siano stati rappresentati in ambito ideologico o artistico-letterario
con la figura zoomorfa del maiale (Orwell, Pasolini, ecc.). Infatti, nelle società tradizionali, il
pasto è il momento in cui il gruppo si riunisce e con-divide il momento della distribuzione
sociale. Una distribuzione non necessariamente eguale; in cui ognuno riceve, nelle forme e
nel quantum, in base ai ruoli e ai livelli gerarchici di autorità. L’obeso, come un vampiro, è
colui che rifiuta la “transazione simbolica” e si nutre, parassitariamente, di risorse scarse.
La metafora della società obesa ha bene espresso la traccia più rilevante di
un’interpretazione della modernità fondata sulle categorie “economiciste” di capitalismo e
industrialismo.
Oggi, è arrivato il momento in cui sembra possibile utilizzare una nuova metafora alimentare
in grado di rappresentare i tratti socio-culturali salienti della nostra società contemporanea:
la società ortoressica. L’ortoressia nervosa è una sindrome psico-culturale, la cui definizione
è opera di Steve Bratman, che può essere descritta sommariamente come l’ossessione per
la sana (opportuna) alimentazione. L’ortoressico è colui che passa una parte rilevante del
proprio tempo alla ricerca spasmodica e ossessiva della perfezione dietetica, organizzando,
ricercando e selezionando il cibo. Nonostante il quadro clinico non sia ancora stato
definitivamente stabilito, l’ortoressia nervosa rappresenta una condizione che interessa una
quota crescente della popolazione occidentale e, qui, ci serve come rappresentazione
metaforica di una condizione “epocale”.
Viviamo, infatti, in una società fondata sull’iper-riflessività alimentare, nelle sue varie
accezioni: dietetica (fitness), etica (consumo critico), estetica (food-design), psicopatologica (disturbi alimentari), ansiogena (paure alimentari). I mass-media e la scienza
dell’alimentazione ci propongono quotidianamente una vera e propria babele narrativa e
simbolica, da cui traspare la consapevolezza della perdita di un rapporto col cibo che in
passato era meno opaco e caratterizzato da mediazioni dirette con la dimensione
comunitaria. La società ortoressica, invece, è ossessionata dal cibo, da quello “giusto” e da
quello “sbagliato”: vi trovano facile presa l’ansia e la paura per ciò che si mette nel piatto.
Quali reti innovative riconnettono la disgiuntura tra cibo, culture e territori, nel sud del mondo
e a “casa nostra”?
Benkler afferma correttamente che una più ampia accessibilità della conoscenza e
dell’informazione può certamente avere un peso notevole nel ridurre le gravi diseguaglianze
che minano alla base lo sviluppo umano (HD) mondiale. Quest’ultimo, infatti, è strettamente
correlato allo sviluppo concreto di alcuni ambiti specifici come l’alimentazione (cibo e
sicurezza alimentare), la salute, la ricerca e l’educazione. In tutti questi ambiti, oggi, giocano
un ruolo determinante prodotti, beni e strumenti information-embedded. L’applicazione di
forme di produzione commons-based a questi ambiti può aiutare uno sviluppo umano più
equo agevolando pratiche bottom up decentralizzate. In tal senso, l’open source può aiutarci
ad evitare quella che è stata efficacemente definita da Heller la ‘tragedia degli anticommons’. L’espressione è stata coniata per criticare un utilizzo disinvolto che molti
economisti liberisti continuano a fare del famoso dilemma formulato dall’ecologo americano
Garrett James Hardin (1968) e noto come: ‘la tragedia dei commons’. Questa è riferita alla
situazione in cui una pluralità di soggetti che usufruiscono di un bene comune (non soggetto
a restrizioni di proprietà privata), agendo razionalmente per il perseguimento dei propri
interessi di breve periodo individuali, finiscono per sperperare le risorse (limitate) comuni,
anche se ciò lede evidentemente i propri interessi di lungo periodo.
La tragedia degli anti-commons, invece, descrive una situazione opposta, in cui la
proliferazione di detentori di diritti di proprietà frustrano la possibilità di raggiungere un
risultato sociale desiderabile, a causa del collasso dei meccanismi di coordinamento
necessari a garantire lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti. Un caso
emblematico di ‘tragedia degli anti-commons’ lo hanno fornito le biotecnologie, sia quelle
‘rosse’ (ambito sanitario e farmaceutico) che quelle ‘verdi’ (ambito agricolo). Lo sforzo
effettuato a partire dagli anni ’30 per incrementare le rese dei raccolti e aumentare la qualità
nutrizionale del cibo prodotto al fine di ridurre l’impatto delle carestie e della malnutrizione
ha spinto verso l’attivazione di processi di innovazione tecno-scientifica che, una volte
divenute proprietarie, non hanno più saputo rispondere in maniera soddisfacente alle
aspettative.
Prendiamo come esempio il caso del Golden Rice, una varietà di riso modificato
geneticamente al fine di introdurre vitamina A nella dieta povera delle popolazioni che lo
consumano. Qui, il ricorso alla politica della brevettazione proprietaria ha trasformato un
prodotto potenzialmente rivoluzionario in un paradosso tragico. I veti, gli impedimenti e i
costi elevatissimi causati dall’incrocio delle decine di brevetti (distribuiti in tutto il mondo) che
gravano sui vari passaggi che obbligatoriamente bisogna affrontare per la sua realizzazione
ha dato vita ad un inestricabile ginepraio legale ed economico che ha reso il Golden Rice
un prodotto di fatto non sostenibile.
Ne emerge un quadro in cui i livelli di equità sociale, la tutela delle risorse ambientali e della
salute pubblica sono stati spesso sottoposti ad inaccettabili distorsioni. Il caso degli
organismi geneticamente modificati (GMO), è solo quello più eclatante. Se ne analizziamo
l’impatto possiamo affermare che si è trattata di un’esperienza disastrosa dal punto di vista
socio-economico (impoverimento e proletarizzazione massiccia dei coltivatori del Terzo
Mondo), dal punto di vista ambientale (riduzione della biodiversità), e dal punto di vista della
reale efficacia. Senza tener conto della grave crisi simbolica che essi hanno provocato
anche nel mondo ricco ed economicamente sviluppato.
Mediante una politica brevettuale fondata sulla ‘esclusione’, l’industria biotecnologica ha in
maniera crescente ristretto l’accesso dei coltivatori alle risorse fitogenetiche. Infatti, il
germoplasma è il materiale grezzo su cui si fonda qualsiasi programma di plant-breeding e
a cui tradizionalmente i selezionatori hanno sempre avuto libero accesso per migliorare in
maniera iterativa e selettiva, nel corso di varie generazioni, le varietà delle piante.
L’avvento degli organismi geneticamente modificati è che un tipico esempio di free-riding
antisociale. Il selezionatore (spesso una multinazionale) brevetta (e quindi rende
inaccessibile) un germoplasma che è il risultato dell’incrocio di geni e altro germoplasma
sviluppati da altri selezionatori in regime di accesso libero. Spesso, infatti, questo materiale
biologico è stato sviluppato dalle pratiche culturali di comunità indigene, oppure nell’ambito
di programmi finanziati con fondi pubblici o da centri di ricerca internazionali e messi
liberamente a disposizione di tutti. Uno dei punti più alti di fondamentalismo brevettuale è
stato poi raggiunto quando sono stati brevettati semi resi artificialmente sterili per escludere
la possibilità che essi potessero essere ripiantati dai contadini. Le biotecnologie
convenzionali, così, separando i semi (e l’informazione genetica contenuta al loro interno)
dal raccolto e, quindi, dalle pratiche socio-culturali e dall’ambiente naturale che
tradizionalmente lo generavano e ‘custodivano’, hanno reso i coltivatori dipendenti dalle
multinazionali globalizzate specializzate e proprietarie dei costosissimi brevetti.
Ora, la produzione del cibo e lo sviluppo delle tecniche agricole sono il frutto di un deposito
secolare di risorse sociali, culturali e simboliche. Così, tale deposito viene marginalizzato
dai processi di produzione scientifica, provocando uno sradicamento del cibo e
dell’agricoltura dalle tradizioni locali e un arricchimento diseguale a tutto vantaggio di big
players globalizzati. In pratica, mediante la privatizzazione della biodiversità, è stata
realizzata una graduale erosione della sovranità che in passato i coltivatori avevano sui
semi. Ciò a cui abbiamo assistito è stata, dunque, la sistematica espropriazione delle risorse
simboliche e materiali ad opera di opachi e sradicati knowledge network internazionali.
La ‘proprietarizzazione’ radicale della ricerca che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni dello
sviluppo tecno-scientifico anche in ambito agro-biotecnologico ha introdotto delle gravi
inefficienze che hanno limitato drasticamente il suo potenziale economico e sociale. L’open
source applicato alla green biotechnology può risolvere molti di questi problemi, adattandosi
ai bisogni reali degli utilizzatori a prescindere dall’ampiezza del mercato che questi
utilizzatori rappresentano, velocizzando i processi innovativi e rendendoli economicamente
più accessibili, oltre che più affidabili.
L’open source applicato alle biotecnologie si pone in chiara continuità e anzi rafforza le
esperienze già consolidate di re-skilling practices in ambito agricolo che hanno l’obiettivo
ambizioso di coniugare la ricerca genetica avanzata e i saperi contadini. In entrambi i casi,
infatti, si opera un tentativo di sviluppo tecnologico bottom up che re-incapsuli le
biotecnologie nelle tradizioni sociali, culturali ed ambientali delle comunità, attraverso la
collaborazione partecipata di tecnologi, scienziati, contadini e cittadini in un meccanismo
virtuoso di partecipazione e condivisione che recuperi tutti i saperi e le risorse ambientali
locali. Per tale ragione, parlare di commons-based peer production in ambito agrobiotecnologico significa sviluppare un modello di ricerca partecipata in grado di riconoscere
agli agricoltori un ruolo fondamentale. Infatti, le biotecnologie ‘convenzionali’, attraverso il
miglioramento genetico, procedono alla selezione di varietà che spesso non rispondono alle
necessità degli agricoltori più poveri e di quelli che operano in ambienti marginali con
condizioni climatiche e sociali difficili dove la scarsezza di beni comuni come l’acqua e
l’indisponibilità delle sementi sono una realtà più che mai critica.
Al contrario, la decentralizzazione del miglioramento genetico prevede l’utilizzo e la
valorizzazione della local knowledge degli agricoltori fin dall'inizio del processo, quando la
variabilità genetica è ancora grande. Il processo avvicina agricoltori e ricercatori affinché gli
uni apprendano dagli altri. La partecipazione degli agricoltori nel processo di selezione
condotto nelle loro condizioni agronomiche e climatiche, non solo è efficace, ma accelera
notevolmente il processo di adozione delle nuove varietà senza il coinvolgimento dei
complessi meccanismi del rilascio ufficiale delle varietà, della produzione di seme certificato
e della divulgazione e garantisce un più alto mantenimento della biodiversità.