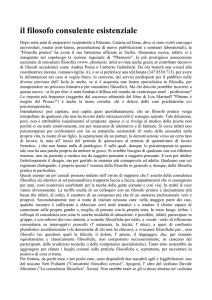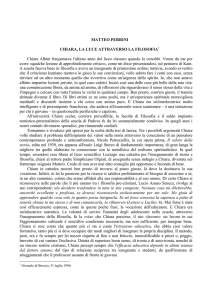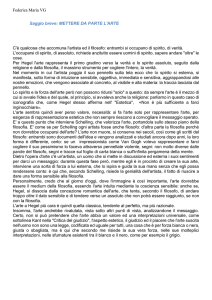Persuasione e insegnamento
Paolo Facchi
Il sogno di Anselmo
C’e una cosa che un bambino non può rifiutare che gli accada, è
quella di crescere. Il suo organismo si evolve e si ingrandisce per
forza propria. Se non viene nutrito e protetto, si ammala e muore.
Noi adulti e benestanti abbiamo certamente tanti problemi. Ma il
più grave e colpevolizzante è proprio quello dei bambini fatti nascere e poi abbandonati a se stessi, così che muoiono dopo aver
vissuto quanto gli bastava per accorgersi che erano vivi.
Il bambino dunque, per poco che gli si dia da mangiare, anche
male e in quantità non sufficiente, continua a crescere: le sue gambe si allungano, la testa si ingrossa e tutti gli organi arrivano a maturazione. Acquista faticosamente la posizione eretta, impara a
correre, a saltare e così via, senza maestri né insegnamenti; è ben
noto che questo vedersi crescere, anche molto rapidamente, provoca nelle giovani e nei giovani gravi turbamenti. L’età dello sviluppo è un periodo difficile e in taluni casi di grave tensione interna. Ma non crescere proprio non si può.
Arriva il periodo nel quale il bambino, divenuto ragazzino e
poi, come si dice, giovanotto, si accorge di avere le stesse capacità,
anche mentali, degli adulti. Se è una ragazza, una “signorina”, sa
che può mettere al mondo un bambino come ha fatto la mamma.
Ma poi si rende conto che queste sue capacità, ormai complete e
forse anche superiori a quelle di mamma e papà, non sa come adoperarle. Nell’apprendimento di qualche mestiere, nella vita di
strada come in quella di casa e di scuola, il ragazzino è bravo come
suo padre, talora anche di più; la differenza è che il padre sa sempre dove ha da andare, lui vive fra le incertezze. Il giovanotto, la
signorina sanno anche parlare come gli adulti, talora anche meglio, ma la differenza è che quelli sembra non abbiano dubbi su ciò
60
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
che dicono. Invece a lei, a lui, ai compagni, mancano le cose da dire, le sicurezze, le belle esposizioni ordinate; e si sentono giudicati
dagli anziani, che ora non sembrano più cosi indulgenti come lo
erano con loro stessi bambini.
Ecco che la vita li porta a far cose che gli adulti cominciano a
non voler fare più. Cosi, in tutte le società e in tutti i tempi, arriva
il momento nel quale si sentono dire “largo ai giovani!”. Ed essi
son lì, altezzosi all’apparenza, di fatto titubanti e perfino disperati,
perché sanno che tocca a loro ma non sanno come cavarsela.
Hanno ricevuto, è vero, molte ammonizioni ed insegnamenti
dalla famiglia, dalla scuola, da cinema, giornalini, libri e anche da
compagni più maturi. Ma una cosa è la ginnastica prenatatoria ed
un’altra è buttarsi in acqua e nuotare; anche se non si tratta di
muoversi nel mare o in fiume, ma in una ben costituita piscina,
dove si vede sempre l’altra sponda e ci sono bagnini, salvagenti ed
altro. I grandi hanno fatto le cose per bene davvero!
Man mano che una situazione nuova si presenta, l’idea più
semplice è guardare come hanno fatto gli altri che son già passati
di lì. Di situazioni veramente nuove ce ne son poche, in fondo. Inizia così la ricerca delle soluzioni da prendere a modello o da prendere come precedenti. E questi modelli, questi precedenti non li
possono fornire che i più anziani.
E gli anziani saranno i genitori, in una famiglia con babbo e
mamma; ma anche altre persone come parenti, amici di famiglia
e incontri occasionali, presi come maestri; persone anche, delle
quali il giovane ha soltanto sentito dire che hanno fatto qualcosa
di risolutivo. È una ricerca incrociata, perché la giovane guarda a
modelli femminili e maschili, il giovane a modelli maschili e
femminili. Man mano che si cresce si lascia la scuola e arriva la
vita e anche lì son sempre gli anziani ai quali si guarda. Tanto
che nei momenti nei quali si dice che i giovani contano di più,
quando c’è la contestazione e perfino la rivoluzione, è facile mostrare che le idee per le quali si battono e qualche volta anche
muoiono erano nate nella testa di qualcuno dei padri e dei nonni.
Quanto alle guerre, si sa bene che le fanno i giovani ma le gestiscono i vecchi.
61
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
Si accorgono cosi che un vero modello che accolga appieno le
loro attese non lo trovano. Anche Garibaldi ne ha combinata qualcuna di storta, anche Mazzini non le diceva proprio tutte giuste;
quanto a Carlo Marx, ogni tanto sonnecchiava anche lui ed i pensieri di Mao sembrano troppo facili per essere veri. Di Marcuse
non si capiva bene di che cosa veramente si occupasse e i discorsi
di tanti filosofi sembrano fatti più per essere ripetuti che per essere
compresi. Quanto poi agli adulti di famiglia e del proprio ambiente, beh, ne hanno fatte tante di fesserie, ne hanno dette tante di cattiverie inutili. Ma fino a che punto un figlio può accanirsi sulle
colpe di coloro che lo hanno generato e allevato?
Cosi, un poco alla volta, o anche tutto d’un colpo, si fa strada
l’idea che ci sarà ben qualcuno che sa tutto e comprende tutto, che
è sempre nel giusto e altro ancora.
Questo qualcuno non lo si trova sulla terra; sarà nei cieli, dove
c’è tanto posto e dove noi non siamo capaci di andare. È vero che
sta lassù, ma sarà ben disposto a venire di tanto in tanto anche fra
di noi, che non sempre sappiamo cavarcela nel vivere; e sarà anche
capace di raddrizzare certi torti e far andare le cose come devono
andare.
Ognuno avrà ben compreso che stiamo parlando di qualcuno che
comunemente si chiama “Dio”. Ci son quelli che dicono che è talmente al di sopra di tutto che è indecoroso soltanto parlarne; altri si
limitano a nominarlo, altri ancora passano il tempo a pregarlo che
faccia lui quello che loro non son capaci di fare; e altri un poco lo ricattano come se ne dovesse soffrire del fatto che a lui non ci si rivolge per ogni occasione. Scrivono il suo nome con l’iniziale maiuscola
quelli che dicono che ce n’è uno solo e vale per tutti; usano la parola
come un nome proprio. Invece quelli che pensano che sono tanti dicono “gli dei” e poi si divertono nel dare a ciascuno un nome suo
proprio. Questo Qualcuno (o questi qualcuni), già che lo pensiamo,
già che ne parliamo, già che gli rivolgiamo le nostre preghiere e lo
invochiamo quando siamo in difficoltà, conviene davvero pensarlo
come eterno e immortale, onnipotente, come uno che non c’è niente
che non possa fare ed ha, come si diceva, “tutti gli attributi possibili
o tutte le proprietà”. E se ha tutte le proprietà non potrà mancargli
62
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
quella di esserci, di esistere, altrimenti non sarebbe quell’essere perfettissimo che noi pensiamo, come argomentava Anselmo d’Aosta,
monaco medioevale. Ma se non fosse lui, quello a cui stiamo pensando, il “perfettissimo”, sarebbe pur sempre possibile pensare ad
un altro che “perfettissimo” sia, e quindi anche esista; e sarà lui
quello che abbiamo chiamato “Dio”. Insomma l’esistenza di Dio si
ricava dalla stessa idea che necessariamente ne abbiamo:
… infatti si può pensare che esiste un essere il quale non può
non essere pensato come esistente, e questo è maggiore di un
essere che può essere pensato come non esistente; (…) se infatti qualche intelletto potesse pensare qualcosa maggiore di Te,
la creatura sorpasserebbe il Creatore e lo giudicherebbe…1.
Oppure la si ricava per i nostri sogni, come in questa bella vicenda
dello stesso Anselmo quale ce la racconta Sofia Vanni Rovighi:
Dell’infanzia di Anselmo Admero ci riferisce un episodio
cosi grazioso, nella sua fresca ingenuità, che vale la pena ricordarlo, anche perché il fido segretario non poté udirlo se
non dalla bocca dello stesso Anselmo. Avendo egli appreso
dalla madre che su in Cielo vi è un Dio che regge e governa
ogni cosa, si figurò che il Cielo, reggia di Dio, poggiasse
sulle cime di quegli alti monti che egli si vedeva intorno, e
pensò che, scalandoli, si potesse raggiungere il Cielo; sicché, fisso in questo pensiero, una notte sognò di salire sui
monti, in Cielo, e di trovarvi solo il Padre Eterno col suo dispensiere, ché le ancelle del Signore erano tutte nelle valli a
raccogliere le messi. Fu accolto benevolmente dal Signore,
che lo fece sedere ai suoi piedi, gli chiese chi fosse e donde
venisse e gli fece servire un pane bianchissimo. Svegliatosi,
fu persuaso di essere stato davvero in Cielo e di avervi gustato il pane del Signore e lo raccontò a tutti2.
1 Anselmo, Il proslogio, capo III, trad. dal latino di Paolo Calliari e Luigi Ajme,
Istituto Missionario Pia Società San Paolo, Alba, 1944, p. 49.
2 Sofia Vanni Rovighi, Sant’Anselmo e la filosofia del secolo XI, Bocca, Milano,
1949, p. 22.
63
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
È possibile, è sensato, pensare che un così benevolo Signore davvero non sia? Un Signore che non ti giudica, ma interviene a tuo
favore senza che tu chieda, perché sa lui di che cosa tu hai bisogno. Oppure non interviene affatto, ma questo è ancora più difficile da pensare. A questo punto arrivano i problemi, perché è facile
chiedersi che cosa faccia ora, dopo che ha creato il mondo, e gli animali, e gli esseri umani.
La tradizione dice che il settimo giorno si riposò. Ma poi è arrivato l’ottavo, e poi gli anni, i secoli, fino a quando ci siamo noi. E
chi non pensa “farà qualcosa che va bene anche per me? O per i
miei simili, o per quelli della mia parte, del mio gruppo, della mia
società?”. È davvero disumano credere in un essere così onnipotente e allo stesso tempo credere che non faccia niente, ma proprio
niente, per risolvere almeno qualcuno dei nostri piccoli problemi
umani; problemi che sono spesso di rivalità con altri nostri simili.
È difficile pensare che se Dio sta dovunque non starà anche con
quelli dell’altra parte.
Ma noi sappiamo che gli eserciti germanico e austriaco, nella
prima guerra mondiale, assegnavano decorazioni militari con la
scritta “Gott wird uns zum Siege helfen”, che si può tradurre con
“Dio ci aiuterà a vincere” o anche con “ci condurrà alla vittoria”. È
inutile fare dell’ironia sapendo come è andata a finire. Non volendo rinnegare Dio è incominciata la caccia al non credente traditore,
al protetto dal Demonio. Si è arrivati cosi alla seconda guerra
mondiale. Lanci la prima pietra quel credente che non ha mai ceduto alla tentazione di mercanteggiare la propria fede, chiedendo
qualcosa per sé. E non ha mai nemmeno pensato che all’altro, al
nemico, fosse toccata la protezione del Demonio.
I popoli che ci insegnano a bollare come “politeisti” (greci e romani antichi, arabi prima di Maometto, celti, germani, slavi e tanti
altri) vivevano come se ogni popolo, ogni etnia, ogni città, avesse i
propri dèi, e poi le cose andavano come andavano. Se andavano
bene “rendevano grazie agli dèi”, se andavano male se ne lamentavano. Le colpe degli insuccessi erano distribuite tra terreni e celesti; gli dèi erano pensati come umani privilegiati, immortali, di
capacità spesso misteriose; comunque non dovevano faticare per
64
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
vivere ed erano, a seconda dei casi, benefici oppure cattivi, comunque orgogliosi, vanitosi, vendicativi; proteggevano o perseguitavano a loro discrezione. Non sembra infliggessero agli umani l’umiliazione del perdono. Erano insomma degli umani superdotati.
Un solo piccolo popolo, gli ebrei, la pensò diversamente. Dissero, e con chiarezza, che Dio è uno solo; e aggiunsero che siccome
erano loro i soli a pensarla così, questo unico Dio si occupava di
loro soltanto. Gli altri popoli, che non erano arrivati a questa semplice verità, questo loro unico Dio li trascurava o li avversava, se si
mettevano contro quel popolo che era diventato il suo. Ma questo
loro Dio unico non seppero poi pensarlo molto diversamente da
come gli altri, gli idolatri, pensavano i loro.
Ne fecero piuttosto un Dio cattivo, soprattutto preoccupato di
mostrare la sua preveggenza e potenza, di tenere gli uomini in
soggezione e rispetto; si veda la storia biblica del sacrificio di Isacco. Per affermare la sua potenza non rinunciava alla più trista delle
tecniche, quella del “divide et impera”; si veda la storia biblica della torre di Babele. E poi ricorse addirittura al diluvio. Alle origini
aveva collocato i primi due uomini da lui creati nel paradiso terrestre; ma aveva voluto che ci vivessero come bambini che non maturano mai, e non maturano mai perché non provano la paura; li
aveva voluti per sempre incapaci di qualsiasi giudizio che portasse
ad un’assunzione di responsabilità. Adamo ed Eva andavano in
giro nudi, perche là dove vivevano non avevano mai freddo; ma
non collegavano la differenza fra nudo e vestito ad altro, perché
non avevano il senso del peccato; tollerò che si coprissero e poi li
chiamò “peccatori” quando se li toglievano; la contemplazione del
corpo umano, prima innocente, diventò una colpa.
La conclusione di questo connubio fu che l’onnipotenza di Dio
venne associata alle vicende storiche di un popolo, e soprattutto
alle sue sconfitte, alle sue disgrazie. Mentre gli idolatri, più tardi
chiamati anche “pagani”, potevano permettersi qualche volta di
dare la colpa ad un dio (per esempio distratto nel momento della
battaglia perduta), questo agli ebrei non era possibile. Un Dio
sempre presente, onnipotente, vigile, non può lasciare che al suo
65
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
popolo “eletto” accada il male per distrazione o per caso. Facendoci soffrire ha voluto mettere alla prova la nostra fede. Dobbiamo
mostrargli che non cediamo alle sue astuzie; più ci tratta male e
più lo onoriamo e serviamo e più dobbiamo accusare noi stessi di
colpe che andiamo a cercare con solerzia in qualcosa che abbiamo
fatto o pensato o sentito. Non gli sarà mai mossa un’accusa, un
rimprovero, in conseguenza del quale egli si senta giustificato ad
abbandonarci.
Io credo che non sia bene accompagnare i giovani nella loro
formazione con queste idee terrificanti, sapientemente perfezionate nei secoli da teologi e confessori. Il terrorismo dell’educazione
ecclesiastica si dispone tutto attorno al controllo della pratica sessuale. Questo perché la formazione sessuale, gli incontri fra i giovani, sono sempre stati una variabile capace di assumere i valori
più dirompenti nell’equilibrio delle forze sociali. E non si dovrebbe invocare Dio per queste cose. Nel sogno di Anselmo Dio non
chiedeva al bambino, prima di dargli quel suo “pane bianchissimo”, se avesse commesso “atti impuri”. Si dirà che era un sogno,
un desiderio. Ma sarebbe ora di andare incontro a questi sogni.
La neutralità dell’insegnante
«Tutti gli uomini aspirano per natura alla conoscenza» è l’affermazione di apertura della Metafisica di Aristotele (Carlo Augusto
Viano). Il significato è ambizioso e diviene addirittura fondante, se
lo si unisce a quanto altrove lo stesso Aristotele afferma, che il sapere è tale in quanto lo si può insegnare; ovvero può essere messo
in comune con altre persone, nelle forme dell’insegnamento. Dunque c’è un “uomo aristotelico” il quale desidera, per essersi lui
stesso definito così, insegnare ciò che lui stesso ha appreso, per
conquista propria o perché trasmessogli da altri.
Conviene precisare da parte nostra che insegnare non corrisponde ad imporre e ancor meno, come si vedrà, a persuadere.
Una o più opinioni diventano insegnamento quando si ritiene che
rispondano a domande; e quando Aristotele attribuisce all’uomo
in generale il desiderio di conoscere, che è poi la capacità di far
66
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
domande, anticipa sagacemente una giustificazione di tutto ciò
che si accinge ad esporre sul sapere e sui suoi metodi. Oggi noi
siamo forse meno esclusivi, ma è certo che la società moderna discrimina coloro che respingono conoscenza e sapere.
Nata, nelle sue forme semplici e primitive, come necessità di
sopravvivenza e di vita, la conoscenza fattasi scienza, è arrivata a
cambiare la vita. È il sapere comunicabile che ha prevalso, contro
le lusinghe di un sapere sacerdotale basato sulla custodia dei testi
sacri o quelle di un sapere oracolare, fatto di sentenze non motivate. Il sapere che si può comunicare e insegnare è generatore di fiducia al proprio interno; non fonti esterne, privilegiate e autoritarie, producono autopersuasione in coloro che praticano tale sapere, ma la sua stessa efficacia e intersoggettività. Se produce effetti
che corrispondono a quelli desiderati si diffonde e si fa accettare.
Dunque vive e si afferma chi sa e chi comunica e insegna. Ma
sapere e comunicare non sono doni di natura, concessioni divine o
altro, che discendano da qualche cielo nascosto. Sono risultati,
conquiste, e sono anche da vedere come diritti. Ogni uomo ha il
diritto di realizzare il proprio desiderio di sapere, ogni uomo ha il
diritto di mettere al corrente gli altri di quello che sa (anche se soltanto crede di sapere). Si deve condannare ogni autorità, società,
governo, potere o simili, che ostacolino l’attuazione di questi diritti o non li promuovano con la dovuta energia.
Il sapere produce informazione per sé e per gli altri e presuppone l’autoconvincimento; non soltanto della sua utilità immediata, che può essere anche per fini non sempre difendibili, come la
sopraffazione o la guerra; ma della sua corrispondenza a valori
per tutti, quali il progresso, la liberazione dalla paura, l’allungamento della vita, il benessere collettivo; insomma ciò che si
chiama “felicità in questa vita”, rovesciando la tradizionale contrapposizione religiosa del compenso-riconoscimento (gli infelici
saranno felici e compensati in un’altra vita delle sofferenze patite
in questa); no, gli infelici hanno diritto a chiedere la felicità in vita
e non vanno trattenuti e consolati con prospettive che rendano addirittura confortevole l’idea di morire. E chi nasce, nasce anche con
il diritto alla felicità.
67
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
Va detto che la neutralità del sapere, dietro la quale si trincerano uomini di scienza e anche uomini di cultura, alcune sue giustificazioni le ha. Si lavora meglio al riparo dalle ingerenze di politici,
filosofi, pontefici, moralisti e sacerdoti; i quali hanno ben poco titolo per selezionare i risultati, se non l’appello a valori che gli scienziati stessi dovrebbero condividere. Di per sé il sapere scientifico
mette in crisi abitudini e convincimenti che potrebbero apparire da
esso indipendenti e invece li fa apparire come riconducibili a fasi
più arretrate della conoscenza; non soltanto è sparito il “con dolore partorirai i figli” ma non è più concepibile una condanna dell’attività sessuale non riproduttiva; così come non è più concepibile una condanna del controllo demografico, sia all’interno delle
coppie che nella società. Non è necessario tirare in ballo ogni volta
il processo a Galileo per comprendere che gli uomini hanno bisogno di protezione e di incoraggiamento e poi vanno lasciati in pace a discutere dei loro lavori e dei loro risultati. Poi succedono altre cose (come la bomba su Hiroshima) e l’uomo di ricerca non
può essere addebitato o accreditato di tutto quello che vien fatto
dopo di lui, a partire dai suoi risultati.
L’autoconvinzione dell’uomo di scienza è dunque cosa ben diversa da quella dell’uomo di potere che deciderà se utilizzare o
non utilizzare i suoi risultati. E tuttavia non può essere soltanto legata, questa fiducia nel proprio lavoro, all’ottenimento di taluni
successi. Sappiamo che i fisici dell’atomo si sentirono ingannati
dai politici degli Stati Uniti, che li avevano spronati a dargli
l’atomica con la paura che ci arrivassero i tedeschi di Hitler e poi la
usarono contro civili giapponesi; come ebbe a dire Enrico Fermi
«A quell’epoca avevamo smesso di pensare». Rimane però certo
che non si sarebbe formata alcuna forma di sapere, nemmeno
l’arte di addomesticare gli animali e di costruire le navi, se si fosse
voluto legarla preventivamente a determinati usi o successi.
Che l’uomo di scienza sia convinto di quello che sta facendo è
una condizione interna al suo stesso lavoro. Ma quando si riferisce
a proposizioni prese singolarmente, la sua è un’adesione pragmatica, argomentata volta per volta. L’inerzia e l’attrazione reciproca
dei corpi son due principi della fisica ritenuti costantemente validi
68
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
anche quando manca una conferma osservativa. Ma non è mai stata attribuita loro la validità letterale di un testo sacro né richiesta la
silenziosa adesione come ad un dogma.
Insegnamento non è persuasione, anche se chi insegna è solito
argomentare in favore del proprio lavoro e dei risultati ottenuti.
Ma del proprio lavoro di insegnante, che riguarda altri venuti
prima di lui; e non è la stessa cosa del lavoro compiuto da coloro
di cui espone il pensiero. È anche un diritto, che va riconosciuto
anche a quelli che non fanno parte della comunità degli scienziati,
rendere pubblico quello che hanno fatto e argomentare in favore
di esso; fa sempre parte dell’insegnamento, perché lascia chi ascolta libero di dissentire o di non curarsi affatto di quanto gli è stato
detto. L’ignorante sarà discriminato dalla società, non condannato
come le varie chiese condannano il peccatore. L’insegnamento non
produce infedeli.
Un buon insegnante non è necessariamente immedesimato con
tutto quello che trasmette; non può essere così per il predicatore.
È fuori posto fra insegnanti e ricercatori chi assume atteggiamenti da predicatore. Chi predica non può insegnare e chi insegna
non può predicare. Infatti l’insegnamento è dialogico, la predicazione esclude il dialogo; l’insegnamento riconosce l’errore, anche il proprio, la predicazione lo esclude. È su queste basi che
divien lecito porsi alcune domande: è possibile insegnare alcunché senza esserne persuasi? Più esplicitamente, è possibile che
un insegnante, chiamato ad istruire altri, assuma verso l’oggetto
del proprio insegnamento la posizione distaccata di chi dice agli
allievi:
Queste sono le nozioni che vi devo comunicare per dovere
professionale, o per un impegno che ho preso, ma non chiedete a me un giudizio, positivo o negativo, sulla loro validità, perché su questo punto io vi lascio piena libertà di regolarvi come credete?
È possibile, addirittura, insegnare ciò che si ritiene sbagliato, erroneo, peccaminoso? È possibile comunicare efficacemente l’errore?
69
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
L’indifferenza o l’avversione verso ciò che si insegna non ne ostacolano o ne impediscono l’insegnamento?
Stando all’uso comune delle parole, diverse risposte sono possibili. Saranno piuttosto sul positivo se ci riferiamo al sapere scientifico. Si, di certo, è possibile insegnare dottrine scientifiche che si
ritengono superate e farlo in modo efficace; cosi come un insegnante di geometria può dimostrare un teorema con un ragionamento che sa imperfetto o incompleto, ma lo ritiene più facile per
gli allievi e gli chiede meno tempo; le inferenze ingannevoli, i sillogismi scorretti si possono spiegare altrettanto bene dei loro fratelli più fortunati.
Basta passare alle scienze che hanno per oggetto l’uomo perché
questa bella sicurezza cominci ad incrinarsi. Il chimico può non
avere scrupoli nel mettere in formula un farmaco o un veleno, ma
il medico non sarà così indifferente verso il paziente; né un insegnante di ginnastica potrà vantarsi di essere altrettanto bravo a
sfasciare gambe e muscoli, quanto é bravo nel rinforzarli. Si parla
di insegnamento anche riguardo alla storiografia, ma qui comincia
ad essere dubbio che si possano esporre efficacemente vicende e
personaggi che ripugnano. Chi si vantasse di una sua imparzialità
difficilmente riuscirà convincente. Così è accaduto, per far un nome noto e recente, allo storico Renzo De Felice la cui dichiarata
neutralità espositiva nella vita di Mussolini è stata subito presa
come la copertura di simpatie personali, se pur caute e non consapevoli. Nello scriver di storia è meglio dir chiaro che si sta da una
parte e poi cercare di essere onesti. Altrimenti il valore informatico
di un’opera passa in secondo piano e ciò che viene chiamato insegnamento viene preso come un mezzo per trasmettere valori personali che non si arriva a presentare esplicitamente.
C’è poi tutta una cultura nella quale sembra assodato che una
convinzione favorevole sia indispensabile ad un buon insegnamento, non soltanto efficace ma anche corretto. Sono quelle che
chiamerei “materie etiche”, nelle quali l’errore viene fatto corrispondere al male. Fra di esse primeggia la religione, essa viene, si
dice proprio così, “insegnata” anche nelle scuole italiane. Ma si dice anche che lo può essere soltanto da persone che aderiscono a
70
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
quella religione che insegnano e si rivolgono a giovani per i quali
tale insegnamento è stato chiesto dalle famiglie. Si tratta dunque
di un discorso che si rivolge all’interno di una comunità di fedeli e
devoti, alla ricerca di conferme più che di novità. E che, in Italia
almeno, viene riservato a persone nominate da un’organizzazione
ecclesiastica, che su quella religione da insegnare pretende di possedere la verità.
Ma che cosa davvero “insegna” un insegnante di religione? Si
potrà ancora parlare di insegnamento quando l’autopersuasione è
così forte da non ammettere contestazioni e non si rifiuta di invocare il mistero quando la parola risulti insufficiente a dare le attese
risposte? Le quali del resto sono risposte note e prestabilite e per le
quali si richiede soltanto una giustificazione. E può venir insegnato un mistero? Cose ben diverse sono il mistero e l’ignoranza;
quest’ultima è l’onesto limite che ogni studioso si riconosce, quella
è un presuntuoso rifugio di coloro che affermano senza argomenti.
Un insegnante, supponiamo, evangelico, come potrebbe insegnare
scrupolosamente la dottrina cattolica senza operare in se stesso
una scissione tra il credente e l’insegnante? E come potrebbe non
sentirsi responsabile per aver fatto conoscere tante deviazioni dalle Sacre Scritture? È ben diverso esporre il sistema tolemaico o la
fisica prerelativistica. Quando un insegnamento assume forme così
esplicite di unilateralità sarebbe da dir chiaro che si tratta di diffusione, di persuasione e, nelle forme più collettive, di propaganda.
Ma la propaganda si accompagna necessariamente alla censura e
la censura è ostacolo al manifestarsi di quelle curiosità divergenti
che sono all’origine del sapere. Dunque le materie etiche non si
possono insegnare? Si potrebbe rispondere che le potrebbe insegnare soltanto chi sa metterle tutte sullo stesso piano, ma allora
non si capirebbe quale è l’origine del suo impegno. Torniamo alla
censura. Chi raccomanda una convinzione propria, e la raccomanda per fede, si ritiene giustificato se cerca di impedire che le persone alle quali si rivolge abbiano accesso a punti di vista alternativi; se poi la fede si lega ad un’idea di salvezza, a un’esigenza sempre presente fino a divenire ossessiva, è chiaro che le alternative
assumono un volto demoniaco; e non si può rimanere indifferenti
71
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
alla dannazione propria e delle persone che si amano. Sparisce del
tutto l’idea che credenze diverse siano uno stimolo al perfezionamento della propria o comunque una via per arrivare a soluzioni
migliori. Il credente vien fatto crescere con l’idea di essere un debole bisognoso di protezione, viene coltivato nei sospetti e nelle
paure, per l’al di qua e per l’al di là. È un tratto comune in tutte le
personalità autoritarie, in tutti i regimi tirannici o totalitari, che si
diffonda l’idea che la gente non è capace di badare a se stessa. Il
cittadino, il devoto, vanno protetti, salvati, anzitutto dalle opinioni
perverse e non può certo essere la scuola un veicolo di eresie così
perniciose. Ma anche nei regimi che aspirano a forme liberali, che
incoraggiano i singoli e ammettono l’accesso a fonti alternative, v’è
una censura. Si esercita prevalentemente sui giovani e nella sfera
privata (famiglia, scuola) e sulle classi meno dotate di vie d’accesso alternative. Il cittadino di una società e di uno stato liberali o liberalizzanti arriva adulto già abbondantemente censurato di tante
opinioni che non incontrerà mai per il resto dei suoi giorni; anche
se non gli vengono sottratti i mezzi rifiuterà “spontaneamente” di
accedere a quelle visioni del mondo che già da piccolo avrà appreso a non tenere in considerazione. Dunque non esiste un’educazione che non sia brutalmente selettiva e nutrita di censure?
Si obietterà che manca il tempo, e anche i mezzi, per dare conto
a tutti, anche ai non giovani che pure hanno bisogno di insegnamenti, di tutti i punti di vista che sono in circolazione su ciò di cui
si parla; e che comunque vi è selezione quando si sceglie di trattare
una materia piuttosto che un’altra e che tale selezione può essere
vista come censura nei riguardi delle materie escluse. C’è sempre
un punto di vista; e non dobbiamo presentarci nemmeno con quello per il timore che risulti esclusivo di altri? Non sarà un concludere che è meglio restare ignoranti e badare, come dicevano tanti nostri vecchi, al buon senso? Sarà facile rispondere che il quesito è
provocatorio. Ma non è tanto assurdo pretendere – è proprio il caso di dirlo, “pretendere” che un sapere e la visione del mondo che
ne deriva vengano esposti in modo da rimanere aperti alla propria
negazione; ovvero che forniscano direttamente quelle chiavi espositive e interpretative, quelle possibilità, che permettono di accede-
72
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
re ad altri insegnamenti, pure quando sono esclusi e magari anche
condannati. Non si richiedono insegnamenti eclettici o pasticci di
cultura; ma punti di vista pensati e ben formulati e tuttavia capaci
di indirizzare verso altre possibilità. Ma queste aperture sono possibili quando si lavora con l’osservazione e la descrizione, che sono sempre migliorabili; appare alquanto più difficile e tuttavia doveroso quando si vuole ottenere da chi ascolta una condizione di
fedele.
Ma chi “insegna” una di queste materie etiche può essere lui
stesso in dubbio. In tal caso potrà essere un buon insegnante? Non
sarà piuttosto un persuasore, un propagandista, perché soltanto
come tale può cancellare i propri dubbi? La pratica del sapere esclude le censure, i testi sacri e le fonti privilegiate. Si esce dall’insegnamento, si entra nella propaganda, quando il discorso non è
più costruito per rispondere a domande, ma per selezionarle; ci
sono le domande appropriate, quelle che facilitano la conferma, e
le altre; quelle che bisogna respingere perché aprono la porta alla
colpa e al peccato. La semplice propagazione di una fede, anche
quando si manifesta come esposizione e soluzione di problemi del
momento, non è da chiamare “insegnamento”; questo nobile nome, che ha consentito di costruire le nostre civiltà, non è da usare
con tanta improprietà.
Il tempo dello studente
Certe considerazioni che si son fatte a proposito dell’insegnamento
della religione (v. La neutralità dell’insegnante) si possono fare
anche per l’insegnamento della filosofia. Chi insegna dovrebbe aver sempre presente che il tempo è per lo studente più prezioso di
quanto lo sia per l’insegnante; un anno, un mese perduti sono per
un giovane una perdita maggiore che per l’anziano. D’altra parte
ci sono degli obblighi; il rapporto fra studente e discente è in ampia misura obbligatorio; non si può, perché non si sa e non se ne
ha il tempo, giustificarsi ogni volta per quello che si trasmette. E
allora bisogna ricorrere alla necessità e nei casi più dubbi ricorrere
alla fiducia: “fidati di me, non ti farò perdere i tuoi anni”.
73
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
Chi insegna, le istituzioni nelle quali insegna, il sistema di rapporti sociali e istituzionali nei quali si colloca, hanno bisogno della
fiducia del discente. La domanda è: che fiducia può chiedere un
insegnante di filosofia? Soprattutto quando la materia si trova inserita in programmi obbligatori? Sono stato mosso a queste considerazioni dalla relazione di uno stagista francese, il quale si chiede
appunto «peut’on obliger un élève à philosopher?».
È implicito che se invece di “filosofare” si dicesse “far di conto”
o “tradurre da una lingua all’altra” la risposta sarebbe più facile e
quasi sempre affermativa. Le scuole dell’obbligo si presume che
insegnino cose necessarie per tutti; per le scuole alle quali uno
studente si iscrive di suo si presume vi sia in lui una certa pazienza nell’accettare programmi che possono non essere di immediata
chiarezza. Sarebbe cattivo insegnante chi per pigrizia, tolleranza o
benevolenza non si sentisse in dovere di seguire le indicazioni che
ha ricevuto. Anche perché in ogni caso dovrebbe essere abbastanza riconosciuto sin dall’inizio che cosa alla fine ci si troverà ad avere appreso o non.
Ma che cosa uno si aspetta di aver appreso alla fine di un corso
di filosofia, nelle scuole medie o nelle università? Nelle scuole medie italiane la questione è stata risolta, alquanto tartufescamente a
mio avviso riducendo la filosofia alla sua storia. Una riduzione che
non si avrebbe avuto il coraggio di compiere per nessuna delle altre materie: la grammatica non è di certo la storia della grammatica, come matematica e fisica non sono di certo la loro storia; ma
nemmeno per la letteratura o per l’arte si potrebbe compiere questa riduzione; e quanto alla “storia-storia”, che è poi storia politica,
sarebbe paradossale sostenere che insegnandola si prepari qualcuno a diventare un personaggio storico.
Con l’insegnamento della storia della filosofia è come se si dicesse all’allievo: “noi ti raccontiamo di certe persone e della loro
vita, ti facciamo leggere qualcosa di ciò che hanno lasciato scritto,
dopo sceglierai tu se riproporti ciò che loro si sono proposti o lasciar perdere”. Quelli che sostengono che filosofi si nasce e non si
diventa si limitano a sperare che fra i loro studenti ci sia qualcuno
che è nato filosofo e non lo sa. L’apprendere che ce ne sono stati
74
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
tanti prima di lui e la lettura di qualcuno dei loro scritti gli darebbe il mezzo di esprimere, per dire meglio, ciò che ha in animo o
pensa in maniera confusa.
Un insegnamento di filosofia non dà abilitazioni professionali
riconosciute. Chi ha studiato filosofia non riceve attestati da mettere in cornice: non c’è un ordine dei filosofi e non sarebbe giustificato dire che un signor Tale è filosofo perché ha letto tanti libri comunemente ritenuti “di filosofia”, o spesso nemmeno questo, perché gli autori si erano battezzati filosofi loro stessi; e nemmeno che
il nostro signor Tale è filosofo perché prendeva buoni voti quando
a scuola lo interrogavano sulla storia della filosofia. La sola professione che gli viene riservata è quella di tramandare, attraverso
l’insegnamento, ciò che ha appreso da altri insegnanti.
Ricordo che da studente, appunto, di filosofia, si dibatteva a
lungo, fra compagni, che cosa fosse questa filosofia che si faticava
tanto ad apprendere; e anche che, questo era il più grave, non c’era
modo di sapere quando la si era appresa a sufficienza. Ad un certo
momento concludemmo che la sola risposta onesta era che si doveva chiamare “filosofia” tutto ciò che gli uomini hanno chiamato
con questo nome in qualche occasione o momento. Non c’era esclusione che si giustificasse.
Ma era una angolazione ancora “socio-storicistica”, nel senso
che faceva dipendere la qualifica di filosofo dal consenso di altri e
questi consensi bisognava andarli a cercare nella storia della cultura. Più tardi arrivai a convincermi che la qualifica di filosofo è del
tutto autoperfomativa. Punto e basta.
“Performative” sono, secondo una scoperta del filosofo inglese
John Austin, vissuto nella prima metà del novecento, quelle forme
verbali mediante le quali si enuncia un’azione e la si compie con il
suo stesso enunciarla. Di norma il fare è altra cosa dal dire, come
tutti sanno, ma quando si usano questi verbi il dire è anche un fare. Non esiste un’azione che corrisponda all’asserzione “io prometto”; e nessuna che corrisponda a “io battezzo”, per limitarsi ai
casi più citati. Le azioni del promettere e del battezzare si possono
fare soltanto con le loro parole stesse.
È chiaro che ci sono problemi di validità, di riconoscimento, di
75
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
garanzia, che variano da una cultura all’altra e da una persona
all’altra. Ma non c’è niente che impedisca di trasferire la qualifica
di performativo dai verbi ai sostantivi. Se con una forma verbale
usata performativamente si fa ciò che si dice, con un sostantivo si è
ciò che si dice. La parola “filosofo” è una di queste; a partire dal
momento in cui uno dice, ad alta voce e pubblicamente, io sono un
filosofo, lo diventa. E quelli che lo ascoltano non hanno nessun argomento per levargli il diritto a questa autoperformazione.
Se tale qualifica ci viene attribuita da altri, anche in questo caso
le possibilità di rifiuto sono vicine allo zero. A chi ti aggredisce dicendo “ma tu sei un filosofo, ragioni da filosofo”, non si potrà mai
rispondere che non è vero. Più efficace sarebbe “non voglio essere”; e chi non vuol essere filosofo nemmeno lo è. Se l’altro insiste,
prima o poi dovrà definire la filosofia, una cosa da ingenui.
La filosofia è dunque autoperformativa e uno non si assume
nessun obbligo quando se ne qualifica sacerdote. Chi si è dato
questa veste se la può togliere, e con la stessa libertà. Non deve dare alcuna spiegazione. Cadrebbe in errore se ad esempio dicesse
“arrabbiato come sono oggi non sono più filosofo” perché cadrebbe nell’associazione banale e contestabile della filosofia con l’indifferenza.
Siccome però, con queste autoperformazioni, si corre il rischio
dell’isolamento, in ogni epoca i filosofi hanno cercato di socializzarsi. Ma senza perdere i vantaggi di quella posizione, che sono
soprattutto una certa non imputabilità e non responsabilità. Nella
recente storia italiana il filosofo-ministro Giovanni Gentile disse
cose terribili a giustificazione del regime fascista e delle sue violenze; ma rimase per molti di cattivo gusto prendersela con qualcuno che in fin dei conti era un filosofo. Da questa esigenza di socializzare sono nate le cosiddette “discipline filosofiche”. Enunciazioni che si potrebbero chiamare “filosofiche” se ne trovano facilmente in tante situazioni: nei proverbi, nella poesia, nel diritto,
nella pedagogia, nell’etica, nel discorso politico e in tante materie,
anche scientifiche, come vengono insegnate nelle scuole o nei luoghi dove si lavora. Molte volte la differenza fra il praticante di un
mestiere che si fa filosofo per un quarto d’ora e poi smette quando
76
Paolo Facchi
Persuasione e insegnamento
lavora e chi fa il filosofo per tutta la vita è riconducibile alla terminologia, che il filosofo impiega in maniera sovrabbondante e non
spendibile, come si dice, in soldoni.
Se noi ora ci chiediamo, come abbiamo fatto per l’insegnamento
della religione e delle materie etiche, che cosa insegna un professore di filosofia, possiamo soltanto rispondere che insegna le proprie
convinzioni; quelli più onesti trasmettono anche i loro dubbi. E,
appunto, una situazione di isolamento, dalla quale può uscire aggiungendosi un altro nome: sarà la filosofia della scienza, del linguaggio, dell’arte, della storia, del diritto, dell’educazione e altre
ancora.
Lo studente corre i suoi rischi, perché si accolla il problema di
cercar di comprendere se quanto gli viene trasmesso è sapere
scientifico, linguistico, giuridico, ecc. oppure divagazioni, riflessioni ecc., su questi temi. Per gli studenti che amano le incertezze
può essere stimolante.
Già nell’Antichità si distingueva tra la fisica dei tecnici (Archimede) e quella dei filosofi (Aristotele). I primi cercavano di mettere le regolarità naturali al servizio dell’uomo, i secondi descrivevano e spiegavano, ma non costruivano macchine o scavavano
canali. Prevalsero i filosofi per parecchi secoli ma poi con Galileo e
successori i tecnici si imposero. I fisici di oggi, passati attraverso la
geometrizzazione della fisica con Cartesio, Newton ed Einstein,
sono tecnici quando, per citare un esempio famoso, si limitano a
riferire che non è possibile indicare ad un tempo posizione e velocità della stessa particella luminosa (Heisenberg); sono filosofi
quando, messi di fronte a certe generalizzazioni in senso probabilistico di questa difficoltà, rispondono che Dio non gioca a dadi
(Einstein). E non parlava certamente da fisico Fermi quando disse
la celebre frase che gli viene attribuita: “A quell’epoca avevamo
smesso di pensare”.
L’enorme sviluppo del sapere scientifico in campi tanto diversi
fra di loro ha portato a una progressiva emancipazione di discipline che un tempo erano “ancillae” della filosofia. Ad un certo momento astronomi, fisici, chimici, psicologi, economisti, ma anche
critici d’arte o studiosi dei costumi e delle genti rivendicano il di-
77
Rivista quadrimestrale
Anno 1 n.s. settembre/dicembre 2010 - N. 3
ritto di essere considerati come tali e basta. Le riflessioni dei filosofi diventano pressoché inutili al loro mestiere; spesso distraggono
e fanno perdere tempo.
Ma i filosofi hanno le loro carte da giocare. È vero che per la
bomba atomica o quella all’idrogeno, per il chinino, l’aspirina, la
penicillina, per andare sulla luna, non c’è stato bisogno di loro, ma
per giudicare di queste imprese c’è bisogno di qualcuno che tecnico non sia; e che si faccia filosofo anche per un quarto d’ora. E ne
ha anche il diritto. Un’umanità che si lasciasse prender la mano
dai tecnici sarebbe un’umanità acefala.
Ognuno può farsi filosofo in quanto si pone il problema di unire ciò che il tecnico separa e di metterlo in relazione a bisogni, aspirazioni, tendenze, che siano il più possibile di tutti quelli che
vivono sulla Terra, ormai unita. Bisogna nella misura del possibile
ricomporre ciò che il tecnico ha, per la necessità del suo lavoro, tenuto distinto.
È possibile insegnare tutto questo? Risponderei di si, con la raccomandazione di dare più importanza alle domande, che nella loro storia i grandi pensatori si sono posti, che alle risposte, molto
spesso deludenti. Si potrebbe anche conservare l’impostazione storica, ma alla condizione che sia una storia di domande, di ciò che
si chiesero alcune grandi personalità capaci di sottrarsi alle certezze comuni. E la selezione sarebbe da farsi partendo dalle domande
di oggi.
78