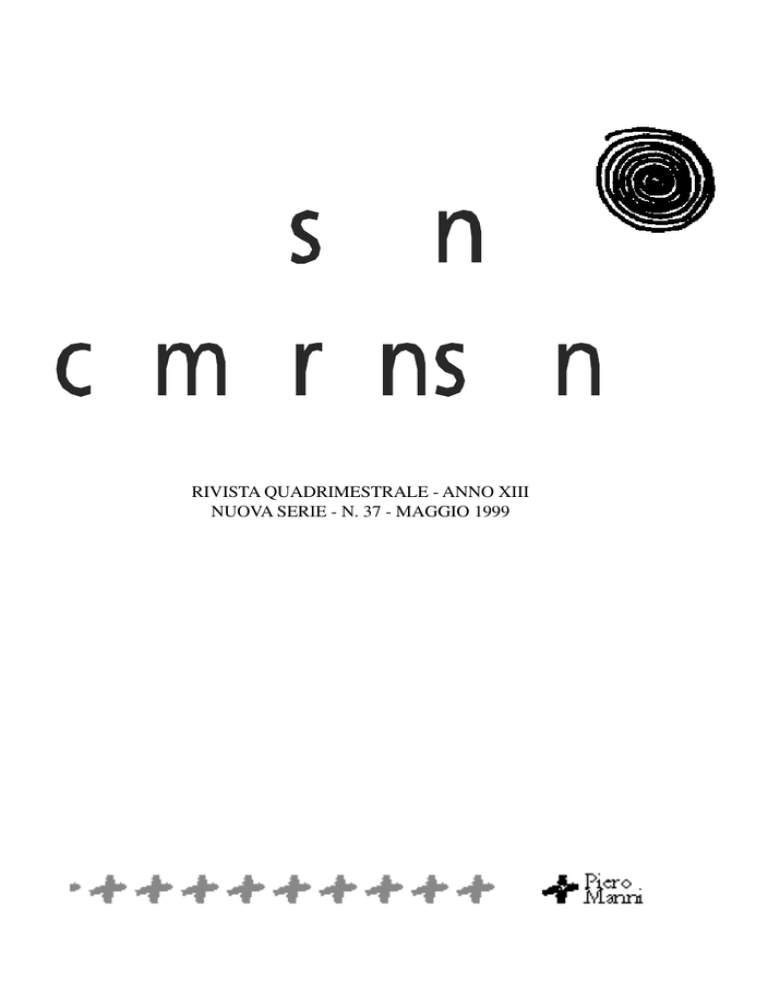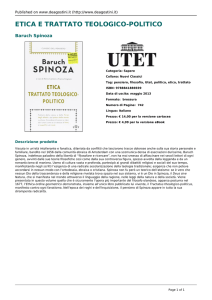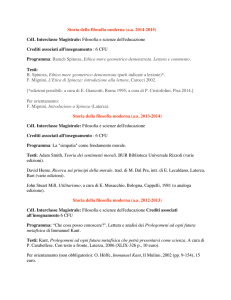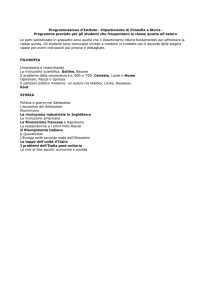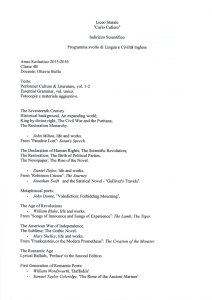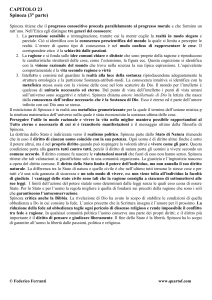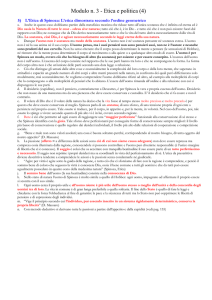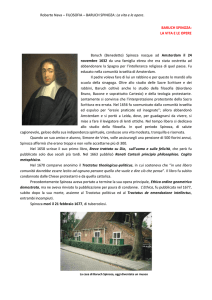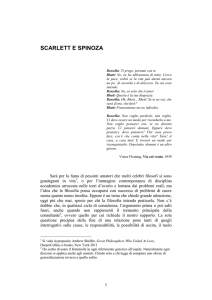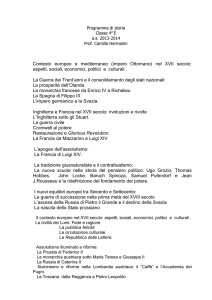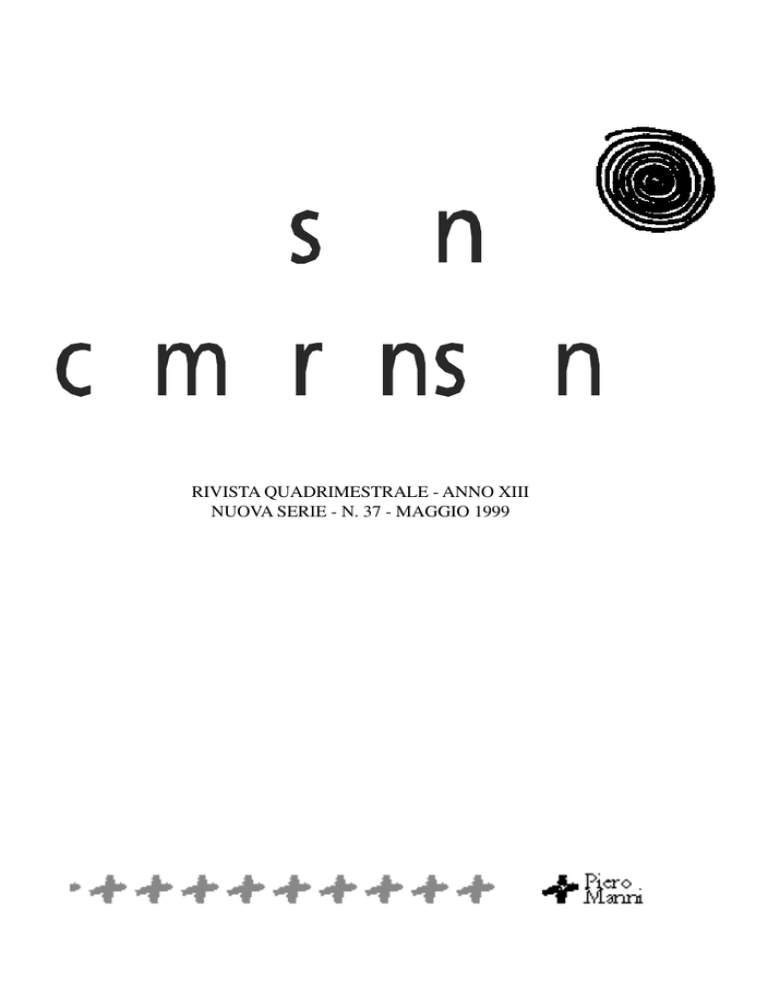
RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XIII
NUOVA SERIE - N. 37 - MAGGIO 1999
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano di
Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, attraverso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso Dipartimento.
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Antonio Delogu (Sassari),
Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio Ponsetto (München),
Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Daniela De Leo, Lucia De Pascalis
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia, Università
degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8; fax (0832) 3366626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Nino Bixio, 11/b
- 73100 Lecce - Tel. e Fax. 0832/387057. Iscritto al n. 389/1986 del Registro della
Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia lire 40.000, Estero lire 76.000,
c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata. Un fascicolo lire 18.000, degli anni precedenti il doppio.
SOMMARIO
5
Fabio Costantino
DALLA SOLITUDINE ONTOLOGICA AL PATTO SOCIALE:
SAGGIO SUL PENSIERO POLITICO DI SPINOZA
39
Silvio Suppa
AUGUSTO DEL NOCE DI FRONTE AL MARXISMO:
LA LETTURA DI ANTONIO GRAMSCI
61
Pierpaolo Marrone
LIBERALISMO, IRENISMO, VOLONTARISMO
NELLA FILOSOFIA DI RORTY
79
Angelo Prontera
IGNAZIO SILONE
NELLA PROSPETTIVA FEDERALISTA ED EUROPEA
85
Marisa Forcina
LA DIFFICILE CITTADINANZA FEMMINILE
IN UNA POLITICA INDIFFERENTE
94
Alessandra Lezzi
LA SCELTA PROCREATIVA:
IL DIRITTO DI UN FIGLIO E IL DIRITTO DEL FIGLIO
105
Recensioni
127
Pubblicazioni ricevute
3
4
DALLA SOLITUDINE ONTOLOGICA AL PATTO SOCIALE.
SAGGIO SUL PENSIERO POLITICO DI SPINOZA
1. Sono trascorsi più di trecento anni dalla morte di Spinoza. Malgrado le
sue espressioni e le sue preoccupazioni spesso strane, ciò che a nostro avviso
caratterizza questo pensatore è che, più d’ogni altro, e soprattutto più di ogni
empirista, egli aveva preso sul serio il problema fondamentale della verità e del
destino umano, la qual cosa conferisce alla sua opera una risonanza di profondità, di impegno e di libertà che raramente troviamo ad un livello tale nei filosofi
“laici”. Per quanto ci riguarda, infatti, ispirandoci al metodo degli storici di mentalità, è cosa molto importante mettersi a fianco di Spinoza uomo, cercare di
comprendere il non-detto che tuttavia ci suggeriscono sicuri elementi biografici,
storici e intellettuali.
Ecco, dunque, un figlio di un commerciante agiato, un borghese intelligente,
proteso verso un brillante avvenire in una comunità in cui ha tutto per riuscire,
che ha fatto studi teologici e commerciali, e che, proseguendo del tutto gli studi,
lavora nel commercio del padre sin dall’età di 13 anni, commercio che dirigerà
col fratello per ben due anni, rivelandosi un eccellente uomo d’affari. E poi ecco
un uomo di 24 anni che rompe coll’ambiente religioso ed economico, condannandosi alla solitudine, offrendosi alla persecuzione, vivendo nell’insicurezza,
meditando nella povertà, guadagnandosi da vivere –quale simbolo!– come
guardiano di porci.
Il 1656 è il momento d’una conversione filosofica che nonostante in molti
aspetti rappresentasse la continuazione di idee che si erano sviluppate nel
pensiero giudaico, lo spingeva inevitabilmente ad una decisa ed intransigente autonomia di pensiero per cui la rottura era ormai inevitabile, non
solo perché Spinoza rifiutava l’autorità della comunità, ma soprattutto a
causa della divergenza tra la sua filosofia e la tradizione religiosa del suo
tempo. L’aspetto più interessante di questa formula è senza dubbio la distinzione che essa implica tra “idee” e “tradizione. É l’affermazione d’un pensiero che ancora non si enuncia, ma che è stato nutrito da quello di un Uriel da
Costa o da un Juan de Prado con cui Spinoza ebbe legami stretti, formato
alla scuola d’un Van den Ende, gesuita divenuto ateo e libero pensatore,
influenzato dal cartesianesimo e dal cristianesimo liberale degli ambienti
intellettuali.
«Veramente, scrive G. Casertano, un tentativo di compromesso vi fu, da
parte dei rabbini, per scongiurare la rottura definitiva: ed una cospicua pensione di mille fiorini viene offerta al Nostro perché continuasse a professare ufficialmente(cioè ipocritamente)il culto dei padri. Ma egli, sdegnato rifiuta, proclamando con fermezza di voler rifuggire dall’ipocrisia e restare fedele alla verità:
sarebbe andato avanti per la propria via senza mai abbandonare la luce che lo
SAGGI
di Fabio Costantino
5
6
guidava nella sua ricerca, che era di luce aperta e di limpida razionalità. Un
ebreo fanatico tenta di pugnalarlo all’uscita da un teatro…»1.
Questo pensiero, che persegue la felicità nella ricerca della verità e dell’armonia politica, contro la mondanità e le idee ricevute, si sviluppa in 17 anni, dal
Breve Trattato del 1660 al Trattato politico del 1675-77.Otto anni per la metafisica e sette anni per la filosofia politica, preceduti da alcuni anni di ricerca in cui
la maturità è conquistata in una riflessione metodologica.
L’attitudine spinozista, nel metodo e nel dato, è certo intellettualmente sincera e coraggiosa, ma i punti d’arrivo sono probanti? E i risultati sono validi?
Studiosi, diversi per estrazione scientifica ed ideologica, hanno cercato, alcuni
di dirigere il bilancio dello spinozismo in se stesso, stabilito dalla esègesi contemporanea, e nei suoi rapporti con i sistemi moderni, la Kabbala e Chuang Tzu, Descartes e Freud, il buddismo e la Bibbia.
Certamente il sistema filosofico di Spinoza è poliedrico trattando temi quali la
libertà e l’autorità, la necessità, il naturalismo etico, l’individualità e la società, il
finito e l’infinito, gli attributi e i modi, il misticismo e le sue radici, la rivelazione
filosofica, il metodo e il dato e, infine, la democrazia. Niente che non sia già
conosciuto o che non sia stato trattato da studiosi di chiara fama e competenza.
Una parte più nuova e originale(ma fino ad un certo punto!)riteniamo possa
essere rappresentata dalla ostilità di Spinoza verso ogni dottrina autoritaria e
giuridica unitamente al suo razionalismo puro che si arrende solo davanti alla
saggezza di Cristo o a quella di Salomone.
In effetti tale razionalismo, –puro o assoluto, che dir si voglia–, insorge contro
il principio di autorità, poiché egli sostiene che è impossibile accettare che il passato sia istituito come punto ultimo di riferimento della parola vera. Per convincersene è sufficiente ricordare gli errori di cui i concetti degli Antichi sono la fonte.
Scrive in proposito Spinoza: «Niente di sorprendente per il fatto che degli
uomini che hanno creduto alle qualità occulte, alle specie intenzionali, alle
forme sostanziali e a mille altre sciocchezze abbiano immaginato spettri e spiriti
e creduto alle vecchie […]»2.
A questo punto si impone una notazione: Spinoza fustiga, in modo veemente,i filosofi greci i cui concetti sono, a suo parere, delle pure astrazioni forgiate
dall’immaginazione al fine di nascondere la loro ignoranza delle cose, ovvero
delle cause dei fenomeni.
Ma che cosa significa questa nozione di autorità? Essa evoca un contesto
politico, nel senso più ampio del termine, evidente. Non si parla dell’autorità
d’un pater familias o di quella d’un capo di Stato? Il suo esercizio è imprescrittibile poichè comporta la sottomissione e l’adesione volontaria di coloro ai quali
essa si rivolge. È là la sua forza; l’autorità esclude qualsiasi sentimento d’alienazione provato da colui sul quale viene applicata. Riconoscere volontariamente l’autorità necessita l’accettazione della sua legge e dunque la legittimità delle
sue decisioni e delle sue azioni, la giustezza del suo dire e dei suoi gesti.
Un’aura senza difetti circonda il detentore dell’autorità, per cui conviene sapere
d’onde trae questa forza. Si impone pertanto uno sguardo rapido al suo luogo
d’origine e, quindi, alla filologia e alla storia.
L’etimologia della parola ci insegna che essa è stata formata a partire dal
SAGGI
verbo latino augere (aumentare, accrescere) che ha prodotto il sostantivo auctor (l’autore). Si percepisce così, immediatamente, una prima caratteristica
duplice dell’autorità: l’idea di creazione d’un ordine inesistente prima e, ad un
tempo, di sviluppo di tale ordine. Fondandosi su un passato che si fonda su se
stessa, l’autorità assicura la propria perpetuazione e il proprio ampliamento.
La sua forza proviene dal fatto di essere legata a questo passato sacro e,
quindi, intoccabile, di cui ricorda la presenza. Così il legame temporale giustifica colui che la detiene dalla prevalenza del suo pensiero, a seconda che il suo
proposito sia politico, etico, religioso o scientifico, in quanto la sua verità si
inserisce nella verità inaugurale.
Si capisce così perché nel diciassettesimo secolo ancora la religione pesa
formidabilmente sugli spiriti nella misura in cui i teologi che sono delle teste
politiche detengono la verità che la conoscenza del messaggio biblico loro concede. Allo stesso modo una formula quale “Ipse dixit” taglia corto ogni discussione poiché gli scritti dello Stagirita equivalgono alla Bibbia in materia di conoscenza profana. Riassumendo, l’autorità trae la propria legittimità dal passato al
quale è indissolubilmente legata e possiede la verità che si colloca nell’emergenza e nel sacro.
Se la si rapporta ora all’istituzione romana del Senato, si prende consapevolezza che si tratta dell’effettuazione dell’autorità politica. Il senato non occupa il
potere, che appartiene al popolo; al contrario, scrive Cicerone, «l’autorità è nel
senato»3. Il senato non legifera, ma parla e consiglia. Chiamati patres conscripti, i senatori –l ’origine della parola è senex che significa anziano– sono i
custodi della tradizione, essi parlano in nome dei padri fondatori, della fondazione.
D’altronde, la storia romana prova ciò che un breve studio linguistico ci insegna.
La decadenza dell’impero romano corrisponde all’allentamento dell’autorità
senatoriale provocato dall’oblio delle origini. Roma non decadde tanto a causa
della follìa d’un Caligola o della tirannìa d’un Nerone quanto perché essa ha
permesso la decadenza dell’istituzione senatorile.
Si comprende meglio allora perché l’argomento dell’autorità è giustamente
evocato. Come argomento l’autorità è una ragione, come autorità essa è la
ragione, la presenza, cioè, del vero che sopravvive sin dall’origine dei tempi e a
cui si accosta con la paura della scomparsa. In quanto presenza del passato
nel presente, la parola autorità non può che significare verità.
E tuttavia la ragione esige di non fidarsi che delle proprie norme e, in questo
senso, l’autorità non rappresenta una forza d’inerzia che frena l’approfondimento dello spirito in cerca di verità.D’onde la riflessione lapidaria di Spinoza:
«L’autorità di Platone, di Aristotele, di Socrate, etc., non ha grande fondamento
per me»4. Spinoza, così, scrive la parola autorità solo per rigettarne l’argomento, e ciò nell’ultimo paragrafo della sua ultima lettera al suo corrispondente
Boxel.
Prudenza questa che si può definire contemporaneamente politica e pedagogica.
Prudenza politica che si riferisce sempre al 17^ secolo, anche nell’Olanda
7
8
relativamente liberale; non occorre pertanto ricordare che i fratelli De Witt, capi
del Partito Repubblicano e protettori di Spinoza erano stati assassinati dagli
Orangisti due anni prima.
Prudenza pedagogica soprattutto, perché il filosofo si sforza di far comprendere, invano, che nello stabilire il vero conta solo un pensiero autonomo; il fatto
è che egli fustiga, come abbiamo visto, i discorsi autorizzati che sono per natura autoritari5.
In effetti il fine principale del Tractatus teologico-politicus, che è formulato
nel sottotitolo ed esposto dettagliatamente nell’ultimo capitolo, consiste nell’affermare la libertà di pensiero, di coscienza e di parola come diritto inalienabile
della persona e come condizioni necessarie per una società moralmente sana.
È in questo contesto che la libertà è proclamata come il fine supremo dello
Stato, e Spinoza appare come uno dei fondatori più eminenti del liberalismo
borghese contrariamente ad Hobbes e prima di Locke. In effetti, occorre evidenziare non solo l’esistenza di punti comuni alle idee politiche tra Spinoza e
Hobbes, Locke, Machiavelli, che caratterizzano il pensiero filosofico dal
Cinquecento al Settecento, ma anche le differenze, essenziali perché mettono
in evidenza e valorizzano l’originalità della filosofia di Spinoza, il cui pensiero
politico, se può trovarsi nei pensatori sopra citati, non ha che la coincidenza del
progetto che non può che accentuare la differenza dei risultati: il fine dello Stato
spinozista contrasta doppiamente con quello di Hobbes; gli individui il cui egoismo mette in pericolo la propria sopravvivenza hanno bisogno di essere sotto
la ferula dello Stato che, in Hobbes, li sottomette totalmente mentre in Spinoza
essi rimangono in qualche modo liberi.Quel che è da notare come tratto caratteristico del Trattato teologico-politico è che Spinoza si pronunciava contro le
rivoluzioni politiche,che sarebbero secondo lui impotenti a cambiare in maniera
sostanziale i rapporti socio-politici.
Gli avvenimenti dell’agosto del 1672 determinarono un’altra conclusione che
si trova formulata nel Trattato politico dove si afferma che il fine dell’esistenza
dello Stato non consiste che nella sicurezza, poiché la libertà in quanto “fermezza di spirito” è solo una virtù privata. In questa affermazione Spinoza fa un
passo indietro in quanto guadagna terreno la concezione della libertà contemplativa tipica dell’Etica.
E per non fare anche noi dei passi indietro, torniamo al Tractatus theologico-politicus di cui ribadiamo la critica all’autorità religiosa e all’autorità politica.
Ma perché Spinoza tratta in uno stesso scritto problemi teologici e problemi
politici? É un caso? A noi pare di no.Infatti –scrive uno dei più acuti interpreti
contemporanei del pensiero di Spinoza– “discutendo nella prima parte il primo
e più profondo pregiudizio teologico intorno al primato della conoscenza rivelata su quella naturale, Spinoza intende dimostrare l’autonomia e almeno la pari
dignità della conoscenza naturale preparando così i mezzi per poter discutere
nella seconda parte, il secondo pregiudizio teologico circa il primato dell’autorità religiosa sull’autorità civile e politica. Spinoza, infatti, nella seconda parte
combatterà tale pregiudizio servendosi di quella conoscenza naturale il cui diritto e la cui autonomia aveva dimostrato nella prima: perciò potrà delineare sul
suo solo fondamento l’origine e la natura della società civile e politica,rivendi-
SAGGI
cando, in pari tempo, il supremo diritto all’autorità civile al comando e il supremo diritto della conoscenza naturale nell’esercizio della libertà”6.
Certo è che mostrare che la libertà di giudicare ed onorare Dio come buono
sembra a Spinoza potesse essere accordata all’individuo senza che fossero
compromesse la pietà e la pace dello Stato: tale era l’obiettivo del Trattato teologico-politico. Infatti su ogni società politica incombe una minaccia: “Sotto l’aspetto della religione, afferma Spinoza, la folla si applica ad uno scrupoloso
rispetto con un culto cieco. Nello stesso tempo, sotto l’aspetto della religione,
essa è sviata dal rispetto per l’autorità politica verso una devozione per i preti e
per i re.” «Superstizioni e fastosi cerimoniali –aggiunge il Nostro– si addicono
più ad una monarchìa che ad una repubblica In cui piuttosto non solo è tollerabile, ma altresì necessaria, la più ampia libertà del filosofare».
Infatti Spinoza ha avvertito che il fenomeno religioso e il fenomeno politico
presentano entrambi –nella loro essenza più profonda– dei caratteri comuni
che evocano identiche risonanze nella sensibilità degli uomini. In effetti
Spinoza,assumendo quale argomento di riflessione la religione, non fa che anticipare in qualche modo quella che sarà la problematica sociologica contemporanea,in particolare weberiana, dei rapporti tra le pratiche sociali e le concezioni religiose et etiche,che spiegherebbe l’origine religiosa del potere politico.É
nel contesto d’una storia strutturale del politico,nella quale la religione interviene come elemento strutturante decisivo (la qual cosa non solo non esclude l’intervento di altri fattori, quali quelli demografici ed economici,ma anzi li richiede)
che sorgerebbe lo Stato moderno. Questo Stato sarebbe il prodotto dell’ebraismo e del Cristianesimo,che dopo secoli di mistificazione,si sarebbe presentato, agli occhi di Spinoza,come uno spaccato della religione,una specie di separazione da un nucleo originario,che avrebbe prodotto la secolarizzazione e la
laicizzazione. Questa uscita,questo braccio separato che avrebbe formato la
modernità non implica la scomparsa della credenza religiosa individuale nè la
scomparsa delle stesse istituzioni religiose. Si tratta solo di un allontanamento
dalla strutturazione religiosa del politico,accesso ad una sorta di autonomia del
politico,per usare il linguaggio di H. Arendt e dei suoi studiosi (6bis), con tutte le
conseguenze afferenti. La conseguenza più evidente ed ovvia, secondo
Spinoza, è che la politica rappresenta,gioca nella società moderna, il ruolo
decisivo che giocava la religione nelle società traidizionali o arcaiche. La comprensione dello Stato,della sua storia,delle sue vicissitudini, dei suoi errori,
della sua patologia, implica l’assunzione del carico di questo fatto decisivo nella
molteplicità e nella complessità dei suoi effetti.
Sarebbe certamente eccessivo pretendere che il Tractatus TheologicoPoliticus sottitenda una vera filosofia della storia. Ma è opportuno riconoscere
che Spinoza pone il problema e da storico e da sociologo.Egli è soprattutto
attento al fatto che le radici storiche dello Stato e della Religione affondano nel
sentimento primitivo e indifferenziato del sacro, come appare dalla storia del
popolo ebreo.
Ci si può domandare perché Spinoza insiste nel descrivere tanto minuziosamente lo Stato primitivo degli Ebrei. Ma se il filosofo si riferisce così frequentemente e così a lungo alla storia dei Giudei, è perchè questo gli permette, con
9
l’aiuto di esempi tratti dalla Bibbia, di illustrare la tesi circa lo scacco inevitabile
del principio teocratico.Infatti la politica,sostiene Spinoza,precede ogni forma di
religione, e scrive: «nulla è rimasto dell’antica religione se non il suo culto
esterno (con il quale sembra che il volgo aduli più che adorare Dio), e la fede si
è ridotta ad un insieme di credulità e di pregiudizi: e quali pregiudizi!, che trasformano gli uomini da esseri razionali in bruti,impediscono complteamente che
ciascuno usi il proprio libero arbitrio,e riconosca il vero dal falso…»7.
La religione è posteriore allo stato di natura ed ha un carattere, per così
dire, derivato. Per tale motivo nelle manifestazioni esteriori essa è subordinata
al potere politico. Tesi, questa,che Spinoza afferma esplicitamente nel cap. XIX
del Tractatus Teologico Politicus: «Voglio dimostrare che la religione riceve la
sua forza giuridica solo dai decreti del potere pubblico,e Dio non ha nessun
particolare imperio degli uomini se non attraverso coloro che hanno il potere
pubblico,e inoltre che il culto della religione e l’esercizio della pietà devono
accordarsi con la pace e l’utilità dello Stato e di conseguenza i loro modi debbono essere determinati soltanto dai poteri supremi,e questi pertanto debbono
essere gli interpreti della legge divina»8.
2. L’interpretazione della scrittura
10
Spinoza sostiene che la Scrittura non è affatto l’espressione della Verità
rivelata ma una guida morale per l’esistenza quotidiana. Egli afferma,perciò,
che le autorità teologiche oltrepassano la loro vocazione quando si insinuano,in
quanto tali, nelle discipline che fanno risaltare la “verità”. Onde persuaderci di
questa diffidenza, per non dire ostilità, di Spinoza nei confronti delle pretese
teologiche volte a giustificare i problemi scientifici, basta notare che, quando
Boxel nella sua prima lettera rivendica l’autorità dei filosofi e dei teologi,
Spinoza occulta decisamente la parola e si accontenta di discutere le affermazioni filosofiche. Questo oblio che possiede, non c’è dubbio, l’aspetto dell’atto
mancato, di freudiana memoria, è supportato anche dall’osservazione secondo
cui «i teologi sono massimamente solleciti a trar fuori dalle Sacre Scritture proprie fantasticherie e dottrine e munirle dell’autorità divina», per cui, secondo
Spinoza, «il metodo d’interpretazione della Scrittura non differisce dal metodo
di interpretazione della natura, ma si accorda completamente con esso»9.
Da questo punto di vista, appare fondamentale, nell’itinerario spinoziano,
dissacrare la Bibbia con l’aiuto di un metodo esegetico destinato a mettere in
rilievo le contraddizioni storiche e filologiche, insomma trattare la Scrittura sul
piano strettamente scientifico.
Restituendo alla Scrittura l’umanità dei suoi autori, Spinoza vuole liberare gli
uomini dalla paura, origine della superstizione e della schiavitù. La qual cosa
induce uno studioso a scrivere quanto segue: «Schiavo della sua paura,in
quanto non riesce a dominarla, non conoscendo nè il mondo né se stesso, l’uomo diventa successivamente schiavo dei prodotti della propria paura, divinità e
dei esigenti e deliranti»10. Così, neanche il miracolo nè il mistero trovano posto
SAGGI
nella riflessione di Spinoza, questo Feuerbach ante litteram. Essendo la natura
e Dio una sola e stessa cosa, il necessario dispiegarsi di un’unica sostanza,
niente autorizza nel sistema spinozista l’apparizione di avvenimenti particolari
che romperebbero l’ordine fisso e immutabile della natura. «Le conclusioni che
il filosofo –si legge in uno studio sull’argomento– trae dalla sua analisi sono
queste: 1) la parola “miracolo” ha senso solo in relazione alle opinioni degli
uomini; 2) i miracoli non servono che al volgo, il quale ignora nel modo più
assoluto le leggi naturali; 3) il miracolo, in qualsiasi modo lo si intenda, non è
che un’assurdità; infine, credere nei miracoli significherebbe non ammettere più
nulla per certo ed essere condotti, alla fine, all’ateismo [...]. Da quanto s’è detto,
appare in tutta chiarezza che dopo il “severo esame” della Scrittura condotto da
Spinoza11,alcuni principi-cardine della fede religiosa –quali la rivelazione profetica, il culto, la realtà del miracolo ecc.– venivano completamente ridimensionati
o, a dir meglio, addirittura negati12. Ma che cosa significa, a questo punto, credere? Che cosa è la fede? E la teologia in che cosa consiste?
Analizzando il tema della scelta del popolo ebraico, Spinoza afferma che
«l’elezione degli ebrei non riguardava altro che la felicità temporanea e la
libertà puramente fisica, ossia il dominio politico, il modo e i mezzi con cui ottenerlo, e di conseguenza anche le leggi, in quanto necessarie allo stabilire quel
particolare dominio, e infine il modo con cui queste furono rivelate»13. Spinoza,
dunque, è convinto che la pretesa elezione degli Ebrei concerne esclusivamente privilegi temporali e materiali diventando così depauperata di senso. Quando
infatti –scrive Spinoza «si legge nella Scrittura (Deut., cap.IV, vers.7) che nessuna nazione ebbe il proprio Dio così vicino come il loro gli ebrei, dobbiamo
intendere l’affermazione come riferita solo alla particolarità della loro condizione
politica e limitatamente a quel tempo in cui ad essi capitavano tanti miracoli.
Per quanto riguarda infatti la misura dell’intelletto e della virtù, cioè della vera
beatitudine, Dio, come già abbiamo detto e dimostrato,è ugualmente propizio a
tutti»14.
Questo bizzarro compromesso induce ad interpretare l’ambivalenza fondamentale di Spinoza che non giunge né a negare la Missione d’Israele, né ad
accettarla in quanto tale. Questa “elezione materiale” assume, nella storia dell’umanità, l’andamento d’uno spasso d’un bambino viziato.
Ma più che il proposito generale, è la scelta dei mezzi che qui ci preoccupa.
Sin dalle prime righe del capitolo III del Tractatus theologico-politicus, Spinoza
si richiama a considerazioni di morale e di giustizia. L’elezione è presentata
come portatrice della felicità d’un popolo con l’esclusione di tutti gli altri. Dalla
scelta divina scaturirebbe una beatitudine che sarebbe tanto più grande in
quanto non sarebbe partecipata. Ora rallegrarsi della fruizione solitaria e gelosa
d’una saggezza di cui altri non beneficiano manifesta un carattere malvagio e
invidioso15. Gli Ebrei sono dunque presentati come egoisti che gioiscono del
monopolio del loro privilegio.
Tuttavia, Spinoza che domina così perfettamente la Bibbia, non ignora ciò
che significa realmente l’elezione. Anche se non entra nel proposito di ricercare
lo spirito della lettera, quella è così sufficientemente importante e chiara per
sfumare il giudizio moralistico del nostro filosofo.
11
12
Il popolo giudeo, come Mosé, subisce più di quanto lo desideri la scelta di
Dio, il giogo temibile della Legge e dell’Alleanza. Testimone tra le Nazioni, esso
è responsabile, il solo responsabile della Parola di Dio che deve contribuire ad
espandere con la sua condotta esemplare: «Poichè voi siete più ribelli delle
genti che vi circondano, non avete seguito i miei comandamenti, non avete
osservato i miei decreti, e neppure avete agito secondo i costumi delle genti
che vi stanno intorno, ebbene, così dice il Signore Dio:
Ecco anche me contro di te: farò in mezzo a te giustizia di fronte alle
genti»16.
Ruolo difficile, come sottolinea il Deuteronomio: «Prendete questo libro della
legge e mettetelo a fianco dell’arca dell’alleanza del Signore vostro Dio; vi
rimanga come testimonio contro di te; perché io conosco la tua ribellione e la
durezza della tua cervice»17.
Riflettendo su questa ingiunzione opprimente, si vede molto male come
possa essere destinata ad anime pure. Secondo Spinoza Mosé ha voluto con
un tale linguaggio,usando soprattutto tali ragioni,istruire gli Ebrei al culto di Dio
e legarli meglio con uno strumento in relazione con la puerilità del loro spirito.
Così, la sola opera di Spinoza, pubblicata mentre egli era vivo, il Trattato
teologico-politico, è consacrata alla lettura della Bibbia in cui l’autore dimostra,
sostanzialmente, che la Scrittura non è affatto l’espressione della Verità
Rivelata ma una guida morale per l’esistenza quotidiana.
Non solo, ma Spinoza contesta chiaramente certe affermazioni tradizionali,
come l’attribuzione a Mosé del Pentateuco, con la messa in evidenza nel testo
biblico di contraddizioni, di ripetizioni, di variazioni nella lingua utilizzata, ecc.
In sostanza, il Trattato teologico-politico offriva nel Seicento la narrazione
storica della nascita e della decadenza di uno Stato che il culto dell’elezione dei
suoi membri aveva votato all’odio delle nazioni? O, invero, offriva il paradigma
ideale di ogni società politica stabile, nonostante le nefaste conseguenze del
culto del Vitello d’Oro e la collera del Legislatore?
Il Trattato teologico politico faceva del Cristo semplicemente l’uomo eccezionale che concluse l’evoluzione del giudaismo universalizzandone l’obbligo centrale d’amore del prossimo? O faceva, piuttosto, del Cristo letteralmente il “figlio
di Dio”, una figura del tutto diversa da quella dei Profeti? Tante questioni che
sollevano ancor oggi passioni di cui Spinoza, forse, non aveva previsto la forza.
Questioni che in una lettura d’insieme del Trattato offrono alla storia degli Ebrei
la sua giusta collocazione18.
Per affrontare con uno spirito sereno la maniera con cui Spinoza tratta –a
volte non serenamente– dell’elezione e della “insubordinazione naturale” degli
Ebrei, deve essere posta una questione preliminare: per Spinoza la natura non
crea dei popoli, ma degli individui; sono gli individui19 che, da una parte, si credono eletti e che, d’altra parte, non accettano di far passare il loro conatus sotto
la ferula della legge. Richiamo importante, perché Spinoza apriva il terzo capitolo del Trattato Teologico politico con una notazione generale sulla pretesa
elezione, notazione che si adattava certamente al popolo giudeo in cui certi
“interpreti” vi avrebbero visto un segno di antisemitismo, impregnato di simpatie
cristiane20: «La vera felicità e la Beatitudine non stanno per ciascuno che nel
SAGGI
godimento del bene e non nella gloria d’esser solo a goderne, rimanendone gli
altri esclusi; in effetti, considerarsi in possesso d’una beatitudine più grande
perché si è soli in una condizione buona […] e perché si ha una fortuna migliore degli altri, significa ignorare la vera felicità e la beatitudine; la gioia che si
prova a credersi superiori, quando non è del tutto infantile, non può nascere
che dall’invidia e da un cuore malvagio»21.
Per Spinoza, i Giudei del suo tempo si ingannavano sul senso che si poteva
dare all’elezione partendo dai dati della Scrittura. L’elezione era una maniera di
parlare del successo temporale momentaneo che furono per gli Ebrei la fuga
dall’Egitto e la fondazione del loro Stato. La sopravvivenza del popolo ebreo
fuori dello Stato costituito dalla legge di Mosé si spiega con due ragioni, l’una
negativa, l’odio delle nazioni, l’altra positiva, il segno della circoncisione; quest’ultima è paragonata alla stoia dei cinesi, ma l’insieme non ha senso se non è
considerato come una risposta alla domanda: c’è una provvidenza divina speciale per il popolo giudeo? Si tratta, dunque, di respingere l’idea di elezione
iscrivendo ogni storia speciale sotto la giurisdizione d’una regola d’universalità–
le leggi uniche e necessarie della storia e della natura. Ma sarebbe necessario
aggiungere: uno degli anelli della necessità è qui d’ordine simbolico; è questo
simbolo che si sostituisce allo Stato debole; il vero problema,per sostituire la
questione della dinamica del sistema,è allora di sapere se quest’ordine simbolico risponde o no ad una necessità passionale; si può rispondere positivamente
se si supera la visione abituale d’uno Spinoza come positivista giuridico per il
quale, invece, non c’è altra realtà politica che lo Stato, e se lo si va a cercare
dal lato di ciò che fonda contemporaneamente la necessità e la perpetua fragilità dell’ordine statuale: i nodi passionali che organizzano l’entrata reticente
degli individui nella società civile; ora lo sappiamo per il Trattato Politico, l’ordine simbolico è una delle possibili risposte a tale passione del nuovo che fa di
ogni individuo il nemico potenziale della cosa pubblica. Resta allora da pensare
come tale risposta possa sopravvivere all’ordine che difendeva.
Riservandoci di tornarci su nella seconda parte del presente lavoro,per il
momento è opportuno puntualizzare che l’elezione fu, per Mosé, un mezzo per
esortare i compagni all’obbedienza, un mezzo per legarli a sé che fosse in rapporto con l’«infanzia del loro spirito»22. Infanzia dello spirito alla quale s’aggiungeva una miseria fisica e morale certa. Infatti, per spiegare la facilità con la
quale Mosè poté convincere gli Israeliti dell’attenzione particolare di Dio nei loro
confronti, ma anche la facilità con la quale, in pochi giorni, essi trasferirono la
loro devozione verso un vitello, Spinoza osservava, nel capitolo II, che degli
uomini «intrisi di superstizioni egiziane, barbari e sfiniti dalle disavventure della
schiavitù, non avevano di Dio una conoscenza integra»23. Ma, lungi dall’insegnare questa conoscenza integra –che neanche lui possedeva– Mosé stabilisce una relazione diretta tra la convinzione dell’elezione e l’obbligo all’obbedienza.
Non insegnò da filosofo una regola di vita fondata sulla libertà dell’anima;
insegnò da legislatore come i suoi compagni potessero essere guidati dal timore delle punizioni o dalla speranza delle ricompense, a seconda che si mantenessero ribelli o obbedienti.
13
14
Insomma, osserva Spinoza, insegnò agli Ebrei «come dei genitori insegnano ai bambini privi di ragione»24.
Niente di eclatante per il fatto che Mosé tratta i suoi compagni di strada
come dei bambini.
Nel momento dell’esodo dall’Egitto, essi si ritrovano come allo stato di natura e la marcia nel deserto è per loro come una seconda nascita. Ed è a partire
da questo “stato di natura” che occorre comprendere le formule con cui
Spinoza evoca “l’insubordinazione naturale” degli Ebrei. Dopo secoli di antisemitismo, i lettori del Trattato teologico politico leggono questa formula come
sinonimo d’una “insubordinazione naturale tipica degli Ebrei”. Se ne trovava,
del resto, giustificazione nell’Antico Testamento in cui i Giudei sono descritti,
troppo frequentemente e letteralmente, come “un popolo di dura cervice”.
Per esempio, Mosé, nell’Esodo, si lamenta con Yahvé del fatto che l’alleanza col suo popolo sarà difficile, come testimoniava la tradizione politeista del
Vitello d’oro: «Va’ pure verso la terra dove scorre latte e miele […] Ma io non
verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei
popolo di dura cervice»25. Ed in un celebre passo del Deuteronomio è lo stesso
Yahvé che dichiara: «Ascolta, Israele! Oggi tu attraverserai il Giordano per
andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e
fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli
Anakiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: Chi mai può resistere ai figli di
Anak? Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come
fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li
farai perire in fretta […]. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il
Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile paese; anzi, tu sei un popolo
di dura cervice. Ricordati, non dimenticare, come hai provato all’ira il Signore
tuo Dio nel deserto. Da quando usciste dal paese d’Egitto fino al vostro arrivo in
questo luogo, siete stati ribelli al Signore»26.
Le allusioni all’insubordinazione sono così particolarmente numerose quando è evocato il passaggio dallo stato di natura nel deserto allo stato di società
in cui Mosé tenta di costringerli. E l’immagine della “dura cervice” si relaziona
troppo precisamente, in ebreo, alla rappresentazione della bestia restìa, che
non vuol sopportare d’essere guidata o d’essere afflitta da un traino.
Ora proprio Spinoza sottolinea che, a dispetto dell’insubordinazione naturale
degli uomini che non sopportano volentieri di chinare la schiena sotto una qualsiasi legge, gli Ebrei hanno dovuto scegliere tra l’obbedienza, che varrebbe loro
una felice continuazione del loro Stato, o l’insubordinazione che ne produrrebbe la rovina.
Questa insubordinazione è una prerogativa degli Ebrei, e Spinoza insiste a
dirlo.
Concludendo, nel capitolo XVII del Trattato teologico politico, la descrizione
della società mosaica, Spinoza si domanda perché gli Ebrei spesso sono venuti
meno all’obbedienza della legge e sono stati così spesso sotto il giogo straniero: «Credo di aver esposto, sia pur brevemente, i principi fondamentali di questo Stato. Restano ora da ricercare le cause per cui accadde che gli Ebrei vennero meno alle legge sì gran numero di volte, furono tante volte sottomessi ed
3. La teoria del conatus
Ora l’argilla non è altro che un’immagine, che Spinoza attribuisce a San
Paolo, per descrivere il conatus individuale. Sottoposto ad ogni sorta di determinazione esterna, questo conatus tende sempre meno a perseverare nell’essere, anche nella schiavitù e sotto la forma dell’intelletto: d’onde la persistenza
del politeismo negli Ebrei usciti dall’Egitto; d’onde la fermezza d’animo con la
SAGGI
infine il loro Stato potè essere del tutto disperso. Ma forse qualcuno dirà che ciò
è avvenuto per la disobbedienza di questo popolo.
Ma simile risposta è puerile; infatti perché questo popolo fu meno sottomesso alla legge degli altri; forse per natura? Ma questa non crea i popoli ma gli
individui, che si distinguono in popoli solo per la diversità della lingua, delle
leggi e dei costumi ricevuti»27. Ma già nel capitolo VII Spinoza aveva scritto che
la storia della Scrittura «deve narrare le vicende di tutti i libri dei profeti di cui
abbiamo memoria; cioè la vita, i costumi, le inclinazioni dell’autore in ciascun
libro, chi egli fosse, in che occasione, in che tempo, per chi e infine in quale lingua egli abbia scritto»28. E su questa scia commenta G. De Ruggiero: «Se
anche Dio ha parlato agli Ebrei» un’ipotesi che per motivi di spiegabile circospezione è collocata in una penombra discreta, e che oscilla tra una rivelazione
naturale e una rivelazione soprannaturale –è certo che la parola divina è stata
accolta e interpretata secondo la mentalità, la cultura, il temperamento etnico di
coloro che la ricevevano»29.
Come si vede, Spinoza, partendo dai testi dell’Esodo e del Deuteronomio, si
convince che la grandezza inaccesibile di Dio e la sua temibile maestà hanno
fatto paura agli Ebrei.
Malgrado la distanza che separa i governanti dai governati, malgrado tutto,
deve esserci tra di loro una comune misura. Altrimenti la comunicazione diventa impossibile.
Ma nel capitolo XIX del Trattato teologico politico, Spinoza afferma che la
distinzione tra i due patti tra gli Ebrei e Dio non corrisponde nella Scrittura che
ad una maniera di presentare le cose. In realtà gli Ebrei hanno trasferito i diritti
a Dio soltanto col pensiero, cioè teoricamente, e non praticamente. In realtà,
fino alla conclusione del patto con Mosé gli Ebrei adottavano spontaneamente un linguaggio metaforico per parlare dell’intangibile: così per parlare dell’anima e dell’intelletto essi parlavano del “cuore”.
Indicazione importante, perché è questo cuore che il Signore vuole a volte
“indurire” ma lo fa senza alcuna distinzione tra Giudei e Gentili.Si conosce sufficientemnte il modo col quale Yahvé indurì per dieci volte il cuore del Faraone
–finchè non fossero morti i primi nati del suo popolo- Faraone che si intestardì
a non permettere che il popolo di Mosé lasciasse l’Egitto. In breve, nota
Spinoza, Dio spande la sua misericordia su chi vuole e indurisce chi anche Lui
vuole. Se gli uomini non sono scusabili, è per la sola ragione che essi sono
nella potenza di Dio come l’argilla in quella della ceramista.
15
16
quale, come per una seconda natura sopportarono ogni cosa per servire la loro
patria; d’onde l’indurimento del cuore del Faraone; d’onde ancora l’ostinazione
di certi scettici a dire che essi dubitano di tutto anche se il loro spirito non dubita30.Tuttavia questo conatus, argilla malleabile o cuore di pietra non è isolabile
dalle leggi della natura nelle quali è preso ed, in particolare, da forze che, eventualmente, possono ammorbidirlo.
La questione può essere così risolta: l’individuo si forza di perseverare nel
suo essere. E il suo sforzo per conservarsi,lungi dall’essergli sopraggiunto,non
si distingue dalla sua essenza attuale: la sua essenza, per il solo fatto che era
concepibile, tendeva necessariamente ad attualizzarsi da sempre; dal momento in cui si attualizza tende,dunque allo stesso modo,a riattualizzarsi in ogni
momento,per cui il conatus d’una cosa è il prolungamento nella durata della
sua eterna vis existendi.Ogni indviduo, che sia finito o infinito,appare così come
la risultante dei suoi propri effetti: come una totalità fissa su di sé, che si produce e si riproduce da se medesima in permanenza.
A livello di un individuo Infinito,che non ha limiti esterni,questa autoriproduzione non incontra alcun ostacolo: il Modo infinito immediato produce il modo
infinito mediato,che riproduce il Modo infinito immediato: è la vita stessa
dell’’Universo31.
Nel caso d’un individuo finito,al contrario,possono e debbono sorgere,
secondo Spinoza, degli ostacoli: una cosa singola non esiste se le altre cose
singole non le preparano un contesto favorevole,se il suo conatus non è sostenuto da tutti gli altri conatus; ed un momento arriva sempre dove la cooperazione si trasforma in antagonismo.Ma l’individuo finisce da se stesso,nella misura
in cui agisce,ovvero nella misura in cui ciò che fa si deduce da una sola natura,tende a conservarsi per una durata illimitata. Nessuna esperienza indebolirà
mai questa verità fondamentale. Se noi crediamo di incontrare un essere che
non cerca di perseverare nel suo essere, significa semplicemente che non si
tratta di un vero individuo32.
Come per il principio dell’insubordinazione, così Spinoza dà molteplici indicazioni che fanno dell’elezione un’espressione metaforica d’uno stato di schiavitù dell’individuo: l’individuo, cioè, colmo di desideri, ma ignorante delle leggi
che presiedono alla loro soddisfazione. L’Appendice della prima parte dell’Etica
aveva esposto il meccanismo con cui ogni individuo, per poco che le circostanze gli siano favorevoli, si crede il prediletto da Dio e cerca, con un culto appropriato, di conservare gelosamente tale privilegio.
In un linguaggio più adatto ai lettori del Trattato teologico –politico, Spinoza
indica analogamente che ogni elezione divina è individuale. Nessuno sceglie il
proprio modo di vivere e non fa nulla,se non per una vocazione singolare di Dio
che ha eletto tale individuo al di sopra degli altri per questa opera o per quella
maniera di vivere33.
Considerato nel suo fondamento ontologico, con le sue conseguenze antropologiche (ma anche fisiche implicitamente), qual è dunque il contenuto della
dottrina spinozista del conatus? Più radicalmente dello “sforzo” hobbesiano, è
la “conservazione di sé da parte dell’essere”, la cui origine si trova nello
Stoicismo, conservazione di sé di ogni essere in quanto essere, per quanto fini-
SAGGI
to possa essere, in quanto è una parte dell’essere infinito, essere finito che non
può essere intrinsecamente essere distrutto né da sé stesso, né da ciò di cui è
una parte, ma solo da altri esseri finiti nelle relazioni esteriori: che ciò sia una
parte dello spirito o una parte dell’estensione, esso si conserva, senza dover
essere conservato da altro che da se stesso,come credeva anche Descartes; il
principio di conservazione è contenuto nell’essenza dell’essere in quanto tale,
essentia actualis, non essere in potenza, ma essere in atto e/o agente, come
per gli Stoici. Ma questa conservazione nelle sue conseguenze implica una
continuità nei suoi effetti ovvero una cotinuità nel movimento, che si tratti del
movimento del corpo o del movimento delle idee e anche degli affetti; lo spinozismo, che rifiuta l’atomismo degli istanti distinti, o separati, include ontologicamente la possibilità di un conatus, che sia un principio, un abbozzo di movimento, tale quale aveva voluto definirlo Hobbes, questo “piccolo movimento”,
momentum, facendosi in un punto e in un istante che restano sempre divisibili
mai isolati, “momento” motore, non sviluppato, ma sviluppantesi, come ce l’ha
insegnato il progresso della fisica34.
4.Il diritto naturale
Questo conatus fonda il diritto naturale: trasposizione, nella durata, dell’eterno diritto delle essenze all’esistenza. Quale meraviglia in ciò? La fonte di ogni
valore, per Spinoza come per tutti i suoi contemporanei, è Dio.
La causa unica di tutte le cose, per definizione, ha tutti i diritti. Ma Dio,
secondo Spinoza si identifica con l’autoproduttività interna di ciascuna realtà
individuale, con l’aspetto naturante del Tutto e delle totalità parziali che lo compongono. Tutto ciò che fa un individuo è dunque valido ipso facto.
E ciò, non solo perché non ci sono norme trascendenti(la qual cosa ci fornirebbe un nichilismo morale), ma perché, positivamente, la norma è immanente.
Ogni essere ha tanto Diritto quanta potenza per perseverare nel suo essere, in
quanto tale potenza misura esattamente il suo grado di partecipazione al divino.
Per tale motivo il diritto naturale (jus naturale) di un individuo umano, astrazione fatta dall’organizzazione politica e da quella religiosa, è una regola di
condotta che non differisce gran che dalle leggi fisiche che seguono tutte le
cose naturali con una necessità ineluttabile: «Per diritto ed istituto di natura non
intendo altro che le regole naturali di ciascun individuo, secondo le quali concepiamo ognuno come determinato naturalmente ad esistere ed operare in un
certo modo. Per esempio, i pesci sono determinati dalla natura al moto, e i
grandi a mangiare i più piccoli; perciò per un supremo diritto di natura i pesci
hanno il loro regno nell’acqua, e i grandi mangiano i più piccoli. Infatti è certo
che la natura considerata assolutamente ha un supremo diritto su tutto ciò su
cui si può operare, ossia il diritto di natura si estende fin dove si estende la sua
potenza; la potenza della natura infatti è la stessa potenza di Dio, che ha un
supremo diritto su tutto [...] ne consegue che ciascun individuo ha un supremo
17
18
diritto ad esistere e ad operare a seconda di come naturalmente è stato determinato [...]. Perciò tutti gli uomini [...] vivono per un supremo diritto sotto le sole
leggi delle inclinazioni. E cioè, come il saggio ha un supremo diritto su tutto ciò
che la ragione prescrive, ossia di vivere secondo le leggi della ragione, così
anche l’ignorante e colui che non sa dominare il proprio animo, ha un supremo
diritto su tutto ciò a cui lo spingono i suoi desideri, ossia vive secondo le leggi
dei suoi desideri. E ciò è lo stesso di quel che insegna Paolo, il quale prima
delle leggi, cioè fin quando gli uomini vivono sotto l’imperio della natura, non
riconosce alcun peccato»35.
Il diritto naturale dunque si misura a seconda del grado della potenza di ciascuno, del successo o dell’insuccesso del suo sforzo per conservarsi, essendo
questo sforzo un’espressione di un determinato della potenza di Dio o della
Natura, considerata nella sua totalità e nel suo aspetto dinamico.
Qualunque sia il grado di perfezione d’un individuo, segue la legge della sua
natura.
Definita dalla sua singola essenza, senza tener conto degli interessi altrui,
senza provare alcun sentimento di gratitudine. Anche, ponendosi dal punto di
vista del diritto naturale, i valori giuridici e etici sono sprovvisti di senso. Coloro
che vivono secondo la legge della brama vivono secondo la stessa necessità
naturale, come coloro che vivono secondo la legge della ragione, senza che vi
sia una regola normativa per indicar loro un altro modo di vivere né mezzi coercitivi e persuasivi per obbligarli a seguirla.
Secondo Salomone, allo stato di natura si presentano possibilità analoghe
al giusto e all’ingiusto, al puro e all’impuro. Al contrario, la condizione di socialità è uno stato in cui gli uomini, invece di sbranarsi e di condannarsi così alla
solitudine, all’insicurezza e alla miseria, intrecciano fra di loro relazioni di reciproca assistenza, associando i loro conatus al fine di mostrare i mezzi più sicuri
per ciascuno di favorire il dispiegamento del proprio conatus. «Il diritto naturale
dunque di ciascun uomo –scrive Spinoza – non è determinato dalla sana ragione, ma dai suoi desideri e dalla sua potenza […] Ciascuno dunque, considerato
solo sotto l’imperio della natura, giudica qualcosa utile per sé, mosso o dalla
sana ragione o dall’impulso delle passioni, e la desidera per un supremo diritto
di natura, e gli è lecito impadronirsene in qualunque modo, o in qualunque
altro modo gli parrà facile; e di conseguenza egli considera nemico chiunque
vuol impedire di appagare il suo animo»36.
Il principio è dunque d’una semplicità brutale: è l’identificazione assoluta del
diritto al fatto.
Lo stesso Hobbes non s’era spinto fin là; non per timidezza, ma perché
glielo impediva la sua antropologia. In effetti, il filosofo inglese manteneva nell’uomo una dualità mezzo-fine: i movimenti animali, di cui i nostri desideri erano
lo sbocco, avevano il ruolo d’assicurare la conservazione d’un movimento vitale
definito indipendentemente da essi.
Era dunque il movimento vitale, e solo esso, che dava all’azione umana il
suo principio giustificatore: il diritto naturale consisteva nella libertà che ha ogni
uomo d’agire come vuole, certo, ma per preservare la propria vita37. Da qui
discende una possibile distinzione, almeno in teoria, tra i mezzi legittimi che
SAGGI
rispondono veramente a questo fine, e i mezzi illegittimi che non vi conducono
realmente. È vero che questa distinzione era praticamente inoperante: nello
stato di natura, in cui ciascuno è responsabile del proprio destino ed in cui tutti
sono in guerra contro tutti (bellum omnium contra omnes), nessun mezzo di
difesa può essere escluso a priori. Ma se il diritto naturale si misurasse così,
solo in rapporto alla forza, non sarebbe che qualcosa di secondario, di derivato
e, in qualche modo, di accidentale; sarebbe un quid che non mira all’essenza
stessa del Diritto, ma alle conseguenze d’una situazione particolare.
Niente di simile in Spinoza: il suo monismo antropologico non permette di
dissociare la vita da conservare dai mezzi che la conservano; è il conatus, uno
e indivisibile, che è l’istante legittimante, ed il conatus ingloba tutti i nostri desideri particolari con tutti i comportamenti che ne derivano; ogni atto si giustifica
dunque col solo fatto che lo compiamo, senza alcun riferimento ad una qualsiasi norma preesistente.
Ciò è possibile perché il Diritto naturale è, per Spinoza, insuperabile. In
Hobbes non regnava che nello Stato di natura; una volta costituita la società
politica, cessava di aver valore. Ma questa dottrina si fondava precisamente sul
dualismo del movimento vitale e del movimento animale. L’unico principio del
Diritto, in ogni circostanza era la conservazione dell’esistenza biologica bruta.
Solo in tale ottica i due metodi erano concepibili. Nello stato di natura, l’individuo lasciato a se stesso restava solo giudice dei movimenti animali(comportamento motore e verbale) da eseguire per difendersi: questo era il suo Diritto
naturale.
Ora, questo non si può dire che avvenga in Spinoza per il quale mezzi e fini
non erano distinti. Come sfuggiremmo alla sfera del Diritto naturale. Sarebbe
necessario, per questo, liberarci dalle leggi della Natura. Tutto ciò che giudichiamo buono, se ne abbiamo la forza, lo facciamo necessariamente, e il Diritto
Naturale non significa più nulla. Senza dubbio potrà essere trasferito in diritto
politico, quando lo Stato sarà divenuto esso stesso un Individuo più potente di
noi; ma questo diritto politico non sarà mai che la risultante globale dei diritti
naturali. Ciascuno, in non importa quale situazione, ha sempre il diritto di fare
ciò che vuole e ciò che può. Il ruolo dello Stato non consisterà che nell’orientare in un certo senso tutti questi desideri e tutti questi poteri; se obbediamo,
vuol dire che gli vogliamo bene, non che lo temiamo; e se vogliamo e possiamo
disobbedirgli, ne abbiamo il diritto, a nostro rischio e pericolo. Diritto naturale e
diritto tout court sono sinonimi. In questo senso è bene notare che il Sovrano
perde il suo diritto, quando perde il potere di costringere i soggetti, e non, come
per Hobbes, quello di proteggerli.
Perché, in tali condizioni, Spinoza parla d’un “abbandono” del Diritto
Naturale, o del suo “transfert” da un individuo all’altro? Queste sono espressioni del Tractatus teologico – politicus e dell’Ethica, e non tanto del Tractatus politicus, in cui Spinoza sembra aver preso maggiore consapevolezza delle implicazioni della sua tesi e dove non si trovano quasi affatto: in quest’ultima opera
il verbo transferre appare solo occasionalmente38.
E, d’altra parte, questa evoluzione concerne più la formulazione (peraltro
molto importante) che la fondazione stessa della dottrina. Sin dal Tractatus teo-
19
20
logico-politicus, in effetti, Spinoza aveva insistito sulla portata reale dell’alienazione giuridica. Infatti, e solo i fatti contano, l’abbandono dei nostri diritti naturali
non può essere mai totale; altrimenti, cesseremmo d’essere uomini, cioè d’essere. Nel Trattato politico scomparirà solo la distinzione –poco spinoziana– tra
la teoria e la pratica.
Il fatto è che, come sarà già stato notato, il termine di diritto naturale non
implica in Spinoza alcun significato etico o giuridico, e l’originalità di tale dottrina sta nel fatto che essa si oppone tanto ai teorici del Diritto teologico puro
quanto ai filosofi che sostengono l’esistenza oggettiva d’un diritto naturale “universale” e razionale indipendente dalla legge divina, come il suo compatriota
Grozio, per il quale il diritto naturale è talmente immutabile che non può essere
cambiato neanche da Dio. E come Dio non può impedire che due più due faccia quattro, così non può impedire che ciò che è essenzialmente cattivo non
sia cattivo. Per Grozio, le cose si svolgerebbero allo stesso modo, anche se ci
accordassimo che non c’è Dio o che gli affari umani non sono l’oggetto delle
sue cure39.
È evidente che la sua visione panteistica non teologica dell’Universo impediva a Spinoza di fondare il Diritto umano sulla volontà di un Dio legislatore .
Ma è molto più interessante vedere ciò che separa l’Autore del Tractatus
Theologico-Politicus dai sostenitori del diritto naturale classico.
È facile notare anzitutto che gli Autori che si sono interessati del diritto naturale si pongono generalmente in una prospettiva finalista della natura umana.
Le loro speculazioni mirano principalmente a “liberare le esigenze fondamentali” della persona, il “fine naturale” dell’individuo, della società, ecc. Insomma, i
teorici classici del diritto naturale hanno sempre avuto intenzioni più o meno
normative e riformiste. Si tratta per loro di determinare sub ratione boni il
modello d’organizzazione giuridica e politica meglio appropriato alla missione
naturale dell’uomo, tale quale essi la concepiscono.
Spinoza, invece, non colloca mai il diritto naturale sul piano dei “fini” ideali.
Al contrario poiché lo status naturalis si definisce come il regno dei “mezzi” e
della forza, lo jus naturale non fa che tradurre una situazione empirica che evidentemente non assegna alcun posto ai valori morali e giuridici. Il diritto naturale non pone, a suo avviso, alcun problema perché non esiste valore naturale
anteriore al diritto sociale40. Le preoccupazioni di Spinoza sono qui di ordine
strettamente ontologico. E ciò diventa più comprensibile se si pensa che il diritto vero comincia, secondo Spinoza, solo col diritto positivo, ovvero col diritto
civile, tipico della società civile, come dirà Galluppi41.
In effetti, la natura “spinoziana” ignora la legge, nel senso giuridico e morale
della parola. Di conseguenza, soltanto la legislazione positiva dello Stato, che
procede da una volontà comune e che poggia sulla pratica contrattuale dell’insieme dei cittadini, merita il nome di diritto. Ecco perché l’espressione “diritto”
naturale prende in Spinoza il senso di “ potere”, di “potenza” naturale41bis Lo jus
naturae si confonde con la potentia naturae. Insomma, il diritto naturale è il
diritto di natura.
La dottrina dei Trattati politici, che identifica il diritto naturale e la potenza
dell’essere, corrisponde esattamente ad una teoria sviluppata nell’Etica(terza e
quarta parte).Si sa che, per Spinoza, il grado di realtà degli esseri si misura
dalla loro perfezione42. Così, si dirà che un dato individuo possiede tanti più
diritti che può concentrare in se stesso una più grande quantità della potenza
totale della Natura, di cui costituisce una singola determinazione.
Il carattere originale delle concezioni socio-politiche di Spinoza sopra citate,apparirà meglio ancora nell’alternanza dialettica del jus naturale e del jus
civile, seguendo il patto sociale. Infatti, per quanto i due sistemi si oppongano e
insistano nell’opporsi, natura e società conserveranno sempre dei legami organici interni, sottili e profondi.
Comunque sia si possono sin d’ora determinare i caratteri fondamentali del
jus naturae e postulare che la dottrina spinoziana va incontro ai principi del
razionalismo tradizionale e dell’universalismo giuridico, come pure del liberalismo ottimista. In effetti, solo con una ferma decisione e con un impegno
costante gli individui umani costituiscono un legame sociale al fine di non vivere
più sotto l’imperio della brama che li trascina in direzioni divergenti e di lasciarsi
guidare ormai dal solo imperativo della ragione, principio d’accordo e di convergenza tra gli uomini. Tesi, questa, che Spinoza enuncia chiaramente e senza
mezzi termini quando afferma che pur restando validi i diritti a soddisfare i propri bisogni naturali,”tuttavia nessuno può mettere in dubbio quanto sia più utile
agli uomini vivere secondo le leggi e i precisi comandamenti della nostra ragione”; non solo ma vivendo fuori dalle “leggi della ragione,restano schiavi delle
necessità della vita”, onde è necessario “venire ad un patto e di conseguenza
trasmettere alla collettività quel diritto su ogni cosa che ciascuno avea da natura”43. Come si vede, siamo in pieno contrattualismo, anche se le fonti sociali
che hanno alimentato la concezione politica spinoziana si radicano interamente
nei legami che egli intratteneva col movimento del panteismo settario piccolo
borghese su certi punti anche vicino alle masse popolari. Si conoscono, d’altra
parte, le sue strette relazioni col partito repubblicano di de Witte, partito patrizio
–borghese, verso il quale nei Paesi Bassi di quell’epoca erano attratti gli interessi della cultura e della tolleranza religiosa.
Immaginiamo per un momento un mondo in cui il diritto naturale di ciascuno
non fosse il prodotto di cause naturali, ma avrebbe origini razionali. Che cosa
avverrebbe?
Tutti gli uomini seguirebbero allora, necessariamente, gli insegnamenti della
ragione e realizzerebbero immediatamente –anche automaticamente– il regno
del diritto positivo nella natura: «Se fosse […] in nostro potere di vivere secondo il dettame della ragione e di lasciarci trascinare dalla cieca cupidigia, tutti
seguirebbero la via della ragione e farebbero una vita da saggi»44. La natura
umana produrrebbe e senza mediazioni la Repubblica dei Fini. Si vedrebbe il
Diritto sorgere d’un sol colpo dalla Ragione universale, come Atena uscire tutta
armata dal cervello di Zeus. Il male nel mondo sarebbe impossibile.
SAGGI
5. Il patto sociale
21
22
Ma nell’ordine naturale non esiste l’interesse generale. Come l’individuo
rappresenta in Spinoza la realtà naturale più “naturale” di tutte, così solo lui è il
possibile legislatore nello stato di natura «in cui l’individuo è il solo arbitro della
propria condotta, in cui dispone del supremo diritto di prescriversi da sé le leggi
e di interpretarle per sé, quasi di abrogarle se egli pensa di badare, così,
meglio al proprio interesse45».
L’essere resta il solo fondamento del diritto come di ogni cosa. Qui, è l’essere individuale che costituisce l’essenza del diritto. Il problema della libertà che è
uno dei fondamenti della dottrina spinoziana appare nello stesso tempo come
dottrina sociale, in quanto «homo qui ratione ducitur,magis in civitate, ubi ex
communi decreto vivit, quam in solitudine,ubi,sibi soli obtemperat, liber est46.
Minacciato da ogni parte, lasciato a se stesso nell’assenza d’un bene comune positivo definito da una volontà generale, dove andrebbe dunque l’uomo a
cercare un principio d’azione altro dalla sua conservazione individuale e un fine
altro dal suo piacere egoistico? Ma la solitudine ontologica dello stato di natura
rafforza tuttavia il primo germe della libertà, in quanto è nell’anarchia naturale
che la libertà civile prende la sua origine e sono gli imperativi della conservazione indivudale che renderanno necessario il patto sociale.
L’idealismo sociale di Spinoza, come tutti gli idealismi premarxisti nell’interpretazione dello Stato, si manifesta nella tendenza sistematica a subordinare la
soluzione dei problemi sociali a quella dei problemi morali. Il fine più generale
verso il quale tendono queste aspirazioni è di cercare di risolvere il problema,
insolubile nelle fondamenta d’una società divisa in classi, di armonizzazione
degli interessi privati e puramente egoistici dei cittadini dello Stato con gli interessi della società intera, essendo quest’ultima identificata da Spinoza, come
da tutti gli altri teorici del contratto sociale, con lo Stato.
L’idealismo sociale di Spinoza si manifesta soprattutto nella convinzione che
la funzione principale dello Stato è nel suo ruolo d’educatore morale. Il fatto è
che, nonostante egli si sia in qualche volta avvicinato alla comprensione del
ruolo che giocano i fattori economici nella vita della società, per esempio sul
ruolo della divisione del lavoro, e a volte sulla comprensione dell’ineguaglianza
che regna nelle classi sociali, tuttavia nella sua concezione questi fattori non
giocano un ruolo rilevante.
Certo, alla fonte della vita sociale si trova l’insieme di tutti i desideri e appetiti individuali. La vita collettiva è in effetti provata dagli uomini come un mezzo
desiderabile per accrescere efficacemente la loro potenza naturale onde perseverare nell’esistenza, in quanto «nulla può concordare con la natura di una
certa cosa più degli altri individui della stessa specie; e perciò nulla si dà di più
utile all’uomo per conservare il proprio essere e fruire della vita razionale dell’uomo che è guidato dalla ragione»47. Da questo punto di vista la politica spinoziana ha potuto giocare un ruolo determinante nell’avvenimento dell’individualismo democratico. Se è così, perché tacciare allora Spinoza di “psicologismo
sociologico”? Sarà necessario rimproverargli d’atomizzare la realtà sociale sollevando così tutte le difficoltà tipiche dell’individualismo monadico? No, o
sarebbe preferibile studiare la politica spinoziana senza tener conto degli stretti
legami con la filosofia generale da cui dipende. Ora, lo spinozismo resta anzi-
SAGGI
tutto una visione unitaria del Mondo e non si può dimenticare che la potenza
individuale non è che una modalità determinata della potenza globale della
Natura intera, la quale a sua volta non è «niente di più della potenza coniugata
di tutti i tipi naturali»48. La teoria spinozista del patto sociale poggia su questa
identità sostanziale tra l’appetito individuale e la necessità naturale generale. In
effetti, il patto sociale non risulta da una decisione contingente e arbitraria degli
uomini che avrebbero deciso, un bel giorno, di mettere fine allo stato di natura
per instaurare il regno del diritto. Rinunciando al suo diritto naturale per accettare di sottomettersi all’autorità e alla legislazione comune dello Stato, l’uomo
obbedisce ancora agli imperativi della legge naturale che spinge tutte le cose
singolari a desiderare ciò che loro sembra utile e ad evitare ciò che diminuisce
il loro essere. Questo principio rappresenta per Spinoza una vera legge universale della natura, al punto che egli la colloca tra le verità eterne: «È,infatti,
legge universale dell’umana natura che nessuno trascuri ciò che giudica buono
se non per speranza di un bene maggiore o per timore di un più gran male; e
neppure sopporti un qualche male se non per evitarne uno peggiore, o per la
speranza di un maggior bene. In altre parole, ciascuno tra due beni sceglierà
quello che egli stesso giudica più grande, e tra due mali quello che gli sembra il
minore. Dico espressamente che sembra maggiore o minore a colui che sceglie; non che realmente la cosa sia come egli la giudica. E questa legge è così
fermamente scritta nella natura umana che la si deve considerare un’eterna
verità che nessuno può ignorare»49. Di più, non è concepibile «non aver bisogno di nulla al di fuori di noi per conservare il nostro essere e vivere in modo
tale da non aver alcun rapporto con le cose che sono fuori di noi». La conseguenza è che «nulla gli uomini possono desiderare di più efficace per la conservazione del proprio essere quanto che tutti concordino su tutte le cose»50.
Ora, da una parte, anche allo stato di natura l’uomo deve necessariamente
vivere in società. Spinoza lo mostra in un passaggio del capitolo V del Trattato
Teologico-Politico, che gli altri testi non fanno che riassumere brevemente.
Ridotti alle nostre sole risorse individuali, ci troveremmo in un ‘impotenza quasi
totale. Infatti il nostro corpo, molto complesso, ha bisogno di molte cose per
conservarsi e mantenersi, e queste cose che non sono provvidenzialmente
adattate al nostro uso, debbono essere trasformate per esserci utili. Ora, nella
solitudine, non saremmo del tutto incapaci di compiere tutti i lavori che ciò
esige: quantitativamente è necessario troppo tempo; qualitativamente essi
sono troppo variati perché non possediamo tutte le attitudini necessarie.
Ma, d’altra parte, allo stato di natura è impossibile una qualsivoglia società
stabile. Sin dall’inizio,l’imitazione dei sentimenti genera di sicuro l’ambizione di
dominio e l’invidia quanto la pietà e l’ambizione di gloria.
Ora, è vero che il diritto naturale autorizza a cercare il proprio bene a spese
degli altri, ma si tratta di un’arma a doppio taglio, perché gli altri hanno lo stesso diritto. Al punto che, la potenza e l’indipendenza individuali, in principio illimitate, a poco a poco nello stato di natura svaniscono.
Quando tutto è permesso a tutti, ciascuno è schiavo. L’individuo spende
tutta la sua energia per non soccombere e per impedire che gli altri lo emarginino. Tuttavia, malgrado tutti gli sforzi, e qualunque sia la sua potenza, un indivi-
23
duo isolato non arriverà mai a sbarazzarsi della concorrenza implacabile dei
suoi simili e a liberarsi dalla paura.
Così, se «qualcuno ritiene che sia servo chi agisce per un mandato e libero
chi ubbisce solo al proprio animo. Ciò non è vero in senso assoluto; infatti in
realtà chi è trascinato dalle sue passioni e non può scorgere né fare qualcosa
di utile per sé, massimamente è servo, mentre è libero solamente colui che vive
con animo integro guidato soltanto dalla sua ragione»51. Di conseguenza il patto
sociale non può essere considerato come effetto del libero arbitrio. Esso costituisce un episodio dell’ordine cosmico, in cui «il diritto naturale dell’uomo fin
quando resta definito dalla potenza di ciascuno e resta diritto del singolo, esso
si riduce a nulla, essendo più un’ opinione che una realtà, e non presentando
alcuna garanzia di adempimento»52. Qui Spinoza, giustamente rileva Chianese,
«riafferma quoad rem, per dirla alla scolastica, ciò che aveva già affermato
quoad nomen nel TTP»53, in cui il nostro filosofo così scrive: «la legge che
dipende dalla decisione degli uomini, e che si chiama più propriamente jus, è
quella che essi prescrivono per una vita più comoda e sicura, o per altre cause
[…]»54.
In conclusione,in quanto “cosa naturale”,l’uomo resta sottoposto all’«ordine
comune della Natura».
6. Dal patto sociale allo Stato
24
Da quanto abbiamo fin qui detto emerge che la teoria spinoziana della politica non si inscrive nella linea di Hobbes e Rousseau fino a Kant, perché non è
una teoria del diritto. Il naturalismo di Spinoza fonda sull’identità diritto –potenza una teoria puramente empirica dello Stato. La politica ha un senso in
Spinoza in quanto risposta a problemi antropologici e ontologici. La politica fa
parte di quell’insieme di forze dirette all’acquisizione della felicità.
La società civile è «costruita» in funzione del concetto del diritto naturale,
per cui si impone una organizzazione politica, e ad ogni puntualizzazione del
concetto è inevitabile una caratteristica supplementare. Tutti gli ingranaggi e le
risorse dello Stato sono compresi dall’attualità della loro giustificazione razionale. In tal modo ci si rende conto non solo della teoria dello Stato in Spinoza ma
anche della sua peculiarità: allo stesso modo è discussa e risolta la questione
del ruolo del patto sociale.
Questo problema politico è notorio e rappresenta, per così dire, la sintesi
tra Patto sociale e legittimità. Psicologia, morale e Diritto naturale sono fondanti
la legittimità la cui significazione quindi cambia relativamente alle definizioni di
questi tre termini; la natura dell’uomo, la sua morale, il suo diritto naturale sono
giustificativi del contenuto cognitivo del concetto di legittimità. Al di là di questa
relatività, di questa diversità dei punti di vista, rimane l’unità: lo Stato ha il fine
esclusivo di permettere di conseguire la felicità. Lo Stato di Spinoza supera e
comprende il concetto classico. Non si tratta più di sopravvivere ma di vivere
bene; per far questo occorre vivere secondo la Ragione e la ragione del popolo
SAGGI
non è altro che lo Stato: «sono migliori –scrive Spinoza– tutte quelle azioni che
l’uomo o lo Stato compiono allorché godono al massimo della propria autonomia [...]. Altro, per esempio è coltivare a buon diritto un campo, altro coltivarlo
nel migliore dei modi […]; e per conseguenza, altro è il diritto di comandare e di
amministrare la cosa pubblica, altro è il comandare e il governare alla perfezione»55.
Il segreto della felicità allora «consiste nell’esercizio politico della
Ragione»56.
Possiamo allora ribadire che lo Stato non è una unione di costrizioni, una
società di schiavi, ma una comunità fondata su criteri razionali. E poiché la
società politica implica gerarchia, subordinazione e obbedienza dei governati ai
governanti, si deduce che una sana ragione ci insegna che gli uomini non
dipendono che da se stessi quando sono schiavi delle loro passioni e che la
pace che la ragione ci impone di ricercare non può essere ottenuta che con
l’obbedienza alle leggi dello Stato. Il patto sociale si impone a noi come una
soluzione ad un tempo naturale e razionale, in quanto l’organizzazione politica
stabilisce un ordine sociale che «ogni uomo guidato dalla ragione si sforzerebbe di conseguire allo stato di natura, sia pure senza successo»57. È vero che
l’obbedienza a questa o quella legge può a volte sembrare contraria alla ragione, ma, anche se in principio è comunque una legge della ragione scegliere tra
due mali il minore, successivamente è un fatto che uno Stato scivola verso la
rovina se impone ai cittadini misure irrazionali. La società politica è infatti
«distinta da una comunità di uomini liberi fondata sulla conoscenza di Dio, ma,
del resto, la prima non saprebbe esistere senza la mediazione della
seconda»58. Ciò di cui l’individuo allo stato di natura si disfa è il suo diritto naturale. La conseguenza di ciò è che, secondo Hobbes, l’uomo si trova votato al
sovrano anima e corpo. Per Spinoza è la ragione per la quale l’uomo entra in
società il premio su tutti gli effetti dell’atto con cui si è impegnato. Qui stanno
tutte le sfumature del concetto spinozista del patto sociale, il quale «costituisce
il crogiolo giuridico nel quale sbocca tutto un vasto movimento d’argomenti che
coniuga la psicologia, la sociologia e l’etica, ed in cui parte l’istituzione politica
per antonomasia: lo Stato»59.
Tuttavia esiste in Spinoza il pericolo di dissoluzione dello Stato, soprattutto
nelle prime forme di governo che sono la monarchia e l’aristocrazia. Spesso
infatti non basta la sola ragione per governare bene lo Stato: la condizione
della stabilità e della durata d’uno Stato è l’inviolabilità delle leggi, le quali
«sono –scrive Spinoza– l’anima dello Stato. Quindi, salve queste, è salvo
necessariamente anche lo Stato. Ma le leggi non possono conservarsi inviolate, se non siano difese dalla ragione e dalla comune passione degli uomini»60.
Ecco perché le leggi, se si avvantaggiano del solo apporto della ragione sono
deboli e se ne viene facilmente a capo. Le leggi sono forti se si accordano contemporaneamente con la ragione e con le affezioni comuni. Una buona direzione dello Stato richiede pertanto una conoscenza delle affezioni comuni, e l’uso
d’un insieme di misure destinate a realizzare l’accordo delle passioni dei governanti e dei governati con le prescrizioni della ragione.
Il solo modo di sfuggire a tale immenso pericolo è di istituire uno Stato
25
26
democratico, oggetto dell’ultima parte del Trattato Politico. É la sola organizzazione statale che concilia gli interessi del sovrano e dei soggetti e che conseguentemente assicura anche la continuità dello Stato. Conciliare gli interessi
del sovrano con quelli dei soggetti, e quelli dei soggetti fra di loro, dipende,
insomma, da qualche cosa di più dell’esistenza dello Stato: dipende dalla forma
d’organizzazione presa come base dall’esistenza degli interessi e quindi della
loro soddisfazione; e ciò dipende, ovviamente per Spinoza, dall’esistenza dello
Stato democratico.
Ma quando uno Stato si può dire democratico? Senza distinguere il problema del fondamento dello Stato e quello della forma di governo, Spinoza afferma che la società in cui il patto sociale è sempre rispettato senza portare offesa
al diritto naturale, cioè alla potenza di ciascuno, è uno Stato democratico, in cui
gli individui non trasferiscono il loro potere né ad un altro individuo, né ad alcuni
individui, ma ad un’assemblea generale di tutti gli individui che esercitano un
diritto sovrano su tutto ciò che è in loro potere.
Non che Spinoza neghi l’esistenza del regime monarchico o aristocratico.
La storia ne dà esempi numerosi, dal momento che il regime democratico, nella
purezza della sua essenza, è un regime raro. Ma Spinoza dichiara che se ha
preferito assumere il regime democratico come sistema di riferimento nello studio dei fondamenti dello Stato, è perché sembra essere il regime «più naturale
e il più vicino alla libertà che la natura concede a ciascuno»61.
Tale è dunque la Democrazia spinozista. La formula radicale ed egalitario-unitaria S2 S3 conviene a tutte le istituzioni senza eccezioni. Applicata
dal basso in alto nella Monarchìa ideale (armata, regime della proprietà,
modo di selezione dei dirigenti), dava alle masse popolari una forza invincibile e una coesione monolitica; applicata dall’alto verso il basso nella
Aristocrazia ideale (istituzioni governative, Giustizia, religione), essa dava la
stessa forza e la stessa coesione al potere sovrano; ora, nella Democrazia,
in cui il corpo sovrano si con-fonde col popolo, è normale che essa si impone dappertutto.
Al contrario, la formula T2 T3 applicata dall’alto verso il basso nella
Monarchia non aveva altro obbiettivo che quello di diminuire la capacità di resistenza del re; applicata dal basso verso l’alto nell’Aristocrazia, non aveva altro
obbiettivo che di diminuire la capacità di resistenza della plebe; nella democrazia, in cui non c’è né re né plebe, essa perde ogni ragion d’essere.
Così, lo Stato liberale prende ormai il suo aspetto più compiuto; senza ostacoli da aggirare, senza divisioni da superare, il movimento di salita e di discesa
che caratterizza il suo conatus può ora, in democrazia, svolgersi col massimo
di semplicità e d’armonia62.
Ecco, ora, che ci si aprono nuove prospettive sulla concezione spinozista
della società politica. Ad esempio, come tutti gli autentici pensatori di filosofia
politica, Spinoza sa che l’organizzazione sociale fondata sul patto è, se non il
solo, almeno il primo e necessario ricorso contro la violenza. Ciò che oggi noi
chiamiamo Stato o istituzione è inizialmente la difesa efficace opposta alla violenza di tutti contro tutti (omnium contra omnes), guerra che, certamente, sul
piano meramente naturale non è né buona né cattiva, ma che, sul piano dei
SAGGI
fatti, s’oppone alla stessa esistenza degli individui e dei gruppi a causa della
legge della reversibilità infinita: questo è un principio spinozista.
Ma, mentre i difensori contemporanei dello Stato s’arrestano alla considerazione (classica e, peraltro, indispensabile) della funzione negativa e difensiva
delle istituzioni contrattuali, Spinoza spinge la sua riflessione più lontano e
getta le basi d’una politica positiva della libertà di tutti. Non solo, ma a differenza di certi estremisti di sinistra63 Spinoza non getta il bambino con l’acqua sporca: infatti solo con la mediazione delle istituzioni può essere costituito un regime di vera democrazia.
La democrazia spinozista, infatti, quanto all’istituzione politica è il governo
collegiale, e quanto alla legittimità costituzionale è la forza effettiva della massa
tutta intera64. In quanto Stato, tale democrazia, all’interno, è tutta potenza poiché è il solo fondamento della legittimità delle leggi, e tuttavia esprime e garantisce la libertà di ciascuno in quanto non c’è diritto pubblico se non attraverso il
consenso individuale di diritto o di fatto. Insomma, il fine stesso della democrazia spinozista è, con la sicurezza, la libertà.
7. Spinoza e Machiavelli
È singolare che molti studiosi del Machiavelli, anche dopo l’interpretazione di Spinoza, abbiano insistito a considerare il segretario fiorentino un
“immorale”(!), un “impostore”, un riformatore che avrebbe rotto ogni possibilità di rapporto tra le ragioni politiche e le tendenze intime e spirituali dell’uomo.
È singolare, perché Spinoza colloca Machiavelli tra i “partigiani della libertà”,
che avrebbe messo in guardia un popolo libero contro il pericolo di perdere
tale libertà nel caso della dittatura o nel tentativo di abbatterla65.
È singolare, perché Machiavelli «è il solo grande pensatore politico che
Spinoza cita, e –cosa rara in questo filosofo– conferendogli elogi egli è sapiens,
prudentissimus, accutissimus Florentinus»65bis.
Il fatto è che, come quello dei Greci, l’ideale politico di Spinoza e di
Machiavelli traduce una certa esperienza vissuta delle relazioni sociali, tali quali
dovevano manifestarsi nella vita quotidiana delle poleis greche e dei piccoli
Stati italiani del ’500 e delle città mercantili inglesi del ’600 (così come sarà per
la Ginevra rousseauiana), lontano quindi dai grandi Stati nazionali tali quali s’erano formati all’alba dell’età moderna.
Sono dunque delle piccole repubbliche laboriose che servirono da quadro
alle riflessioni politiche di Machiavelli e di Spinoza, al punto che lo Stato aristocratico, per Spinoza, conta appena 250.000 cittadini.
Sia in Machiavelli che in Spinoza, la libertà pubblica ha rappresentato qualcosa di familiare, un certo stile di vita, prima di divenire un oggetto astratto di
studi teorici.
Tuttavia, Machiavelli guarda con nostalgia l’antica potenza di Roma. Anche
davanti allo sgretolamento d’un’Italia disgregata e in preda dello straniero, egli
27
28
arriva ad invocare con tutto il cuore l’uomo, il Principe, capace di ricostruire,
con la forza se necessario, l’unità esterna del proprio Paese66.
Spinoza, cittadino d’un giovane Stato libero e indipendente, non può rivendicare nulla di simile. Nessuna aspirazione nazionalista, resa più acuta dal ricordo lancinante d’un passato di grandezza, viene ad animare un paese nuovo
come le Province Unite.
L’autore del Trattato Politico è pertanto rimasto l’uomo delle piccole società
a forte coesione interna67, basate sull’azione comune e/o sull’affinità spirituale68.
Per le sue funzioni diplomatiche. Machiavelli possedeva evidentemente
un’esperienza degli affari pubblici che mancava del tutto a Spinoza. Comunque
sia, i due Autori hanno manifestato un eguale interesse per le libertà concrete.
Per l’uno e per l’altro la vera forza dello Stato consiste nella libertà69.
Occorre notare ancora che il loro umanesimo politico si è ispirato alla
medesima fonte: gli storici latini70. Così la loro teoria del governo segue l’impronta delle tradizioni classiche che concernono il problema dello Stato. Come
Platone, Machiavelli e Spinoza si sono rappresentati la successione dei regimi
politici sotto la forma d’un’evoluzione ciclica a tre tempi ed hanno concepito lo
Stato –aristotelicamente– come un essere individuale sottoposto alle leggi della
nascita, della crescita e della morte. Con la differenza che, vissuto più di un
secolo e mezzo dopo Machiavelli, Spinoza ha letto Hobbes (del quale, come è
noto, conservava nella propria Biblioteca il De cive) dal quale avrebbe attinto la
teoria dei tre tipi di governo, che si ritrova egualmente in altri teorici politici a lui
contemporanei, quali il Van Hove71.
Così Machiavelli è presente un po’ dovunque nel Tractatus Politicus ad incominciare dal capitolo primo dove almeno due volte Machiavelli, sia pure in
modo allusivo, è chiamato in causa: «[…] non concepirono mai una politica che
fosse suscettibile di pratica applicazione, ma soltanto costruzioni chimeriche
non realizzabili se non nel Regno di Utopia o in quella poetica età dell’oro nella
quale non erano affatto necessarie»72; passo, questo, che come è stato rilevato
da insigni studiosi, ricorda molto da vicino il cap. XV del Principe,in cui il segretario fiorentino così si esprime: «Ma,sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi
la intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della
cosa, che alla immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e
principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli è
tanto discosto da come si vive a come si doverebbe vivere, che colui che lascia
quello che si fa per quello che si doverebbe fare, impara più tosto la ruina che
la preservazione sua: perché uno uomo, che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni”73. Come si vede,
il principio espresso da Spinoza col termine conatus è presente in Machiavelli
col termine preservazione. Così come è comune ai due Autori la concezione
della separazione tra moralità pubblica e moralità individuale: «Per ciò si è
d’avviso –scrive Spinoza– che in tutte le scienze applicate, ma specialmente
nella politica, la teoria sia diversa dalla pratica e che alla direzione della cosa
pubblica nessuno sia meno adatto dei teorici, vale a dire dei filosofi»74. E
Machiavelli: «Et havvi ad intendere questo, che uno principe, e massime uno
principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali li uomini sono
SAGGI
tenuti buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare contro
alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla relligione»75.
Ciò, anche se Spinoza, a volte, pensa inversamente, ovvero che la moralità
individuale, conseguenza sia dell’autonomia intellettuale, sia della semplicità e
della purezza del cuore, sfugga alla giurisdizione dello Stato. Ciò, perché uno
degli anelli della necessità del “politico” è, qui in Spinoza, d’ordine simbolico; ed
è tale simbolo che si sostituisce ad uno Stato debole; la vera questione, per
risituare il problema nella dinamica del sistema, è allora di sapere se quest’ordine simbolico risponde ad una necessità passionale: si può rispondere positivamente se si supera la visione abituale di Spinoza come positivista giuridico
per il quale, invece, non c’è altra realtà politica che lo Stato, di cui è impossibile
una qualsiasi legittimazione giuridica, sarebbe anche inutile porre una simile
questione. Una teoria dei limiti giuridici dello Stato presupporrebbe inoltre una
teoria della libertà esterna, estranea a Spinoza, il quale non riconosce che la
libertà interna76.
Il problema della libertà resta dunque posto. Meglio: deve essere posto a
proposito di ogni regime, non come problema incondizionato, ma come problema pratico degli effetti del suo funzionamento: «la libertà politica che non poggi
su solide basi non si difende mai senza pericolo»77.
Per esempio, Spinoza insiste sul pericolo di affidare, in un regime aristocratico, delle importanti responsabilità a seconda della loro competenza a funzionari di origine plebea: «I funzionari di qualunque consiglio, e gli altri funzionari
di quel tipo, poiché non hanno diritto di voto, vanno scelti fra i borghesi.
Ma, siccome costoro hanno tratto dalla lunga pratica degli affari un’esperienza utilissima per la loro trattazione, avviene spesso che al loro consiglio si
attribuisca più importanza del dovuto e che la sorte dello Stato intero dipenda in
gran parte dalla loro direttiva: cosa, che riuscì rovinosa agli Olandesi78.
Così, contrariamente a Machiavelli stavolta, Spinoza pensa che il sistema
dei tribuni della plebe, praticato a Roma, non è, in regime aristocratico, un buon
esempio da imitare, non solo in ragione dell’inefficacia pratica e degli abusi dei
tribuni di Roma, ma soprattutto perché il regime aristocratico non si mantiene
più nella sua purezza nel momento in cui si riconosce l’autorità dei tribuni eletti
dalla plebe. Il fatto è che Spinoza ci vuole presentare dei regimi politici coerenti
e non si limita e formularne le basi costituzionali, ma vuole descrivere e descrive di fatto in maniera dettagliata il regime di proprietà, l’organizzazione dell’
esercito, della giustizia ed anche le procedure parlamentari e le modalità di elezione tipiche di ciascuno di essi. Così come in un regime democratico come
quello romano Spinoza prende cum grano salis, come si suol dire, la elezione
di un ditattore la cui “alterigia” rischia di degenerare, con grave pericolo per la
“cosa pubblica” in monarchia79. Machiavelli insiste, al contrario, sugli effetti
benefici della istituzione dittatoriale a Roma e scrive: «[…] non fu il nome né il
grado di Dittatore che facesse serva Roma, ma fu l’autorità presa dai cittadini
per la lunghezza dello imperio; e se in Roma fusse mancato il nome dittatorio
ne avrebbero preso un altro, perché è sono le forze che facilmente si acquistano i nomi, non i nomi le forze. E si vede che ‘l Dittatore, mentre fu dato secondo
gli ordini politici e non per autorità propria, fece sempre bene alla città»80.
29
30
Il fatto è che Roma conobbe all’inizio una monarchia molto poco solida, i cui
soggetti erano estremamente indisciplinati; ne risultò un’Aristocrazia che rimase in piedi per molti anni nonostante numerose e costanti guerre civili, che
–secondo Spinoza– porteranno alla restaurazione della monarchia, sia pure
sotto altro nome 81 l’istituzione dei Dogi a Venezia e a Genova, secondo
Spinoza, sembra testimoniare un ‘evoluzione analoga: queste due Repubbliche
saranno state un tempo delle monarchie: «È chiaro, infatti, che così il governo
si avvicina al monarchico, e, a quanto si può desumere dalla storia di quei
popoli, non per altro motivo essi fecero ciò, se non perché prima dell’istituzione
di questi consigli erano soggetti a un reggente o duce, come fosse stato un
re»82.Sin dal primo momento della assunzione della carica, il doge prestava giuramento davanti ai membri del clero e delle Assemblee di agire sempre conformemente alle leggi dello Stato. Sin dal 1400 si diceva a Venezia che il doge
avesse la maestà d’un re o di un principe, anche se anche nella storia di
Venezia si trovano complotti e trame che spesso non raggiungevano lo scopo
per la sorveglianza del Senato83. Il Senato, tale quale è concepito da Spinoza,
si ispira contemporaneamente agli Stati generali dei Paesi Bassi, composti dai
deputati delle sette province, che provvedevano particolarmente alla politica
estera della federazione, e al Senato di Venezia, composto inizialmente da sessanta membri chiamati Pregagdi, in quanto essi si riunivano su invito del del
doge, distinto dal Gran Consiglio, e le cui competenze si estendevano non solo
alla politica estera, ma soprattutto alla difesa e alla vita economica della
Repubblica. Nello Stato spinoziano le attribuzioni del senato debbono essere
meno estese di quelle del Senato veneziano, e, d’altra parte, essendo del tutto
autonomo dall’assemblea dei patrizi, che corrisponde agli Stati generali, deve
controllare i suoi poteri e confermare le sue decisioni. Il potere esecutivo è
un’emanazione del potere legislativo, perché non si tratta di realizzare un equilibrio tra i poteri, ma di impedire gli abusi dell’assemblea incaricata del potere
esecutivo. Teoria, questa, chiaramente ispirata dal Machiavelli, il quale, ad un
certo punto scrive: «[…]considerando ancora come hanno fatto quelle repubbliche che sono state tenute ben ordinate nel dare l’autorità per lungo tempo,
come davano gli Spartani agli loro Re, e come danno i Viniziani ai loro Duci;
perché si vedrà all’uno e all’altro modo di costoro esser poste guardie che facevano che ei non potevano usare male quell’autorità» 84. Gli Spartani e i
Veneziani avevano, insomma, trovato la soluzione alla domanda classica “Quis
custodiet custodes?”. La funzione dello statolder d’Olanda rappresenta lo stesso pericolo. Se, infatti, considerazioni storiche ed etniche spiegano queste
sopravvivenze, l’esistenza d’un capo è, per Spinoza, incompatibile con l’essenza di un governo aristocratico.
Quanto all’Olanda, infatti, il suo caso è tuttavia marginale e occasionale:
essa non ha mai avuto dei re, «ma soltanto dei Conti (comites), ai quali non fu
mai trasferito il diritto di sovranità. Infatti, le stesse Alte Potenze d’Olanda,
come esse stesse fanno noto in una dichiarazione pubblica al tempo del conte
di Leicester, sempre si riservarono l’autorità di richiamare i conti alle attribuzioni
del loro ufficio, e conservarono sempre il diritto di difendere questa loro autorità
e la libertà dei cittadini, di punire i conti che degeneravano in tiranni e di limitar-
SAGGI
ne l’autorità così che non potessero far nulla se non con la concessione e l’approvazione degli Stati. Da ciò segue che il diritto sovrano appartenne sempre
agli Stati, e l’ultimo conte tentò di usurparlo; per cui non è vero che gli si ribellarono, ma restaurarono invece l’antico loro diritto che avevano quasi completamente perduto»85.
La conseguenza è che, secondo Spinoza,un popolo cresciuto sotto un regime democratico, non muti la sua forma di governo eleggendosi un monarca,
col pericolo di mettere in gioco la “santità” del regime aristo-democratico e il
rispetto dei diritti della plebe, per cui, sulla scorta dell’esperienza veneziana,
d’accordo con Machiavelli, afferma l’opportunità che «il presidente del consiglio
dei sindaci deve essere ogni giorno, con altri dieci o più sindaci, a disposizione
del pubblico, per ascoltarne le rimostranze e le segrete accuse contro i ministri» (86, p. 135) senza tuttavia confondere accusa con calunnia: «quanto le
accuse giovano alle repubbliche –scrive Machiavelli– tanto le calunnie nuocono
[…]. Che se fusse stato in Firenze ordine di accusare i cittadini e punire i calunniatori, non seguivano infiniti scandali che sono seguiti» 87. Evidentemente
Machiavelli non può fare a meno di preoccuparsi dell’educazione politica del
cittadino che ha il diritto/dovere di difendere la libertà dello Stato che poi coincide con la propria libertà. Solo che, mentre Spinoza è, paradossalmente, più
pessimista, Machiavelli, come abbiamo sopra accennato, invece è convinto che
un’istituzione come quella dei Tribuni della plebe a Roma può risultare decisiva
ai fini della salvaguardia della libertà: «Surge adunque questo bene nelle
repubbliche, o per virtù d’un uomo o per virtù d’uno ordine. E quanto a quest’ultimo, gli ordini che ritirarono la Republica romana verso il suo principio furono i
Tribuni della plebe […]»88. Il pensiero di Machiavelli è in altre parole quello di
affidare un tesoro, un deposito, una costituzione a coloro che meno hanno il
desiderio di violarli.
Per esempio, il popolo preposto alla difesa della libertà, non essendo in
condizioni di usurparla rispetto ai patrizi, deve necessariamente averne maggiore cura, e, non potendosene impadronire, deve limitarsi ad impedire che altri
se ne impadroniscano89. Anche Rousseau insisterà sull’importanza dei Tribuni
della plebe a Roma come mezzo di proteggere il popolo contro il governo,
ovvero contro i consigli, il senato e i comizi. Il tribunato degenera in tirannia
solo quando usurpa il potere esecutivo di cui esso dovrebbe essere il moderatore e quando vuol emanare le leggi di cui dovrebbe essere il protettore90.
Spinoza, invece, insiste stranamente sull’inefficacia pratica e sui possibili abusi
dei tribuni di Roma, ma soprattutto sull’idea che non si può mantenere il regime
aristocratico nella sua purezza ammettendo l’autorità dei tribuni eletti dalla
plebe.Ma spinoza non sembra credere nemmeno all’efficacia dei Censori,che
invece vengono esaltati da Machiavelli91 e, ancora, da Rousseau92. Scrive infatti
il nostro filosofo che «questa autorità dei sindaci […] non potrà impedire, invece, l’insinuarsi dei vizi che la legge non può vietare, quali sono quelli ai quali gli
uomini sono portati dall’ozio e ai quali si deve non di rado la rovina dello
Stato»93 (TP, X, 4, pp. 168-169).
Il fatto è che, poco preoccupata dei principi fondamentali della vita sociale,
la politica machiavellica rimane anzitutto un’arte di governare gli uomini. Al con-
31
trario, quella di Spinoza, imperniata sul problema delle origini dello Stato, rimane inseparabile da una filosofia dell’esistenza umana che ci rinvia da se stessa
ad una certa visione del mondo.
Occorre pertanto ribadire la validità del rapporto diretto tra le analisi del
Trattato politico con la critica al principio d’autorità del Trattato teologico/politico e con l’ontologia, da noi appena accennata, dell’ Etica94.
8. Conclusione
32
Tra il 1654 e il 1660 Spinoza sembra aver esposto in latino davanti ad un
uditorio di fortuna (più o meno ben preparato a comprenderlo) le grandi linee
del suo nascente sistema metafisico. È ancora impregnato di una certa filosofia
presa in un pensiero che non ha ancora definitivamente rotto col pensiero teologico. Ed è col favore della sua riflessione metodologica, grazie all’intuizione
del Deus sive natura, che egli è sul punto di rompere col pensiero teologico. Vi
sono, poi, il Breve trattato,in cui il pensiero è ancora teologico,e Il trattato sull’emendazione dell’intelletto che segna la rottura e annuncia un metodo che sarà
dominato nella sua essenza, ed infine l’Etica che ci offre un pensiero padrone
di sé e fermamente deciso a non pensare che la Natura, aurora d’un pensiero
che, dopo essere passato attraverso il positivismo assoluto del XIX secolo
coglierà la maturità nel XX secolo.
Abbiamo un cammino analogo per il pensiero politico. Nel Breve trattato i
problemi della felicità e della libertà sono pensati ancora in una prospettiva teologica. Poi viene la rottura annunciata dal Trattato sull’emendazione dell’intelletto e in eco i primi tredici capitoli del Trattato teologico/politico in cui Spinoza,
come abbiamo visto, si libera del pensiero teologico in una critica di primordine.
Questo lo porta, nel capitolo XVI, alla affermazione dell’ideale democratico e di
una libertà che non dipende ormai che dal solo uomo, idee che inaugurano il
pensiero politico moderno e che saranno riprese nel Trattato politico.
La politica –contrariamente alla tradizione aristotelica che vi vedeva una
forma del sapere pratico il cui oggetto era sprovvisto di necessità e discendenva dal campo del possibile– è determinata, secondo Spinoza, come conoscenza necessaria delle azioni degli uomini, i quali non possono sfuggire alle leggi
naturali. In effetti, non è che per una mancanza di conoscenza secondo
Spinoza, in questo caso come in tutti gli altri, noi consideriamo le cose come
possibili o contingenti. La completa conoscenza delle leggi naturali permette
dunque di escludere che non importa quale azione politica possa, non importa
come sfuggire alla comprensione razionale94. La politica diviene così lo studio
scientifico delle azioni umane, il quale si limita alla loro comprensione, guardandosi dal valutarle o dal giudicarle. Le passioni umane, effettivamente, non sono
né buone né cattive, e come i diversi fenomeni fisici, esse sono determinate
come proprietà appartenenti alla natura.
Il sapere teoretico delle cause reali che determinano le azioni umane lascia
anche posto ad una attitudine tecnica che ha il dovere di riconoscere le condi-
SAGGI
zioni concrete che permettono di organizzare meglio la vita sociale. È il
momento tecnico –produttivo della politica, che si articola fino al momento
puramente speculativo della teoria del diritto naturale, e che persegue l’invenzione delle forme istituzionali che possano assicurare la più grande sicurezza
alla vita pubblica.
È su questa base teorica generale che Spinoza fonda la propria concezione
dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, la critica della monarchia di diritto divino, la
soluzione ai problemi dei rapporti tra gli Stati e della guerra giusta, di cui si trovano abbondanti riferimenti nelle sue opere.
Ecco perché la dottrina spinozista della democrazia si rapporta strettamente
ad una certa concezione filosofica della società umana. Come è noto, per
Spinoza la vita sociale consiste in un contratto. Tuttavia non si è mai –forse–
sufficientemente insistito sul fatto che il patto sociale tale quale è concepito da
Spinoza, implica necessariamente sin dall’inizio l’esistenza d’una eguaglianza
convenzionale tra tutti gli individui che decidono d’abbandonare lo stato di natura per riunirsi sotto una legge comune. La società civile è costruita in funzione
del concetto del diritto naturale per cui si impone un’organizzazione politica e,
ad ogni precisazione del concetto, è inevitabile il sorgere di una caratteristica
supplmentare. Tutte le ruote e le risorse dello Stato si spiegano col fatto della
loro giustificazione razionale. Come si vede, in tal modo si rende giustizia non
solo alla teoria dello Stato di Spinoza, ma anche alla sua peculiarità; cosicché
si trova discussa e risolta la questione del ruolo del patto sociale, nel senso che
psicologia, morale e Diritto naturale sono fondatori della legittimità il cui significato cambia in relazione alle definizioni di questi tre termini; la natura dell’uomo, la sua morale e il Diritto naturale sono giustificativi del contenuto cognitivo
del concetto di legittimità. Al di là di questa relatività, di questa diversità di punti
di vista, resta l’unità: Lo Stato non ha che un obiettivo, quello di permettere di
cogliere la felicità. Lo Stato di Spinoza supera e comprende il concetto classico.
Non si tratta più di sopravvivere ma di vivere bene; per fare ciò occorre vivere
secondo la Ragione, e la Ragione del popolo non è altro che lo Stato.
Il segreto della felicità sta allora nell’«esercizio politico della Ragione» che
conferisce al sovrano un potere assoluto il quale, malgrado uno statuto che non
lo sottomette ad obblighi contrattuali, ha dei poteri limitati.
Ciò di cui l’individuo si disfa allo stato di natura è il suo diritto naturale ,per
cui, secondo Hobbes, si trova votato anima e corpo al sovrano. Per Spinoza
non è così, nel senso che la ragione per la quale l’uomo entra in società domina su tutti gli effetti dell’atto con cui si è impegnato. Infatti il patto sociale costituisce il crogiolo giuridico in cui sbocca tutto un vasto movimento d’argomenti
che coniuga la psicologia, la sociologia e l’etica,e d’onde parte l’istituzione politica per antonomasia: lo Stato.
Così la politica spinozista è irriducibile a tutte le altre correnti, ma soprattutto
al liberalismo che rischia di separare individuo e società; il più vicino a Spinoza
sarebbe piuttosto Hegel, che mette avanti –anche lui– il carattere globale dello
Stato. Così tutto lo sforzo spinoziano per integrare l’irrazionalità come elemento
necessario della realtà politica deve coniugarsi con la costituzione della
Ragione come solo mezzo di rendere possibile la vita politica, almeno nelle sue
33
34
forme superiori; per articolare questi due temi, occorre aver fatto ricorso ad una
specie di “astuzia della Ragione”: gli uomini irrazionali costruiscono, come se
fossero razionali, degli insiemi politici organizzati che in seguito permetteranno
lo sviluppo della razionalità degli individui.
Nello spazio politico così determinato, Spinoza analizza i rapporti tra natura
e società (conatus, stato di natura, società civile, posto del diritto positivo); ne
segue che la teoria generale dello Stato –in cui sarebbe presente una dimensione “olistica”, opposta alla dimensione individualistica dei liberali–95, i tre tipi di
governo, la concezione della libertà ci fanno riflettere sulla dimensione “utopistica” (da cui Spinoza prende, almeno a parole, le distanze nel capitolo I del Libro
Primo) nel senso che la salvezza sta, secondo il Nostro, nella filosofia che è
l’esercizio della Ragione. L’utopia ne mostra i risultati, che supererebbero la più
ragionevole delle congiunzioni d’interessi. Ma la via della salvezza passa attraverso la politica, strumento obbligato di razionalizzazione, che si riferisce
all’Utopia ma tuttavia si costruisce sulla realtà e non sui sogni.
In ogni modo, l’originalità del pensiero politico spinoziano sta nel fatto che il
punto di vista ontologico permette di superare la semplice interazione tra Stato
e individuo, per determinare i processi socionaturali di produzione causale dell’individuo e dello Stato96.
La libertà spinozista allora costituisce una struttura ontologica della natura,
per cui, pensando al rapporto dei generi di conoscenza e dei regimi passionali
sotto l’unità d’un genere di vita, si comprende meglio come si articolino i due
generi, passionale e razionale, dello Stato, poiché tutti gli uomini vivono contemporaneamente nella immaginazione e nella ragione. Lo “Stato assoluto” del
TP non è che il corpo politico la cui stabilità è assicurata particolarmente dalla
formazione di opinioni comunicabili, non esclusive, correlanti il processo di
democratizzazione alla circolazione dell’informazione.
Questo ribadisce il legame intrinseco tra democratizzazione dello Stato e
democratizzazione del sapere, circolazione dell’informazione ed educazione
dei cittadini, e mostra, su questo preciso punto,una prossimità che sarebbe
interessante analizzare più da vicino tra Condorcet e Spinoza.Ma questa analisi
avrebbe una portata metafisica più ampia perché permette di ridurre i dualismi
che un pensiero intellettualistico reinserisce sempre surrettiziamente nell’interpretazione di Spinoza: tra natura e cultura, natura e storia, natura e libertà, individuo e Stato, governanti e governati.
1
B. SPINOZA, Dio Natura Uomo (Pagine scelte dalle opere) a c. di G. CASERTANO, Napoli Firenze, Il Tripode, 1969, p.IX. Sigla: DNU. ll fatto è che Spinoza, negli anni cruciali in cui stava per
rompere con la Sinagoga, viveva –tra l’altro– in un clima Messianico e Millennarista, circondato da
persone che preparavano attivamente la prima o la seconda venuta del Messia.
2
Cfr. La Lettera 56 di Spinoza a Boxel, in SPINOZA, Epistolario a c. di A. DROETTO, Torino,
Einaudi, 1974, p. 31, e ancora la editio definitiva delle opere complete di Spinoza a c. di C.
GEBHARDT, Heidelberger Akademie Wissenschaften,1925, pp. 1247-1248.
3
De legibus, III, 12, 38. Si possono ancora reperire riferimenti più o meno espliciti a TERENZIO,
SAGGI
TACITO e SENECA che percorrono tutti i testi di Spinoza che evidenzia così un interesse “umanistico”
per i temi greco-latini che integra nel suo sitema modificandone e capovolgendone l’uso tradizionale.
4
Lettera 56, in C. GEBHARDT, op. cit., p. 1247.
5
Cfr.Tractatus theologico-politicus, tr. it. a c. di E. GIANCOTTI BOSCHERINI e A. DROETTO, Torino,
Einaudi, 1964 (2^ ed.), p.176. Sigla: TTP.
6
Cfr: F. MIGNINI, Introduzione a Spinoza, Laterza,1990, p. 89
6bis
Cfr. tra gli altri T. SERRA, L’autonomia del politico, Facoltà di Scienze Politiche, Teramo, 1984.
7
B. SPINOZA, Dio Natura Uomo, cit., pp. 111-112
8
Ivi, pp. 127-128.
9
Ivi, p. 119
10
Cfr. R. MISRAHI, Spinoza, Paris, 1964. “Schiavo è colui –commenta Casertano in una esegèsi,
a dir poco, pre-kantiana– che subisce le leggi in quanto non è riuscito a sollevarsi dal suo chiuso
individualismo ed egoismo alla razionalità di esser: libero invece chi vi obbedisce in piena libertà,
riconoscendo nella razionalità delle leggi l’espressione della propria razionalità, cosicché obbedendo alle leggi obbedisce a se tesso” (DNU, p.119, n13; cfr. pure TTP, cap. VI, pp.150 e 157)
11
«La regola universale d’interpretazione della Scrittura è –scrive Spinoza– di non attribuirle
nessun insegnamento che non risulti massimamente chiaro dalla sua stessa storia. Quale debba
essere poi questa storia e che cosa principalmente debba narrare, è qui il luogo di mostrare”
(DNU,pp.119-20).
12
Cfr. G. CAPANA, Presentazione del “Trattato Teologico-Politico” di B. Spinoza, in «Per la filosofia -Filosofia e insegnamento», A. II, n. 4, Maggio-Agosto 1985, p. 81. Sigla: GC.
13
DNU, p.116 e TTP, p. 93
14
Ibid.
15
TTP, pp.123 e ss.
16
Ezechiele, 5, 7-8, in La Sacra Bibbia, a c. della C.E.I., Moncalieri 1976, p.866.
17
Deuteronomio, 31, 26-27, in Op. cit., p. 181.
18
Spinoza non adopera indifferentemente i termini “ Giudei”, “Ebrei”, “Israeliti ”. Il termine
“Giudei” è il più generale e, con la sfumatura peggiorativa che occorre riconosere al XVII secolo,
Spinoza lo usa per distinguere i Giudei dai Gentili; “Ebrei” è sempre adoperato in relazione diretta
o indiretta con la istituzione dello Stato e l’esistenza passata o possibile d’una comunità politica;
”Israeliti” è adoperato quando c’è un rapporto dei Giudei con Dio che è in parola (indipendentemente dalla funzione politica del giudaismo primitivo)
19
TTP, cap. XVII, pp. 227-229
20
G. BRYKMAN, La judéité de Spinoza, Paris, 1972, chap.III, le refus de soi.
21
TTP, pp. 48-49
22
Ivi, p. 69
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Cfr. Esodo, 33,3, in La Sacra Bibbia, cit., p. 77
26
Deuteronomio 9, 1-6, in op. cit., pp. 161-162
27
B. SPINOZA, TTP, cap. XVII, in La libertà di pensiero, a c. di A. DEVIZZI, Milano, U.EC, 1949, p.
62
28
DNU, cit., p. 120 e TTP, Torino, Einaudi, cit., pp. 99-101.
29
G. De RUGGIERO, L’età cartesiana, Bari, Laterza,1958, p. 246, ripreso anche in DNU, p. 120,
nota14 .
30
B. SPINOZA, Tractatus de intellectus emendatione, V I 24, cfr. DNU, p. 63. Il tema del conatus
è il passaggio obbligato dalla fisica galileana alla fisica newtoniana e trova il suo punto di riferimento più interessante nel De corpore di Hobbes (che pur essendo stato pubblicato nel 1655, circolava
già in manoscritto sin dal 1640, nella seconda redazione dell ’Etica di Spinoza(1671-1672) e
nell’Ipotesi di una nuova fisica, prima parte della leibniziana Teoria del movimento astratto (1671).
31
Cfr. B. SPINOZA, Etica, III, propp. 6 e 7, a c. E. GIANCOTTI, Roma, Editori Riuniti, 1988, pp. 178179; sigla: ET.
32
Op. cit., III, prop. 8, p. 179.
33
Ne consegue, come Spinoza potette osservare o sentirlo dire nel 1665, che non importa
quale gruppo umano o individuo possa vantarsi d’essere eletto.
35
36
34
È da notare che Spinoza, esponendo la teoria cartesiana del movimento e dell’inerzia nella
Secunda pars Renati Des Cartes Principiorum philosophiae More Geometrico demonstrata, adopera la parola momento, invece della parola istante.
35
DNU, pp. 125-126
36
Op. cit., p. 126. Nasce allora una “volontà comune”, che, appunto perché riunisce tutte le
forze degli individui, è capace di fissare il legittimo e l’illegittimo, il giusto e l’ingiusto. La storia dello
Stato degli Ebrei è, come abbiamo visto, un esempio del passaggio dallo stato di natura allo stato
sociale e nella misura in cui si delimitano i poteri in seno alla società.
37
Leviathan, I, XIV, p. 6638. È presente, ad esempio, secondo lo studio di A. MATHERON
(Individu et communaute chez Spinoza, Paris, Les éditions du Minuit, 1988, p. 295, nota 22), nel §
4, cap. VI; nel § 5 del cap. VII, e nel § 3 del cap. VIII, mentre è assente dal cap. II.
39
Cfr. G. GURVITCH, La Philosophie du Droit de Hugo Grotius et la théorie moderne du Droit
international, in “Revue de Mèthaphysique et de Morale, n° 3, Juil.-Sept. 1927, p. 368.
40
Questo aspetto sarà messo in particolare evidenza nel primo Ottocento dal nostro P. Galluppi
che insisterà, appunto, sul carattere naturale del diritto sociale: «L’uomo nasce nella società: egli si
perfeziona nella società, e dee consacrarsi al bene della società. La società è uno stato naturale
dell’uomo, non mica uno stato arbitrario, ed accidentale. Le persone sono gli elementi delle società
domestiche. Le società domestiche sono gli elementi delle società civili. Le società civili sono gli
elementi della società universale del genere umano» (Cfr.P. GALLUPPI, Elementi di filosofia, Napoli,
Tramater, 1846, 5 voll., II, p. 394; cfr. pure le edd. del 1820-27, del1832. Cfr. anche Il nostro saggio
Il rispetto dei patti. Saggio sul pensiero giuspolitico di Pasquale Galluppi, con Prefazione di A.
VERRI, Vibo Valentia, Mapograf, 1995, p. 63 e sg.)
41
In effetti, per Galluppi lo stato di natura è solo una precedenza ideale di fronte allo Stato, ma
sostanzialmente l’uomo è un “animale sociale”. Si legge infatti che “il sovrano è un elemento necessario della civil società” (Op. cit., p. 399)
41bis
B. SPINOZA, Trattato Politico, a cura di L. CHIANESE, Roma, Nuova Edizioni del Gallo, 1991,
p. 16, sigla: TP. “La formula spinoziana del diritto come potenza –scrive il curatore– sanava sul
piano giuridico il dissidio che Machiavelli aveva denunciato tra la politica e la morale e che i moralisti, per salvare ad ogni costo i loro dogmi, cercavano di comporre con lo scandaloso ripiego del
probabilismo casuistico” (Op. cit., s.l., nota 2).
42
“Per realtà e perfezione, dice Spinoza, intendo la stessa cosa” (Etica, Parte II, Def. VI, ed.
cit., p. 124; cfr. pure la nota 5 a p. 367 in cui la curatrice mostra gli antecedenti scolastici e cartesiani del concetto di perfezione cui si ispira Spinoza.
43
T TP, cap. XVI in La libertà di pensiero, cit., pp. 34-35 e ss.
44
TP, II, 6, in ed. cit., p. 18
45
TTP, cap. XVI, cit.; cfr. supra nota 35.
46
Ethica, IV, prop. LXXXIII: «L’uomo che è guidato da ragione è più libero nello Stato, dove vive
secondo un decreto comune, che nella solitudine, che nella solitudine, dove obbedisce soltanto se
stesso» (in Et., ed. cit., p. 282).
47
Ivi, p. 284.
48
TTP, cap. XVI, p. 194
49
Et., parte IV, Scolio XVIII, p. 245
50
Ivi, p.246
51
DNU,p.127
52
TP, pp. 23-24
53
Ivi, p. 24 nota 1.
54
DNU, p.117
55
TP., V, 1, p. 56
56
Cfr. A. H. ANDUJAR, La teoria del Estado de Spinoza. Universidad de Sevilla,1989, p. 44
57
TP, III, 6, p. 37
58
Cfr. S. ZAC, Societé et communion chez Spinoza, “Revue de Métaphysique et et de Morale”,
nn. 2-3, 1958
59
A. H. ANDUJAR, Op. cit., p. 45.
60
TP, X, 9. pp. 171-172
61
TTP. cap. XVI, in Devizzi, op. cit., p. 39
62
A. MATHERON, op.cit., pp. 501-502 e ss.
SAGGI
63
Spinoza denuncia le tentazioni di presa individuale e non legittima del potere (TP, cap. III, 8,
p. 39).
64
TP. III, 2: «[…] risulta evidente che il diritto di sovranità o dei sommi poteri non è altro che il
diritto naturale determinato dalla potenza, non già dei singoli, ma della massa, che viene guidata
come da una mente sola» (Op. cit., p. 34)
65
Scrive Spinoza infatti: «Di quali mezzi debba servirsi per fondare e mantenere il suo Stato un
principe mosso esclusivamente dalla sete di dominio, lo spiegò esaurientemente l’acutissimo
Machiavelli […]. Inoltre egli ebbe forse intenzione di dimostrare quanto un popolo libero debba
stare attento di non affidare in modo assoluto la propria sorte ad un uomo solo […]; egli fu un partigiano della libertà,per la salvaguardia della quale suggerì anche salutari consigli» (TP, V, 7, in ed.
cit., pp. 59-60). Cfr. pure la nota 7 a pag. 59 in cui il Curatore parla del carattere democratico del
pensiero di Machiavelli evidenziato, oltre allo Spinoza, da altri estimatori tra cui Alberico Gentili e il
Bruder.
66
Scrive infatti Machiavelli: «Non si debba, adunque, lasciare passare questa occasione, acciò
che l’ Italia, dopo tanto tempo, vegga uno suo redentore[…]. A ognuno puzza questo barbaro dominio.Pigli, a dunque, la illustre casa vostra questo assunto, con quello animo e con quella speranza
che si pigliano le cose iuste» (Cfr. Exortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris
vindicandam, Cap. XXVI de Il Principe di N. Machiavelli, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 105)
67
Spinoza indica la sua città come modello di libera Repubblica: «La città di Amsterdam sia d’esempio: essa fa esperienza dei frutti di questa libertà con grande suo vantaggio e con grande
ammirazione di tutte le nazioni. Infatti in questa fiorentissima repubblica e città eminentissima vivono uomini di ogni nazionalità e confessione religiosa nella più grande concordia» (Cfr. TTP, cap.
XX, in DEVIZZI, op. cit., p. 92).
68
Questa inclinazione dello spirito comunitario resta uno dei tratti distintivi della personalità di
Spinoza, derivatagli dalla frequentazione della Comunità giudea di Amsterdam. Nonostante fosse
isolato, soprattutto dopo l’espulsione dalla Sinagoga, Spinoza seppe creare intorno a sé una piccola cerchia di amici e di estimatori.
69
Cfr. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, in op. cit., II, 2, p. 280: «[…] si
vede per esperienza le cittadi non avere mai ampliato né di dominio né di ricchezza se non mentre
sono state in libertà»; Spinoza, TP, cit., II, 7, p. 19: «La libertà è infatti una virtù, cioè una perfezione».
70
Per Machiavelli ciò è noto, quanto a Spinoza, Tacito, Sallustio, Curzio, Cicerone, figurano nell’inventario della sua Biblioteca (Cfr. TP, cit., alla p.181).
71
Di questo scrittore politico Spinoza conservava nella propria Biblioteca le Consideratien van
Staat, ofte Politike Weegschaal, J Vinkel, Amsterdam 1662: egli lo definisce “prudentissimus Belga
V.H.” nel Tractatus Politicus, VIII, 31 su cui cfr.TP, cit., p. 139 e nota 6. A questo scrittore Spinoza si
ispira pure per le varie citazioni latine di Tacito e di altri Autori, i cui nomi, nel testo del Tractatus,
eccetto Cicerone, non riporta quasi mai.
72
TP, I, 1, p. 6
73
Il Principe, cit., p. 65
74
TP, I, 1, pp. 6-7
75
Il Principe, cit., cap. XVIII, p. 73
76
Cfr. in proposito G. GEISMANN,Spinoza jenseits Hobbes und Rousseau, in “Zeitschrift für philosophische Forschung”, 43, 3, pp. 429-430.
77
TP, VIII, 44, p. 148
78
In questo brano Spinoza pensa inizialmente soprattutto a Oldenbarneveldt e a de Witt, i quali,
senza essere dei plebei (o borghesi), non erano neanche appartenenti alla vecchia nobiltà, e per
quanto fossero Grandi Pensionari d’Olanda, nelle assemblee non avevano diritto di voto. Alla fine
del brano, poi, egli allude al 1672, anno in cui Luigi XIV mosse guerra ai Paesi Bassi che avevano
l’esercito in una scandalosa situazione di impreparazione; la qualcosa spiega in seguito il famoso
colpo di Stato degli Orangisti.
79
TP, X, 1, pp. 166-167.
80
N. MACHIAVELLI, I Discorsi sopra…, cit., I, 34, pp. 209-210
81
TTP, cap. XVIII, in DEVIZZI, op. cit., p. 73
82
TP, VIII, 18, ed. cit., pp. 128-129
83
Op. cit., VIII, 29, pp. 135-136
37
cfr. N. MACHIAVELLI, I Discorsi, cit., L. I, cap, XXXV, p. 213.
TTP, cap. XVIII, in DEVIZZI, cit., p. 73
86
TP, VIII, 28, pp. 134-135.
87
N. MACHIAVELLI, Discorsi, cit., L.I,cap.8,pp.151-152
88
Ivi, p. 381
89
Ivi, pp. 275-276
90
«Questo corpo che chiamerò tribunato –scrive Rousseau– è il conservatore delle leggi e del
potere legislativo […]. Il tribunato non è una parte costitutiva dello Stato e non deve avere alcuna
parte della potestà legislativa né dell’esecutiva: ma in ciò appunto la sua parte è più grande; perché, non potendo far nulla, può impedire tutto. È più sacro e più riverito, come difensore delle leggi,
che non il principe che le eseguisce e il sovrano che le dà. Ciò si vide ben chiaro a Roma, quando
quei fieri patrizi, che disprezzarono sempre il popolo intero, furono costretti a piegare dinanzi ad un
semplice ufficiale del popolo, che non aveva né auspici né giurisdizione. Il tribunato, saggiamente
temperato, è il più fermo appoggio di una buona costituzione» (cfr. Il Contratto sociale, in Opere, a
c. P. ROSSI, Firenze, Sansoni, 1972, pp. 335-336)
91
Scrive Machiavelli: «I Censori venivano contro all’ambizione e all’insolenzia degli uomini.I
quali ordini hanno bisogno di esser fatti vivi dalla virtù d’un cittadino…» (Discorsi,cit., p. 381)
92
«La censura –scrive Rousseau– mantiene i costumi, impedendo alle opinioni di corrompersi,
conservando la loro rettitudine con savie applicazioni, talvolta anche fissandole quando siano ancora incerte» (Il contratto sociale, cit., L. IV, cap. VII, p. 338).
93
TP, X, 4, pp. 168-169
94
Cfr. PREPOSIET,op.cit., pp. 220-224 e note.
94bis
C. PACCHIANI, Spinoza tra teologia e politica, Padova, Aldo Francisci Ed., 1979, pp. 61-62
95
Cfr. J. PEÑA ETCHEVARRIA, La Filosofia politica de Espinosa, Universidad de Valladolid,1989, p.
431.
96
Cfr. R. BORDOLI, Spinoza nella critica francese contemporanea, in “Critica marxista”, 6, 1989,
pp. 115-151.
84
85
38
AUGUSTO DEL NOCE DI FRONTE AL MARXISMO.
LA LETTURA DI ANTONIO GRAMSCI.*
1. Il moderno; ovvero pensiero e politica.
Descartes e Machiavelli
Il rapporto fra Augusto Del Noce e il marxismo, è stato più volte analizzato,
anche perchè ha certamente rappresentato una delle esperienze più dense di
contenuti e problemi, nell’arco dell’intero dibattito politico-filosofico sul
Novecento italiano1. Cercherò non già di ripercorrere tale rapporto nella sua
interezza, nè di attraversarlo in tutto il suo spessore. Il marxismo qui ci interessa in quanto premessa, segmento teorico preliminare, alla successiva lettura
che Del Noce fa degli scritti di Antonio Gramsci. Questa, d’altro canto, non
sarebbe interpretabile senza mettere a punto alcuni elementi della critica che il
nostro autore rivolge al marxismo, soprattutto in riferimento al nesso pensieropolitica, così fortemente influenzato dai risvolti pratici della filosofia di Marx.
È parere consolidato che la produzione teorica di Del Noce non risenta
immediatamente delle suggestioni dell’impegno politico militante. Egli, quindi,
giustamente non viene considerato alla stregua di un protagonista di ‘battaglie’
politiche, o di schieramenti banalmente ideologici. Tutta la sua produzione intellettuale, insomma, non può essere ricondotta a esigenze di ‘frontiera’, anche se
essa ha dato vita a frequenti interventi di stampo giornalistico e ad appassionate manifestazioni di punti di vista non certo solo testimoniali. Tuttavia, la sua
sensibilità, attentissima alle questioni di ‘ordinamento’ del mondo e di scelta dei
valori, è carica di contenuti più ampiamente politici. Pertanto, pensiero e politica, evitando di esaurire sbrigativamente questa sintesi nel suo precipitato ideologico e, perciò, più facilmente falsificabile, rappresentano le due grandi sponde
fra cui scorre l’esperienza morale di Augusto Del Noce. I due termini, infatti,
stabiliscono un campo teorico che nel nostro autore getta le sue radici all’esordio stesso del moderno, fra crisi della filosofia rinascimentale e innovazione del
razionalismo cartesiano2.
Anche il tema del moderno, molto dibattuto nella letteratura su Del Noce, è
ricco di collegamenti con l’interpretazione del marxismo e con le passioni della
politica. In questa sede, non potendo concedermi il dovuto spazio sull’argomento, dirò solo che in ultima istanza, nella lettura di Del Noce, la modernità consiste certo nella grande trasformazione indotta dalla secolarizzazione, ma quest’ultima segue da presso una modificazione più radicale, più penetrante. Essa
è collocabile all’altezza dell’età rinascimentale e della sua crisi, all’altezza della
relazione fra pensiero e politica che, dal XVI secolo in poi, assume forme inedite e difficili da analizzare. Tali forme, tuttavia, non sfuggono a Del Noce, il
SAGGI
di Silvio Suppa
39
40
quale anzi le colloca alla radice di un rapporto indissolubile fra carattere totale,
perchè scientifico, della ragione, e carattere forte, anch’esso perchè scientifico,
della politica.
Già la lettura di Descartes genera nel nostro autore un’ idea precisa, una
definizione netta della politica; anche l’interpretazione di Gramsci risentirà della
rapporto fra pensiero e politica, per come Del Noce lo desume dalla lezione
tardo-rinascimentale e dalla sofferta relazione fra azione e ragione. Per altro
verso, nel celebre Cartesio e la politica3 affiora una sensibilità alla politica, una
capacità di percepire la dimensione dell’ ‘intervento’ nell’esperienza teorica, tale
da connotare irreversibilmente tutto il senso della produzione intellettuale delnociana. A trenta anni di distanza da quel saggio, negli anni ‘80, l’esordio del
razionalismo moderno è, per Del Noce, ancora una vicenda leggibile dentro
paradigmi esplicitamente ispirati ad una nozione ampia di politica: chi è “l’avversario di Descartes?”, egli si chiede infatti in una voce dell’Enciclopedia filosofica, analizzando il tormentato rapporto fra il filosofo di La Haye e il libertinismo4. Contemporaneamente, il pensiero cartesiano per Del Noce è “filosofia
della libertà”5, ma in un senso quasi negativo, o almeno problematico, avendo,
quel pensiero, fondato una condizione di indipendenza dal mondo, propria del
soggetto-cogito, il cui divenire critico è anche disimpegno dal dato dell’esistente. Ma al di là di questo profilo di critica filosofica, già nel Cartesio degli anni ‘50
si è delineata la strada della politica. Anzi, qui la politica appare nella sua piena
e autonoma funzione, ricondotta in una compiuta definizione dell’agire umano.
Infine, la politica irrompe come livello alto del pensiero, per effetto di una contrapposizione geometrica e totale: da una parte, vi è l’isolamento autoreferenziale della verità del soggetto; qui si conferma il tema della libertà-distacco,
della libertà-disimpegno di Descartes; si evidenzia, insomma, la radice filosofica di un soggetto tendente ad essere potenza a sè. Dall’altra parte, si pone la
tecnicizzazione machiavelliana della politica: la sua tecnica-artificio si attesta,
nel moderno, come paradigma indelebile di una più ampia frattura storica fra la
pratica (o azione politica), e le “altre forme della vita spirituale”6. In tal modo,
per Del Noce il moderno si dischiude già condizionato da una scissione, che è
anche una perdita, una dissipazione. A suo parere, infatti, la collocazione lontana di soggetto (cogito cartesiano) e politica, pur segno di un’innovazione, comporta comunque una crisi, la quale dipende dai due movimenti, analoghi e
distinti, della ragione individuale e di quella dello Stato.
In che consiste tale antagonistica analogia? Nel fatto che entrambi i termini,
individuo e Stato, tendono a costituirsi in una reciproca lontananza. Il primo con Descartes- affiora quale protagonista di un pensiero tautologicamente
ridotto ad autospeculazione, a movimento autoproduttivo, fino ai limiti dell’arbitrarietà. Il secondo termine, lo Stato, si costituisce invece -con Machiavelli- nel
codice della tecnica, riletta come ordine senza valori, o ordine senza deontologia. Il significato problematico del moderno, che è nella sua forza di scissione,
si condensa così, per Del Noce, nei suoi due momenti di massima intensità
produttiva: la politica e il pensiero. Fra di loro vi è una relazione tanto simmetrica, quanto incapace di procedere oltre la reciproca e opposta parzialità.
Razionalizzazione tecnica della politica e razionalità del pensiero, orfane di un
SAGGI
senso dell’eterno volontariamente smarrito, impongono nel loro spazio la
necessità di riaprire la questione della rilegittimazione morale del mondano, che
è poi, nel linguaggio di Del Noce, la critica della storia.
Nel saggio del ‘50, pertanto, il nostro filosofo afferma che è “conforme alla
natura del machiavellismo che la sua influenza si eserciti sotto la forma di pressione di una realtà che esso misura […] La dissociazione della vita spirituale da
un mondo politico che appare senza verità è il corrispettivo nel singolo di questa vittoria del machiavellismo; è quella solitudine che esso genera inevitabilmente”7. Egli denuncia, così, l’inversione fra profilo teorico e profilo pratico della
politica; egli denuncia, cioè, l’autonomizzarsi dello scopo pratico, machiavellicamente non visibile dentro la forma teorica che ha assunto. Ma anche la concentrazione cartesiana di soggetto e pensiero, ancora nel 1982, conferma in Del
Noce perplessità e delusione, soprattutto considerando l’esito di quella concentrazione, che a giudizio del filosofo, nell’opera ultima di Descartes non va oltre
l’abbandono del “méditatif”, a favore di una pratica ridotta a ““maîtrise” di sé e
del mondo”8.
2. Pensiero e politica;
ovvero il marxismo, nuova forma del moderno
L’incontro con il marxismo, più volte riproposto nell’opera delnociana9, rinnova e conferma l’idea di una modernità fortemente condizionata dall’irrisolto problema del rapporto fra politica e filosofia. Ma qui sono capovolti i termini rispetto
alla coppia Descartes-Machiavelli. Ora si tratta, per Del Noce, di apprestare
una risposta alla concentrazione di politica e pensiero per come Marx la ripropone, in chiave di prevalenza delle ragioni dell’azione su quelle della filosofia;
in chiave, dunque, di filosofia dell’azione. Infatti la ragione cartesiana, nel suo
isolamento, in Marx si è riproposta sotto il sembiante di un hegelismo disarmato; la mera tecnica machiavelliana, invece, si è trasformata nel dominio sans
phrase. Contro questa scissione, il filosofo di Treviri, agli occhi di Del Noce,
introduce una nozione radicale di “ragione scientifica”, sposando “galileismo
morale” e scienza politica dentro una visione dell’esistenza, letteralmente
dipendente dalla prepotenza dell’effettività e della contrazione dell’uomo dentro
la sua opera politica ed economica, o “pratico-sensibile”, dice Del Noce10. “Una
simile caratteristica –egli prosegue– importerebbe […] che il marxismo non
possa direttamente pronunciarsi sui problemi ontologici. Di fatto invece Marx,
seguito sino a oggi da tutto il marxismo autentico, da Engels a Stalin, ha inteso
la tesi della verifica nella prassi e della reciprocità di teoria e prassi come equivalenti, che […] l’uomo è soltanto e senza residuo nell’opera, che non è niente
prima del suo agire […]. Ha cioè ontologizzato la ragione scientifica nella ragione scientifica assoluta”11. In altre parole, Marx ha optato per un giudizio storico
basato sull’effettività; si è così sottratta all’uomo l’intera dimensione della vita
che resta fuori dall’azione e dall’esito ad essa congiunto, (“interiorità e intenzione”)12. Esiste insomma un oggi, un presente, per l’uomo, e forse anche un
41
42
tempo del futuro, grazie alla risorsa del ‘progetto’. Ma, venendo a mancare in
Marx il tempo e il valore che preludono all’azione, venendo insomma tutta la
ragione (per ripensare a Cartesio), assorbita nella tecnica, (per ripensare a
Machiavelli), resta completamente preclusa, per Del Noce, la possibilità di unificare il passato con il futuro, il valore con l’azione, l’eterno con il contingente, la
tradizione con il progresso. Ecco dunque, nel marxismo, la nuova forma della
dissipazione, avviata dal nesso fra razionalismo moderno e prassi politica autonomizzata.
Il pensiero di Del Noce è partito dalla critica della modernità e da una rinnovata esigenza di senso dell’eterno; ma ora rimprovera al marxismo una sua intima contraddizione e manifesta quasi una sorta di sfiducia di conseguire il mutamento reale, muovendo dall’ossessiva necessità dell’agire, quale molla del
divenire: “Ma la riduzione della ragione marxista a semplice ragione scientifica egli dice- non sembra significare affermazione della “naturalità filosofica” del
marxismo? E affermare questo non è anche smorzarne lo spirito rivoluzionario?
Si può ancora parlare di rivoluzione quando questa non attinge “i valori”? Si
dovrà pensare che il marxismo abbia di mira soltanto una trasformazione economica in un ordine di valori dato, o comunque non posto da esso direttamente
in discussione? Si arriverebbe allora a questa conclusione: che il comunismo
dovrebbe vedere nella rivoluzione soltanto un “ritmo accelerato” dell’ evoluzione”13. Se la rivoluzione è un’esperienza contraddittoria, nel modello scientifico
della razionalità marxiana della politica, il primo nucleo della vocazione al suicidio della rivoluzione medesima, è già scritto dentro l’impianto originario della
filosofia di Marx. Quest’ultima, alla verifica di Del Noce e dei suoi criteri di valore, appare al di sotto delle possibilità di libertà consentite da un recupero positivo della metafisica. Non si tratta dunque di una semplice contrapposizione fra
mondanità ed eternità: il problema è più sottile, e tende a rimuovere ogni possibilità di equazione fra valore, e azione purchè sia. In ciò, il nostro autore rivendica, nelle sue categorie filosofiche, l’esigenza di una moltiplicazione dei livelli
del giudizio, negando che ogni innovazione, che ogni azione, che ogni politica,
insomma, sia anche costruzione.
Il nodo del problema che Del Noce solleva, sta nel fatto che in Marx effettivamente si sovrappongono due strati differenti di pensiero: entrambi quasi diafani e trasparenti, essi perdono in questa sovrapposizione la specificità dei loro
profili, così da intrecciarsi in una confusione del pensare con l’agire. Ma non si
tratta per Del Noce di una confusione ‘neutra’ o omogenea, nè di una generica
sottolineatura dell’indole intellettuale di ogni linea consapevole di azione. In
quella confusione assume maggiore importanza la dimensione del fare, della
prassi, a cui si piega ogni altro valore, dal pensiero alla morale. Al fondo di questo processo, Del Noce denuncia un contemporaneo levarsi di due autonomizzazioni: da una parte esiste, poco più che un retaggio, la ragione, quasi neutralizzata in uno sterile movimento autoriproduttivo, metafora impoverita della
“volpe” machiavelliana. Dall’altro lato si pone la politica, vera nuova forza attiva,
“leone” capace di costringere il pensiero alle motivazioni della prassi. La ragione cartesiana autoreferenziata, originario fulcro del moderno, per Del Noce è
soppiantata, in Marx, da uno spirito galileiano proiettato verso l’azione e desti-
SAGGI
nato a dettare un’inedita nomenclatura della razionalità. Conseguentemente, al
paradima machiavelliano della politica, anch’esso segnato da autoreferenza, il
marxismo sostituisce se stesso, costituitosi in scienza politica e in “prassi politica”14.
Mi sembra decisivo questo passaggio, per rileggere correttamente le pagine che il nostro filosofo dedica a Gramsci. Lo sviluppo parallelo e separato di
ragione e politica in apertura del moderno, poneva Descartes in una condizione
di privilegio, essendo egli, per Del Noce, il pensiero pensante, di fronte all’ asettica tecnica della politica di Machiavelli. Vi era dunque, nel cartesianismo antirinascimentale, una gerarchia dello spirito, pur lacerato: dal pensiero, al conflitto;
questo è il suo movimento. Con Marx, come già accennavo in precedenza, l’ordine è invertito, a giudizio di Del Noce, proprio grazie ad una forzatura di quella
separazione cristiana-occidentale fra morale e politica, che è tipica di
Machiavelli. In La “non-filosofia” di Marx, del ‘47, viene formulata, infatti, una
considerazione grave e, al tempo stesso, terribilmente problematica: “[…] il
machiavellismo –scrive Del Noce– separa morale da politica, proprio perchè in
esso permane l’antropologia cristiana; viceversa Marx riconcilia morale e politica proprio per la sua negazione di questa antropologia (si pensi alla celebre
frase di Lenin: moralità è ciò che serve alla rivoluzione proletaria)”15. La trasfigurazione del marxismo in scienza politica -una sorta di equazione ‘marxismo, e
perciò, scienza politica’- ha così occupato l’intero campo dello spirito, sul piano
della pratica, su quello dell’etica, e su quello della verità, essendo esso la fonte
del valore. Ecco perchè nella gerarchia dello spirito, con Marx, il conflitto ora
prevale sulla ragione, risucchiando il rapporto fra Descartes e Machiavelli nella
dilatazione sconfinata e totale del secondo, in confronto al primo; anzi nel simulacro di Machiavelli, profondamente alterato dalla trasfigurazione marxista.
Infatti “[…] la rivoluzione marxista –conclude Del Noce– ha segnato la fine del
machiavellismo. Machiavelli non serve più per spiegare la politica dal ‘17 ad
oggi, proprio perchè in Machiavelli c’è la politica e non l’etica della durezza e
tra le due posizioni non c’è continuità, ma salto”16.
L’argomento definisce in modo drammatico, all’indomani del secondo conflitto mondiale, i nuovi termini della relazione fra pensiero e politica.
Profeticamente, questa relazione racchiude in se tutta la motivazione della futura divisione del mondo: essa, forse, non è ancora visibilmente concreta, nel ‘47,
ma è già sanzionata, prima ancora che dagli eserciti, proprio dalla barriera della
politica eticizzata, dal suo scopo mondano, ma teologizzato. E persino un’
importante riflessione, che non svilupperò in questa sede, verrà da Del Noce in
ordine al disorientamento che un simile statuto etico del conflitto getta fra i “cristiani di sinistra”, come egli li definisce. Essi sono così attratti dalla tentazione
di leggere la politica nella chiave dei fini superiori e vincolanti moralmente, che
la codificano in una torsione religiosa, dunque impropria e pericolosa, dell’impegno mondano17. È inoltre il caso di aggiungere che la “non-filosofia” di Marx, si
profila in del Noce, in tutto il suo significato di negatività, almeno per due ragioni.
In primo luogo, questa non-filosofia si prospetta come l’esito finale di un processo tutto inscritto nella modernità, e ricostruibile soltanto a partire dall’inter-
43
44
pretazione del suo codice politico, dal significato della sua valenza politica.
Avviatosi all’insegna di una separazione fra razionalità del soggetto e tecnica
della politica, dopo la coppia emblematica Descartes-Machiavelli, questo processo si ripropone in Marx con una significativa alterazione: in Marx la ragione,
costretta a fare i conti con il principio della prassi, è infatti interamente posseduta dallo scopo, dal disegno della politica. Essa ha perso la sua qualità di esperienza del soggetto, per ridursi a supporto dedicato alla politica, vera nuova evidenza, anzi sintesi, del moderno. La possibilità di negare il presupposto volgarmente materialistico della storia, è esaltata rapportando ad una dimensione
galileiana l’intera logica della ‘filosofia’ di Marx; ma da qui, il passo verso un
collegamento stretto e possessivo fra storia e prassi, è breve per Del Noce, fino
all’adozione della prassi a nuovo paradigma dell’autonomia della politica, o dell’autonomia dei suoi scopi. Ma vi è ancora dell’altro, che concerne il secondo
aspetto del significato negativo della “non filosofia” di Marx.
Nello studio sulla coppia Cartesio-Machiavelli e su quella Galileo-Marx, Del
Noce riafferma l’utilità storica di un confronto con l’eterno e con la metafisica,
ma richiama una contraddizione, una vera incoerenza teorica del moderno,
come carattere tipico della sua complessità e della sua ambivalenza. Così, da
una parte, nella fondazione machiavelliana della politica, si annida un profondo
“stacco fra il machiavellismo pensato e il machiavellismo vissuto (onde la corrente sentenza che non si può essere praticamente machiavellici che professandosi antimachiavellici)”18. Dall’altra parte, questa stessa inversione fra pensato e agito, fra essenza e apparenza, si ripropone in Marx, laddove l’eccesso
di prassi, impedisce la sua coerente prosecuzione. Vi è in questo gioco di contrari che ritorna anche in Gentile (attivismo-nichilismo), e in Gramsci (rivoluzione e suo suicidio), non soltanto la testimonianza di un pensiero tormentato in
Augusto Del Noce, ma anche la sottile percezione del significato arduo del
moderno, della sua logica discontinua, della possibilità che il suo divenire si differenzi e sfugga, rispetto alle ragioni e ai modi del suo costituirsi. Questa possibilità di alterazione, questa incertezza, è denunciata da un filosofo, come del
Noce, che è profondamente ispirato all’eternità e alla fede. Ma proprio qui si
configura un motivo di grande fecondità, in sede di revoca di qualsiasi regola,
per altro solo prammatica, per interpretare il mondo, il senso del mondo, in
modo inappellabile. Per curiosa circostanza, a Del Noce, teorico dal fortissimo
impianto metafisico, tocca lo strano destino di negare, sul piano della storia e
della politica, qualsiasi tendenza allo spirito di sistema, alle regole irreversibili,
alle disposizioni totali. E così, il rigore della metafisica diviene la premessa ad
una nuova esigenza di mutamento.
3. Il marxismo italiano. Il ‘caso’ Gramsci
La posizione sul marxismo va intesa, dunque, come un filtro fondamentale
per la lettura di Gramsci da parte di Del Noce. Ciò vale sul piano teorico, dove
egli abbraccia e definisce la specificità italiana del marxismo, in quanto pensie-
SAGGI
ro volto all’azione, nella categoria della filosofia della prassi. Ma vale anche sul
piano politico, dove i celebri concetti gramsciani di “società civile” e di “guerra di
posizione” hanno comportato una nuova scrittura del tema della lotta di classe
in Occidente. Non è perciò superfluo ricordare quanto spazio occupi l’ideale
confronto con Gramsci, nell’itinerario intellettuale di Augusto Del Noce. Al rapporto Gentile-Gramsci si affianca l’argomento del “suicidio della rivoluzione”, da
cui deriva l’omonimo testo. Si tratta di una tappa decisiva nella messa a punto
dei termini italiani della crisi del marxismo. Che in quel testo si consumi un
dibattito serratissimo su Gramsci, e sulle interpretazioni del gramscismo, è
stato sempre assai chiaro; che poi la questione non si sia limitata soltanto ad
un profilo di intrepretazione culturale, è testimoniato dai diversi interventi a
risposta e a discussione delle tesi di Del Noce19. In questa sede non ripercorrerò l’itinerario parallelo Gentile-Gramsci, già trattato da diversi studiosi, in chiave critica. Vorrei invece tentare di evidenziare alcune ragioni di quel parallelo,
per come Del Noce lo legge: ne derivano, infatti, interessanti problemi in ordine
alla recezione di Gramsci che, indipendentemente dalla condivisione o meno
delle tesi delnociane, coducono ad un esito non solo di interpretazione, ma
anche di critica di un modo di concepire la politica.
Lo studio di Del Noce su Gramsci si sviluppa lungo due direzioni. Sul piano
teorico, e non senza la consapevolezza di importanti riflessi politici e ideali,
come da molti è stato notato, si afferma in piena evidenza la matrice della filosofia della prassi. Essa in un certo senso delimita i confini del problema, ma lo
fa allargandoli in misura consistente, fino a sollevare importanti domande sul
significato della ravvicinatissima consecutio Gentile-Gramsci. Infatti Del Noce,
come già è stato rilevato, ricostruendo la linea Labriola-Croce-GentileGramsci20, punta decisamente a descrivere un’originalità nella tradizione del
marxismo italiano, una sua specificità occidentale e filosofica, con connotati
chiaramente distinti rispetto alla ‘grande’ matrice del materialismo storico prima,
e del leninismo, dopo. Il nesso Gentile-Gramsci, insomma, risponde in Del
Noce ad una precisa impostazione culturale: egli tende ad evidenziare, da
Machiavelli a Gramsci, le implicazioni filosofiche del pensiero politico italiano e,
più in generale, del rapporto pensiero-politica. Ma egli così ripropone anche
una sorta di tradizione occidentale, una sorta di percorso –dove Occidente e
filosofia si incontrano– che, non senza incoerenze e rotture, ha tuttavia profondamente influito sui caratteri della politica. Sembra quasi voler affermare –Del
Noce– che anche nell’ambito di una forte autonomizzazione della politica,
anche nell’ambito di un itinerario che, legittimamente, dalla scienza di
Machiavelli conduca sino a quella di Marx, le pagine italiane si differenziano. In
queste pagine, infatti, fortissimi momenti di intensità politica, di senso dell’azione, come quelli di Gentile e di Gramsci, non hanno potuto tuttavia affrancarsi
completamente dalla filosofia, ed anzi hanno dovuto renderle conto. Nel valore
epocale della filosofia della prassi, si conserva pertanto un criterio di differenziazione del marxismo occidentale, e del suo movimento logico, rispetto sia alla
teoria rivoluzionaria leninista, sia alla “non-filosofia” di Marx, suo precedente
teorico21.
Ma la lettura gentiliana della filosofia di Marx,22 in definitiva, si distingue
45
46
secondo Del Noce, proprio perchè, ben oltre il dato della ‘variante’ teorica, essa
afferma un punto di vista non speculativo e, insieme, non positivistico. Non
sembra riaffiorare in questo Gentile di Del Noce, capace di influire sulle radici
del gramscismo, una nuova stesura del capitolo centrale della modernità, relativo a ‘pensiero e politica’? Rileggiamo alcuni passaggi essenziali: “In che senso
–egli si chiede– dico […] che il pensiero di Gentile rappresenta una svolta di
capitale importanza nella storia della filosofia, in un senso [sic] la più importante
del nostro secolo, e lo dico senza essere per nulla gentiliano? In quello che ha
portato all’estremo non soltanto […] l’idealismo o la sua forma soggettivistica,
ma la filosofia del primato del divenire, chiarendone l’esito antimetafisico”23.
Non è intento di questo contributo, diffondersi sul ‘problema’ Gentile in Del
Noce, oggetto per altro di importanti studi24. Vorrei però porre in evidenza che
nella sintesi di idealismo e divenire, nella congiunzione fra pensare il mondo e
agire per cambiarlo, si apre ora un’altra pagina della modernità. Come già per
Descartes, per Machiavelli, per Marx, anche per Gentile si afferma un ruolo da
analizzare su di un piano epocale; anche per Gentile si tratta, infatti, di porre in
luce un segno di civiltà, un modo di essere dell’uomo. Qualcosa che spinge
fuori dalla nicchia il filosofo-osservatore e lo immette nella spirale del mutamento: ecco l’elemento in comune della galleria filosofica della modernità in cui Del
Noce torna a soffermarsi. E in questo senso, Giovanni Gentile autore di La filosofia di Marx, è per lui “come punto ultimo a cui deve giungere lo svolgimento
dello hegelismo nella forma della filosofia della prassi; quindi come un oltremarxismo rispetto a cui il marxismo non si trova nella possibilità di
rispondere”25. Tensione verso il mutamento e posizione antimetafisica, sono i
due elementi entro i quali sembra che il pensiero di Gentile non possa essere
altrimenti che filosofia della prassi, adozione del progetto, forzatura, morale e
pratica, del contingente. L’elevazione di questo progetto a finalità assoluta ed
esclusiva, è poi la forma esteriore dell’autonomizzarsi della volontà dello spirito,
dimentica ormai della metafisica e dell’eterno. Certo, va ricordato che molto
spesso Del Noce critica duramente questo atteggiamento, classificandolo come
un altro capitolo della corsa al nichilismo da parte della modernità; ma non è su
questo giudizio -più volte ricorrente negli studi- che intende procedere il mio
ragionamento. Vorrei invece riassumere l’intera esperienza di Gentile, per
come viene riletta da Del Noce, in chiave di rigetto di una forma, per così dire,
passiva, del pensiero; il suo idealismo si rivolge contemporaneamente contro la
vecchia immagine del “Dio ascoso”, formula denigratoria di ogni economicismo,
contro “ogni metafisica, così idealistica come materialistica”26. Ciò vale tanto
rispetto allo stesso Marx, del quale Gentile rifiuta quella sorta di vulgata filosofica che fu il materialismo storico, quanto rispetto ai suoi successivi interpreti. Ed
è proprio su questa linea che Del Noce incontra Gramsci. Ma qui la questione,
nata in sede di confronto culturale, si apre ai suoi risvolti più specifici di teoria e
concezione della politica.
Il “neomarxismo” di Gramsci, per il nostro filosofo, non è altro che “la riaffermazione di Marx dopo la “filosofia dello Spirito”, correttamente intesa come
riforma dello hegelismo quale si rendeva necessaria dopo il marxismo, o come
tentativo di vittoria sul marxismo, all’interno della riforma dello hegelismo”27.
SAGGI
Sono termini fortissimi, che accolgono nella filosofia della prassi linguaggi
diversi, ma sempre orientati ad una retrospettiva critica verso le loro stesse
radici –la coppia Hegel/Marx– e ad una feconda reciprocità fra rivoluzione e
filosofia. Sappiamo bene che la tesi della contiguità Gentile-Gramsci è stata in
seguito criticata dagli eredi del gramscismo; ciò è del tutto comprensibile28. Ma
qui interessa sottolineare un altro aspetto del problema, rappreso nel rapporto
Gentile-Gramsci: esso attiene, infatti, alle ragioni più profonde per le quali Del
Noce, negli anni ‘70, osservando in filigrana la crisi della società occidentale,
l’improduttività di valori cui è giunto il processo avanzato di modernizzazione,
cerca di rendere leggibile la causa generale di questa crisi. Egli ritiene di rinvenirla sia sul versante della grande tradizione ‘borghese’, da Cartesio a Marx, sia
su quello del suo filone antagonistico più accentuato, da Marx, al marxismo,
alla teoria e ai soggetti storici della lotta di classe. Insomma, Gentile-Gramsci è
per Del Noce il binomio entro il quale si conclude il bilancio –negativo– dell’edificazione della società moderna-occidentale, ma anche quello della sua modificazione-distruzione rivoluzionaria. Se all’altezza dell’edificazione, la nozione di
tecnica sancisce, nel linguaggo di Del Noce, l’impasse della separazione fra
pensiero e politica, al momento della rivoluzione corrisponde l’analoga contraddizione fra filosofia (senza valori) e prassi, fra pensiero che si riduce nel chiuso
del soggetto, e movimento, che ricade nell’enfasi della volontà parziale.
Il ragionamento di Del Noce vuole pertanto negare l’equivoco sia di una
serialità lineare nella storia del marxismo filosofico, sia di un continuismo ferreo
fra la lettera di Gramsci e la lettura che altri ne fanno. Sembra quasi che egli si
serva del gentilismo, per sottolineare la lontananza non riducibile fra l’essenza
della teoria gramsciana, dunque la sua lettera, –che concerne la prassi– e il
suo uso politico da parte dell’organizzazione che a quell’essenza si richiama,
dunque la sua lettura –che si pretende valore–. Il fatto è che Del Noce colloca
in Gramsci un’ulteriore stagione di motivazione autonoma della politica, di autoreferenzialità, questa volta affidata al primato della prassi, nuova versione dell’antica tecnicizzazione machiavelliana. Prassi elevata a valore, prassi in quanto scienza politica: qui il focus di una forza distruttiva, qui il nichilistico ponte di
congiunzione con Gentile, trovano dimostrazione e verità, per Del Noce. Egli
ritiene che le interpretazioni fra fine anni ‘60 e anni ‘70, vadano nel senso di
attribuire a Gramsci, se non una vera e completa autonomia dal leninismo,
almeno l’avvio di una teoria rivoluzionaria ‘positiva’, in grado di offrire soluzioni
adeguate alla specificità e alla complessità della crisi dell’Occidente. Ma è proprio qui lo iato che Del Noce denuncia, quando rileva che ad un’essenza
sostanzialmente leninista di Gramsci, abbia fatto seguito un “gramscismo” elevato a teoria occidentale, cioè innovativa, della lotta politica fra le classi.
L’ampiezza totale dello spettro di intervento di Gentile e Gramsci, autorizza poi
Del Noce ad accomunarli in una valenza intenzionalmente palingenetica. Egli
trova infatti confermato lo sbilanciamento fra prassi-politica e speculazionevalore in Gentile e Gramsci, proprio perchè vede in entrambi una linea di intervento che va dalla politica in senso stretto, allo spirito, all’educazione di un
Paese, dallo Stato, alla società civile. Il segnale che Del Noce lancia, si motiva
sulla lucida percezione che entrambi gli autori studiati si misurino sì sul terreno
47
48
delle sovrastrutture -per dirla con Gramsci-, ma questo terreno rimane comunque un’arena privilegiata per la verifica dell’efficacia della prassi e dell’adeguatezza tecnica del progetto politico. Ed è questo l’oggetto su cui oggi vi è ancora
spazio per la riflessione.
Del resto, il giovane Gramsci, quello ‘torinese’ dei “Consigli”, e ancora
prima, quello di Il nostro Marx 29 e di La rivoluzione contro il “Capitale”30, quello
delle critiche culturali e dei corsivi di costume, ben noto a Del Noce31, è già in
rottura rispetto alla tradizione socialista e alle sue varianti fra economicismo e
massimalismo; ma la sua fucina intellettuale è attenta a tutta la vita civile che si
svolge “sotto la Mole”. Gli scritti maturi, i Quaderni, sono ancora più ricchi sotto
questo profilo, e vengono perciò rivisitati dal nostro filosofo, alla ricerca di categorie condivise o condivisibili da Gentile, dal primato della società civile, già
rilevato da Bobbio32, al marxismo distinto dal materialismo storico, al blocco storico, e persino all’egemonia. A tale riguardo le discussioni non sono mancate,
all’insegna dell’originalità e dell’indipendenza intellettuale di Gramsci, della sua
accezione incontaminata di “filosofia della prassi”. Molto spesso si è trattato di
obiezioni motivate ora da una logica politica immediata, ora da una fine battaglia ideale, ora dall’esigenza di un aggiornamento teorico adeguato alla crisi del
marxismo, dagli anni ‘70, in poi33. Nell’ottica di Del Noce, invece, il vero problema riguarda il fondamento di valore della politica come tale, cioè autonoma,
che il filosofo mette in discussione, in quanto valore prevalente, primato, della
prassi. Importante è infatti la sua precisazione, quando, rievocando la capacità
di dubbio che consapevolmente possiede la filosofia dello spirito nell’accezione
gentiliana, egli ricorre ancora al modello cartesiano: “Ripensare oggi la filosofia
gentiliana -scrive- è essere riportati, in modo nuovo, al processo della prima
meditazione cartesiana e all’estensione estrema del dubbio metodico: a porre
cioè la questione di quale forma di pensiero possa resistere alla scepsi gentiliana,[…]”34. Del Noce sa bene, e lo ricorda esplicitamente, che Gentile è filosofo
“affermativo” e “assertorio”, tutt’altro che pensatore reculant nel dubbio35, e perciò non gli sfugge il significato di revoca sostanziale, ed intenzionale, del suo
lavoro di demolizione etico-politica. Ma anche Gramsci, forse meno “assertorio”
che Gentile, deve misurarsi con una dimensione del dubbio, del disfare: nei
suoi primi scritti, il giovane dirigente nega, quasi cartesianamente, sebbene citi
Novalis, l’obbiettività dell’ordine circostante, allo scopo di ritrovare e riaffermare
la propria identità: “Critica –scrive Gramsci nel 1916– vuol dire appunto […]
coscienza dell’io […] che si oppone agli altri, che si differenzia– Conoscere se
stessi vuol dire essere se stessi, vuol dire […] distinguersi, uscire fuori dal
caos, essere un elemento di ordine, ma del proprio ordine e della propria disciplina a un ideale”36. La riedizione di un fondamento soggettivo dell’ordine, all’altezza del ‘900, ben si collega con la spinta all’intervento: la sintesi resta quella
di pensiero e politica che, ripartendo dalle premesse razionalistico-cartesiane
della cultura della revoca, muove verso Machiavelli, verso la politica come innovazione-rimozione. E che su questa strada si incontri Gramsci, ma anche
Gentile, almeno nel momento motivazionale del rapporto fra pensiero, forte, e
politica, anch’essa forte, è argomento che richiede certo molti affinamenti e precisazioni, ma ricco di motivi ancora inediti, su cui riflettere con animo sereno.
SAGGI
Indubbiamente si tratta di vicende, anche individuali –quella di Gentile e di
Gramsci– assai diverse e non confrontabili, –basti pensare alla divaricazione
fascismo-comunismo–: nel linguaggio di Del Noce, però, nella sua ricerca
appassionata delle ragioni più profonde ed epocali della perdita del senso dell’eternità, le figure di Gramsci e Gentile provocano una profonda suggestione,
dal significato della religione, che le allontana, a quello dell’educazione nazional-popolare, che secondo il nostro filosofo, le riavvicina. Ma facciamo ancora
un passo, inoltrandoci nella provocazione intellettuale che Del Noce ci propone.
4. Il Gramsci di Del Noce:
la politica fra progetto e teologia
Un altro aspetto rilevante del discorso di Del Noce, riguarda l’analisi, direi
più politica, del corpus del gramscismo e della sua ‘fortuna’ nel corso del ‘900.
Anche qui ricorrono molti riferimenti a Gentile, ripetitivi, in parte, ma anche di
approfondimento e precisazione.
Soffermiamoci, dunque, sul termine “suicidio”, che Del Noce trova confermato nello stesso Gramsci, a proposito del popolarismo e del nuovo impegno
politico dei cattolici. È un termine carico di significati, e non sempre omogenei
fra loro: vorrei tratteggiarne almeno due varianti.
La prima, risalente a posizioni già da tempo maturate nel nostro filosofo, è di
netta critica al concetto di rivoluzione, in quanto esperienza destinata a contraddirisi nel suo rapporto fra presente e prospettiva. Già a proposito dello
scontro Stalin-Trotzki37, Del Noce pone in risalto il conflitto dei tempi che spinge
al suicidio-fallimento la categoria di ‘rivoluzione’. Nata all’insegna di una scelta
per l’avvenire, di una soluzione di progresso, essa ricade nella reintegrazione
del presente, quando la prassi politica impone il realismo come via obbligata
per consolidare la forza e il potere. Così la rivoluzione, per Del Noce, è doppiamente distruttiva: una volta, nascendo, nega la tradizione e sfida l’eternità; una
seconda volta, consolidandosi, nega se stessa e perde la coerenza con il valore in nome del quale è sorta38.
La seconda accezione, anch’essa negativa, della rivoluzione, consiste nel
suo trasferirsi, dissolvendosi, dal piano dell’opzione, a quello della scienza politica, dal piano della parzialità, ma parzialità consapevole, dichiarata e, perciò,
riconosciuta, a quello della totalità, del politico non suscettibile di contraddizione. È il ragionamento in cui Del Noce segnala come al dualismo, o parzialità,
della società antica, segua il monismo, o totalità, della società moderna39; in
queste coordinate, già presenti ben prima degli anni ‘70, si colloca la sua lettura
di Gramsci, che ora si fa decisamente più spigolosa, in aperta polemica circa gli
esiti della teoria della rivoluzione in Occidente, e circa le stesse interpretazioni
del gramscismo. Il carattere occidentale dell’opera gramsciana è a più riprese
ribadito. Essa, infatti, risponde ad una “mentalità –scrive Del Noce– […] chiaramente occidentalista ed eurocentrica. Nei paesi occidentali, in ragione del loro
maggior grado di civiltà e di cultura, […] la rivoluzione può manifestarvi il suo
49
50
più profondo aspetto, che è quello della priorità della riforma intellettuale e
morale”40. Si tratta di un corretto richiamo della peculiarità della teoria di Antonio
Gramsci e del suo discrimen invalicabile rispetto a tutte le abbreviazioni del
leninismo ortodosso, da Bordiga, alla fine del secolo. Ma proprio questo livello
della discussione porta Del Noce a collocare in Gramsci un nuovo stadio, una
fase evolutiva, particolarmente sofisticata, del processo di inversione-suicidio
della rivoluzione. Tanto più elevata e ‘sovrastrutturale’ diviene la qualità del conflitto politico, tanto più per Del Noce si accentua la divaricazione fra pratica e
pensiero, fra scienza politica e verità, essendo quest’ultima sacrificata ad un’urgenza che non le appartiene e che privilegia invece lo scopo dell’effettività. Il
paradigma del suicidio, insomma, non è altro che una nuova definizione dell’impossibile valore del primato della prassi; allargare i confini dell’azione –fino a
comprendervi il piano e la qualità della cultura e dello spirito, delle sovrastrutture, insomma– serve solo a rilegittimare uno scopo –politico– preselezionato,
cioè anteposto al medesimo processo con cui diviene. In tale schema, dunque,
è il valore della politica che illumina il senso del ‘progetto’, e non viceversa. È
evidente che Del Noce vuole verificare un’altra forma della corsa al nichilismo
attribuita a Gentile e a Gramsci, e a tutte le filosofie che intendono il moderno
come oblio dell’eterno. Ma, più in generale, qui il nichilismo altro non è, se non
il risvolto della contrazione della teoria, anche quella rivoluzionaria, nel precipitato del suo ‘prodotto’, nella ‘cosa’ realizzata. La logica del suicidio anima dunque la polemica contro il comunismo, non già in quanto sovvertimento, trionfo
del materialismo, ma in quanto apparato intellettuale, affermazione di un principio, geloso di una tecnica che non rivela41. Nel significato complesso della categoria del suicidio politico, ritorna così, in Del Noce, la denuncia di quella sorta
di insincerità della politica del moderno, basata sul paradigma di un’adozione
autentica del machiavellismo, in quanto affidata alla professione dichiarata di
antimachiavellismo. Si evidenzia ormai l’oggetto reale della polemica: il suicidio
nasce, nel lessico gramsciano, a proposito dell’esperienza di organizzazione
dei cattolici in partito politico, e in quella sorta di loro décalage alle regole
moderne della politica e della lotta di classe. Il suicidio è nella necessità di
accettare, insomma, una mondanizzazione, se non estranea, almeno impropria, rispetto alla natura, alla storia, ai valori –non conflittuali– del cattolico. La
sua trasformazione politica in ‘popolare’ è per Gramsci un radicale cambiamento di identità –il trapasso dall’eterno al contingente–, che non tarderà a sortire il
frutto della ‘cattura’ dei cattolici dentro lo spazio dell’autonomizzazione delle
leggi della politica, terreno privilegiato per un altro stadio, forse egemonicamente risolutivo, del conflitto di classe. Ecco perchè Del Noce sottolinea, nel suicidio, il mutamento di un’identità subìto e non avvertito, fino al limite dell’estinzione, qualcosa che lo stesso Gramsci riprende più ampiamente anche con la
categoria di “rivoluzione passiva”. Ecco perchè, riverberata trasversalmente
sull’intero impianto teorico gramsciano, fino al concetto di egemonia, questa
dimensione del suicidio autorizza il nostro filosofo ad un vero e proprio schieramento, che non esclude il ricorso a parole durissime: “Gramsci aveva insomma
inventato –egli dice– un’altra forma di estinzione dell’avversario; non più persecuzione fisica, ma “suicidio”. È qui che si chiarisce il significato di termini tanto
SAGGI
ripetuti come “compromesso storico” ed “eurocomunismo”42. Il conflitto viene
dunque all’oggi, e bisogna evitare, in questa sede, di impostare con Del Nocepensatore una discussione riferita a un Del Noce-dirigente politico, che non è
mai esistito. Non uscirò pertanto della logica stessa del nostro filosofo, perchè
mi sembra importante ricostruirne soprattutto la coerenza ed il significato, ancora utili ad una riflessione dentro percorsi intellettuali diversi dal suo. A ben leggere il testo in esame, si scopre infatti che dietro la parole taglienti, Del Noce
conserva un significato molto più prudente e problematico, che tocca due nodi,
soprattutto, sui quali vorrei infine soffermarmi, anche perchè non mi sembra
che siano stati sufficientemente esaminati fin ora.
Il primo nodo riguarda la questione del continuismo, a cui il gramscismo è
stato piegato, artefice la ricostruzione togliattiana. È ben vero che dal Gramsci
di Togliatti a quello successivo, vi sono state importanti sfumature; ciò vale
soprattutto per la questione del ‘leninismo’, cui il dirigente comunista è stato inizialmente ricondotto. Ma, insieme con il leninismo, la connotazione occidentale
del suo pensiero e l’attenzione alla società civile, al ruolo della cultura, non
sono mai mancate nella lettura e nella tematizzazione di Togliatti43. In queste
due sponde, -leninismo e ‘battaglia ideale’- di cui mai l’una ha del tutto oscurato
l’altra, trova fondamento la questione del continuismo, impostata nel senso
della realizzazione di un processo di trasformazione, anche di negazione,
senza che il processo medesimo fornisca i segni della sua presenza e della sua
visibilità. L’enfasi del processo, della prassi, porta Del Noce a criticare Gramsci,
e il gramscismo, in nome di due equivalenze: quella fra rivoluzione e nichilismo
(rivoluzione-distruzione), e quella fra continuità ideale e nascondimento della
innovazione sostanziale (continuità-superamento). La prima equazione ha
messo capo al rapporto con Gentile, su cui non è il caso di ritornare. La seconda assume invece il significato di un gioco di apparenze, dove il conservare,
non è altro che il vero volto-strumento del rimuovere, dove l’affermazione di
una tradizione, non è altro che il mezzo per infrangerla, dove il livello del valore,
cede -ancora una volta- a quello della prassi. Non si tratta soltanto di un modo
di congiungere ‘passato e presente’, come recita un celebre titolo della redazione togliattiana dei Quaderni; si tratta di individuare, nel laboratorio culturale
in cui questa funzione e questa conformazione del continuismo sono maturate,
l’esito pratico cui tende un processo di trasformazione che avanza, grazie al
fatto di celare il suo stesso movimento. Continuare il passato è un modo per
assorbirlo, negarlo, esattamente come Del Noce interpreta tutta la posizione
del marxismo e della cultura rivoluzionaria gramsciana, su Benedetto Croce.
Dalla filosofia della prassi, al laicismo antireligioso, all’importanza del conflitto
ideale e dei suoi risvolti egemonici, il pensiero di Gramsci, adottato a statuto
teorico del superamento politico, è stato utilizzato anche per assorbire il suo
avversario, per conservarlo, devitalizzandolo, per reintegrarlo storicamente,
proprio mentre lo azzera politicamente. “La vittoria sulla cultura crociana -rileva
infatti Del Noce- doveva avvenire nella forma di continuità-superamento: il passaggio dell’intellettuale crociano al marxismo non doveva richiedere la forma di
una conversione brusca, ma quella di una rigorosa coerenza apportata alle precedenti convinzioni […]. La cultura gramsciana si presentava dunque come la
51
52
legittima erede della crociana […]”44. Anche Croce deve passare attraverso una
metamorfosi: il marxismo militante, conservando l’avversario nel velo della continuità-superamento, lo oscura e lo utilizza per la sua autolegittimazione. E’
questa, a giudizio di Del Noce, una prima forma di “compromesso”, anche
abbastanza dinamica, legata com’è al progetto di un mutamento-assorbimento
di tipo egemonico. La seconda forma si riferisce alla condivisione fra cattolici e
comunisti della medesima scena politica. Quest’ultimo motivo, rispetto ad altri
luoghi dell’impegno di Del Noce, è assai più sfumato nel testo ora in esame.
Qui, però, egli dedica uno spazio particolare alla combinazione di compromesso e continuismo, dalla quale deriva la definizione dei caratteri del totalitarismo45, nel senso che il termine riveste nella sua elaborazione. Ecco dunque
profilarsi il secondo nodo della questione del continuismo, per la verità affrontato meno di altri aspetti, o ridotto al significato più propagandistico del termine
‘totalitarismo’.
Per Del Noce, il totalitarismo si presenta anche in Gramsci, ma ben al di
fuori del paradigma critico, ormai ‘classico’, di ‘democrazia e socialismo’ 46.
Permane certamente nel nostro filosofo anche la preoccupazione di una verifica della coerenza democratica del comunismo in Occidente; essa è infatti
oggetto di frequenti interventi più circoscritti e occasionali, di polemica politica
quotidiana, direi. Ma la parte aurea del problema, è per Del Noce la ripresa, in
seno al marxismo militante contemporaneo, della reidentificazione di morale e
politica47. L’assenza di uno scarto fra le due dimensioni, fa della rivoluzione,
come in Lukacs, una sintesi pratica del coinvolgimento integrale, che l’esito ultimo della rivoluzione medesima domanda48. Si profilano tre linee di critica del
totalitarismo, entrambe di carattere decisamente ‘sovrastrutturale’. La prima,
scorge nella reidentificazione di morale e politica una sorta di arretramento
rispetto alla tradizionale tesi machiavelliana della separazione delle due esperienze. Ma soprattutto, Del Noce nega che questo livello di mondanizzazione
integrale della morale, sia “l’unica via per la riacquisizione dell’unità interiore”49.
In questo senso, il discorso sul totalitarismo offre al nostro autore una nuova
occasione per respingere le possibilità di ricomposizione dell’uomo, a partire
dal mondano e dal relativismo della politica. La saldatura fra politica e morale,
in un quadro di motivazione generale ed assoluta dell’azione, cancellerebbe
–sembra avvertire Del Noce– qualsiasi altro livello di giudizio, che non sia l’immediatezza dell’interesse organizzato in potere politico. Un secondo livello di
critica del totalitarismo si spinge, attraverso i testi gramsciani, al confronto-contrapposizione fra totalitarismo comunista (basato sulla identificazione fra politica e morale), e totalitarismo fascista (basato sul cesarismo), o “totalitarismo
mancato”50. Non è naturalmente il caso di inoltrarsi nell’interpretazione del fascismo da parte di Del Noce, e tantomeno nell’uso che egli fa dell’analisi gramsciana, a riguardo; d’altro canto, le sue pagine non si soffermano su alcuni passaggi di rilievo, quali Americanismo e fordismo e la categoria di rivoluzione passiva, con la medesima intensità riservata ad altri aspetti di Gramsci e del gramscismo. Ma il vero interesse teorico di Del Noce guarda altrove, guarda alle
interpretazioni del ‘900, alla polemica politica corrente, volendo egli evitare che
l’alternativa fascismo-comunismo o fascismo-antifascismo, si risolva in un agile
SAGGI
gioco di riflessi e di accomodanti strumenti di legittimazione. A Del Noce, in
verità, preme la questione dei contenuti culturali del totalitarismo, molto più che
quella delle sue etichette. Anche su questo piano vi è stato e vi sarà dibattito.
Leggiamo però con chiarezza la sua posizione, collegandola direttamente al
discorso sulla secolarizzazione, sulla perdita del senso religioso, e sulla trasformazione in religione della politica.
Questo è il terzo livello della critica delnociana del totalitarismo, forse quello
che più sta a cuore del nostro filosofo, dal momento che egli stesso rivela che
“Il caso Gramsci è […] importante perchè permette di saggiare i sensi di totalitarismo”51. Sotto questo profilo, la discussione che Del Noce agita, forse quella
vera, travalica il confine dell’ideologia, e tocca direttamente la conformazione
morale della politica, quando essa, totalizzandosi, si trasforma in religione, in
valore trascendente ed indiscutibile. Del Noce qui sicuramente rigetta, nello
schema rivoluzione-comunismo, un modello storico di rivoluzione socialista
–eraltro l’unico disponibile–; ma insieme rigetta la sua assolutizzazione, la sua
trasformazione in modello generale della motivazione politica, complice, a suo
giudizio, il pensiero gramsciano. Ora il comunismo è criticato in ragione non di
un discorso democratico-istituzionale, ma perchè indirizzato ad una radicalizzazione del laicismo e della politica, capace di farsi religione, anzi un’antireligione
che ricade nel suo contrario, insomma una teologia politica. Si parte, pertanto,
dall’ affermazione nella mentalità rivoluzionaria che “trascrive in termini mondani l’aspirazione al “totalmente altro”; da ciò la simmetria dei fenomeni rivoluzionari con i religiosi (mentalità messianica […] intollerante […] che ha il riscontro
politico nel rifiuto del riformismo, eccetera)”52. Si arriva, infine, dopo i passaggi
sull’arcaicità (premodernità) dell’ideale comunista, a rilevare in Gramsci, l’
espressione di un cattolicesimo rovesciato, di un comunismo elevato a religione. Ma la critica di Del Noce procede oltre quest’aspetto. Il problema non concerne la sostituzione di un ideale storico-mondano, cioè il comunismo, alla
natura metafisica dell’essenza religiosa; non si tratta cioè di respingere l’inversione fra finito e infinito, per usare il linguaggio delnociano, nè di riscattare, con
l’argomento religioso, il ruolo della Chiesa cattolica dalla dura contestazione
che le rivolge Gramsci. La questione di fondo è un’altra, per Del Noce: essa
consiste nel fatto che tutte le diverse letture di Gramsci, comprese quelle suggerite in chiave di pluralismo e di teoria della transizione, non sciolgono il debito
teorico verso il ‘ritorno’ di teologia politica, sia pure laicizzato e secolarizzato.
Per valutare il pensiero gramsciano, sostiene il nostro filosofo, è stato necessario avallare una confusione e sovrapposizione radicale fra Kant e Machiavelli53,
fra rigorismo e tecnicismo, cioè fra i due volti della politica divenuta essa totalità. La risposta che Del Noce vuole offrire, insomma, passando per Gramsci,
sta nella descrizione dello statuto contraddittorio della politica, fatta totalità.
Questa politica, che ha rimosso ogni ostacolo religioso, ha assorbito nell’ideale
rivoluzionario ogni altro dovere, ogni altra visione del mondo, è nuovamente
tornata indietro ripetto a Machiavelli, e si è fatta essa religione, mondanizzando
senza alternative anche il significato della temperie religiosa: “Non stupisce
perciò –conclude Del Noce– se il comunismo italiano appare oggi come la forza
più edeguata a mantenere l’ordine in un mondo in cui qualsiasi religione è
53
54
scomparsa; non soltanto la religione cattolica, ma ogni sua forma anche immanentistica e secolare; anche la fede nel comunismo. L’insoddisfazione sincera
dei rivoluzionari autentici trova giustificazione. Certo, il comunismo gramsciano
può riuscire, ma realizzando l’esatto opposto di quel che si proponeva” 54. Si
conclude così, coerentemente, un lungo percorso che parte dal rifiuto dell’acrisia della tecnica politica elevata a valore, e giunge alla constatazione dei rischi
di teologia politica, interni anche alla teoria rivoluzionaria della lotta fra le classi.
Il ‘suicidio’ della rivoluzione è un paradigma su cui Del Noce si concentra prima
del 1989, prima della “fine di un’illusione”, come dice Furet55; prima che la rivoluzione consumi il suo suicidio nel crollo dell’utopia, prima che anche i cattolici
riaprano il problema del loro essere nel mondo, rinnovando il loro sguardo alla
speranza e al senso eterno della vita56. Ma, dovendo concludere, vorrei segnalare un tema di riflessione futura: nel suo discorso su Gramsci, Del Noce fa
mostra di una tenacia e di una coerenza teorica vigorosissime, capaci anche di
attraversare con armi filosofiche, il terreno difficilissimo della teoria politica della
transizione. Contemporaneamente, però, la sua analisi ci lascia una formidabile, stimolante contraddizione: come si tengono insieme, un Gramsci gentiliano,
attualista e rivoluzionario, e un Gramsci continuista, pronto ad inglobare nella
rivoluzione tutto lo scenario storico che la riguarda, fino al risucchio di se medesima? Come si collegano insomma, l’atto con la sua fine e la stasi? Del Noce
non ci suggerisce risposta che non sia quella di un concetto della rivoluzione,
dentro le pagine di Gramsci, così preoccupato di criticare, di togliere, così rapito dall’etica del contro, da ridursi nichilisticamente alla tautologia negativa. Ma
forse l’ultima risposta, sta ancora nelle pagine di Gramsci, che sono da rileggere, evitando di inseguire organicismi e razionalizzazioni ipercoerenti. Forse la
verità è in una scissione che è dentro l’opera di Gramsci, in quella torinese, e in
quella del carcere. Converrà lavorare perchè emerga, se essa esiste; e anche
questo risulterà per il contributo di Augusto Del Noce.
*
Viene qui riproposto il testo della relazione, da me tenuta, al Convegno internazionale di studi
su Augusto Del Noce: essenze filosofiche e attualità storica, (Roma, Università “La Sapienza”, 9 11 novembre 1995). Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Prof. Francesco Mercadante,
organizzatore del Convegno medesimo e curatore dei relativi Atti, il quale generosamente ha
acconsentito alla mia richiesta di pubblicare in anticipo questo contributo.
1
Sul rapporto fra Augusto Del Noce e il marxismo, ma anche sull’intera esperienza del filosofo,
esiste ormai una larga messe di interventi, che non è possibile discutere nel dettaglio, in questa
sede. Vorrei tuttavia porre in evidenza che l’argomento viene qui richiamato senza nessuna intenzione di svolgerne gli aspetti relativi al dibattito politico-ideale, e senza alcuna accezione prossima
a questioni di egemonia culturale. Si tratta, invece, di ripercorrere, in breve, un momento fondamentale della formazione ideale di Del Noce, soprattutto per quanto riguarda la definizione del
moderno e il nesso fra pratica politica e deontologia dei valori. Il fatto, poi, che questo nodo di problemi contenga anche la posizione del nostro filosofo sul tema più generale della crisi del marxismo, che è degli anni successivi, testimonia anche della sua capacità di tradurre in linguaggio filosofico e in approfondimento culturale, tensioni e conflitti ideali, altrimenti destinati a cadere nella
SAGGI
trappola del pregiudizio. In ogni caso, sulla interpretazione del marxismo in Del Noce, ma anche su
un arco più vasto di contributi, rinvio alle recenti pubblicazioni, ricche di indicazioni bibliografiche,
ora discusse, ora solamente menzionate, di R. BUTTIGLIONE, Augusto Del Noce. Biografia di un pensiero, Milano, Piemme, 1991; G. CECI-L. CEDRONI (a c. di), Filosofia e Democrazia in Augusto Del
Noce, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1993; P. SERRA, Augusto Del Noce. Metafisica e storia, Napoli,
ESI, 1995; C. VASALE, Augusto Del Noce: una “filosofia della libertà e dello spirito”, in C. VASALE-G.
DESSÌ (a c. di), Augusto Del Noce e la libertà. Incontri filosofici, Torino, SEI, 1996, e (ivi) P. SERRA,
Filosofia e Libertà. Osservazioni sul rapporto fra Del Noce e Gramsci.
2
Meriterebbe maggiore spazio e attenzione il rapporto fra Del Noce e la politica, per la verità
mai trascurato dagli studi più recenti. La critica del totalitarismo, il problema della democrazia, la
riflessione sull’impegno militante dei cattolici e sui cattolici ‘di sinistra’, sono temi ricorrenti nell’opera del nostro filosofo, regolarmente ripresi da studiosi importanti (più di recente, G. CECI-L. CEDRONI,
a c. di, Filosofia e Democrazia, cit.; C. VASALE-G. DESSÌ, a c. di, Augusto Del Noce e la libertà, cit.).
Ma vi è una questione, sulla quale è il caso di soffermarsi brevemente, relativa alla difficoltà di indicare in Del Noce un concetto di politica chiaro e univoco. Pur non essendo una categoria fondante
del suo pensiero, la politica ritorna più volte nei suoi scritti filosofici e in quelli a indirizzo di polemica
culturale. Anzi, si può ben dire che Del Noce tratti di politica, sia nel senso più ampio del termine,
sia in quello più restrittivo, con intenzione ora di una critica del ‘politico’, in quanto categoria, ora di
una sua revisione, ora di una sua riaffermazione.
Ciò non dipende da un’ incertezza sull’argomento, o da una discontinuità del suo pensiero;
dipende, semmai, dalla vasta gamma delle accezioni di ‘politica’, che si intrecciano nell’opera del
nostro filosofo, senza che egli, volta a volta, ne definisca apertamente il senso, pur chiarissimo, nel
suo lessico e nella sua veduta. Nella difficoltà di riconoscere un significato ed un ruolo nettamente
politico ad un pensatore, come Del Noce, che si motiva tutto sul principio della trascendenza,
Buttiglione opta per l’affermazione, fra “le caratteristiche del pensiero delnociano”, della “politicità
della sua filosofia”, (R. BUTTIGLIONE, Augusto Del Noce, cit. p. 53). E’ una definizione molto suggestiva che, a mio sommesso avviso, tuttavia, non rappresenta sino in fondo lo spessore di questa
“politicità”, in quanto la áncora, hegelianamente, ad un vincolo con il tempo, con il “proprio tempo”,
dice Buttiglione, (ibidem). Non c’è dubbio che Del Noce avverta il senso della contemporaneità,
come materiale storico-umano su cui intervenire e lavorare, attraverso la filosofia; raramente calza
come per il nostro autore, la definizione di “filosofo attraverso la storia”, (D. CASTELLANO ,
Introduzione. Del Noce, un filosofo attraverso la storia, in D. CASTELLANO, a c. di, Augusto Del Noce.
Il pensiero filosofico, Napoli, ESI, 1982, p. 16). Ma è anche vero che la politicità del suo pensiero
vuole esprimere l’esigenza morale di travalicare i confini della storia e del tempo, per riaffermare
l’importanza del valore e dell’eternità. Nella nozione di politica che Del Noce adotta, vi è, insomma,
una tensione continua, una dilacerante e feconda ambivalenza fra l’attimo presente, che è proprio
del governo materiale, e l’eternità, che è propria della produzione di valori di civiltà. In tale ambivalenza si annida, in forma riassuntiva, tutta la dialettica delnociana fra azione come distruzione, e
pensiero come conservazione, fra onnipotenza della decisione politica contingente, e sua esiguità
nella grande dimensione dell’eterno.
In questo lessico senza mediazioni, si dispone tutto il discorso di Del Noce sui limiti della politica, ma anche sull’impossibilità di un suo totale oblio; cosicchè la sua filosofia si sviluppa esordendo
dalla critica-rifiuto della politica, dalla critica della modernità in quanto irruzione del politico, per
accettare poi, nei suoi passaggi migliori, la sfida di quel mondano che si concentra e si esprime nei
topoi e nei soggetti della politica e del pensiero politico. A riguardo, Mercadante ricorda giustamente che “Lo storico delle origini in Del Noce coincide dialetticamente con lo storico della fine della
modernità, e quindi con un contemporaneista principe. Non per nulla ha frequentato Marx per tutta
la vita,[…] Per un “filosofo attraverso la storia”, secondo la formula che volentieri egli applica al fatto
suo, ciò significa rispondere alla sfida dei contrari”. (F. MERCADANTE, Postfazione a A. DEL NOCE,
Filosofi dell’esistenza e della libertà, raccolta di scritti a c. di F. MERCADANTE e B. CASADEI, Milano,
Giuffrè, 1992, pp. 663-664, passim). La stessa immagine di produttiva dilacerazione era, ancora, in
Piovani, quando, quasi con un ossimoro, egli ricordava “l’esuberante passione storico-speculativa
di Del Noce [cui] sta sempre a cuore qualcosa di più di quello di cui parla”. (P. PIOVANI, Scandagli
critici, Napoli, Morano, 1986, p. 238). Il ruolo della politica, nel senso che ho cercato di illustrare, è
inoltre ricondotto da Cesa, all’arduo “rapporto religione-politica”. (C. CESA, Augusto Del Noce e il
pensiero moderno, in “Giornale critico della filosofia italiana”, maggio-agosto 1993, p. 192). Non è
55
56
sfuggita al fine studioso, la difficoltà della teoria di Del Noce, della sua dinamica di attrazione e
repulsione rispetto al fatto della politica e all’ interpretazione del moderno in chiave di contrasto fra i
due generi, per altro non affini, di religione e politica, di eternità e contingenza. La stessa duplicità
di significato ricorre, infine, anche in Vasale, quando attribuisce a Del Noce un “realismo politico
[…] inclusivo della moralità”. (C. VASALE, Augusto Del Noce: una “filosofia della libertà e dello spirito”, in C. VASALE-G. DESSÌ, Augusto Del Noce, cit., p. 9). Politica e morale, nel loro rapporto, alludono alla tradizione come forma di vita da ritrovare, al livello del valore come luogo di esordio del ricominciare, allo statuto moderno del conflitto fra agire per un fine contingente e agire per un fine
universale.
3
A. DEL NOCE, Cartesio e la politica, in “Rivista di Filosofia”, vol. XVI, 1950, p. 3 e ss.
4
A. DEL NOCE, Da Cartesio a Rosmini, raccolta di scritti a c. di F. MERCADANTE e B. CASADEI,
Milano, Giuffrè, 1992, p. 14.
5
Ivi, p. 16.
6
In termini inequivocabili, Del Noce indica la duplice “rottura” di cui sono responsabili, in parallelo, Descartes e Machiavelli: “Se consideriamo bene, –egli dice– è possibile trovare un’analogia
strutturale tra la posizione cartesiana e la machiavellica, proprio nella guisa in cui esse rompono
con l’umanesimo e iniziano il moderno. Che cosa, infatti, caratterizza il machiavellismo se non la
coincidenza della determinazione della realtà politica nel suo carattere esistenziale con l’isolamento
del politico dal problema della totale realizzazione umana (la politica come tecnica), e dove altro è
la sua frattura con l’umanesimo, almeno nel suo principio logico iniziale? Sembra ora che abbiamo
in Cartesio, trasposto, qualcosa di simile. L’accentuazione del tema esistenziale -il problema della
verità posto come indisponibile da quello della mia affermazione come esistente- coincide con l’isolamento della filosofia dalla totale realizzazione dell’uomo: e cioè, mentre per l’umanesimo l’uomo
si realizza pienamente soltanto nella comunità, la realtà sociale è posta da Cartesio come esteriore
al mio realizzarmi quale essere spirituale”. (A. DEL NOCE, Cartesio e la politica, cit., pp. 8-9). Alla
separazione machiavelliana della politica dalle altre forme della vita spirituale, fa riscontro, dunque,
la separazione cartesiana operata, invece, a partire dalla vita spirituale.
7
Ivi, pp. 7-8.
8
A. DEL NOCE, Da Cartesio a Rosmini, cit., p. 44.
9
Questo è un altro argomento che meriterebbe un’analisi autonoma e dettagliata. In questa
sede resterò al tema del mio contributo, limitandomi a segnalare la ricca discussione di R.
BUTTIGLIONE, nel cap. IV del suo Augusto Del Noce, cit. Ma si veda anche, di P. SERRA, Augusto Del
Noce. Metafisica e storia, cit.
10
A. DEL NOCE, Marxismo e salto qualitativo, in “Rivista di Filosofia”, 1948, p. 209. Si tratta di un
intervento di grande importanza, che Del Noce scrive in dibattito serrato nei confronti di Felice
Balbo, autore di Religione e ideologia religiosa, apparso nella medesima rivista e nella stessa
annata. L’oggetto del contendere è nelle posizioni critiche che Del Noce illustra con forti argomentazioni teoriche, rivolte all’indirizzo del “cristiano-marxismo” e dei “cristiani di sinistra”. Molto opportunamente, Mercadante ricorda, a riguardo, la lunga frequentazione che Del Noce ha del marxismo, in quanto lo assume come “un fenomeno epocale”, e perciò “lo analizza per circa quarant’anni”. (F. MERCADANTE, L’interpretazione filosofica della storia contemporanea, in D. CASTELLANO, (a c.
di Augusto Del Noce, cit., p. 31).
11
A. DEL NOCE, Marxismo e salto qualitativo, cit., pp. 209-210.
12
Ibidem.
13
Ivi, p. 211.
14
Ivi, p. 223.
15
A. DEL NOCE, La “non-filosofia” di Marx e il Comunismo come realtà politica, in E. CASTELLI (a
c. di), Atti del Congresso Internazionale di Filosofia, promosso dall’Istituto di Studi Filosofici, Roma
15-16 novembre 1946, vol. I, Il Materialismo Storico, Milano, Castellani e C. Editori, 1947, p. 381.
16
Ibidem.
17
A. DEL NOCE, Marxismo e salto qualitativo, cit., pp. 214-215.
18
A. DEL NOCE, Cartesio e la politica, cit., p. 7.
19
Con differenti argomentazioni, più volte sono apparsi articoli e interventi tendenti a criticare,
rettificare, respingere, il rapporto Gentile-Gramsci, per come Del Noce lo ricostruisce. Si vedano,
fra gli altri, B. DE GIOVANNI, Etica e religione in Giovanni Gentile, in M. CILIBERTO (a c. di), Croce e
Gentile fra tradizione nazionale e filosofia europea, Roma, Editori Riuniti, 1993. De Giovanni, per la
SAGGI
verità, è incline ad una distinzione fra Gentile e Gramsci assai più esile, sino a guadagnarsi la non
velata critica di essere traduttore “in campo “gramsciano” della riflessione di Augusto Del Noce”, (G.
LIGUORI, Gramsci conteso, Roma, Editori Riuniti, 1996, p. 254.); A. INFRANCA, Del Noce critico di
Gramsci e Gentile, in “Critica Marxista”, n. 4, 1994; F. IZZO, Filosofia della prassi e concezione della
modernità, in “Critica Marxista”, n. 2-3, 1987; L. LA PORTA, Gramsci secondo Del Noce o Gramsci
secondo Gramsci?, in “Critica Marxista”, n. 3, 1993; G. LIGUORI, Gramsci conteso, cit.; P. SERRA,
Tradizione italiana e “suicidio della rivoluzione”. Il momento genetico della centralità del nesso
Gentile-Gramsci nel modello analitico di Augusto Del Noce , in M. CILIBERTO (a c. di), Croce e
Gentile, cit.; P. SERRA, Osservazioni sul rapporto tra Del Noce e Gramsci, in C. VASALE-G. DESSÌ (a
c. di), Augusto Del Noce e la libertà, cit.; G. VACCA, Gramsci e Togliatti, Roma, Editori Riuniti, 1991;
G. VACCA, L’interpretazione di Gramsci nel secondo dopoguerra, in “Studi Storici”, n. 2-3, 1993.
20
Questa linea di evoluzione ‘filosofica’ del marxismo, da cui deriva Gramsci, è molto ricorrente
negli interventi sul Gramsci di Del Noce. Vale la pena di porne in evidenza il punto di approdo, ben
sintetizzato da Serra, (P. SERRA, Tradizione italiana e “suicidio della rivoluzione”, cit. p. 152). Qui si
parla di un “Gramsci filosofo”, come condizione per considerare autosufficiente il suo pensiero.
E’questa, per Serra, la tesi di Del Noce, che nella “filosofia” di Gramsci vedrebbe una sorta di allontanamento e quasi di fuoriuscita dal marxismo. Gramsci, così, sarebbe moderno perchè si allontana da Marx: è un’ interpretazione discutibile della posizione di Del Noce, che credo voglia accentuare, nel dirigente comunista, sì l’originalità, ma anche la dipendenza da un patrimonio -il marxismo/filosofia della prassi- tutto compiuto nel moderno.
21
Giustamente Serra conclude un suo intervento sul Gramsci di Del Noce (Tradizione italiana e
“suicidio della rivoluzione”, cit.), ponendo in evidenza che la filosofia della prassi è segnata da due
precisi caratteri distintivi: da una parte appartiene alla vicenda occidentale del marxismo; ma dall’altra parte essa domanda a sua volta una storicizzazione, in quanto attiene alla definizione della tradizione italiana del marxismo. Il rapporto fra marxismo e filosofia rimane così una definizione molto
larga, e molto attuale, per riproporre una distinzione critica all’interno di una precisa tradizione politica. Va tuttavia notato che, se il discorso di Del Noce utilizza, nel nesso fra politica e filosofia, l’occasione anche per un intervento di critica politica tout court, ciò non vuol dire che la sua lettura di
Gramsci debba servire solo ad una discussione sul gramscismo, come ‘stagione ‘ del marxismo
militante in Italia. Ad una simile conclusione indulge spesso Serra, pur in un contesto di idee molto
stimolanti. Personalmente ritengo che il filtro delnociano soccorra per identificare non poche ‘forzature’ del Gramsci degli anni ‘70; ma oltre questo aspetto, resta tutta da percorrere la ricerca di quello che il nostro filosofo voleva affermare, oltre Gramsci e oltre un’accezione non già solo del marxismo di Gramsci, ma anche della politica, nell’ultimo scorcio del secolo.
22
Per una più compiuta analisi della riflessione delnociana su Giovanni Gentile, è d’obbligo rinviare a A. DEL NOCE, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, il Mulino, Bologna, 1990.
23
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, Milano, Rusconi, 1992, p. 121.
24
Oltre i testi precedentemente richiamati, si veda G. GOISIS, Il suicidio della rivoluzione:
Augusto Del Noce critico del gramscismo, e G. M. POZZO, Augusto Del Noce di fronte a Giovanni
Gentile, entrambi in D. CASTELLANO (a c. di), Augusto Del Noce. Il pensiero filosofico, cit.
25
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, cit. pp. 122-123.
26
Ivi, p. 253.
27
Ivi, p. 126.
28
Rinvio, a riguardo, alle indicazioni fornite precedentemente alla nota n. 19 e, più ampiamente,
alla generosa ricostruzione di G. LIGUORI, Gramsci conteso, cit.
29
A. GRAMSCI, Il nostro Marx, in “Il Grido del Popolo”, 4 maggio 1918; ora in Scritti giovanili.
1914-1918, Torino, Einaudi, 1958, p. 217. Qui Gramsci si attiene ad una immagine di Marx assolutamente dettata dall’urgenza della politica e dalla categoria dell’attualità della rivoluzione, in questi
anni centrale per il giovane dirigente: “Marx è stato grande, –egli dice– […] perchè il frammentario,
l’incompiuto, l’immaturo è in lui diventato maturità, sistema, consapevolezza […] per questo fatto
egli non è solo uno studioso, è un uomo d’azione; […] i suoi libri hanno trasformato il mondo, così
come hanno trasformato il pensiero” (ivi, p. 218, passim). Nello stesso articolo Gramsci, sul modello già attivo nella classe dominante, inverte dichiaratamente il processo di acquisizione di autocoscienza, muovendo dalla pratica politica, verso la consapevolezza ideale dei fini: “La classe che
detiene lo strumento di produzione -egli scrive- conosce già necessariamente se stessa, ha la
57
58
cosienza, sia pur confusa e frammentaria, della sua potenza e della sua missione. Ha dei fini individuali e li realizza attraverso la sua organizzazione, freddamente, obiettivamente, […]”; (ivi, p. 219).
Ma sul giovane Gramsci, rinvio al testo, non recente, però molto ricco di analisi, di L. PAGGI,
Gramsci e il moderno principe, Roma, Editori Riuniti, 1970. Si veda anche di G. BERGAMI, Il giovane
Gramsci e il marxismo. 1911-1918, Milano, Feltrinelli, 1977, dove emerge una tesi su di un certo
gentilismo nel giovane Gramsci. Mi permetto, infine, di ricordare, sempre sulla formazione politica
giovanile di Gramsci, S. SUPPA, Il primo Gramsci. Gli scritti politici giovanili, (1914-1918). Napoli,
Jovene, 1976.
30
A. GRAMSCI, La rivoluzione contro il “Capitale”, in “Avanti!”, ediz. milanese, 24-11-1917 e in “Il
Grido del Popolo”, 12-1-1918; ora in Scritti giovanili, cit. p. 149: “La rivoluzione dei bolsceviki –scrive Gramsci– è […] la rivoluzione contro il Capitale di Carlo Marx. Il Capitale di Marx era, in Russia,
il libro dei borghesi, più che dei proletari. Era la dimostrazione critica della fatale necessità che in
Russia si formasse una borghesia, si iniziasse un’èra capitalistica […]. I fatti hanno superato le
ideologie […] I bolsceviki rinnegano Carlo Marx, affermano con la testimonianza dell’ azione esplicata, delle conquiste realizzate, che i canoni del materialismo storico non sono così ferrei come si
potrebbe pensare e si è pensato”, (ivi, p. 150, passim). Non è certamente poco, per antedatare la
critica del materialismo storico in Gramsci, nonchè la sua tendenza a capovolgere il rapporto fra
storia e politica.
31
Del Noce, nelle pagine introduttive del suo cit. Il suicidio della rivoluzione, richiama frequentemente gli anni e le esperienze del giovane Gramsci, con particolare riferimento al suo sodalizio
intellettuale con Piero Gobetti. Inoltre, alla p. 280 dell’op. cit. è menzionata, relativamente agli anni
di Il grido del popolo, la figura di Renato Serra. Infine, molto ripetuti sono i riferimenti al periodo e
agli articoli di L’Ordine Nuovo; in particolare, va richiamato l’articolo del 1° novembre 1919 in cui
Gramsci conia il termine del suicidio politico a proposito dei ‘Popolari’. Questo articolo è attentamente analizzato dal Del Noce, op. cit., pp. 260-261.
32
N. BOBBIO, Gramsci e la concezione della società civile, in P. ROSSI (a c. di), Gramsci e la cultura contemporanea, Atti del Convegno internazionale di studi gramsciani tenuto a Cagliari il 23-27
aprile 1967, Roma, Editori Riuniti, 1969.
33
La sintesi più ricca di questi riferimenti polemici, mi pare sia ricompresa, oltre che nei già citati contributi su Augusto Del Noce, in G. VACCA, Gramsci e Togliatti, cit.; G. LIGUORI, Gramsci
conteso, cit.; nei già menzionati interventi su Del Noce, di P. SERRA; e ancora B. DE GIOVANNI, Il
Marx di Gramsci, in B. DE GIOVANNI-G. PASQUINO, Marx dopo Marx, Bologna, Cappelli, 1985; L.
PAGGI, Le strategie del potere in Gramsci. Tra fascismo e socialismo in un paese solo. 1923-1926,
Roma, Editori Riuniti, 1984.
34
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, cit. p. 124.
35
Ibidem.
36
A. GRAMSCI, Socialismo e cultura, in “Il Grido del Popolo”, 29 gennaio 1916; ora in Scritti giovanili, cit., p. 25, Vale la pena di richiamare per esteso il brano, assai significativo: “È attraverso la
critica della civiltà capitalistica che si è formata o si sta formando la coscienza unitaria del proletariato, e critica oggi vuol dire cultura, e non già evoluzione spontanea e naturalistica. Critica vuol dire
appunto quella coscienza dell’io che Novalis dava come fine alla cultura. Io che si oppone agli altri,
che si differenzia e, essendosi creata una meta, giudica i fatti e gli avvenimenti oltre che in sé e per
sé anche come valori di propulsione o di repulsione. Conoscere se stessi vuol dire essere se stessi, vuol dire essere padroni di se stessi, distinguersi, uscire fuori dal caos, essere un elemento di
ordine, ma del proprio ordine e della propria disciplina ad un ideale.”
37
Cfr. U. SPIRITO-A. DEL NOCE, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, Milano, Rusconi, 1972,
pp. 112 e ss.
38
Sia pure in maniera più implicita e nell’ambito della serrata discussione sulle posizioni di
Franco Rodano, la critica del concetto di rivoluzione ritorna in A. DEL NOCE, Il cattolico comunista,
Milano, Rusconi, 1981, p. 347 e ss.
39
L’immagine deriva dal rapporto Socrate-Bruno, che Del Noce richiama: il primo è negato da
un dichiarato interesse della polis, distinto dalla “vita spirituale”. Il secondo è invece condannato al
rogo sulla base della “falsità” della sua filosofia, dichiarata tale da un potere politico rivestito, anche,
di autorità religiosa. Qui lo spirito, senza autonomia, è interamente rappresentato e posseduto dal
politico. La contraddizione fra relativismo della vita spirituale e assolutismo della vita politica, è il
punto di approdo di un ragionamento più vasto, al centro del quale vi è proprio la critica della logica
SAGGI
contraddittoria del rivoluzionario, ribattezzato da Del Noce “attivista”: “[…] il soggetto delle esperienze attivistiche –egli scrive– si riduce a volontà; e l’agire gli si presenta come un imperativo (soltanto nell’azione io affermo la mia esistenza come soggetto; il non agire coincide perciò con la
degradazione morale). Da ciò la prima fondamentale contraddizione dell’attivismo: l’azione a cui dà
luogo sarà necessariamente immorale, per il disconoscimento della realtà degli altri, e al tempo
stesso dovrà necessariamente esser mistificata come morale […] E, seconda fondamentale contraddizione: […] l’attitudine attivistica […] è segnata da un’essenziale politicità nel senso rigororso
che non può attuarsi che sul piano politico; ed è la contraddizione di questi suoi due fondamentali
aspetti a far sì che essa non possa esplicarsi che come distruttiva di una comunità […] Per conseguenza, l’attivismo deve dar luogo a un’ elevazione della politica a religione, che è un fenomeo
radicalmente nuovo nella storia”. (A. DEL NOCE, La “non-filosofia” di Marx, cit. pp. 382-383, passim). L’equazione fra riforma rivoluzionaria, e sua alterazione nell’asocialità della teologia politica, è
del tutto evidenziata. Essa è, nel linguaggio di Del Noce, la radice originaria della vocazione suicida
di ogni rivoluzione.
40
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, cit., p. 255.
41
Per non interrompere l’unità di questo importante passaggio, non sono state inserite nel testo
le citazioni utili a dimostrarne il fondamento. Riporto in nota, pertanto, pochi passi di una pagina di
Del Noce, in cui teoria delle sovrastrutture, nella sintesi della “riforma intellettuale e morale”, primato della politica e nesso con Gentile, sono facce del medesimo prisma teorico: “Quanto sinora si e
detto -scrive Del Noce- porta a riconoscere come le tesi gramsciane siano così concatenate che la
discussione sul loro valore si riduce a un punto unico: la pensabilità della sua filosofia come verità.
È cioè impossibile separare il giudizio sulla sua politica da quello sulla sua filosofia, perchè per lui
la politica è “filosofia in azione”; non nel senso di una politica che si modelli su una filosofia o si
subordini alla sua guida, ma in quello secondo cui la politica è la forma in cui la filosofia si esprime.
L’unità della teoria e della prassi è la liquidazione della “teoria”, perchè il pensiero è identico alla
prassi; [questo c.vo è mio]”. Poco oltre, Del Noce, per indicare l’idea di immanenza in Gramsci, ed il
suo carattere tutto risolto nel progetto politico, cita a sua volta un passo dei Quaderni, relativo alla
“riforma intellettuale e morale”, e vi aggiunge una significativa considerazione: “Perciò -egli scrive,
rileggendo le parole gramsciane- una riforma intellettuale e morale non può non essere legata a un
programma di riforma economica, anzi il programma di riforma economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale”. [A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a c.
di V. GERRATANA, Torino, Einaudi, 1975, vol. III, p.1561]. Portiamo l’attenzione sulla seconda parte:
avremo che il socialismo è la concretezza della riforma intellettuale e morale, perchè media il passaggio dall’individuo-singolo all’individuo-collettivo. E’ un pensiero che sottende sempre così gli articoli de “L’Ordine Nuovo” come i Quaderni. E sempre ritorna l’ispirazione gentiliana”. A. DEL NOCE, Il
suicidio cit., p. 304.
42
Ivi, p. 261.
43
La sintesi più efficace intorno alle ragioni della prima edizione dei Quaderni del carcere, quella cosiddetta ‘tematica’, o anche ‘togliattiana’, mi sembra sia nei due contributi di G. VACCA,
Gramsci e Togliatti, cit. e L’interpretazione di Gramsci nel secondo dopoguerra, cit.
44
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, cit., pp. 264-265, passim.
45
Spunti molto interessanti sul totalitarismo, sono già nel saggio di G. DESSÌ, Del Noce critico
del totalitarismo, in G. CECI-L. CEDRONI (a c. di), Filosofia e Democrazia in Augusto Del Noce, cit.
Dessì tratta l’argomento con particolare attenzione al doppio versante antifascismo-anticomunismo.
A suo giudizio, la tutela della libertà diventa in Del Noce preoccupazione centrale, dopo il ventennio
di regime, e anche dopo la vicenda di Ungheria. Sono, questi, argomenti certamente vivissimi nell’esperienza del nostro filosofo, ma io credo che il nodo del totalitarismo meriti anche un’altra spiegazione, teorica, ben più profonda rispetto alla pur vera e fondamentale opposizione ai sistemi politici senza libertà.
46
È il caso di citare le parole di Del Noce, al quale non sfugge la capacità innovativa del pensiero di Gramsci, rispetto alla sua stessa tradizione, nonchè la tendenza ad impostarvi i principi di una
teoria occidentale della transizione al socialismo, in alternativa alla continuità della formula del
sistema sovietico: “E’ ben nota -scrive Del Noce- la tranquillante risposta abituale: per resistenze e
contrasti che possa incontrare nell’URSS e nei Paesi satelliti, il processo di evoluzione democratica
è tuttavia irreversibile; nei Paesi occidentali i partiti comunisti tendono sempre più ad abbandonare
il modello sovietico per assumere il volto umano. Naturalmente, […] il processo non può che essere
59
lento; ma d’altra parte, non si può rinunciare né a quella grande parte di verità che il marxismo possederebbe, né al pluralismo. E’ nota anche la tesi opposta: la “barbarie” ha le sue radici filosofiche
nel marxismo stesso. Penso che proprio la considerazione del pensiero di Gramsci, in cui si deve
riconoscere, nelle intenzioni, il più liberale tra gli eredi del marxleninismo, possa portare a veder
chiaro in tale questione. A chi chiedere infatti la risposta se non a lui, come al più umano dei comunisti?”. A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione cit., p. 273.
47
Dessì ne parla già a proposito della critica del marxismo che Del Noce fa negli anni ‘40. (G.
DESSÌ, Del Noce critico del totalitarismo, cit.).
48
A. DEL NOCE, Il suicidio della rivoluzione, cit., pp. 273-274.
49
Ivi, p. 274.
50
Ivi, p. 276
51
Ibidem.
52
Ivi, p. 277
53
Ivi, p. 295
54
Ivi, p. 334.
55
F. FURET, Il passato di un’ illusione: l’idea comunista nel XX secolo, Milano, Mondadori, 1995.
56
Momento di particolare consapevolezza di questa mentalità, è certamente il testo-intervista di
GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Milano, Mondadori, 1994.
60
LIBERALISMO, IRENISMO,
VOLONTARISMO NELLA FILOSOFIA DI RORTY
1. Fondazione e filosofia politica
È necessaria una giustificazione razionale della società liberal-democratica?
A guardare i modelli più influenti che si sono succeduti in ambito anglosassone
a partire dall’opera di Rawls, Una teoria della giustizia, sembrerebbe che la
risposta debba essere affermativa. Sia in Rawls, sia in Gauthier, sia in Dworkin,
sia in Ackerman1 è individuabile una prospettiva fondazionalista e una preferenza per le spiegazioni genetico-razionali delle istituzioni liberal-democratiche. Le
procedure di validazione di queste istituzioni fanno capo, in ognuno di questi
pensatori, a un consenso tacito e trascendentale che i cittadini pienamente
informati dovrebbero avere verso quelle istituzioni che contribuiscono a mettere
in forma i loro conflitti2. Ossia, il problema etico-politico si può ridurre a questa
domanda: quali sono le regole che permettono l’accesso degli individui a quel
particolare torneo che è l’agone politico? Queste regole hanno, tuttavia, sempre
bisogno di essere supplementate da alcune altre, che specificano quali sono le
caratteristiche principali che individuano i decisori e anche la natura degli
asserti che si trovano a pronunciare.
Applicare l’etichetta di «realismo morale» a questi modelli, anche quando
l’enfasi è posta più sulle pratiche costruttiviste e/o coerentiste, non pare essere
una grande forzatura. Nella maniera più chiara questo è visibile nel lavoro filosofico di Rawls, e quando parla di costruttivismo kantiano e quando insiste sul fatto
che le condizioni specificate –la posizione originale, le condizioni di Razionalità
e di Ragionevolezza, e così via– valgono per noi cittadini delle democrazie occidentali, perché sono caratteristiche ascrivibili alla ragion pratica.
Non è sbagliato tentare di ordinare gli autori citati all’interno di una gradazione, a seconda che la giustificazione proposta sia più o meno forte. Si andrà
così dai modelli forti di Rawls e Gauthier a quelli depotenziati di Ackerman e
Dworkin. Ma sino a che punto può spingersi il depotenziamento del modello
giustificativo senza collassare? E ancora: è possibile rinunciare al modello
razionalistico di giustificazione etico-politica del liberalismo, mantenendo nel
contempo attraenti le nostre istituzioni liberali?
È nella risposta a queste domande che risiede l’importanza degli scritti di
Rorty3, poiché da un lato egli si colloca in pieno nella tradizione liberale americana, ma da un altro il suo percorso è un tentativo di fuoriuscire dal fondazionalismo. Su queste due coordinate deve essere, quindi, misurata la riuscita delle
sue analisi teoriche. Sorge naturalmente una prima difficoltà ermeneutica: mentre per gli altri autori citati è attestata una preoccupazione costante per le tematiche della vita associata, questa non è invece riscontrabile in Rorty. In effetti,
SAGGI
di Pierpaolo Marrone
61
62
presso il pubblico colto Rorty è divenuto noto con un volume di questioni epistemologiche, che a molti è sembrato come una sorta di de profundis della filosofia analitica4.
Il punto di partenza più appropriato per comprendere le sue posizioni in
ambito etico-politico è costituito però proprio da questo ultimo lavoro. Rorty vi
conduceva un attacco a fondo contro il «rappresentazionalismo», ossia contro
l’idea che lo scopo della filosofia sia la costruzione di una epistemologia e che il
fine dell’indagine teorica sia riuscire a spiegare ciò che la scienza lascia inesplicato. La vera essenza degli esseri contingenti che chiamiamo uomini sarebbe,
cioè, la conoscenza, e lo scopo asintotico del conoscere il rispecchiamento
della vera realtà. Da questo pregiudizio discende non solo una nuova forma di
superstizione che sostituisce alla religione la scienza, ma anche l’idea che il
mondo dello spirito sia diverso dal mondo della natura. Nella migliore delle ipotesi questi due mondi vanno ricostruiti a partire da opzioni epistemologiche
diverse: nel primo caso seguendo i criteri traballanti delle
Geisteswissenschaften ; nel secondo assumendo il rigore delle
Naturwissenschaften. Queste suddivisioni sono animate dall’«autoinganno che
consiste nel pensare di possedere una natura profonda, nascosta e ricca di
significato metafisico, tale da renderci ‘irriducibilmente’ diversi dai calamai e
dagli atomi»5.
L’intento di Rorty non era, tuttavia, una semplice messa in mora, condotta
con gli stessi strumenti dell’epistemologia della filosofia analitica, di siffatto
pregiudizio, quanto piuttosto la liquidazione del problema epistemologico,
ovvero la sua riduzione a una delle molte voci che compongono il mosaico
della conversazione umana. Non vi è un motivo fondante o epistemologico per
distinguere in questa conversazione quali voci debbano stare in primo piano
ed essere ascoltate, e quali debbano tacere. Espressioni come «la teoria
vera» o «la cosa giusta da fare» sono singolari. Non c’è un insieme di condizioni necessarie e sufficienti per individuarne un referente unico. «Nessuno
pensa che ci siano condizioni necessarie e sufficienti in grado, ad esempio, di
individuare il referente unico di ‘la migliore cosa da fare per lei in quella situazione piuttosto imbarazzante’ […]. Perché lo stesso non dovrebbe valere per i
referenti di ‘quel che avrebbe dovuto fare in quell’orribile dilemma morale’
oppure ‘la Vita buona per l’uomo’ oppure ‘ciò di cui il mondo è davvero
fatto’?»6. Il platonismo perenne, che sta sempre dietro ad ogni confutazione
del relativismo, è costretto a presumere che la varietà referenziale di «Vero»,
«Buono», «Giusto», e così via, sia una semplice contingenza e una distorsione correggibile in foro interno e in homine viatore. La teoria della conoscenza
ha sostituito il bisogno di Dio.
Le tesi di Rorty alla fine degli anni Settanta, se non avevano immediatamente a che fare con questioni di filosofia politica, non di meno, producevano
questo legame indirettamente, nel momento in cui venivano legate a tesi derivate dall’epistemologia della storia della scienza e, infine, ad altre dal sapore
esistenzialistico. Rorty, ad esempio, osservava che la divisione fra scienze
della natura e scienze dello spirito, lontana da dire qualcosa sulla nostra vera
essenza, è un modo ante litteram di proporre la distinzione kunhiana fra scien-
SAGGI
za normale e nuovi paradigmi di comprensione. La distinzione sarebbe soltanto che il primo modello è capace di raccontarci storie su uno sfondo consolidato e generalizzato di comprensione accettata, mentre il secondo cerca di tradurre linguaggi incommensurabili in altri commensurabili, introducendo nuove
storie che non possono venir assimilate dai vecchi modelli. I contrasti fra queste due sfere incominciano quando si ipostatizza il nostro linguaggio normale,
facendone l’unico criterio di comprensione. È chiaro, d’altra parte, che certi
ambienti culturali e politici favoriscono l’intersezione fra diversi linguaggi più di
altri.
Anche nel caso dell’antirappresentazionalismo è visibile un intreccio con la
dimensione etico-politica. L’antirappresentazionalismo di Rorty è, infatti, derivato
da due fonti: a) il concetto wittgensteiniano di gioco linguistico; b) la nozione heideggeriana di Dasein. Queste due fonti concorrono ad affermare che, a meno non
ci siamo noi a dare significato a qualcosa, nulla avrebbe significato (perciò nulla
sarebbe vero). Non perché vi sia una sorta di «forza che forma i fatti traendoli fuori
da una massa indeterminata, che costruisce la realtà da qualcosa di non ancora
abbastanza determinato da poter valere come reale»7, ma soltanto perché il
nostro linguaggio e il nostro corpo sono prodotti dell’ambiente in cui ci è toccato in
sorte di vivere, e questo vale a fiortiori per tutte le nostre pratiche sociali. Parlando
in gergo: il gioco linguistico umano è il suo essere-gettato nella dimensione naturale e storico-sociale.
Tramontata l’idea che «il nostro compito principale consista nel rispecchiare accuratamente, nella nostra Essenza Rispecchiante, l’universo che ci
circonda», idea che deriva dalla convinzione «che l’universo sia costituito di
cose molto semplici, chiaramente e distintamente conoscibili, e che la conoscenza delle loro essenze fornisca un vocabolario di base che permette la
commisurazione di tutti i discorsi»8, cosa ci rimane? Il sogno di una chiusura
dell’indagine non è nulla di più di ciò che Nietzsche pensava essere un desiderio di conforto metafisico, che si appaga trovando a tutti i costi dei punti di
riferimento.
A questa volontà di potenza Rorty contrappone un altro programma filosofico, quello ermeneutico. La novità dell’ermeneutica sta tutta nel tentativo di
isolare uno dei tre principali significati che nella nostra tradizione intellettuale
si sarebbero assegnati al termine «spirito». Abbiamo, da un lato, il dualismo
cartesiano e le varie versioni del trascendentalismo, che sono accomunate
dall’immagine dell’essenza rispecchiante. Dall’altro lato, abbiamo la nozione
romantica dell’uomo che crea la propria essenza. Vi è però una terza via, che
consiste nel «riconciliare il risultato ‘naturalistico’ [...] –che cioè ‘la irriducibilità’ delle Geisteswissenschaften non è una questione di dualismo metafisico–
con la nostra intuizione ‘esistenzialista’, che ridescrivere noi stessi sia la cosa
più importante che possiamo fare»9. La nostra ridescrizione non è una maggiore comprensione di noi stessi –che riprodurrebbe il pregiudizio conoscitivo
che attraversa l’intera tradizione filosofica–, ma ha una funzione di utilità
pragmatica. Una volta che si sia accettato che le essenze sono solo il prodotto di superficie dei nostri progetti, ridescrivere significa semplicemente ricreare.
63
2. Ermenentica, contingenza, volontarismo
64
Ci si dovrebbe chiedere se il proposito di ridescrivere e ricreare noi stessi
non rinvii, in maniera implicita e distorta, a quell’essenzialismo che Rorty ha
dichiarato morto. Di fatto, questo ritorno all’essenzialismo via la presa di distanza da ogni essenzialismo, è possibile nella filosofia rortiana grazie a uno stravolgimento della nozione gadameriana di wirkungsgeschichtliches
Bewusstsein. Ma l’abbandono del rappresentazionalismo non riduce, per Rorty,
l’indagine a uno scetticismo senza prospettive, o a un pessimismo anti-umanistico. Se ci troviamo su un piano dove esistono solo uomini, vale a dire enti che
creano, dobbiamo trovare allora una filosofia adeguata a dirigere la nostra
attenzione verso altre forme di pensiero che non abbiano, programmaticamente, preoccupazioni essenzialiste. E qui che Rorty tenta di far entrare l’ermeneutica gadameriana10. Questo inserimento avviene, però, nel solco di un titanismo
interpretativo, che risulta difficile attribuire, come fa Rorty, a Gadamer11. La
«coscienza della determinazione storica» sarebbe quella particolare torsione
intellettuale che ci permette di compiere un movimento teleologico rovesciato
rispetto alle filosofie del passato. Il compimento della storia, infatti, non starebbe nell’automanifestazione dello spirito razionale, né nell’assunzione del compito infinito della ragione da parte del filosofo funzionario dell’umanità, ma nella
manifestazione di una contingenza che appare in maniera privilegiata nel linguaggio12. Questo dovrebbe permetterci anche di vedere con maggiore malizia
la storia delle confutazioni del relativismo. «Il mio suggerimento che il desiderio
di oggettività è in parte una forma mascherata della paura della morte della
nostra comunità fa eco all’accusa di Nietzsche secondo cui la tradizione filosofica derivata da Platone è un tentativo di evitare di affrontare la contingenza, di
sfuggire al tempo e al caso»13.
Tuttavia, è proprio la volontà di potenza che Rorty rimprovera alla filosofia
atteggiata epistemologicamente, ciò che emerge sotto nuove spoglie. Infatti,
che cosa succede quando giungiamo a concepire la storia come contingenza
totalmente dispiegata, cui abbiamo un accesso privilegiato attraverso il medium
linguistico? Il sogno essenzialista forse tramonta, ma lasciando spazio alla
disponibilità di avere un accesso privilegiato alle diverse modalità con cui la
storia può contribuire a formarci, con un salto volontaristico non minore che nei
«sogni» positivistici e romantici. Il pragmatista che accetta pienamente la contingenza è inevitabilmente etnocentrico, ma senza le consolazioni di una teoria
della natura umana. Se parla di «diritti», egli sa che si tratta di un modo di dire
che noi dovremmo trattare certe categorie in un certo modo «senza trasformare
questa speranza in una teoria della natura umana. Egli vuole che la solidarietà
sia la nostra unica consolazione, in maniera tale da non richiedere un sostegno
metafisico»14. Il soggetto post-metafisico che Rorty ha in mente è, quindi, un
soggetto che vuole, che anzi può volere compiutamente perché non più vincolato da strutture metafisiche. Che può, in definitiva, scegliere la comunità liberale come quella che, etnocentricamente, meglio soddisfa il suo progetto di
appropriarsi, incondizionatamente, della storia come storia degli effetti.
SAGGI
La glorificazione della contingenza, derivata dal suo anti-essenzialismo, è,
però, qualcosa di meno di una visione spregiudicata. Si prenda quanto Rorty ha
da dire a proposito della contingenza dell’io. Abbandonata l’idea che l’essenza
dell’io sia la conoscenza e «l’autoconsapevolezza della nostra essenza»15 possiamo compiere il passo ulteriore e abbracciare una teoria metaforica della
verità, dove non c’è più bisogno di parlare di adeguazione o di rappresentazione, ma solo di interesse a distinguere fra metafore vive e metafore usurate.
Con Nietzsche abbiamo appreso come il mondo vero sia divenuto una favola,
ma non abbiamo perso anche ogni speranza di consolazione. Semplicemente
questa non andrà più ricercata nel trascendimento della nostra condizione animale, ma nella nostra autocreazione. «Creare la propria mente significa creare
un proprio linguaggio, e non lasciare che l’estensione della prima sia determinata dal linguaggio che altri si sono lasciati dietro»16. Ma cosa significa creare la
propria autodescrizione e come va collegata questa idea a quella di «coscienza
della storia degli effetti»? Per Rorty il legame sussiste in quanto entrambe non
sono che l’estrinsecazione di un’attività creativa che, essendo ovvio che non
parte dal nulla, utilizza in maniera libera i materiali di cui dispone: la tradizione
e il linguaggio.
Ma al passato della tradizione noi non abbiamo libero accesso nel senso in
cui vorrebbe Rorty. Non possiamo frequentarlo per trarne ciò che più ci aggrada. Pensare che un’entrata di tal genere sia accessibile significa ripetere l’equivoco della filosofia della coscienza trasparente. La coscienza della determinazione storica rimanda a un’oggettività che non è in nostro potere, non almeno
nel senso usuale in cui usiamo la parola «nostro», «mio», ecc. Noi stessi siamo
all’interno di questa coscienza come il suo effetto principale.
Per Rorty, tutto questo svanisce e si riduce al fatto che noi utilizziamo la tradizione come meglio crediamo per costruirci l’io che più corrisponde alle nostre
esigenze evolutive. Grazie a questo scarto assolutamente volontaristico, il
pragmatismo anti-fondazionale, liberale, individualistico eviterebbe così di praticare una filosofia della conoscenza e, nello stesso tempo, assumerebbe su di
sé il peso completo di questa decisione, eliminando di fatto ciò che comunemente si intende per «tradizione», che sarebbe non più storia di effetti, ma
vicenda continua di manipolazioni pragmatiche. La conoscenza è disposizione
alla manipolazione pragmatica di certi mezzi –il linguaggio, l’ontologia, l’ordine
delle prescrizioni etico-morali, e così via–, perché non vi è alcuna maniera di
formulare dei test di accuratezza della rappresentazione che siano indipendenti
dal successo che si ritiene dovrebbe spiegare questa accuratezza.
Questa curvatura scettica della conoscenza non ci fornisce alcun ausilio,
tuttavia, per decidere quali strumenti di orientamento conoscitivo siano da preferire a quali altri e perché. Dire che la fisica atomica funziona perché si riferisce al comportamento degli atomi, dal punto di vista gnoseologico, non è più
pregnante che dire che l’oppio procura sonnolenza per le sue virtù dormitive.
Allo stesso modo, ritenere che il modus vivendi che qualifichiamo come liberale
sia quello che meglio favorisce la varietà dei comportamenti adattivi e creativi,
non è nulla di più che una petitio principii. Per Rorty, che referenza, verità, corrispondenza siano credenze infondate al di fuori di una prospettiva pragmatica
65
66
non significa che dobbiamo abbandonarle in favore di nozioni più complesse e
sofisticate. Ritenere che questo sia possibile testimonierebbe di una volontà di
potenza antropocentrica ed idealistica, secondo la quale le cose devono in
qualche modo adeguarsi al pensiero che noi abbiamo di esse. Tuttavia, questa
stessa volontà è in opera quando Rorty pensa che la soggettività post-moderna
ci metta finalmente sulla strada di poter scegliere liberamente gli strumenti di
attuazione della nostra soggettività.
l pragmatismo anti-fondazionalista e anti-rappresentazionalista è compiutamente tale perché permette la trasposizione di tesi raggiunte in campo conoscitivo nel campo etico-morale. Così, le tesi anti-fondazionaliste enunciate in
campo gnoseologico valgono pure in ambito etico. Queste tesi sono sostanzialmente quattro: a) il termine «vero» non ha carattere esplicativo; b) la nostra
conoscenza di come adoperare espressioni come «vero di» è una derivazione
di una concezione causalista che è semplicemente quella del senso comune e
che si applica anche ai fenomeni dell’intenzionalità; c) non esistono relazioni
descrivibili in termini di “rendere vero” che intercorrono fra credenze e mondo;
d) la disputa fra realismo e anti-realismo è uno pseudo-problema dal momento
che presuppone che in qualche modo possa essere falso quanto asserito in c).
«Si noti che il pragmatismo così definito non offre alcuna teoria della verità.
Tutto ciò che ci offre è una spiegazione del perché, in quest’area, il meno corrisponde al più, del perché la terapia è migliore della costruzione dei sistemi»17. Il
pragmatista è come il linguista e l’antropologo che «non può prendere le mosse
dalla conoscenza dei significati nativi, acquisiti prima della conoscenza di credenze native, né dalla traduzione degli enunciati osservativi nativi, enunciati
che sono stati certificati mettendoli in corrispondenza con le stimolazioni. Egli
deve essere puramente coerentista nel suo approccio, continuando a girare in
tondo nel circolo ermeneutico finché comincia a sentirsi a suo agio»18.
3. Equilibrio riflessivo e interpretazione
L’uso che Rorty fa del termine «coerentismo» richiama il contesto in cui lo
stesso termine viene usato da Rawls e da Dworkin. Questo termine richiama
una sorta di tecnica per produrre enunciati (morali) ponderatamente perspicui.
Partiamo dall’assunzione di certi principi e saggiamoli sulla base delle nostre
intuizioni morali. Modifichiamo gli uni e le altre fino a raggiungere un assetto
stabile, l’equilibrio riflessivo. Ma quello che c’è di meno in Rorty è proprio il fine
che il coerentismo dovrebbe raggiungere, poiché non vi è alcun assetto stabile
da perseguire al di là della volontà del soggetto o del gruppo impegnato in questa pratica di credere di averlo raggiunto. Quando il circolo ermeneutico comincia a dare la sensazione di «farci sentire a nostro agio», questa sarà una giustificazione ex post di qualcosa che abbiamo già deciso di accettare. Il senso dell’affermazione che la verità non è un concetto con un uso descrittivo è proprio
questo.
È il nesso fra volontarismo e coerentismo che consente a noi, abitanti delle
SAGGI
società affluenti liberali, di abbandonare finalmente il sogno illuminista di stabilire un legame essenziale fra la nostra visione di noi stessi e la nostra visione
della società. È un retaggio illuministico l’idea che esistano unicamente due
strade, percorrendo le quali, gli esseri umani possono concepire la propria vita
come un tutto sensato (questa stessa passione per la totalità sarebbe, del
resto, un portato illuministico da superare). La prima strada è quella della solidarietà, che a sua volta conosce molte gradazioni diverse. Dalla appartenenza
senza prospettive di sviluppo individuale, all’idea che l’etica pubblica dell’accordo è solo una diversa funzione dell’etica privata dell’autocreazione. L’altra strada è l’oggettivazione, la messa in relazione dell’io con una realtà extraumana.
Mentre la relazione di solidarietà sarebbe ogni volta una relazione di mediazione, dell’io appunto con quelle particolari ed idiosincratiche forme in cui la solidarietà si esprime, la relazione di oggettivazione sarebbe immediata nel senso
che non dipenderebbe dalla nostra appartenenza solidaristica a una comunità.
La concezione anti-rappresentazionalista rappresenterebbe una rottura con
questa immagine della realizzazione individuale nella misura in cui verrebbe a
scoprire che anche la verità, così come il giusto e il bene, è motivata da una
«passione»19, cioè dalla volontà di adattamento all’ambiente circostante. Ma
non si può dire che questa idea assuma una qualche forma di dimostrazione
nella filosofia di Rorty, né costituisce, a mio modo di vedere, una giustificazione
di questo stile il fatto che Rorty abbia sostenuto che il compito della filosofia
debba essere in epoca postmoderna esortativo e non più argomentativo.
Riconoscendo che non c’è alcun bisogno per noi di collegare l’etica pubblica
dell’accordo reciproco con l’etica privata dell’autocreazione, si riconosce che il
bene dell’individuo viene a coincidere con la possibilità di usare in maniera la più
svincolata possibile le autodescrizioni che la sua capacità di adattamento gli
mette a disposizione. Tuttavia, per un individuo che assume in maniera esplicita
questo programma di vita non vi è alcuna necessità morale di un legame solidaristico. La ragione è abbastanza semplice. Se la moralità è lo sforzo di vincolarsi
impersonalmente, l’idea dell’autocreazione concepisce, invece, il vincolo reciproco come un limite da superare e non da riconoscere come proprio e costitutivo.
In quanto ente che si adatta, l’uomo è un ente che interpreta, ma questa attività
è sostanzialmente un’autointerpretazione20. Siamo per questo ora in grado, per
Rorty, di abbandonare quella tensione che si esprime nell’idea che vi sia un
legame fondamentale fra l’individuo e la comunità in cui vive. Rorty ne individua
lo strumento principale in una comprensione totalmente astorica del metodo dell’equilibrio riflessivo. «Finché si ritiene che le conclusioni politiche richiedano
fondazione extrapolitica –cioè fınché si ritiene insufficiente il metodo di Rawls
dell’equilibrio riflessivo– si vorrà che venga dato conto dell’“autorità” di questi
principi generali»21. Rorty è, tuttavia, in (consapevole?) errore nel ritenere che il
metodo dell’equilibrio riflessivo sia al servizio di un progetto etico-politico pragmatista e faccia parte di un programma di metaetica liberalizzata. È vero anzi il
contrario. L’equilibrio riflessivo è il movimento per tentativi attraverso il quale cerchiamo di adeguare le nostre intuizioni morali con i nostri giudizi ponderati allo
scopo di raggiungere quel punto di equilibrio dove il conflitto delle prime con i
secondi è stato tolto attraverso opportune modificazioni.
67
68
Il coerentismo morale rawlsiano è, quindi, ben altra cosa di un oltrepassamento dell’io nella direzione che Rorty ritiene compiuta o, altre volte,
auspicabile. Anche perché il progetto di Rawls è più esplicitamente universalistico di quello di Rorty. Rawls si rivolge agli individui liberali che possono
realizzare ora –e certo in base anche alle loro tradizioni e istituzioni politiche– la fusione di Razionale e Ragionevole. Rorty, viceversa, è costretto ad
abbracciare un deontologismo elitario che vede –per ora, almeno– solo alcuni gruppi in grado di comprendere il movimento di dissoluzione dell’io, il
quale a livello etico-politico permette la società liberale come comunità postmetafisica.
Tuttavia, Rorty è ancora preda di un’illusione metafisica che lo rende solidale proprio con ciò che vorrebbe «superare», nel senso che non riesce ad
allontanarsi da una concezione dell’individuo come centro decisionale, come
focalizzatore di progetti, come decisore etico-politico. Anche se l’individuo
liberale, che Rorty concepisce in maniera così ottimistica, non sarà propriamente al di fuori di qualsiasi relazione di gruppo, il bene del suo gruppo, inteso come comunità di personaggi eccentrici, programmaticamente privi di
punti di riferimento, i quali prestano la loro reciproca collaborazione in vista
della protezione reciproca, non sarà uno scopo comune, un progetto condiviso, bensì quello che Rorty descrive come un intreccio complicato di narcisismo privato e di pragmatismo pubblico, che altro non è se non la distorsione
del progetto di un consenso condiviso attorno a un concetto milliano di sperimentazione vitale.
Rorty quando sostiene che anche Rawls sarebbe partecipe di questo movimento, dal momento che il suo contrattualismo sarebbe nulla di più di una
descrizione sociologico-politica della comunità liberale22, interpreta il modello
rawlsiano come una struttura in cui anything goes, quasi che venisse lasciata a
noi la scelta delle ragioni che motivano la nostra adesione, trascendentalmente
sempre possibile e ripetibile, alla società liberale. Il velo di ignoranza, la struttura motivazionale del maximin, il Razionale e il Ragionevole, sono invece la possibilità costante di decidere sub specie aeternitatis.
Rorty è condotto nella sua valutazione positiva della filosofia politica americana, dall’idea che si tratti –almeno nelle sue varianti più celebri– di una versione aggiornata del pragmatismo. La tesi jamesiana della verità come ciò che è
utile nel senso della credenza è ciò che rimane dopo la reazione anti-essenzialista alla ricerca di fondamenti23. Mentre però Rorty si accinge ad abbandonare
l’eredità essenzialista del secolo dei lumi, non è invece disposto a dismetterne
un’altra altrettanto fondamentale, quella legata all’idea di progresso. Soltanto
che il progresso che egli ha in mente è la promozione di una cultura esteticizzata che presume sempre che la creazione di nuovi vocabolari sia ciò che riveste
il massimo valore per il progresso morale delle nostre società, nel senso che
una delle conseguenze secondarie24 di una diffusione generalizzata di questa
pratica sarebbe un nuovo equipaggiamento per la difesa delle libertà liberali via
l’accettazione incondizionata del pluralismo.
Anche in questo caso, Rorty ripete molta della struttura argomentativa di J.
S. Mill25. Ma Mill eseguiva la difesa del pluralismo sulla base di una persuasio-
SAGGI
ne che certo Rorty non può condividere: che la verità ha maggiori possibilità di
emergere sulla base del confronto delle opinioni che non laddove questo
scontro non avvenga. In Rorty il problema non è l’emergere della verità, per
quanto intesa come compito passibile anche di fallimento, ma l’adattamento
degli strumenti autocomprensivi alla mutevolezza dell’ambiente. Ma il successo di questi come viene misurato?26 Come possiamo giudicare della bontà
delle credenze da un punto di vista rortiano? In fin dei conti ciò che il pragmatista rortiano ci dice sono due cose: 1) che il senso di ciò che siamo è preformato nelle nostre credenze, aspettative, desideri, dall’insieme “normale” dei
giochi linguistici che costituiscono la nostra seconda natura quando diveniamo
partecipi, nelle qualità variabili che intercorrono dal ruolo di spettatori a quello
di attori, di una cultura storica; e 2) che questo, tuttavia, non ci autorizza a ritenere che esistano dei vocabolari privilegiati. Pensare che alcuni di questi
vocabolari lo siano dipende da elementi che si riducono alle preferenze degli
attori sociali. Ammesso che sia possibile scindere le preferenze del consumatore dalle sue opzioni etico-politiche, anche dopo questa mossa non saremmo
però affatto in possesso di un criterio extra-linguistico, se intendiamo l’espressione in quel senso ampio che è usato da Rorty. Infatti, le scelte di ordine
etico, morale, politico appartengono a pieno titolo agli apparati autodescrittivi
che l’individuo possiede. Le sue preferenze sono un riflesso dei suoi valori. Ma
passare da questa affermazione all’altra, secondo la quale dipende da noi
scegliere le maniere in cui parlare di noi stessi nell’agone pubblico per rispondere meglio ai problemi che dobbiamo affrontare, è una mossa in sé molto
ambigua.
Chi è mai quel «noi» di cui ci parla il pragmatista? L’idea che nuovi modi di
esprimerci ci possano essere d’ausilio per ottenere la soddisfazione dei nostri
desideri e il riempimento dei nostri fini ideali sembra essere in accordo con le
nostre esperienze adattive. E tuttavia, non vi è modo di decidere che queste
capacità adattive siano meglio esplicate all’interno della comunità liberale. Se
noi abbiamo come fine la tolleranza possiamo anche supporre che la comunità
liberale privilegi meglio questo movimento teleologico. Ma cosa accade se
abbiamo un’idea strumentale-prudenziale della tolleranza? Se assumiamo la
tolleranza come l’ambiente che permette di crearci una nicchia per i nostri
comportamenti e per i nostri vocabolari abnormi, perché dovremmo privilegiare questo valore rispetto a qualsiasi altro che permetta la nostra autorealizzazione? In Rorty però la stessa strumentalità dei valori, irenismo, volontarismo
nella filosofia di Rorty non può essere collegata più che contingentemente al
progetto di una migliore comprensione comunicativa fra gli esseri umani. E ciò
è del tutto in linea con il fondamento individualista della filosofia di Rorty.
L’unica soluzione che Rorty vede alla possibilità che una cultura liberal-democratica perda la sua forza di richiamo per i cittadini che la compongono è la
creazione di un ambiente dove il proliferare di una pluralità di linguaggi sia
favorita e incoraggiata. Ma questo è di fatto possibile, di nuovo, attraverso un
appello moralistico a un senso comunitario, sebbene centrato non su una
morale rigidamente normativa e sostantiva, bensì sull’assunzione del pluralismo stesso come un valore.
69
4. Consenso tacito, tradizione, traduzione
70
Il fenomeno dell’autocomprensione altro non è che il sottoprodotto di vocabolari generati in concrete e diverse temperie storiche e da essi non c’è nulla
che noi possiamo ricavare su che cosa significhi essere un soggetto e sul come
questa eventuale risposta vada collegata al nostro impegno di cittadini liberaldemocratici. Tutto quello che possiamo dire è che come, a livello ontologico,
siamo il prodotto dei vocabolari che ci hanno preceduto, così, a livello eticopolitico, non siamo altro che le intersezioni di discorsi pubblici transeunti. Non vi
è alcun sostrato che possiede queste interpretazioni così come non c’è alcuna
realtà non interpretata cui questi discorsi si riferiscono. Se l’io è l’incrocio di
interpretazioni, volta a volta, aperte alla dimensione pubblica o prossime alla
dimensione privata dell’autocreazione –e Rorty non ci dice quale sarebbe il
discrimine fra queste due dimensioni– allora il soggetto è comprensibile solo
come una serie di componenti che sono tutte transoggettive e convenzionali
nell’ambito della dimensione morale e nell’area della dimensione etico-pubblica.
Vi è qui la modulazione dell’idea ben nota che l’io è il prodotto e/o l’effetto
secondario o di superficie, di altre strategie, di costruzioni sociali, di convenzioni linguistiche e culturali. Di qui deriva l’atteggiamento ambiguo di Rorty verso
la tradizione. Infatti, potremmo pensare di poter ritradurre questo concetto in
quello di vocabolari che sono per noi distanti, ma verso i quali possiamo effettuare un’operazione di transcodifica. Rorty però sostiene che non è affatto
necessario svolgere quest’operazione. Mentre l’ermeneutica di solito afferma
che noi non siamo nelle condizioni di potere decidere se questa mossa possa o
non possa aver luogo, precisamente perché è questa strategia che già da sempre contribuisce a formare la nostra identità, Rorty sostiene che la strategia di
ritraduzione non è affatto tale, ma è solo un espediente tattico per adempiere al
nostro «vero» obiettivo strategico: la ridefinizione autocreatrice del nostro io. La
priorità della democrazia sulla filosofia, è la priorità della costruzione dell’ethos
sulla fondazione, attraverso il decentramento del soggetto sostanziale.
Ma cosa giustifica questa opzione se non un imperativo di carattere morale,
un impegno deontologico e anche un impegno ontologico, dove l’idea che la
nostra autocomprensione sia sempre mediata dalla delineazione di uno sfondo
pubblico di interpretazioni che definiscono la nostra fatticità, viene distorta nell’idea che nelle società liberali siamo in grado di trascendere queste limitazioni,
facendo della nostra costituzione attraverso il gioco della tradizione un progetto
liberamente scelto? A meno che non vogliamo assumere questa idea come la
prospettiva di accettare ciò che comunque non si può rifiutare, dobbiamo rivolgerci verso quell’aspetto titanico e romantico della filosofia di Rorty, che qui si
esprime nell’idea che la nostra fatticità è di genere del tutto particolare, dal
momento che siamo oggetti che si autocostituiscono, trascendendo i propri
attributi. Se è impossibile tentare di sfuggire al nostro punto di vista prospettico
nella speranza di guadagnare un accesso atemporale alla nostra costituzione,
che cosa Rorty ci propone in cambio? Una sorta di nichilismo nietzscheano
SAGGI
costruito attorno a quella che potremmo chiamare deliberazione non intenzionale. Mentre sino ad oggi l’uomo è stato guidato nelle sue azioni e, quindi,
anche nei suoi progetti politici, nella misura in cui questi sono stati lo specchio
di progetti etico-morali di dominio, da un rapporto di costrizione e di vincolo nei
confronti della propria tradizione, costrizione espressa, ad esempio, da contenuti quali «bene», «sacro», «bene comune», «giustizia», ora siamo in grado di
comprendere appieno e di dare attuazione all’espressione nietzscheana del
bambino che gioca con il mondo. Non si tratta più per noi, abitanti
dell’Occidente di perseguire nelle nostre costruzioni etico-politiche e nella
nostra moralità, pubblica o privata che sia, dei moduli veritativi, bensì di comprendere che i vecchi vocabolari attraverso cui la democrazia e le libertà sono
divenute per noi dei beni tangibili, sono dei vincoli oramai troppo stretti. In particolare, siamo ora finalmente in grado di valutare che bene e giustizia, moralità
ed eticità non hanno più bisogno di essere collegate a progetti sovraindividuali,
universalizzabili e atemporali. Il liberalismo e la democrazia sono quei sistemi
in cui, raggiunta una certa capacità di benessere, i cittadini possono giocare
con i vecchi vocabolari e crearne di nuovi non attraverso processi intenzionali,
ma come processi espressivi di sovrabbondanza, come la creazione di nuovi
orizzonti di libertà. Il progetto «politico» di Rorty ha, quindi, molto chiaramente
una matrice estetica, nel senso che la creazione di nuovi vocabolari può, almeno per una porzione ristretta di abitanti del pianeta, essere guidata da criteri
che non hanno a che fare con immediate preoccupazioni di salvaguardia del
benessere o dell’ordine politico27.
Rorty accoglie in pieno l’idea che su questo ordine ci sia un consenso tacito
che assume la forma di un trascendentale negativo che non ha bisogno di
essere questionato ed è perciò irrevocabile. Ma che dire allora di tutte quelle
persone che egualmente pensano a se stesse come cittadini delle democrazie
liberali e, tuttavia, non rinunciano a concepire la propria vita come significativa
in termini non meramente estetici? Quand’anche fossero prigioniere di un qualche significato metafisico insito nell’espressione «progetto di vita» –ammesso
che il pragmatismo rortiano ci autorizzi a dire che sono in errore –, non sarebbe
proprio questo a dare una descrizione più realistica di come per loro si svolgono le cose nelle nostre società?
Rorty ha comunque il merito di aver richiamato la nostra attenzione sull’insufficienza di certe porzioni dei nostri vocabolari in campo etico-morale, ma la
sua soluzione estetizzante è non per questo meno parziale. Ad esempio, che
cosa può voler dire il suo slogan di giocare con i vocabolari in un campo come
quello della bioetica, oppure riguardo alla questione ambientale o nel campo
degli squilibri distributivi fra aree più ricche e quelle drammaticamente povere
del mondo? Si guardi un attimo a questo ultimo problema. Alcuni lo hanno elegantemente evitato nel campo della filosofia politica dicendo semplicemente
che i criteri che vengono adottati nella descrizione del nostro ordine politico non
permetterebbero un’immediata possibilità di intervento a favore del riequilibrio
delle risorse planetarie. Così si è argomentato per il principio di differenza e il
maximin di Rawls; lo stesso risultato dovrebbe essere raggiunto per la concessione minimax relativa di Gauthier; Ackerman lo ha esplicitamente previsto per
71
72
certe applicazioni del suo dialogismo. Per Rorty come dovrebbero stare le
cose? Da una parte, si dovrebbe sostenere che il riequilibrio delle risorse non
potrebbe che favorire una feconda interazione fra vocabolari. Ma se la persona
non è altro che un riferimento continuamente cangiante a una rete di desideri,
di credenze e di emozioni che non fanno capo ad alcun progetto inscritto in una
qualche sostanza, come possiamo sapere che il nostro progetto politico contingente sarà quello che soddisfa le aspettative della parte più sfortunata del
mondo? In fın dei conti, questa immagine dell’io –la quale altro non è che una
dottrina metafisica– ha bisogno di un sostrato anch’essa e precisamente di
essere vera per i partecipanti al club liberale. Si può anche sostenere che quella di Rorty sia un’idea dell’io che discende logicamente in maniera più agevole
da alcune dottrine fondamentali del liberalismo, specialmente dall’idea negativa
di libertà, ma rimane da dimostrare che sia l’unica prospettiva dalla quale si
possono rendere attraenti le nostre istituzioni. Chi sarebbe disposto a combattere per difendere gli effetti secondari della liberal-democrazia che così tanto
entusiasmano Rorty? È facile piuttosto pensare che il soggetto di cui ci parla
Rorty si trovi maggiormente a suo agio in un’esistenza parassitaria rispetto
all’ambiente cui contingentemente si trova ad operare e che potrebbe muoversi
agevolmente anche in altri ordini che non siano quelli liberali. Si può credibilmente pensare che per la maggior parte delle persone le cose stiano così?
Molti di noi pensano che il riferimento a un qualche progetto complessivo di vita
sia parte integrante delle propria autodescrizione. Perché non dovremmo concederlo? Che cosa c’è da guadagnare ad aderire a una prospettiva come quella che ci propone Rorty?
Ad esempio, quando ci troviamo di fronte a un dilemma morale, suggerisce
Rorty, la nostra maniera di risolverlo non rappresenta il riferimento a principi
morali, ma semplicemente il fatto che quando abbiamo agito come abbiamo
agito, abbiamo anche scelto il vocabolario della riflessione morale al cui interno
la nostra scelta morale apparirà giustificata. La nostra fatticità è contemporaneamente la nostra responsabilità, poiché dipende dalle nostre costruzioni
decidere che cosa significa per noi stare nel mondo e che valore strumentale
vogliamo dare alle nostre intuizioni morali e alle nostre istituzioni politiche.
Risulta qui riconoscibile un paradigma descrittivo di derivazione esistenzialista,
anche se Rorty apparentemente rinuncia all’idea che sia necessario edificare
una metafisica o un’ontologia negativa per sostenerlo. Eppure questa ontologia
in Rorty non è mancante, ma semplicemente inesplicita ed è attorno ad essa
che, per Rorty, si struttura il consenso tacito delle genti liberali che cominciano
a vedere se stesse come reti mobili di credenze e desideri, come disegni a partire da vocabolari del tutto opzionali e da metafore, per lo più usurate, disponibili nel nostro ambiente.
Il rischio costante di Rorty è di fare dell’hegelismo rovesciato dove l’autocoscienza e lo spirito assoluto lasciano lo spazio a una teleologia estetica dei
valori che vede la storia come un ordine contingente alla luce di qualsiasi principio trascendente, ma non alla luce della nostra capacità adattiva, che innanzi
tutto è nostro dovere preservare e cercare poi di estendere. Rorty apparentemente restituisce a ognuno di noi la possibilità di essere protagonista di una
5. Liberalismo postmoderno e decisione
L’espressione «liberalismo borghese postmoderno» condensa quanto sin
qui detto della filosofia etico-politica di Rorty. È un’espressione che indica in
parte una descrizione e in parte un compito. Indica la capacità, post-moderna
appunto, di svincolarsi dalle grandi strategie meta-narrative del passato, ma
anche l’opportunità di farlo, poiché è «difficile districare le istituzioni borghesi
liberali dalla terminologia che queste istituzioni hanno ereditato dall’illuminismo
–per esempio la terminologia dei diritti del XVIII secolo che giudici e costituzionalisti come Dworkin devono usare ex officiis. Questa terminologia è costruita
intorno ad una distinzione fra moralità e convenienza [...] questa distinzione
[deve] essere reinterpretata in modo da adattarla alle esigenze di noi liberali
borghesi postmoderni»28. Anche l’idea rawlsiana che il soggetto morale sia un
soggetto razionale è figlia di questa prospettiva oramai tramontata. Sebbene
Rorty dimostri una certa vicinanza nei confronti di Rawls, questa non potrà passare attraverso l’adesione ai principali temi rawlsiani –velo d’ignoranza, ordine
lessicografico, principio di differenza, e così via–. In particolare, egli dovrà evitare di interpretare il cittadino liberale come colui il quale è messo nelle condi-
SAGGI
creazione culturale che ha la stessa dignità delle unità metanarrative che
avrebbero dovuto, in passato, conferire un senso trascendente alle vite individuali e che non possono essere più abbracciate in epoca postmoderna.
Dobbiamo abbandonare ogni progetto di completezza e prendere atto che non
c’è alcun progetto da compiere nel senso che risponderebbe meglio di altri a un
qualche ideale dell’io. Quello che facciamo è solo aggiungere relazioni e fili a
una ragnatela indefinita.
Ma non deve sfuggire che quanto Rorty dice sulla produzione della moralità
e dell’eticità in quanto legata inevitabilmente a prospettive etnocentriche vale a
giustificare qualsiasi sistema di relazioni umane, dall’utilizzazione degli schiavi
nei giochi circensi all’ordine politico liberale. Mentre quello che non segue è la
conseguenza che Rorty vorrebbe trarne: che abbandonando tutte le grandi
strategie metanarrative potremo finalmente trattare il nostro passato come un
immenso repertorio da cui trarre materiale per sperimentare nuove forme di
vita. E perché non, invece, un senso generalizzato di dispersione che non riesce a tradursi in progettualità attiva? È forse da essere d’accordo con Rorty che
questo non significa che la progettualità dispersa dei soggetti debba tradursi in
un collassamento dell’ordine politico, ma per ragioni che a Rorty sembrano
sfuggire, probabilmente in virtù del suo implicito individualismo. Infatti, un elemento su cui Rorty non insiste è la considerazione che le nostre istituzioni possiedono un’inerzialità molto più potente di quella degli individui, la quale permette all’ordine politico di sopravvivere alle crisi di valori che periodicamente
investono i cittadini e che certo trovano una notevole espressione in quella
demistificazione rilassata dei vari gerghi dell’autenticità che sono al centro della
polemica di Rorty.
73
74
zioni di ricreare il velo d’ignoranza e di ripristinare la condizione trascendentale
dell’adesione politica.
Per Rorty, questa stipulazione attorno a un nucleo trascendentale non può
sussistere. Ma continua ad esistere il trascendentale della sua negazione,
ossia sussiste l’espediente e la volontà di collocarsi in un tempo dove i vincoli
possono essere ignorati e l’individuo liberale può dedicarsi alla creazione di se
stesso. Questa è una sorta di «secolarizzazione» del velo d’ignoranza, con la
differenza che Rorty non ritiene che sia possibile sospendere le nostre strutture
idiosincratiche per ritrovare poi una struttura trascendentale con un contenuto.
Il velo d’ignoranza così secolarizzato non è l’uscita dal tempo storico che ci permette di collocarci in quel tempo trascendentale e parallelo che guida il primo,
ma è per Rorty direttamente il nostro tempo liberale borghese postmoderno. Se
trascendentale vi è, questo è puramente negativo, essendo solo una riduzione
del nostro ethos a una struttura di pura possibilità. Ma l’idea che la moralità,
intesa in senso rortiano come razionalizzazione delle nostre aspirazioni e di
parti significative del nostro sé, debba essere identificata con le pratiche e le
istituzioni correnti è errata, poiché non abbiamo affatto garanzie che questa sia
una relazione transitiva. A meno che non venga continuamente presupposto,
come di fatto accade, un consenso attorno a un nucleo normativo, che consente che la conversazione di quella porzione del genere umano che chiamiamo
Occidente non venga interrotta. Anche in Rorty c’è, quindi, in maniera abbastanza sorprendente, un presupposto di moralità. Ad esempio, non dobbiamo
più ragionare in termini di dignità umana intrinseca, ma facendo riferimento alla
«dignità comparativa di un gruppo con il quale una persona si identifica. Le
nazioni, le chiese e i movimenti sono, da questa prospettiva, esempi storici illuminanti non perché riflettono raggi che provengono da una fonte più alta, ma in
virtù di un effetto di contrasto con altre istituzioni peggiori»29. C’è da chiedersi,
naturalmente, come Rorty sia giunto a sapere che alcune istituzioni sono peggiori ed altre migliori.
Rorty pensa che noi dovremmo smettere di pensare alla distinzione fra
moralità e prudenza come a ciò che è richiesto dalla logica dell’imparzialità e
come a ciò che è richiesto in una situazione moralmente non impegnata.
Piuttosto dovremmo pensare alla prima come a un appello a ciò che è condiviso nella nostra comunità e alla seconda come ciò che viene consigliato dai
nostri interessi privati. Il conflitto può sempre sorgere, ma non perché si tratta di
un conflitto fra moralità e prudenza, bensì fra l’eticità del compromesso pubblico e della lealtà al gruppo e la moralità privata dell’autocreazione. La prima è
assoggettata alla pubblicità e si riduce sostanzialmente al tentativo di essere
imparziali, cioè giusti con gli altri. Ciò che conta però per Rorty è chiaramente il
secondo aspetto, la moralità privata della creazione del proprio sé, cui noi cittadini liberali possiamo compiutamente dedicarci.
Questa idea non ripropone ancora una volta l’idea di un vero soggetto,
che si troverebbe a proprio agio più nelle variazioni vertiginose dei vocabolari, che non nell’adeguamento a una qualche struttura normativa? In base a
che cosa Rorty si rende certo che il liberalismo estetico è la scelta migliore
se non a partire da una concezione individualistica del soggetto, che è la
SAGGI
stessa che percorre la filosofia politica nordamericana più recente?
L’appello alla moralità è semplicemente in funzione di capacità deliberative
che l’agente vuole attivare attraverso meccanismi di condivisione. Questo
avrebbe fatto in realtà Rawls naturalizzando Kant attraverso il velo d’ignoranza.
La moralità rimane pur sempre la prospettiva del noi, solo che questo noi non
viene inteso come ciò che fa di noi parte della comunità umana, ma come una
maniera abbreviata per dire che le nostre intenzioni sono più che idiosincratiche. Nella moralità liberale ciò che accade, da un punto di vista metaetico e da
un punto di vista sostantivo, è semplicemente una tolleranza per gli aneddoti e
non un attaccamento ai principi. Rorty è convinto che noi abbiamo tutto da guadagnare nell’approfondire questa abilità ironica e nominalistica di giocare con le
nostre tradizioni senza dover poi ritornare a un qualche punto di partenza per
chiederci quale di queste tradizioni sia quella vera. Il problema morale e quello
etico sono da vedere più come il tentativo di lasciar perdere i vecchi vocabolari
per acquisirne di nuovi che come la ricerca di un centro. Rorty è persuaso che
un’attitudine di questo genere sia il guadagno che possiamo trarre dalla democrazia liberale e sia anche nel contempo ciò che può sostenere le nostre istituzioni.
La scrittura seducente e la prospettiva allettante che Rorty ci mette di fronte
sono fonte di continui passaggi fra ambiti contigui e sovrapponibili, ma non del
tutto identificabili. Questo perché Rorty, sebbene sia così convinto e orgoglioso
del fatto che noi cittadini delle società occidentali affluenti possiamo finalmente
rinunciare a un centro e a un unico criterio di interpretazione, mantiene che le
democrazie liberali siano migliori di altre istituzioni, proprio quando i criteri che
dovrebbero presiedere alla nostra valutazione comparata delle istituzioni politiche divengono dei criteri «estetici». Se anche questo fosse vero, palesemente
però non ci direbbe ancora nulla sul carattere coattivo che l’ordine politico deve
possedere, dal momento che l’inerzia istituzionale è in certa misura garanzia
d’ordine, cioè di distanziamento dallo stato di natura e dall’individualità idiosincratica, che è proprio quell’idea di proprietà (essenziale, alla fin fine) che Rorty
sembra altrimenti ben valutare.
In Rorty, l’adesione al liberalismo è adesione a una struttura vuota, una
semplice possibilità di possibilità, una sorta di teleologia negativa che rende la
posizione di Rorty moralistica, anche se il suo moralismo è quello del laissezfaire. Ma è così ottimisticamente scontato che l’individuo postmoderno abbia a
disposizione una pluralità indefinita di giochi linguistici, di apparenze autodescrittive fra le quali scegliere liberamente quelle che meglio corrispondono alla
sua idea di liberazione? Perché il soggetto post-metafisico dovrebbe essere
libero da questi vincoli, se non perché Rorty ha ancora in mente una nozione di
individuo, di decisore autonomo, di autonomia etica, raggiunta attraverso una
opzione volontaristica che, in realtà, non può non essere ancora una volta una
decisione per il valore della comunità liberale? Quando Rorty ci parla della solidarietà liberale come il vincolo esteticamente rilassato, eppure costruttivo, della
nostra comunità etica, egli ancora una volta pensa il soggetto sul modello di
una tradizione metafisica, che è parte di quella stessa del razionalismo occidentale, che ai giorni nostri si incarna in maniere nuove ed interessanti, ma ben
75
lungi dall’essere oltrepassate o dall’aver bisogno di essere “superate”, nella filosofia politica americana. Una tradizione che attraverso il vincolo di ciò che volta
a volta si chiama velo d’ignoranza, diritti naturali, dialogo liberale, razionalità
strategica, liberalismo borghese postmoderno crede di potere fare a meno di
volere i valori della comunità liberale.
76
1
I testi di riferimento sono: J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982 (A
Theoy of Justice, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971); D. GAUTHIER, Morals hy
Agreement, New York, Oxford University Press, 1986, Moral Dealing. Contract, Etties, and Renson,
Ithaca, Cornell University Press, 1990; R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 1982
(Taking Rights Serionsy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977), Questioni di principio,
Milano, Il Saggiatore, 1990 (A Matter of Principle, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1986), L’impero del diritto, Milano, Il Saggiatore, 1990 (Law’s Empire, London, Fontana, 1986); B.
ACHERMAN, La giustizia sociale nello stato liberale, Bologna, Il Mulino, 1984 (Social Justice in the
Liberal State, New Haven, Yale University Press, 1980).
2
Ho argomentato estesamente in questo senso in Consenso tacito, Torino, La Rosa, 1996.
3
Si prenderanno in considerazione principalmente: La filosofa e lo specchio della natura,
Milano, Bompiani, 1986 (Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, Princeton University
Press, 1979), Conseguenze del pragmatismo , Milano, Feltrinelli, 1986 ( Consequences of
Pragmatism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982), La filosofia dopo la filosofia,
Roma-Bari, Laterza, 1991 (Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge, Cambndge University
Press, 1989), Scritti filosofici, vol. 1, Roma-Bari, Laterza, 1994 (Objectivism, Relatiuism, and Truth.
Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1991), Scritti filosofici, vol. II,
Roma-Bari, Laterza, 1993 ( Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers, vol 2,
Cambridge, Cambridge University Press, 1991).
4
Si tratta de La filosofia e lo specchio della natura, cit.
5
Ivi , cit., pp. 286-287. P. B L U M , “Heidegger and Rory on ‘The End of Philosophy”
«Metaphilosophy», 1990, pp. 223-238, avvicina i due pensatori in un generale trend anti-epistemologico, ma sarebbe più da mettere l’accento sulle differenze che li dividono, e in primo luogo sull’insopportabile profetismo heideggeriano che non è facilmente accordabile con il liberalismo.
6
La filosofa e lo specchio della natura, cit., p. 287; e Scritti filosofici, vol. 1, cit., pp. 127-147.
7
La filosofia e lo specchio della natura, cit., p. 5. Cfr. anche Conseguenze e del pragmatismo,
cit., pp. 124-148, per un esame della dialettica fra le posizioni che si incaricano di difendere il senso
comune e chi invece pensa che abbiamo tutto da guadagnare ad abbandonarlo.
8
La filosofia e lo specchio della natura, cit., p. 274. Sulle affinità fra questa sfiducia rortiana nell’epistemologia e la sfiducia socratica nella filosofia della natura e sulle sue conseguenze per un
atteggiamento ironico nella pratica dell’insegnamento filosofico, cfr. A. NEIMAN, “Ironic Schooling:
Socrates, Pragmatism and the HigherLearning”, «Educational Theory», 1991, pp. 371-384. Una
prospettiva più ampia è delineata in A. F ERRARA , “The Unbearable Seriousness of Irony”
«Philosophy and Social Criticism», 1990, pp. 81-107, che contesta a Rorty l’incapacità di discriminare fra vocabolari diversi. La cosa interessante è che Ferrara lega questa critica a un’altra, cioè
alla soprawalutazione rortiana della divisione che correrebbe fra autonomia privata del soggetto e
dimensione pubblica della giustizia.
9
La filosofia e lo specchio della natura, cit., p. 275. Da qui l’importanza che viene attribuita ai
linguaggi letterari. Cfr. Scritti filosofici, vol. II, cit., p. 119: “L’unica forma di distinzione filosofia-letteratura di cui abbiamo bisogno è una distinzione tracciata nei termini di un contrasto (relativo e transitorio) fra il familiare e il non-familiare, piuttosto che nei termini di un contrasto più profondo ed
SAGGI
emozionante tra il rappresentazionale e il non-rappresentazionale, o tra il letterale e il metaforico”.
10
M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica, Milano, Bompiani, 1988, chiarisce bene perché l’ermeneutica in Rorty non sia che un altro nome del declino dell’epistemologia. Ferraris giustamente
enfatizza i legami con l’esistenzialismo, che a mio awiso non vengono meno neanche quando la
riflessione di Rorty assume un legame più stretto con osservazioni di genere “filosofico-politico”.
11
Cfr. La filosofia e lo specchio della natura, trad. it. cit., p. 276: «Gadamer sviluppa la propria
nozione di wirkungsgeschichtliches Bewusstsein (il tipo di consapevolezza del passato che determina in noi un cambiamento) per caratterizzare un atteggiamento interessato non tanto a quel che
si dà fuori nel mondo, o a quello che è accaduto nella storia, quanto a quello che dalla natura e
dalla storia possiamo trarre fuori per nostro uso». Analoghe considerazioni vengono svolte a proposito di Heidegger e Derrida (Scritti filosofici, vol. 2, cit., p. 119: «Il grande problema esoterico comune a Heidegger e Derrida su come ‘superare’ o sottrarsi alla tradizione ontoteologica è un problema
artificioso che necessita di essere sostituito da un insieme di piccoli problemi pragmatici, in merito
ai quali si potrebbero usare frammenti di quella tradizione per alcuni scopi determinati.») .
12
La filosofia dopo la filosofia, cit., pp. 28-29. Su Nietzsche e Rorty, cfr. D. SHAW, “Rorty and
Nietzsche: Some Elertice Affnities”, «International Studies of Philosophy», 1989, pp. 3-14, e H.
VEATCH, “Deconstruciion in Philosophy” «Review of Metaphisics», 1985, pp.303-320.
13
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 42.
14
Scritti filosofici, vol. I, cit., pp. 41-42. Se prevalesse questa idea ciò non potrebbe avvenire
che in un moto generale che coinvolgerebbe anche l’epistemologia; cfr. p. 44: «Come si presenterebbe la retorica della cultura e in particolare delle discipline umanistiche? Presumibilmente, sarebbe più kuhniana, nel senso che menzionerebbe più concreti risultati particolari –i paradigmi–, e
meno il ‘metodo’. Si discuterebbe meno del rigore e più dell’originalità. L’immagine del grande
scienziato non sarebbe quella di chi attinge al vero, ma quella di uno che inventa cose nuove. La
nuova retorica attingerebbe più al vocabolario della poesia romantica e della politica socialista che
a quello della metafisica greca, della moralità religiosa o dello scientismo illuministico.»
15
La filosofia dopo la filosofia, cit., p. 37. Ma anche il creazionismo antropologico di Rorty non
può fare a meno di una nozione di autoconsapevolezza, che viene, ancora una volta, ricondotta a
Nietzsche. Cfr. p. 38: «[...] rinunciando al concetto tradizionale di verità Nietzsche non rinunciò all’idea di poter scoprire le cause di ciò che siamo. Non rinunciò all’idea che un individuo possa ricondurre all’origine l’impronta cieca recata da tutti i suoi atti. Rifiutò solo l’idea che si trattasse di un
atto di scoperta. Dal suo punto di vista, raggiungere questo tipo di autoconoscenza non vuol dire
arrivare a conoscere una verità che era già là fuori (o qui dentro). Per lui l’autoconoscenza era
autocreazione».
16
La filosofia dopo la filosofia, cit., p. 37.
17
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 171. Non è, per altro, del tutto ovvio che Davidson sia assimilabile al pragmatismo. Ad esempio, M. BAGHRAMIAN, “Rorty, Daridson, and Truth”, «Ratio», 1990,
pp.101-116, presenta la posizione di Davidson come una forma sofisticata di realismo, mentre l’interpretazione pragmatistica di Rorty non sarebbe compatibile con le sue posizioni causalistiche.
18
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 176.
19
La filosofia dopo la filosofia, cit., p. 38. Ma cosa succederebbe se questa idea fosse generalizzabile? L’esito sarebbe un universo di monadi che non comunicano fra di loro, e che proprio per
questo non saprebbero nemmeno che il loro linguaggio è creativo. La creatività può intrattenere un
rapporto ambiguo e parassitario –dialettico, se si vuole– con la tradizione, che Rorty manca di sottolineare.
20
«Questa comunità può essere quella storica reale in cui questi esseri umani vivono, un’altra
comunità reale, remota nel tempo e nello spazio, oppure una comunità del tutto immaginaria, forse
composta da una dozzina di eroi scelti dalla storia, dalla letteratura o da entrambe.» (Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 29). «Il mio argomento poggia sul ben noto assunto antikantiano [...], secondo cui i
‘principi morali’ (l’imperativo categorico, il principio utilitaristico, ecc.) hanno senso solo in quanto
fanno tacitamente riferimento a tutta una gamma di istituzioni, pratiche e vocabolari morali e politici.
Essi sono un promemoria e un’espressione abbreviata di tali pratiche, non la loro giustificazione. Al
massimo, possono essere un ausilio didattico per adottarle.» (La filosofia dopo la filosofia, cit.,
p.75).
21
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 245. I
22
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 241. «Rawls, sulla scia di Dewey, ci mostra come la democrazia
77
78
liberale può cavarsela senza presupposizioni filosofiche.» Sarebbe interessante sapere come questa interpretazione possa essere messa d’accordo con quanto afferma Rawls nelle Dewey
Lectures: «Quello che giustifica una concezione della giustizia non è il suo essere vera rispetto a
un ordine antecedente, e che ci viene dato, ma la sua congruenza con la nostra più profonda comprensione di noi stessi e delle nostre aspirazioni, e con la nostra consapevolezza che, data la
nostra storia e le tradizioni radicate nella nostra vita pubblica, questa è la dottrina più ragionevole
per noi.» (Kantian Constructivism in Moral Theoy, «The Journal of Philosophy», 1980, p. 519). Si
tratta di un passo dove Rawls mostra chiaramente come la sua impresa giustificativa vada intesa
come interna al progetto liberal-democratico. Ma è solo all’interno di questo progetto che risulta
adeguato parlare di Razionalità e Ragionevolezza etico-politiche. Il passo viene discusso da Rorty
in La filosofia dopo la filosofa, cit., p. 74-sgg.
23
Ma che rivela una nostalgia per il fondamento nella misura in cui ritiene di averlo trovato nel
linguaggio o nel testo.
24
L’idea della democrazia come insieme di conseguenze secondarie è stata ripresa recentemente da J. ELSER, Uva acerba, Milano, Feltrinelli, 1989 (Sour Grapes. Studies in the Subversion of
Rationaliy, Cambridge, Cambridge University Press, 1983), che la fa risalire sino a Tocqueville.
25
J. S. Mill, Saggio sulla lilbertà, Milano, Il Saggiatore, 1981 (On Libery, in Collecied Works, vol.
XVIII, Toronto, Toronto University Press, 1977).
26
Forse perché l’imporsi di nuove autodescrizioni crea quel particolare effetto di feed-back fra
linguaggio e ambiente capace di modificare la realtà? Non bisogna essere troppo entusiasti di glorificare gli strumenti di autodescrizione che abbiamo a disposizione. Facciamo un esempio banale: le
previsioni autoavveranti. Poniamo che un certo gruppo abbia una credenza sulla difficoltà di solvenza di una banca, per altro del tutto solida, e che riesca a trasmettere questa credenza alla maggioranza dei clienti della banca, che si precipiteranno a ritirare i propri depositi. La banca si potrebbe trovare ben presto in difficoltà, pur essendo la credenza di partenza del tutto infondata. Si tratterebbe di un cattivo uso delle credenze veicolate dal linguaggio alla realtà, ma tuttavia potrebbe
ancora essere un adattamento riuscito per chi aveva quella credenza. O prendiamo un sistema
politico totalitario. Uno dei problemi sollevati dai totalitarismi di questo secolo è stato appunto la formazione dell’uomo nuovo, ciò della messa a punto di sistemi descrittivi che o avevano un rapporto
di radicale alterità rispetto al passato o intrattenevano un rapporto di estrema ambiguità con la tradizione. Il fatto che fortunatamente questi sistemi abbiano fatto nel passato recente fallimento non
è però attribuibile a qualcosa di intrinseco ai vocabolari che tentavano di imporre, ma a contingenze
storiche di altro genere.
27
Ma non vi è nessuna garanzia di estendere questo modello al di là dei ristretti gruppi cui
Rorty pare riferirsi (gli abitanti delle società affluenti? quelli della California?), così come non affatto
chiaro perché dovremmo abbracciare questo ideale estetico, una volta che fossimo mossi dalla
preoccupazione di fornire una teoria del soggetto umano al liberalismo. Inoltre, in Rorty rimane
misterioso il legame fra questa teoria del liberalismo e altre questioni, ad esempio l’estensione del
modello liberal-democratico, i problemi della giustizia globale, e così via.
23
Scritti filosofici, vol. I, cit., p. 268.
29
Ivi, p. 270. Di qui anche la speranza ottimistica di Rorty secondo cui il progresso morale esiste, e va proprio in direzione di una maggiore solidarietà umana. Quest’ultima tuttavia non «consiste nella consapevolezza di qualcosa presente in tutti gli uomini. Consiste piuttosto nel saper togliere importanza a più e più differenze tradizionali (di tribù, religione, razza, usi, e simili) in confronto
alla somiglianza nel dolore e nell’umiliazione, nel saper includere nella sfera del ‘noi’ persone
immensamente diverse da se stessi.» (cfr. La filosofia dopo la filosofia, cit., p. 221).
IGNAZIO SILONE NELLA PROSPETTIVA
FEDERALISTICA ED EUROPEA
Qualche considerazione preliminare ci sembra opportuna almeno solo per
situare il nostro tipo di approccio, oggi, ad un’opera e ad un autore dello spessore di Ignazio Silone.
Avremmo potuto “armarci” degli strumenti più raffinati della critica letteraria e
filosofica, potevamo permettere al nostro stesso contatto una breve e ampia
ricognizione delle tesi critiche più accreditate o, anche, cominciare con uno studio dell’ambiente e del clima, della razza e delle influenze per poi riproporci di
arrivare finalmente a “leggere Silone”1. Non avremmo, forse, più finito ed a
Silone non saremmo mai arrivati!
Abbiamo voluto invece, metodologicamente, spogliarci di orpelli e di strumentazioni accademiche per andare “incontro a Silone” nella nostra situazione
nuda e sprovveduta chiamando a farci compagnia e guida quel Charles Péguy
che tante volte è stato accomunato nello stile e negli atteggiamenti, nelle idee e
nel metodo, ad Ignazio Silone.
Sappiamo, così, che in genere sono possibili tre tipi di lettura, soprattutto
quando ci si imbatte in una grande opera e nell’opera di un sicuro genio: a)
possiamo mettere in opera una “buona lettura” capace di coronare e far vivere
ancora e far fruttificare al meglio l’opera o, purtroppo, per il limite delle nostre
capacità ed il livello delle nostre intenzioni dar corpo e movimento ad una b)
“cattiva lettura” che fa sì che l’opera viva ancora ma che indubbiamente la sfigura e la snatura, la violenta e la ferisce o, infine, possiamo anche optare per
uno c) “zero di lettura” ed infliggere all’opera la peggiore offesa: una morte
garantita e, forse, potrebbe anche essere definitiva2.
Ci siamo accorti così che l’opera è come un “coniglietto” nelle nostre mani e
mette alla prova non solo la nostra responsabilità ma anche la “delicatezza” e
la “cura” della nostra lettura3. Allora chiediamoci se è il caso di leggere ancora
Silone oggi e, se riteniamo di rispondere in senso affermativo, chiediamoci
come dobbiamo leggere Silone. Per quanto ci riguarda, dobbiamo, e cercheremo di farlo, facendo di tutto per tornare ad essere “lettori ideali” e “puri”: “dei lettori puri, che leggono per leggere, non per istruirsi, non per lavorare; dei puri
lettori, come sono necessari alla tragedia ed alla commedia dei puri spettatori,
come occorrono alla scultura dei puri spettatori, che da una parte sappiamo
leggere e dall’altra vogliano leggere, che infine semplicemente leggano; e leggano semplicemente; degli uomini che guardino un’opera semplicemente per
vederla e per riceverla, per alimentarsene, per nutrirsene, come di un alimento
prezioso, per farne elemento della propria crescita, per avvalersene, interiormente, organicamente, niente affatto per lavorare con, per avvalersene, socialmente, nel secolo; anche degli uomini, degli uomini infine che sappiano legge-
SAGGI
di Angelo Prontera*
79
80
re, e che cosa è leggere, cioè che è entrare in; in che cosa? Amico mio; in un’opera, in una lettura di un’opera, in una vita, nella contemplazione di una vita,
con amicizia, con fedeltà, anche con un certo compiacimento indispensabile,
non soltanto con simpatia, ma con amore; bisogna entrare come nella sorgente
dell’opera; e letteralmente collaborare con l’autore”4.
In questo clima e con questi intenti, cominciamo quindi a leggere, scegliendo quasi per caso, ma così non è, un’opera che ci scuote e ci mette in questione e ci tocca in modo particolare: L’avventura di un povero cristiano5.
In effetti, il nodo essenziale della vita e della scrittura, della riflessione e dell’azione di Ignazio Silone è, ci sembra poco discutibile, “la problematica eticoreligiosa” poiché, dice Silone, ci interessano davvero “i contrasti morali e di
pensiero”6 e, d’altra parte, continua: “Se uno scrittore mette tutto se stesso nel
lavoro (e che altro può metterci?) la sua opera non può non costituire un unico
libro. Ho già detto in altre occasioni che, se fosse stato in mio potere di cambiare le leggi mercantili della società letteraria, avrei amato passare la vita a scrivere e riscrivere sempre la stessa storia, nella speranza, se non altro, di finire
col capirla e farla capire”7.
Così, L’avventura di un povero cristiano si situa immediatamente all’interno
di “una storia del cristianesimo popolare italiano” ancora quasi tutta da fare e
che dobbiamo fare perché, tutti situati e preoccupati e presenti “al presente”
sappiamo comunque “che certe realtà del presente hanno radici lontane”8. C’è
infatti bisogno di un accurato e faticoso “lavoro di scavo” per raggiungere e far
emergere il ed un “sottosuolo” come, in particolare, quello “meridionale in cui,
da Carlo Cafiero e gli anarchici di oggi, risalgono fino a Gioacchino da Fiore”9.
È un lavoro di geologo e di archeologo quindi quello al quale veniamo invitati a partecipare in compagnia di questo “genio poetico del pensiero”10.
È che in questa ricerca, in quest’opera di scavo alla ricerca di una tradizione
profonda ci si accorge subito, soprattutto dopo le eccezionali pagine di Péguy
che qui non possiamo non richiamare ad illustrazione11, si tratta proprio di dar
corpo ad una “rivoluzione”: al di là, in profondità, della carità cristiana e cattolica
che abbiamo conosciuto, si tratta di ritrovare il senso e la sorgente di una “solidarietà socialista” che sappia essere più autenticamente e più profondamente
umana, tenendo presente che una rivoluzione “è un appello di una tradizione
meno perfetta ad una tradizione più perfetta, un appello da una tradizione
meno profonda ad una tradizione più profonda, più vera, più antica e, così, più
eterna. Una rivoluzione è una piena rivoluzione se mette, per così dire, in circolazione, più radicata, dove non erano pervenute le rivoluzioni precedenti”.
Insomma, “lungi dall’essere un superamento in superficie, come si crede troppo
generalmente, una rivoluzione è uno scavo, un approfondimento, un oltrepassamento in profondità”12.
Silone infatti, scrollandosi da dosso tante maschere ideologiche, tante incrostazioni culturali e scolastiche ci tiene a precisare che le etichette di “liberale”,
“radicale”, “socialista” […] non lo toccano e non lo interessano affatto. No, cari
miei, appartengo ad un’altra razza, “appartengo ad un’altra discendenza. Mi
considero, per così dire, post-risorgimentale e forse anche post-marxista (postmoderno anche). Tanto nell’ideologia, quanto nella sensibilità”13.
SAGGI
Ma con queste intenzioni e con questa sensibilità ci si può meravigliare se
un vecchio compagno di scuola, portinaio al manicomio di Collemaggio, lo
accoglie, in occasione di una fugace visita, con l’esclamazione “Finalmente!”
poiché da tanto tempo si augurava, per la vecchia amicizia, e si aspettava il
suo “internamento”, il cui ritardo gli era “incomprensibile”, a causa del fatto,
risaputo, che egli era “sempre contro il governo”?
Allora, eccoci invitati a tenere compagnia ad Ignazio Silone sulle tracce di
Celestino certo non come in una gita, ma quasi in un pellegrinaggio. Ma a che
scopo? Non si tratta di una meta semplice ed univoca ma piena e ricca perché
si tratta di mettersi in viaggio per a) salvarsi dalla tentazione del potere; b) per
ritrovare la spontanea a temeraria solidarietà della povera gente di quel tempo;
c) per riassaporare il gusto e la possibilità di relazioni umane assolutamente
pure e disinteressate.
Questi bisogni e queste intenzioni si rivelano d’altra parte non tanto come
manie intellettualistiche ed astratte quanto piuttosto come “scelte di vita” che
fanno di Silone uno strano ed eccezionale esempio di cristiano che è anche
socialista che si fa anche cristiano per ridare orizzonte e prospettive umane ad
un socialismo che rischia di perderle, nello spirito, sempre rinascente, di parte e
di partito.
Ciò perché in lui “sul sentimento cristiano della fraternità ed un istintivo
attaccamento alla povera gente, sopravvive anche, vi ho già accennato, la
fedeltà al socialismo”14 purché per socialismo si intenda e si pratichi e si viva
una “economia al servizio dell’uomo”.
Ma per tutto ciò Silone è in grado di avanzare anche dei suggerimenti? Ne
emergono dall’Avventura di un povero cristiano?
Se per suggerimenti si intendono “ricette” confezionate e immediatamente
spendibili riteniamo di no, se invece ci si aspettano “proposte” ed idee regolative da sottoporre modestamente alla libertà ed alla vita di ognuno, l’opera ne è
piena. Qui vogliamo, in modo quasi indicativo, segnalare alcune di queste “idee
regolative”.
Una prima sottolineatura, essenziale anche, vedremo, per il tema che ci
siamo assunti, è quella relativa alla necessità di piccole comunità “libere, provvisorie e senza patrimonio”15 all’interno delle quali soltanto ci si può far carico
della miseria e del “dar da mangiare agli affamati”16. Certo, non bisogna aver
paura delle parole e riconoscere che è necessario un certo stile, una anarchia
insomma “come un modo di vivere insieme, secondo la carità e non secondo le
leggi”17. Solo in queste condizioni è infatti possibile costruire uno stare insieme
nel quale non vi sono “né padroni né servi, in casa del Padre, ma solo figli
eguali e liberi”18.
Bisogna così, reimparare a “diventare semplici”19 assumendo la povertà
come condizione favorevole “alla salute dell’anima”20 e tutto questo perché, ci
tiene a sottolineare Silone, “non intendo separarmi dal modo di vivere della
povera gente, a cui appartengo”21.
È lontano comunque, Silone, da qualsivoglia ottimismo cieco e dalle facilonerie dei facitori di parole e dei costruttori di sogni ad occhi aperti anche perché
egli sa quanti e quali siano le difficoltà e gli ostacoli che impediscono spesso
81
82
anche a rispettabili progetti di realizzarsi. Lucidamente si rende conto non solo
che la grande comunità, che chiede compromessi e transazioni, uccide questo
spirito22 ma sa anche che il pericolo maggiore viene dalla profonda “tentazione
del potere” che subdolamente è anche capace di servirsi di noi23. Se a questo si
aggiunge “che raramente i nuovi ricchi si considerano sazi”24 e che la acida
“invidia”25 corrode spesso anche le relazioni più spontanee e più forti, bisogna a
tutti i costi temprarci per liberarci dallo spirito di comando poiché non si tratta
proprio tanto di comandare, ma di amministrare e servire.
È evidente qui che Silone intende porsi sulla retta che fa sue le “ispirazioni
benedettine, joachimite e francescane” nell’attesa e nella preparazione di una
“nuova età del genere umano, “nell’attesa e nella preparazione di una “nuova
età del genere umano”, un’età “senza Chiesa, senza coercizioni, in una società
egualitaria, sobria, umile e benigna, affidata alla spontanea carità degli uomini”26. Ed egli sa bene che questo non è un tema “archeologico, o di pura erudizione, almeno non da noi, dato che il mito del Regno non è mai scomparso
dall’Italia meridionale, questa terra di elezione dell’utopia”27. D’altra parte bisogna pur riconoscere che “la storia dell’utopia è in definitiva la contropartita della
storia ufficiale della Chiesa e dei suoi compromessi col mondo”28. Una utopia
insomma che viene assunta in tutto il suo spessore sia perché essa si rivela
come “il rimorso” della Chiesa29 sia perché l’utopia rappresenta non un sogno
ma il progetto ed il segno di ciò che ancora non c’è ma che può essere e […]
dipende da noi come rivoluzione e speranza: “Se l’utopia non si è spenta, né in
religione, né in politica, è perché essa risponde a un bisogno profondamente
radicato nell’uomo. Vi è nella coscienza dell’uomo un’inquietudine che nessuna
riforma e nessun benessere materiale potranno mai placare. La storia dell’utopia è perciò la storia di una sempre delusa speranza, ed è importante saperla
riconoscere anche sotto connotati diversi”30.
Lo stesso Péguy, d’altra parte, aveva fatto notare che si trattava di un riandare in profondità, alle sorgenti, per far “venire alla luce”31.
Rispetto a questa “utopia” ed a queste profondità di vita e di sensibilità le
ideologie si rivelano “maschere, o alibi, o ornamenti. Perché, la spiritualità di un
serio movimento di popolo non si esaurisce mai nell’ideologia”32. Qui c’è una
certa inestirpabile diffidenza a “concepire la vita pubblica altro che come inganno, ruberia e camorra, indipendentemente da chi sia al potere” poiché “l’unico
vantaggio di una democrazia basata sul voto individuale è che questo, coscientemente usato, può consentire anche ai più poveri l’accesso ad una camorra”33.
Anche un certo “federalismo” così rischia di figurare come “ideologia superficiale” di fronte ad un “ecumenismo contadino ben più sostanzioso e profondo
del cosmopolitismo superficiale”34. Un federalismo può rischiare di essere un’organizzazione istituzionale degli egoismi ed una contrapposizione di tribù e di
etnie mentre l’ecumenismo di cui parlavamo può far anche scoprire e nascere
un senso di solidarietà e di fratellanza con abitanti di una Siberia lontana nello
spazio ma vicina nel cuore e nella fratellanza messa in opera e vissuta: “Quei
cari, piccoli, poveri, Ostyak […] ci somigliano come fratelli”35.
C’è bisogno allora di prendere il treno e di andare in Europa? a Maastricht?
Forse, e qui siamo noi a prestare a Silone espressioni ed atteggiamenti,
* Relazione tenuta al Convegno: “Ignazio Silone tra letteratura e vita nella prospettiva federalista ed europee” Cepagatti (PE), 23 novembre 1997. Angelo Prontera, tra i primi collaboratori e fondatori di questa rivista, è deceduto nel luglio 1998.
1
“Ora l’idea moderna, il metodo moderno consiste esattamente in ciò: essendo data un’opera,
essendo dato un testo, come lo conosciamo? Cominciamo col non toccare affatto il testo; ciò, è la
fine; se ci si potrà mai arrivare! […] Dobbiamo studiare, ci proponiamo di studiare La Fontaine; piuttosto che cominciare dalla prima favola che ci capita, noi cominceremo dallo spirito gallico; il cielo;
il sole; il clima; gli alimenti; la razza; la letteratura primitiva; poi l’uomo; i suoi costumi; i suoi gusti; la
sua dipendenza; la sua indipendenza; la sua indipendenza; la sua bontà; la sua infanzia; il suo
genio; poi lo scrittore; i suoi primi tentativi classici; le sue fuoriuscite gallicane; la sua epopea; la
sua morale; poi lo scrittore, etc. etc.” (C. PEGUY, Questioni di metodo, a c. di A. Prontera, Lecce,
Milella, 1993, pp. 61-62).
2
Cfr. C. PEGUY, La Lettura, a c. di A. Prontera e G. Antonelli, Lecce, Milella, 1992, pp. 30-31.
3
“È spaventoso, amico mio, pensare che noi abbiamo ogni licenza, che noi abbiamo questo
diritto esorbitante, che noi abbiamo il diritto di fare una cattiva lettura di Omero, di decoronare un’opera del genio, che la più grande opera del più grande genio è messa nelle nostre mani non inerte
ma vitale come un coniglietto. E soprattutto che facendola cadere dalle nostre mani, da queste
stesse mani, da queste mani inerti possiamo con l’oblio amministrarle la morte. Che spaventoso
rischio, amico mio, che spaventosa avventura; e soprattutto che spaventosa responsabilità” (Ivi, p.
37).
4
Ivi, pp. 23-24.
5
I. SILONE, L’avventura di un povero cristiano, Milano, Arnoldo Mondadori, IV edizione, 1968.
6
Ivi, p. 10.
7
Ivi, p. 10-11.
8
Ivi, p. 9.
9
Ibidem.
10
“Genio poetico del pensiero” è un’espressione che Péguy aveva utilizzato per qualificare
Corneille (Cfr. C. PEGUY, Nota congiunta su Cartesio e sulla filosofia cartesiana, ora in C. Peguy,
Cartesio e Bergson, a c. di A. Prontera e M. Petrone, Lecce, Milella, 1977). La stessa è stata ripresa da R. SECRETAIN nel suo saggio: Péguy un genio poetico del pensiero ora in traduzione italiana
in A. PRONTERA, Ipotesi e proposte esistenziali, Lecce, Milella, 1980, pp. 177-187. Ora io la faccio
mia e la applico a Ignazio Silone.
11
“Una rivoluzione, mentale, sentimentale, politica, sociale, e tutte le altre, sia che si tratti di una
rivoluzione religiosa e totale nell’animo di un Poliuto o di una rivoluzione politica, sociale o religiosa
nell’animo di tutto un popolo, una rivoluzione non consiste affatto essenzialmente a pensare, a sen-
SAGGI
Silone risponderebbe: “Andateci voi […] io preferisco andare nelle grotte della
Maiella per ritrovare me stesso, le mie radici, il mio popolo, quello che mi ha
fatto e mi nutre e, se proprio volete, per costruire una casa comune, devo
restaurare, rivivere e non abbandonare quella grotta”.
Certo, e qui ritorna Silone, “siamo ridotti in pochi” anche se sono sicuro che
“vi sarà sempre qualche cristiano che prenderà Cristo sul serio, qualche cristiano adduro”36 e comunque sia e comunque vada “i giovani come voi sono ora la
mia speranza”37 perché essi sapranno dar carne ed ossa ad un “cristianesimo,
insomma, non come modo di dire, ma come modo di vivere”38. E la risposta al
titolo, potrebbe ora qualcuno chiedere. Ed io vi rispondo, la risposta datevela
da voi!
83
84
tire, ad essere, politicamente, socialmente, interiormente, domani il contrario di ciò che si era la
vigilia, l’istante dopo il contrario di ciò che si era l’istante prima […]! Una rivoluzione non è un’operazione per mezzo della quale ci si contraddice. È un’operazione per mezzo della quale realmente
ci si rinnova, si diventa nuovo, fresco, interamente, totalmente, assolutamente nuovo” (C. PEGUY,
Par ce demi-clair matin, ed. it. a c. di A. Prontera, Roma, Edizioni Lavoro, 1998).
12
C. PEGUY, Tradizione e rivoluzione, a c. di A. Prontera e F. Fiorentino, Lecce, iusEAed, 1992,
pp. 59-62.
13
I. SILONE, L’avventura di un povero cristiano, cit., p. 12.
14
Ivi, p. 41.
15
Ivi, p. 55.
16
Ivi, p. 57.
17
Ivi, p. 78.
18
Ivi, p. 65.
19
Ivi, p. 126.
20
Ivi, p. 169.
21
Ivi, p. 114.
22
Cfr. Ivi, p. 87.
23
Cfr. Ivi, pp. 147 e 189.
24
Ivi, p. 120.
25
Ivi, p. 170.
26
Ivi, p. 28.
27
Ivi, p. 29.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ivi, p. 30.
31
“La conservazione non deve prendere molte precauzioni né deve consigliare tante attenzioni;
e ciò perché ciò che essa mantiene, ciò che essa conserva appartiene al presente, dunque al
reale; è sicura che in qualche modo appartiene al reale; la rivoluzione, al contrario, lavorando nel
futuro, nell’eventuale, proponendosi di far nascere, non può essere sicura di niente; non avendo
fatto alcuna esperienza, per lo meno totale (la sola che potrebbe contare), non avendo, a conti fatti,
esperimentato la realtà che presenta all’accettazione dell’umanità (infatti l’esperienza totale della
rivoluzione coinciderebbe con la stessa rivoluzione), una rivoluzione non può, a rigor di termini,
garantire la realtà (in simili casi della sua realizzazione, facendo leva su alcuna prova, su alcuna
esperienza; poiché per definizione stessa, non c’è mai stata alcuna realizzazione di questo ideale”
(C. PEGUY, Tradizione e rivoluzione, cit., p. 67).
32
I. SILONE, L’avventura di un povero cristiano, cit., p. 31.
33
Ivi, p. 33.
34
Ibidem
35
Cfr. Ivi, pp. 33-35.
36
Ivi, pp. 200-201.
37
Ivi, p. 200.
38
Ivi, p. 126.
LA DIFFICILE CITTADINANZA FEMMINILE
IN UNA POLITICA INDIFFERENTE
Per quanto concerne la cittadinanza femminile, preferisco parlare di difficile
cittadinanza, piuttosto che di cittadinanza incompiuta. L’incompiutezza evoca la
possibilità di introdurre correttivi nel tempo e di orchestrare meccanismi che
possono portare alla piena compiutezza, al miglioramento del sistema, in direzione di un progresso da compiersi nel medesimo.
Non è questione di progresso e di completamento, come se la immissione
della cittadinanza delle donne fosse qualcosa che aspetta provvedimenti e correttivi dall’alto.
Pesa sulla cittadinanza femminile la questione stessa che è all’origine della
cittadinanza, che ha informato di sé il concetto e la prassi di cittadinanza, senza
che la differenza sessuale diventasse significante, ma, anzi, dove la differenza
spariva per essere assorbita in un universo di indistinzione.
L’in-differenza della politica non è senza colpe.
La politica della cittadinanza nasce nel quadro della cultura democratica
greca, nasce con il grande progetto che si autodefinisce di isonomia (isos= la
stessa, nomos= legge) per tutti i cittadini. In realtà, nell’antica Grecia, non tutti
gli uomini godono dell’isonomia, perché essa è riservata, come lo sarà in seguito, ai maschi adulti che abitano la polis. Ma non tutti gli uomini che abitano la
polis appartengono alla polis, gli schiavi, che pure sono uomini, non sono considerati umani, e le donne, che non solo, è evidente, non sono uomini, non
appartengono, di fatto, alla categoria politica dell’umano, perché quel progetto
di isonomia non le comprende assolutamente.
La cittadinanza politica assumerà grande valore e significato nella Roma
imperiale, dove, nel quadro della giurisprudenza romana, la cittadinanza viene
concessa come protezione. La protezione, assicurata dallo ius romano, si
fonda e si struttura sulla universalità della sua lex; essa viene impartita e concessa come beneficio e corrispettivo della sottomissione. Le terre conquistate
dalla Roma imperiale hanno come premio la possibilità di fruire della lex romana. L’impero chiede in cambio “solo” la sottomissione e il riconoscimento di
quella legge che, per quanto articolata e razionale, di fatto, spesso contrasta
con le differenti leggi locali. Anche qui, l’in-differenza della legge, non è proprio
senza colpa. Sa quello che vuole, nuove terre da annettere e dominare, terre
che contribuiranno in maniera primaria al sostentamento dell’impero, colonie
che forniranno il suo nutrimento, e persegue il proposito con intenti manifesti.
Nel Medioevo la cittadinanza politica, si confonde almeno fino al XII secolo,
con una generica cittadinanza escatologica. La civitas rimane essenzialmente
la civitas Dei, mentre la connotazione dell’umano si confonde con la connotazione del cristiano. Cittadinanza è una generica appartenenza religiosa, suggel-
NOTE
di Marisa Forcina
85
86
lata da una fratellanza e uguaglianza che si realizzerà nell’altra vita e, quindi,
attraverso la morte del corpo e che, proprio per questo, non rende l’umano
soggetto di diritti. Egli è solo, nel migliore dei casi, suddito, concentrato sulle
modalità dell’osservanza e dell’ossequio. Non è nemmeno soggetto di doveri:
politicamente è colui che serve e segue, privo di soggettività e di personalità
autonome. Non è in grado di darsi una legge, perché ogni legge, come ogni
potere viene da Dio. (L’espressione paolina nulla potestas nisi a Deo, sarà
ripresa da gran parte dei papi medievali, diventando il paradigma del potere
ierocratico). La cittadinanza medievale è universale, ma completamente priva
di legami concreti con le volontà e i corpi della gente.
La modernità ha ereditato in vari modi e forme queste premesse storiche da
cui è nata la cittadinanza. In sostanza, i moderni e, persino, i contemporanei
hanno vissuto e pensato l’estensione della cittadinanza come frutto di concessioni delle classi dirigenti, o delle nazioni dirigenti; hanno pensato la cittadinanza come ciò che non include lo straniero, colui che è fuori dalla comunità, denominato clandestino o extracomunitario; hanno pensato la cittadinanza come
generica appartenenza formale che non è inerente al soggetto.
La guerra nei paesi balcanici, la difficilissima situazione delle popolazioni
albanesi, ci ripresenta in tutta la sua drammaticità il problema della cittadinanza: quando i diritti civili, politici e sociali non sono garantiti, perché non sono
pensati come inerenti al soggetto, ma sono elargiti come “graziosa concessione” di nazioni o di classi dirigenti, anche i diritti umani non hanno più senso, né
applicabilità. Quali diritti umani conservano i profughi kosovari nei campi di
accoglienza dove sono stipati in decine e decine di migliaia, e dove la loro permanenza sembra sempre più simile a quella in un lager? I diritti civili sono prioritari anche e persino rispetto ai generali diritti umani, cioè quelli che concernono la vita, la libertà, la giustizia, la pace.
Diritti di cittadinanza sono, secondo la legge, quelli civili, politici e sociali e
cioè il diritto alla vita, all’identità personale, alla riservatezza, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di voto libero e segreto, di libertà associativa, di
garanzie processuali.
Tornando alla difficile cittadinanza femminile e, mettendo per un attimo da
parte, per quanto sia possibile mettere tra parentesi, i problemi di cittadinanza
dei popoli dei Balcani, quale cittadinanza reale è riservata alle donne, quale
isonomia ancora concretizza il diritto, se le garanzie processuali dipendono
dalla taglia dei jeans, la vita dal giudizio dello psicologo, l’identità da una concezione filosofica che ha assestato tutto il suo sapere e il suo discorso sul medesimo e sull’identico?
La questione della cittadinanza è strettamente connessa non solo con la
sua matrice filosofica, ma con la questione dello Stato e quindi, ancora, con la
cultura che lo informa. Oggi, la cultura statalista si fonda sul binomio StatoMercato. In questo tipo di cultura politica, l’emergere di bisogni sociali viene
recepito dai provvedimenti legislativi dello Stato sociale. Ma, chi paga di più,
quale isonomia regola la vita della cittadinanza? Quando, in periodi di difficoltà
per l’economia nazionale, si fanno tagli economici che vanno a colpire proprio
lo Stato sociale, sono le donne che pagano di più. Ad esempio, quando l’assi-
NOTE
stenza ai bambini, agli anziani, ecc. non è garantita, quando le pensioni sono
ritoccate verso il basso, la sanità più o meno privatizzata, il peso della cura va a
gravare di più sulle donne. Il lavoro di cura che esse svolgono con generosità è
lavoro non pagato, esso rappresenta circa il 40% del reddito nazionale lordo.
Quale economia di mercato non riconosce valore al lavoro? Se anche il lavoro
intellettuale, che non produce merci, è pagato e riconosciuto come valore, perché mai il lavoro femminile, quello che concerne la riproduzione, non ha cittadinanza né economica né politica? non ha riconoscimento e non è indicato come
fonte di valore e dunque di diritti? Ciò non significa dare uno stipendio alle
casalinghe, ma riconoscere il contributo effettivo delle donne e la reale corrispondenza tra lavoro di cura e Stato sociale.
Da più parti, nell’ambito del femminismo, si afferma che il patriarcato è finito.
È vero, se il patriarcato è considerato come forma storica che visibilmente
perpetra una oppressione e subordinazione evidente delle donne, ma è anche
vero che vi sono forme non visibili e non ampiamente percepibili di discriminazione.
Ciò avviene quando non si negano i diritti, a patto, però, che questi siano
astratti. Astratti non vuol dire astrusi, ma tratti fuori da qualche cosa, che non è
un generico contesto, ma è il corpo che è il primo contesto sul quale alita la
vita.
Astratti dal contesto del corpo, e quindi dalla vita, i diritti vengono resi “pari”.
Questi diritti “pari”, che sembrano superare le diversità e le gerarchie per realizzare l’uguaglianza e l’isonomia, escludono la messa in campo, la messa in
scena, come fattore di cambiamento, della differenza sessuale. Si è “pari”
quando non si pretende di giocare per intero la propria storia, i propri bisogni, i
desideri, le proprie vulnerabilità. Si è “pari” quando si rinuncia al passato, o lo si
rispolvera con il gusto dell’antiquario, ma non certo per ritrovare radici di identità personale e di significanza del sé, si è “pari” quando si rinuncia a riempire di
contenuti quello che fu ritenuto passività, si è “pari” quando si rinuncia a riscoprire quello che fu necessità, si é “pari” quando, infine, si rinuncia a dare nome
a un futuro che può essere di libertà. Un futuro che prende e nomina la differenza come ricchezza e risorsa.
Le donne oggi, grazie anche alle teorie femministe che dalla fine del 1700
esse stesse hanno promosso con chiara coscienza politica, hanno operato con
una sempre maggiore consapevolezza dei loro diritti, ma non si sono limitate a
quelli.
Consapevoli della sostanziale ambiguità del diritto che, normalizzando,
addomestica, controlla e omologa, le donne stanno puntando sulla valorizzazione delle loro capacità autonome di relazione, che strutturano e spingono verso
nuove forme di solidarietà. Non si tratta solo di elaborare una visione critica del
sistema dominante, ma di forgiare la capacità di mantenere aperta, visibile e
desta la propria soggettività.
Vi è un aspetto importante in questo vivere la difficile cittadinanza femminile.
È il fatto che essa non viene tanto definita dalle donne stesse attraverso mobilitazioni di tipo rivendicativo, quanto attraverso una pratica che potremmo denominare di corresponsabilizzazione orientante.
87
88
Per questo, le donne più consapevoli politicamente sono quelle meno affascinate dalle elargizioni di quote di rappresentanza o dalle prestazioni che le
pongano a cavalcare la fiera del potere. Proprio le donne più consapevoli e
libere, quelle che con passione e tenacia hanno fatto della libertà il paradigma
della propria vita intellettuale e politica, e, dunque, della propria cittadinanza,
sanno bene che la morale autonoma, quella che si affida alla ragione per fornire progetti e precetti definitivi, degenera troppo facilmente in situazioni di dominio. Degenera perché non riesce a riconoscere l’eteronomia, che non è ciò che
ci rende dipendenti, ma ciò che ci permette di riconoscere che c’è altro e, che ci
piaccia o no, con questo altro facciamo continuamente i conti, nel senso che
l’eteronomia è il terreno della continua e progettuale mediazione. È attraverso
la mediazione che si dribbla spontaneamente il conformismo e quindi la possibilità stessa della dominazione. Come insegnava Hannah Arendt, la spontaneità, che è l’opposto del conformismo, è quella che meno si lascia dominare.
Questo meccanismo era ben conosciuto dai regimi totalitari, che, nei lager, con
l’uccisione della persona morale e l’annientamento della persona giuridica, riuscivano facilmente a spegnere anche “la spontaneità, cioè la capacità dell’uomo di dare inizio coi propri mezzi a qualcosa di nuovo che non si può spiegare
con la reazione all’ambiente e agli avvenimenti. Allora non rimangono altro che
sinistre marionette con volti umani, che si comportano tutte come il cane di
Pavlov, che reagiscono tutte con perfetta regolarità, anche quando vanno
incontro alla propria morte, che si limitano a reagire. Questo è il vero trionfo del
sistema”(Le origini del totalitarismo, p. 624).
I progetti politici e di cittadinanza che il pensiero della differenza sessuale va
elaborando non sono uni-direzionali, ma molteplici; è proprio in questa molteplicità che la cittadinanza si costituisce come senso pregnante della comunità e
non come norma giuridico-universalistica e perciò, ancora una volta, astratta.
In quest’ottica, la cittadinanza può anche essere vista come educazione
permanente alla partecipazione e non semplice esercizio di delega.
La cittadinanza femminile funge anche da spia per verificare i dilemmi e le
promesse mancate dell’attuale democrazia. L’endemica crisi che vive la rappresentanza femminile, non è questione di mancanza di desiderio femminile di
rappresentare o di essere rappresentate, ma è denuncia di quello che avviene
realmente nell’attuale democrazia, dove i rappresentanti sembrano operare
solo una rappresentazione del sé, e dove la stessa democrazia è sempre più
simile a ciò che non possiamo avere (come d’altra parte sosteneva il democratico Rousseau). Se il potere di delega e di intervento appare realmente sempre
più limitato e occasionale, se il mandato è puramente formale, perché astratto,
nel senso che si è detto, o, all’opposto, espresso su spinta emotiva e scarsa
conoscenza delle questioni, tanto vale autoriconoscersi fuori da un sistema
che, in pratica , trasforma le élites dei rappresentanti in una oligarchia che si
autoinveste del potere, mantenendo della rappresentanza solo l’involucro formale.
E, d’altra parte, il potere che si autolegittima nel sistema contemporaneo
sembra avere la stessa capacità ambigua e promotrice di falsa coscienza che
Karl Marx attribuiva alla brama e al possesso del “denaro”, il quale “muta la
NOTE
fedeltà in infedeltà, l’amore in odio, l’odio in amore, la virtù in vizio, il vizio in
virtù, il servo in padrone, il padrone in servo, la stupidità in intelligenza, l’intelligenza in stupidità”(Il Capitale, l.I). Spesso, anche strettamente colluso con il
mondo del denaro, il mondo della politica-potere appare, come nell’analisi
marxiana del denaro, “il mondo rovesciato di tutte le qualità naturali ed umane”
e diventa, questa volta sì, “l’universale confusione e inversione di tutte le cose”.
Da queste premesse nasce, specialmente per le donne, ma non solo per
esse, una concezione di cittadinanza come spazio di difficoltà e non di incompiutezza, e quindi i diritti di cittadinanza si pongono non come qualcosa di definitivamente acquisito, ma come realtà da ridefinire e riguadagnare continuamente. Altrimenti c’è il rischio, come racconta R. Musil nel suo (L’uomo senza
qualità p. 29), di rirovarci sempre nel paese di Cacania dove, di fronte alla
legge, tutti i cittadini erano uguali, ma non tutti erano cittadini. Cosa che avveniva regolarmente, abbiamo visto, nella “democraticissima” Atene del IV sec. a.C.
E tuttavia, tra agio e disagio, tra doppia presenza e coscienza del limite una
cittadinanza femminile esiste e si pone come risorsa in costruzione.
Si tratta, dunque, di costruire anche una cittadinanza femminile, e questa
costruzione si delinea più come un’attitudine che un’ideologia. Si tratta di riconoscere un’altra forma di cittadinanza intesa come slancio creativo orientato
criticamente nei confronti del sistema dominante, uno slancio che vuole andare
oltre le condizioni storiche dello sviluppo di questo sistema, oltre i suoi paradigmi di riferimento che delineano gli orientamenti culturali e politici attuali.
Invece, ancora pesa sulla cittadinanza femminile un orientamento interpretativo quasi escatologico in cui essa è ricondotta alla cornice più generale dei
“poveri di Jhawé” cui è destinata la liberazione nel Regno. In quest’ottica, la cittadinanza delle donne assume spesso un’accezione promozionale di tipo pedagogico-morale. Invece, non si tratta di promuovere alla classe successiva, quella che dà alla fine la licenza che ammette all’università del sistema, quanto di
sviluppare la consapevolezza politico-culturale. Una consapevolezza che le
donne hanno sempre dimostrato di possedere, se già A.Adams, moglie di colui
che, come presidente, sarebbe succeduto a Washington, chiariva al marito, nel
lontano 1776: “Non ci consideriamo legate da leggi nelle quali non abbiamo
alcuna voce né rappresentanza” e che “non abbiamo contribuito a creare”,
aggiungeranno le donne della rivoluzione francese, con le parole di Olympe de
Gouges.
Nell’Ottocento, l’impegno per una cittadinanza femminile che reclamava il
diritto di voto e le libertà civili, metteva anche in rilievo il danno economico che
l’esclusione delle donne comportava (cfr. Harriet Taylor, J.S.Mill). Il movimento
della suffragette si impegnerà nella richiesta di un’uguaglianza reale di diritti
rispetto agli uomini. Ma avverrà che, quando anche questi verranno riconosciuti
e sollecitati da uomini attenti e vicini alle richieste femminili, come ad esempio
in contesto francese J. Michelet, alle donne verrà riservato un ruolo speciale,
quello di essere garanti della famiglia, dell’amministrazione della casa, dell’educazione dei figli. Con la conclusione, davvero paradossale, che “tutta una carriera si apre alle donne. Quale? quella dei loro mariti”. Si apriva, in questo
modo, una concezione della cittadinanza che, di fatto, superava la vecchia sot-
89
90
tomissione e subordinazione causata dalla concezione della naturale inferiorità
femminile. Le donne non erano più pianeta oscuro e ottuso, ad esse veniva
riconosciuta autonomia di giudizio e capacità di sostegno culturale morale e
fisico, ma a vantaggio dell’uomo di cui esse rappresentavano addirittura
l’onore. Tutta la vita femminile, alla quale si riconoscevano grandi capacità, era
funzionale a una figura particolare: il marito, considerato ancora il capo indiscusso della prima struttura civile: la famiglia. Quando questa parzialità sarà
superata, nella seconda metà del Novecento, che vedrà il riconoscimento formale, attraverso le più articolate norme giuridiche, alle donne sarà riservato lo
stesso ruolo di sostegno culturale, morale, fisico e persino economico di un’altra figura, quella astratta, dello Stato sociale. Il “genio femminile” è passato a
strutturare, oggi, “l’onore” della società! Ciò che proprio una politica indifferente
non riesce ad immaginare è che ogni soggetto, nella sua singolarità, nella sua
parzialità maschile e femminile, rappresenta pienamente se stesso e al riconoscimento di sé e della propria singolarità fisica e spirituale ha pienamente diritto.
I diritti di cittadinanza femminile sembrano risolti e ottenuti attraverso le
norme che regolano ed estendeno anche alle donne una piena uguaglianza,
nel diritto di voto, nella parità di trattamento e di accesso a tutti i lavori. In realtà
ad esse viene delegata prevalentemente, così come era avvenuto nei secoli
precedenti con la figura fisica del marito, l’organizzazione pubblica dei lavori di
cura, non solo tramite i servizi sociali propriamente detti, ma anche attraverso
lo spazio che viene lasciato sempre più in mano femminile, di altri luoghi.
Sempre più femminilizzati appaiono i settori portanti nella società: scuola, magistratura, sanità. Ciò è dovuto all’alta professionalità e competenza che dimostrano di possedere le donne, che in numero sempre maggiore vincono i concorsi pubblici. Contemporaneamente, però, il carisma professionale e anche il
compenso economico si allineano in questi settori verso il basso, riducendone
vistosamente lo status e delegittimando sottilmente l’importanza che scuola,
giustizia e sanità hanno nella vita civile. Il carisma si autolegittima e si autopone, invece, sempre più nei luoghi di potere, occupati prevalentemente da figure
maschili. In questi luoghi, il potere viene inteso come facoltà, ancora molto
simile alla forza, che può a suo piacimento distribuire le risorse, in genere intese come risorse economiche.
A questo punto la cittadinanza femminile si pone come compito sempre più
difficile, perché non ha norme e concessioni da rivendicare, delle quali ha ormai
svelato il meccanismo perverso, ma ha un compito più arduo, quello di introdurre nuovi significati nello svolgimento di una vita che sia davvero civile.
Si tratta, dunque, di praticare una cittadinanza che fornisca nuovi paradigmi
e che non sia l’estremo compimento di quelli sui quali è nata nel tempo.
La pratica della cittadinanza femminile sta introducendo nuovi sensi nella
storia del mondo. Attraverso il dibattito serrato sul rapporto natura-cultura, ha
decostruito i paradigmi dell’affidamento, dell’accoglienza, dell’obbedienza, del
maternage, intesi tradizionalmente come forme passive e oblative per farne
momenti alti di consapevolezza in grado di costruire mediazioni feconde.
Attraverso il dibattito sulla centralità della sessualità ha decostruito l’opposizio-
NOTE
ne tra aggressività maschile e tenerezza femminile; nella tenerezza e nel non
possesso dell’altro, nell’ascolto, nella pausa del respiro, nella capacità di porsi
al di là del proprio e nell’allungare lo spazio con l’altro, invece che annetterlo a
sé, sta dispiegando nuovi paradigmi su cui costruire legami d’amore e di amicizia, che valgono anche come modelli di rapporti nella civitas e tra civitates
diverse.
Infine, la pratica della cittadinanza femminile sta riconcettualizzando la questione politica e, con essa, la questione stessa del potere, che ne è alla base.
Se la politica, come diceva Hannah Arendt, non è amministrazione di interessi,
ma spazio della partecipazione e della compagnia, il potere non può essere
inteso più come distribuzione, ma come attivazione delle risorse.
Riconcettualizzare il potere significa scioglierlo da ogni forma privatistica, in
cui la proprietà, non solo quella economica, ma la proprietà stessa del potere
genera forme di dominazione e di asservimento. Ciò significa rinunciare alla
vecchia forma verticale in cui il potere tradizionalmente si è espresso, per legittimarlo in una dimensione orizzontale. Ciò significa intendere il potere come
poter-fare, attivazione di possibilità.
Una cittadinanza in cui il potere non generi sfruttamento e oppressione, che
possono essere contrastati solo con il ricatto, apre ad altre possibilità la vita:
quella degli uomini e quella stessa delle donne, dove tradizionalmente anche la
seduzione e la maternità sono state usate in maniera strumentale, con malafede dettata dalla necessità. Il binomio: “tu mi opprimi, ma io ti seduco e quindi
divento la tua necessità, per cui in realtà tu dipendi da me”, è solo la spirale violenta su cui si assesta in equilibrio instabile ogni forma di sfruttamento.
Il femminismo, come pratica politica di questa difficile cittadinanza delle
donne, si è impegnato ormai da tempo nella direzione di una trasformazione
delle relazioni autoritaristiche, competitive e gerarchiche e le ha denunciate
come omologhe. Sul piano simbolico, autoritarismo, competizione e gerarchia
sono sinonimi. Si tratta, allora, di strutturare una concezione dell’autorità come
ciò che attiva relazioni solidali, come ciò che permette alla realtà di manifestarsi
e di essere riconosciuta nella libertà delle sue più varie dimensioni. Si tratta di
praticare una cittadinanza che registri il più ampio mutamento nella concezione
dei rapporti sociali.
Non è poca cosa perché, se mutano i rapporti, mutano le istituzioni.
Difficilmente, al contrario, le istituzioni riescono a mutare i rapporti sociali, perché esse, invece, normalizzano e ratificano, legittimano ed escludono. E, d’altra
parte, è ormai evidente e da più parti argomentato che vi è un legame tra i rapporti sociali, in special modo quelli tra uomo e donna, e l’organizzazione delle
dottrine e delle istituzioni politiche, nonché la loro storia.
Praticare una cittadinanza dove il potere, anzicché essere inteso come
influsso o forza, si manifesti simbolicamente e realmente sia riconosciuto come
energia diffusa, come responsabilità capace di suscitare l’azione e non di bloccarla, significa lavorare contro ogni forma di oppressione ed emarginazione del
diverso.
Una riformulazione del potere e dell’autorità permette di intendere la cittadinanza femminile come forma reale di partecipazione e non rappresentanza da
91
92
promuovere attraverso una partecipazione per quote ai vecchi luoghi di decisione.
Si tratta, insomma, di andare oltre il paradigma della rivendicazione dei diritti, per passare a un esercizio concreto del potere e dell’autorità che non è altro
se non la più ampia e reale capacità di mediazione e di comunicazione di contenuti.
È la mediazione che permette di superare le false dicotomie, i modelli di
società e di azione che separano e, quindi, gerarchizzano, è la mediazione che
apre a prospettive integrate (non integralistiche), e che permette, nell’era della
globalizzazione, una vita ecologica, dove ecologia, riconducendosi all’etimo originario di oikos=casa, faccia sì che la vita abbia, appunto, il significato di un
sentirsi a casa.
Tutto ciò non significa eliminare le specializzazioni e le competenze, ma non
perdere di vista il rapporto costante che c’è tra competenze e problemi sociali.
Infine, ancora una volta, si tratta di riconoscere non una cittadinanza incompiuta per le donne, ma una pratica difficile di cittadinanza, perché si sta assumendo il compito, non iscritto nei codici, di introdurre, nella convivenza regolata
della polis, vissuti, esperienze e valori che appartengono alla sfera della prassi
privata femminile. Non sono diritti da rivendicare, istanze da sottoporre a giudizio, ma tesori di esperienze soggettive che possono diventare oggetto di riconoscimento universale e concreto e non formale.
In questo modo, la cittadinanza femminile sposta anche il contenuto della
forma giuridica e istituzionale, che da norma omologante diventa capacità di
mediazione tra la gente, tra i desideri e i bisogni degli umani. La cittadinanza
femminile vive, quindi, l’esigenza giuridico-politica non come forza, con i meccanismi perversi che questa dispiega e che si concretizzano nei numeri e nelle
percentuali e nelle statistiche, ma come bisogno formativo. L’esigenza giuridico-politica, che una consapevole cittadinanza femminile sta praticando, non si
nutre di un’etica prescrittiva, ma semmai di un’etica descrittiva che mette in
grado di dialogare, di ampliare gli sguardi, e di dar voce a ciò che viene avvertito come necessario e reale.
Una cittadinanza reale è quella in grado di valutare l’orientamento verso gli
obiettivi in permanente e costante relazione alle pratiche e ai processi, nella
consapevolezza che gli effetti non dipendono tanto dai fini e dalle intenzioni (lo
diceva anche il curato d’Ars che di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno), quanto dai procedimenti e dalle pratiche concrete. Alla efficienza delle
azioni e alla tempestività degli effetti oggettivi, le donne, con civica consapevolezza, oppongono i modi e i percorsi con cui essi sono perseguiti, coscienti che
i mezzi sono persino più importanti degli scopi, essendo i mezzi ciò su cui si fa
leva. Mezzi violenti, astuti e menzogneri, distruggono persino gli scopi, mentre
è sempre più evidente che gli scopi si realizzano in molteplici modi differenti e,
tempi che sembrano più lunghi sono molto spesso più efficaci. Il governo del
tempo, perché il tempo non si perda e non si ammazzi il tempo, è forse persino
più importante del governo degli uomini, perché gli uomini si perdono e si
ammazzano quando non sanno vivere nel tempo. E, anche questo non si
amministra con leggi e con quote di tempi.
NOTE
La pluralità delle dimensioni rispetta la pluralità delle prospettive e dei percorsi.
Dunque, anche la cittadinanza femminile non ha nessuna intenzione di riassumere in sè l’universo-donna, ma “solo” di fornire un contesto, in cui ciascuna
sia motivata a compiere le sue scelte, i suoi impegni, i suoi compiti, sapendo di
poterlo fare e sapendo che il suo gesto non sarà inutile o formale.
La difficile cittadinanza femminile fornisce anche un paradigma per valutare
gli scacchi non come momenti di un processo verticale, ma come messa alla
prova e riconsiderazione dei punti di vista che rimangono, comunque, sociali e
politici.
Diventa, allora, questione di cittadinanza e non di letteratura nominare i processi, dare nome alle manifestazioni della vita e del lavoro, quindi padroneggiare la lingua e con essa il pensiero (quindi la cultura, la filosofia) per poter esprimere nuove procedure di mutamento. Nel binomio sapere-potere non solo
Foucault ha indicato con chiarezza che proprio la lingua viene usata dalla classe, dal genere e dalla cultura dominante per screditare ed emarginare l’oppresso e così istituzionalizzare la sua messa fuori campo dalla scena del potere.
Una pratica sapiente di cittadinanza femminile più che rivendicare spazi e
quote di riconoscimento istituzionalizzato, lavora verso un uso di parole adeguate, portavoce di simbolico, per lasciar passare nuovi modelli e nuovi contenuti. Si tratta di cambiare codici e significati cristallizzati in desueti parametri e
scoprire nuove definizioni e modalità, ridando senso anche ad antiche fogge.
Ironia, obbedienza, pazienza, attesa, tessitura, ascolto, si amplificano di significati e si diffondono come espressioni e pratiche ritenute valide.
Le donne oggi, non solo lavorano per la cittadinanza nei diritti o nelle esperienze, ma per la cittadinanza nel linguaggio, che consenta di esprimere l’esperienza propria e non essere espresse da quella altrui. Sicché la cittadinanza,
grazie alla consapevole presenza femminile, sta cambiando fisionomia, dal
ristretto paradigma dei diritti si avvia a prendere in seria considerazione i rapporti di cura al pari di quelli economici, le variazioni nel simbolico al pari di quelle istituzionali.
In conclusione, la cittadinanza, intesa come consapevolezza, in una politica
che non sia in-differente, non scinde più la presa di coscienza dei problemi dall’avviamento di processi di autonomia. Una cittadinanza consapevole e reale,
invece di omologare, attraverso norme che sembrano sempre più articolate,
incoraggia e sostiene l’emergere di sempre nuove soggettività, portatrici della
propria presenza, della propria voce, delle proprie capacità.
93
LA SCELTA PROCREATIVA:
IL DIRITTO DI UN FIGLIO E IL DIRITTO DEL FIGLIO
di Alessandra Lezzi
94
1. Dinanzi alle scoperte tecnoscientifiche, al dilagare di novità mediche, che
un tempo sembravano solo utopie, si è chiamati ad interrogarsi, a scegliere
come orientare il proprio cammino, a riflettere. Ad essere chiamata in causa è
proprio questa riflessione attenta e cosciente, che sembra non essere più in
grado di fronteggiare le innumerevoli e incalzanti rivoluzioni biologiche.
Dunque il problema essenziale del nostro tempo, come già nel 1958
Hannah Arendt sottolineava in The Human Condition1, è nella legittimità di rendere artificiale anche la vita. Oggi siamo alle soglie di una delle più importanti
rivoluzioni tecnologiche della vicenda umana: la cosiddetta rivoluzione biologica, che vede l’uomo oggetto non solo di tradizionali strategie genetiche, l’eugenetica, ma anche di altre possibili strategie, l’ingegneria genetica. E a questa
illimitatezza di pretese si oppone un’etica dei limiti, intesa come strumento di
disciplina. Sia che si richiami alla natura come paradigma normativo, sia che ci
si appelli ad un principio di sacralità della vita che ingiunge il rispetto assoluto
del finalismo intrinseco dei processi biologici umani, l’invito rivolto alla scienza è
di non interferire con la natura attraverso la sistematica distruzione dei limiti.
Secondo questo paradigma, il principio di sacralità della vita ha sempre la precedenza sugli altri doveri prima facie. Questo significa una precisa gerarchia di
doveri che porta a dichiarare illecita la sostituzione del processo naturale con
quello artificiale. L’abbandono di questo paradigma comporta un profondo cambiamento culturale e segna l’affermazione di una nuova prospettiva etica: si
passa dall’etica della sacralità della vita ad un’etica della qualità della vita
L’irruzione dell’etica applicata ha sollecitato la necessità di fornire adeguate
risposte etico-giuridiche, secondo schemi differenti e diametralmente opposti,
utilitaristici o personalistici, che possano ripristinare quei confini che un uso
sconsiderato della scienza travalica.
In questa ricerca verso la “verità”2 si assiste ad una vera e propria lotta sia
tra scienziati, filosofi e giuristi, ognuno con la pretesa di poter raggiungere, a
discapito degli altri, una verità presentata spesso come assoluta, sia tra i sostenitori della qualità della vita, quale principio fondante del proprio discorso, e
coloro che identificano tale principio nella sacralità della vita.
La realtà è veramente complessa e le discussioni in campo bioetico interpellano tutti gli uomini, non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto il singolo soggetto che deve decidere della propria vita o di quella altrui.
È l’uomo con la sua autocoscienza che viene chiamato a riflettere su se
stesso, a fermarsi in questa società in continua evoluzione e a conoscere se
stesso, attraverso un processo etico di determinazione dei valori.
2. Per questo i dilemmi della bioetica vengono posti sul tavolo del diritto,
per essere esaminati e valutati. Ma la domanda su come si debba legiferare in
ambito bioetico appare altamente problematica.
Si assiste attualmente, da una parte, ad una richiesta di una maggiore ed
adeguata legislazione sui problemi bioetici, dall’altra ad una sempre più insistente richiesta di privatizzare le questioni bioetiche per sottrarle a qualsiasi
forma di controllo pubblico e giuridico4. In tale controverso contesto socio-culturale, la cultura giuridica dovrebbe ripensare se stessa e il proprio ruolo sociale5.
Comunque, il pluralismo delle idee e, parallelamente, l’ampia secolarizzazione sono i fattori che rallentano una precisa statuizione del diritto positivo,
nonostante il riferimento, sempre più reclamato, al diritto alla vita e alla libertà,
come diritti fondamentali dell’uomo. Al legislatore si impone una scelta di azione, soprattutto in ciò che riguarda la tutela dei più deboli. In effetti, non vi è
argomento più dibattuto attualmente di quello della normazione delle tecniche
di fecondazione assistita.
3. Due possono essere le linee da seguire nell’approccio giuridico legislativo: a) quella dell’interesse della coppia che si sottopone alle tecniche di fecondazione assistita; b) quella dell’interesse del nascituro.
Come suggerisce Bompiani6, la migliore via da intraprendere nell’ambito
della valutazione dei vari argomenti pro o contro determinate soluzioni legislative, consiste nell’assumere come prioritaria la tutela di quei valori ed interessi
che si riferiscono al figlio: il diritto alla vita e il diritto ad avere una vita giuridicamente e geneticamente non manipolata.
Prima di puntualizzare gli orientamenti dei singoli Stati, elenchiamo alcuni
principi basilari accettati pienamente dalla comunità internazionale. Tali principi
prescrivono il consenso informato alla ricerca della coppia titolare dell’embrione
e pongono il divieto di reimpiantare l’embrione che è stato oggetto di sperimentazione. Inoltre, sono proibiti con divieti penali la clonazione, l’ibridazione e la
partenogenesi. Infine, le richieste sono sottoposte a procedure di autorizzazio-
NOTE
Dunque, vi è una vera e propria messa in discussione globale e sistematica
del patrimonio morale dell’uomo contemporaneo. Leggiamo nell’ultima enciclica: “L’uomo di oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè
dal risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto,
delle tendenze della sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell’uomo,
troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto
oggetto di ‘alienazione’, nel senso che vengono semplicemente tolti a colui che
li ha prodotti; quanto, almeno parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si rivolgono contro l’uomo stesso”3. Essi sono,
infatti, diretti, o possono essere diretti contro di lui. In questo sembra consistere
l’atto principale del dramma dell’esistenza umana contemporanea, nella sua più
larga e universale dimensione. L’uomo, pertanto, teme che i suoi prodotti, naturalmente non tutti e non nella maggior parte, ma alcuni e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua genialità e della sua iniziativa, possano essere rivolti in modo radicale contro lui stesso.
95
96
ne e di controllo. Nell’analisi comparativa si distinguono in primo luogo i Paesi
che ammettono la fecondazione dell’ovocita a scopo di ricerca, da quelli che
consentono la sperimentazione soltanto sugli embrioni sovrannumerari. Ad
esclusione del Regno Unito, tutti i Paesi hanno avvertito l’esigenza di affermare
solennemente il divieto di creare l’embrione per esigenze scientifiche. Così si
sono chiaramente pronunciati in merito l’Australia (art. 13.1 lett. b Legge 10
marzo 1988 dell’Australia Meridionale; art. 6, 5° comma, Legge sulla sterilità
del Victoria ); la Germania (art. 1, 1° comma. 2 Legge sulla tutela degli
embrioni); la Spagna (art. 3 Legge n. 35 del 22 novembre 1988 sulle tecniche
di riproduzione assistita: «si proibisce la fecondazione di ovociti umani per qualsiasi fine diverso dalla procreazione umana»). Anche la Svezia, che ha emanato la Legge n. 115/1991 concernente il trattamento degli ovociti fecondati in cui
si dettano disposizioni essenziali sulla libertà di ricerca embrionale.
Ai Paesi indicati si possono aggiungere l’Austria e la Norvegia che, proibendo in modo netto e radicale ogni tipo di ricerca embrionale (art. 9 Legge austriaca 1992; art. 3 Legge norvegese 1987), comprendono nel divieto generale la
dichiarazione relativa alla prescrizione di non formare embrioni a scopo di sperimentazione.
Dunque, sintetizzando, un certo numero di Paesi europei ha legiferato in
tema di fecondazione artificiale, di embrioni o di ovociti : la Spagna7 ha adottato un’organica disciplina della materia; la Svezia8, la Germania Federale9, la
Norvegia10, la Svizzera11, l’Austria12, la Danimarca13 discipline parziali. Gran parte
degli atti legislativi inerisce alla disciplina dell’inseminazione eterologa.
Altrettanto vale per la Jugoslavia14, l’Ungheria15, la Cecoslovacchia16. Nelle legislazioni più recenti, come l’olandese, la tutela del nascituro è data dalla statuizione (art. 201 del Codice civile) che il marito non ha il diritto di esercitare l’azione di disconoscimento, se ha prestato il suo consenso al compimento di un
atto che ha potuto avere come conseguenza il concepimento di un bambino.
Anche il codice belga nel nuovo testo all’art. 318 nega l’azione di disconoscimento.
Per l’ampiezza dei temi trattati le leggi francesi (Legge n. 94-653 e Legge n.
94-654) costituiscono un esame unico nel panorama delle legislazioni europee.
La Francia, dove l’Assemblea nazionale aveva inserito nel DDL n. 2600 il nuovo
art. 671-2bis in cui si afferma: «l’embrione non può essere concepito in vitro
senza un progetto parentale», ha adottato nel 1994 un modello di legislazione
che se, per quanto riguarda la procreazione artificiale, segue il modello spagnolo, nel senso che intende regolamentare il fenomeno nella sua globalità, dall’altra parte va ben oltre. Da un lato, infatti, vengono elaborati una serie di principi
generali relativi al «rispetto del corpo umano», destinati ad avere applicazione in
campi molto distanti tra loro e talvolta già oggetto di normativa specifica –è il
caso della sperimentazione sull’uomo regolata dalla cosiddetta Legge Huriet,
Legge n. 89-1138 del 20 dicembre 1988. Dall’altro lato si disciplinano ex novo
alcune materie come l’identificazione di una persona mediante le sue «impronte
genetiche» e più in generale i test e screening genetici a fini medici o di ricerca
scientifica, come la procreazione assistita, i trapianti, la tutela dell’embrione.
Nelle sue linee generali, la disciplina francese accoglie il principio della gra-
4. In Italia esiste una regolamentazione ministeriale delle condizioni sanitarie operative, richieste in caso di pratiche di inseminazione artificiale. Il
Ministero della Sanità, con decreto del 31 ottobre 1984, istituì una
Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche medicoscientifiche. La Commissione, presieduta da Santosuosso, presentò il 22
novembre 1985 due distinte proposte, accompagnate da relazioni estese del
Presidente e alcune dichiarazioni di dissenso. Fu emanata il primo marzo 1985
una Circolare del Ministero della Sanità concernente limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione artificiale. In essa si riconosce ai coniugi il
diritto di richiedere il ricorso alle tecniche di inseminazione artificiale solo con
l’uso dei gameti della coppia. Nel 1987 è stata pubblicata una seconda
Circolare concernente misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e
di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione
artificiale, a firma del Ministero della Sanità (Circolare Donat-Cattin).
Nel diritto ad un patrimonio genetico non manipolato, il soggetto richiama
immediatamente i valori costituzionali consacrati negli artt. 2, 13 e 32 della
Costituzione italiana. Sono indiscutibili la meritevolezza e la rilevanza di tutela
dell’interesse ad un patrimonio genetico non manipolato, del nato quanto del
nascituro. Per quel che concerne i trattamenti genetici, sono illecite le manipolazioni dei gameti e dell’embrione precoce, con finalità riproduttive –tanto di tipo
sessuato quanto di tipo asessuato (espressione di quest’ultimo sono le tecniche di partenogenesi e di clonazione, di embriolisi e di embriocombinazione)–
NOTE
tuità del dono di gameti, dell’anonimato del donatore, della nullità dei contratti
relativi alla procreazione per conto d’altri, del divieto (penalmente sanzionato) di
intermediazione tra coppie sterili e madri surrogate o donatori. Sancisce l’attività
di autorizzazione e di controllo sia sulle attività di raccolta, trattamento, crioconservazione e cessione dei gameti (art. 10, Legge 94-654), sia sui centri che svolgono attività di assistenza medica alla procreazione (art. 11, Legge 94-654).
Con una disposizione in qualche modo singolare, si stabilisce poi che il donatore di gameti debba far parte di una coppia che ha procreato e che al suo consenso scritto debba accompagnarsi anche quello del partner (art. 10, Legge 94654). Singolare, perché sembra presupporre un «diritto» del coniuge sul corpo
dell’altro, diritto difficile da giustificare e pericoloso per le implicazioni future che
potrebbe avere. Singolare anche perché carica di valori simbolici la donazione,
che invece, nel contesto della Legge, sembrerebbe motivata da una solidarietà
verso le coppie sterili, piuttosto che espressione di un progetto di coppia.
Dunque, l’embrione umano è fatto oggetto di una particolare protezione.
Esso può essere concepito solo in vista della procreazione e solo con gameti
dei quali almeno uno appartenga alla coppia. La possibilità che venga fecondato un numero di ovociti tale da rendere necessaria la crioconservazione non è
esclusa, ma è regolata con cautela, richiedendosi allora il consenso scritto della
coppia, essendo previsto un termine massimo di conservazione di 5 anni. Il
concepimento di embrioni a scopi diversi dalla procreazione e, perciò, a scopi
di ricerca o di sperimentazione, è vietato, così come è vietata ogni sperimentazione sull’embrione.
97
98
nella misura in cui tendono alla riproduzione asessuata. L’illiceità deriverebbe
dal contrasto con l’ordine naturale del gruppo sociale, cui il costituente ha fatto
riferimento nell’art. 29 della Costituzione. Parlare di naturalità della famiglia
costituisce un richiamo esplicito ad una famiglia conforme alle leggi della generazione, che esigono un incontro sessuale. Il dibattito sull’art. 29 ha lasciato
emergere la prevalente considerazione sulla situazione familiare, non certo
come società di diritto naturale, ma come valore costituzionale garantito, condizionatamente alla sua conformità ai valori caratterizzanti i rapporti civili, e sul
termine società naturale, nell’accezione di insopprimibile esigenza coessenziale alla vicenda umana. Però la meritevolezza di tutela della famiglia non attiene
ad un modello di rapporti precostituito e chiuso alle nuove sollecitazioni che
nascono nel sociale. Anzi, le garanzie costituzionali degli artt. 2, 29, 30 riservano ai singoli l’inviolabile diritto di elaborare i modelli della convivenza familiare.
La constatazione che la tutela penale dell’embrione presuppone l’annidamento in utero e che quella civile dell’integrità si attua successivamente alla
nascita, ma anche la riconosciuta irreferibilità della fattispecie alla tutela della
vita non nata, che si ricollega ad una gravidanza iniziata, farebbero concludere
che l’embrione, precedentemente alla fase dell’annidamento in utero, non
avrebbe tutela e, quindi, di esso potrebbe disporsi liberamente, cioè congelarlo,
usarlo per scopi scientifici o semplicemente disfarsene.
Nel nostro ordinamento molte sono le norme che operano il riconoscimento
della vita prenatale. Si pensi alla norma dell’art. 578 del Codice penale sul feticidio, o per restare ad indici normarivi più recenti, all’art. 1, della Legge 29 luglio
1975 n°405, istitutiva dei consultori matrimoniali, che, oltre alla salute della
donna, dispone la tutela del prodotto del concepimento; all’art. 1 comma 1,
Legge 22 maggio 1978, n°194, che afferma la tutela della vita sin dal concepimento, intento confermato nel 2° comma, che pone il divieto di usare la pratica
abortiva come mezzo per il controllo delle nascite. La tutela del nascituro, in quest’ultima legge, è limitata alla facoltà riconosciuta alla madre di interrompere la
gravidanza in ragione della tutela della sua salute fisica e psichica. La soluzione
legislativa della Legge 194, che consente alla donna di abortire entro un certo termine, fu avallata e realizzata sul piano tecnico, negando che prima del raggiungimento di una certa maturità fisica il nascituro sia identificabile come entità vitale,
avendo subordinato l’interesse del nascituro al preminente interesse della madre.
La nostra Costituzione è imperniata sul valore della personalità, intesa come
titolarità organica di interesse intrinsecamente legato alla natura umana, e riconosciuta in funzione della realizzazione ottimale dell’uomo. Aderendo alla scelta
operata dal Costituente nell’art. 2, occorre lasciare le soluzioni di compromesso
tra tutela della vita non nata ed esigenze della ricerca, come quella additata dal
Rapporto Warnock, che fissò l’inizio della vita umana al quattordicesimo giorno,
ed operare a presidio della realtà naturale della vita umana.
5. In questi ultimi anni l’iniziativa parlamentare non è mancata. Il dibattito
svoltosi presso la Camera dei deputati ha riguardato alcune mozioni e risoluzioni aventi per tema generale la tutela della vita, in particolare le mozioni
Martinazzoli (n.1-00074), Turco (n.1-00121), Arnaboldi (n.1-100126), Poli
Bortone (n.1-00127), Cima (n.1-00128), Capria (n.1-00129), le risoluzioni
NOTE
Garavaglia (n.8-00001) e Sanna (n.8-00002). Tutte le mozioni e risoluzioni, con
diverse intonazioni e in diversi contesti, contengono un comune appello al
Governo per l’assunzione di iniziative che portino a una regolamentazione in
materia di manipolazione genetica, di procreazione artificiale, di sperimentazione embrionale. In generale, tutte le proposte individuano un diritto alla procreazione come potestativo della donna, soggetto richiedente, e non della coppia.
Molto analitiche sono, in tutte le proposte, anche le norme riguardanti la
responsabilità degli operatori medici, la raccolta del consenso, le garanzie sanitarie circa la conservazione dello sperma, la tutela della privacy.
Nuove interessanti proposte sono state, in questi mesi, avanzate per tentare
di legiferare in materia di fecondazione assistita.
Il testo di legge sulla fecondazione artificiale presentato quest’anno alla
Commissione affari sociali della Camera, dopo un anno di intenso lavoro e di
audizioni, è stato al centro, come era prevedibile considerando la complessità e
particolarità del tema e le opposte opinioni sulla tutela della vita nascente, di
polemiche e discussioni. Su tali tematiche i professori Ettore Cittadini presidente della Società italiana fertilità e sterilità, Carlo Flamigni presidente della
Cecos, Vincenzo Giambanco presidente della Società italiana di ostetricia e
ginecologia e Domenico Canale presidente della European fertility research
associated hanno inviato una lettera critica alla presidente della Commissione
affari sociali. Criticamente si è espresso anche Maurizio Mori direttore della rivista Bioetica, anche Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita italiano
ha espresso la sua autorevole posizione in una lettera inviata a tutti i presidenti
dei Movimenti per la vita, dei Centri e dei Servizi di aiuto alla vita e ai componenti del Direttivo nazionale della Federazione del Movimento per la vita.
I punti nevralgici della discussa proposta di legge si articolano intorno alle
seguenti critiche:
a. secondo alcuni, la proposta di legge considera l’embrione già una forma
di vita, e per questo è sottesa da un’ispirazione culturale cattolica, secondo
altri, lo stesso ricorrere a tecniche di fecondazione assistita comporterebbe un
non rispetto dell’embrione.
Su tale posizione occorre sottolineare che il senso del testo è sì quello di un
rispetto dell’embrione, ma è un rispetto limitato, in quanto è vero che non si
accettano sperimentazioni su di esso, poiché è un progetto di vita e merita
quindi rispetto e tutela, ma, come recita l’art. 16 comma 3:
Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, devono tendere a creare
il numero di embrioni strettamente necessario ad un unico impianto, comunque
non superiore a quattro.
Il testo lascia nel vago il destino degli altri embrioni non impiantati che
dovrebbero essere ugualmente tutelati e rispettati. Essi potrebbero essere soltanto congelati, o utilizzati per sperimentazioni e successivamente distrutti o in
qualche caso impiantati.
Dunque ciò non sembra inserito in un contesto di tutela incondizionata della
vita nascente.
Inoltre, è da sottolineare che, secondo i medici, la limitazione al numero di
99
quattro della produzione di embrioni non è sufficiente. Così, molte pazienti
saranno costrette a sottoporsi ad una seconda stimolazione delle ovaie. Ci pare
una limitazione di convenienza, messa lì per non suscitare proteste da parte
del cittadino che potrebbe sconvolgersi dinanzi ad un numero doppio o triplo di
quello in questo articolo sanzionato. Comunque, in questo gioco di numeri la
posta in gioco è la vita umana.
100
b. Un altro punto criticato è la proibizione della selezione dei gameti a scopo
eugenetico. Tentiamo di sciogliere questo nodo problematico.
La proibizione è ritenuta inopportuna da coloro che sostengono che tutta la
medicina si debba muovere nella direzione della qualità della vita. Inoltre, il
ricorso all’eugenetica permetterebbe di evitare l’aborto volontario come conseguenza di un esito nefasto dopo l’amniocentesi.
Nella stessa proposta di legge, art. 16 comma 3 par. b troviamo che è vietata
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, e degli
interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo.
Se da un lato si vieta di intervenire su situazioni sane per condizionare o
manipolare con la selezione o la scelta, dall’altro, sotto la voce per motivi terapeutici, si dà la possibilità di ricorre alla stessa selezione eugenetica per i casi
di anomalie legate a patologie infettive o a malattie ereditarie. Questa ricerca è
una ricerca della razza “sana” e, nel ricorrere a tecniche che possano tutelare
prima di tutto i genitori e la società e, in second’ordine, e solo nel caso in cui
non vi siano anomalie, anche il feto, è il celato desiderio di non volere un figlio
ad ogni costo, ma un figlio sano.
Questo riferimento ai motivi terapeutici in tal articolo richiamati in causa, ci
fa ripensare alla Legge 194 in cui l’aborto per motivi terapeutici è consentito.
c. Anche la questione del limite di 52 anni per potersi sottoporre alla fecondazione assistita ha sollevato critiche.
Il significato della limitazione rigida a 52 anni, espressa nell’art.5, senza
specificazione per le donne o gli uomini, è una via di mezzo tra una provocazione e un problema lasciato aperto. I 52 anni, considerati da alcuni un limite
eccessivo per le donne e per gli stessi uomini, sottolineano pur tuttavia il problema delle donne-nonne e dei padri-nonni. È questo un problema che racchiude in sé l’importanza di una procreazione responsabile, legata anche ad
una differenza di età che deve permettere al figlio di crescere in un contesto
generazionale vicino al proprio, sia per motivi psicologici e sociali che, e soprattutto, per motivi assistenziali.
Nell’art. 5 inoltre è celato anche il difficile caso delle coppie di fatto:
possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate
da convivenza, in età potenzialmente fertile…
Con 276 no, 188 sì e 2 astenuti il Parlamento in data 24 febbraio 1999 ha
d. La questione del ricorso alla fecondazione eterologa sancito nell’art. 4, ha
aperto numerosi problemi, che hanno trovato risoluzione nella abrogazione di
tale articolo.
La posizione espressa nelle proposte di legge n. 414 mirava ad estendere
la possibilità di ricorrere a tecniche di fecondazione assistita utilizzando o seme
di donatore o ovulo di donatrice al di fuori della coppia procreatrice. A tal proposito, il dilemma giuridico mira a porre l’attenzione sul riconoscimento di identità del nascituro. In altri termini il diritto costituzionale di genitorialità a chi spetta? Alla madre e o al padre genetico, o alla coppia di diritto?
Segue, ancora, un ulteriore interrogativo: nel caso in cui si ricorresse al
seme di donatore, potrebbe esserci un non riconoscimento da parte del padre
“adottivo”, per problemi che possono scaturire da ragioni personali, o nel contesto familiare, o dinanzi alla società?
Ma soprattutto, ed è questo a parer nostro il punto cruciale dell’art. 4, è giusto sostenere il diritto alla privacy del donatore o donatrice, nel momento in cui
entra in contrasto con il diritto del nascituro di conoscere la propria storia genetica? E nel momento in cui il figlio “in provetta” avesse ereditato delle malattie
genetiche, che durante il corso della vita si manifestassero, come fare tecnicamente ad essergli d’aiuto?
In risposta a questo inquietante interrogativo l’art. 20 comma 3 del presente
disegno di legge, infatti, così recita:
In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, l’identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave
e comprovato pericolo per salute del nato ovvero per le finalità indicate dall’art.11 comma 2.
NOTE
rimescolato le alleanze politiche e ha dato cittadinanza legale alle coppie di fatto.
Nella discussione della legge sulla fecondazione artificiale, la Camera ha infatti
bocciato tutti gli emendamenti che volevano limitare le tecniche di riproduzione
assistita solo alle coppie regolarmente sposate e ha dato il via libera alla possibilità
di accedere alle tecniche di fecondazione artificiale anche per le coppie di fatto.
Tale votazione ha scatenato la critica della Santa Sede che ha definito questo voto un voto contro la famiglia.
A tal proposito risulta veramente difficile esprimersi sulla questione. Se è pur
vero che il non unirsi in matrimonio potrebbe comportare un non volersi assumere le proprie responsabilità sia nei riguardi del partner che della società, è
discutibile il paragonare il dovere tra i coniugi con il dovere genitoriale. In altre
parole, le coppie di fatto potrebbero rappresentare una classe genitoriale ad
hoc. Il punto cruciale è rappresentato dalla tutela giuridica che si dovrebbe
garantire al figlio di queste coppie di fatto, considerando che il nuovo concetto
di famiglia che la realtà ci propone, che si può condividere o no, potrebbe in
teoria rappresentare un contesto garantista.
La scelta dei legislatori ha fatto sì che si escludessero le coppie di omosessuali e i single dall’accesso a queste tecniche, in nessun caso classificabili
sotto il concetto di famiglia.
101
Nel prendere visione di questo articolo, se da un lato si è rassicurati sulla
possibilità di ricorrere per legge ad un riconoscimento dell’identità del donatore,
dall’altro la lungaggine giuridica e l’eventuale non collaborazione del donatore
potrebbero portare a dei ritardi dell’intervento medico sul figlio.
Infine, e comunque non di minore importanza, sono da sottolineare le presumibili conseguenze psicologiche sul figlio non figlio di entrambi i genitori.
Tale articolo, inoltre, avrebbe dato la possibilità sia ai single, che agli omosessuali di ricorrere a tali tecniche.
Con 251 sì e 215 no il Parlamento ha accolto uno degli emendamenti all’art.
4 che vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistite di tipo
eterologo.
Opposte le posizioni, da un lato la Chiesa cattolica preoccupata dei valori
dall’altro una cultura esclusivamente attenta al dato scientifico. Da un lato una
generale soddisfazione, con un plauso alla Camera, per aver saputo tener conto
della sensibilità culturale e religiosa degli italiani, con sottolineature diverse,
dalla tutela del valore famiglia all’esigenza di curarsi comunque del nascituro.
Ma, al tempo stesso, si osserva che ci si trova di fronte alla normale dialettica
parlamentare che non dovrebbe far sentire o far sorgere discriminazioni o desiderio di rivalse. Dall’altro lato per i ricercatori c’è il rischio che la stessa legge
venga ingabbiata e che si vanifichi per le coppie sterili la possibilità di procreare.
102
e. L’ultima questione, infine, è quella dell’utero “in affitto”, procedura vietata
dal testo di legge.
Il ricorso alla cosiddetta madre surrogata rappresenta una tecnica estrema
che mette in discussione il rapporto madre-figlio, e che ha delle implicazioni
troppo pesanti nelle relazioni tra le persone. Inoltre, è rilevante il rischio che il
corpo della donna sia trasformato in uno strumento nelle mani dei medici, come
pure è grosso il rischio che sia trasformato in uno strumento di profitto. Al primo
punto le donne devono mettere la tutela del loro corpo rispetto al potere della
medicina.
6. Vorremo concludere proponendo degli spunti di riflessione su questo controverso problema della fecondazione assistita.
In primo luogo dobbiamo sottolineare che non tutto quello che oggi è prodotto dalla scienza può essere assunto come positivo. Non è detto che la comunità
assuma i risultati delle sperimentazioni come buoni ed eticamente accettabili.
C’è, insomma, un confine tra quello che la ricerca può fare e quello che poi una
collettività, nella sua sensibilità e a larghissima maggioranza, può condividere.
Le tecniche di fecondazione artificiale e, più in generale, la manipolazione
dell’embrione umano sollevano numerosi problemi, che richiedono soluzioni
giuste e obiettive nel rispetto dei vari agenti e dei vari attori sociali coinvolti.
Il giudizio etico-giuridico, infatti, non esaurisce il suo compito nel fissare il
limite invalicabile dell’azione morale, in una sorta di restrizione, di delimitazione
dell’attività umana.
Ecco la necessità di una riflessione che, tenendo conto dei desideri, dei
bisogni, dei valori in gioco, porti ad un arricchimento creativo nella ricerca di ciò
NOTE
che è lo statuto etico dell’uomo, e che, d’altro canto non sia considerata un
ostacolo al progresso scientifico.
Non è possibile, a chi scrive, prendere in considerazione, in maniera esaustiva,
ogni aspetto del complesso problema della fecondazione artificiale e della manipolazione embrionale. Però, può essere funzionalmente utile analizzare, seppure in
modo sommario, i valori in gioco, cogliendo quelle domande fondamentali, dalle
cui risposte emergeranno le considerazioni etico-giuridiche principali.
In ordine ai valori in gioco dobbiamo considerare: 1. il diritto a procreare; 2.
il valore dell’embrione umano.
Intorno al procreare umano dobbiamo rispondere ad alcune domande:
1) il procreare umano ha una sua peculiare struttura?
2) esiste un diritto alla procreazione; il desiderio di avere un figlio sopravanza il diritto esclusivo degli sposi a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro?
3) è lecito scindere il momento unitivo dal momento procreativo?
Le risposte a queste domande sono molteplici, risentendo del pluralismo
culturale che contraddistingue la nostra società.
Seppure sommariamente possiamo delineare tre posizioni fondamentali:
a) il valore del diritto soggettivo al figlio;
b) il valore della genitorialità;
e) il valore dell’unione coniugale.
È evidente il contrasto insanabile tra la prima e la terza posizione etica:
esse si pongono agli estremi di un dibattito articolato e acceso sull’eticità della
fecondazione artificiale. Entrambe presentano dei rischi e sollevano dei dubbi:
Il diritto soggettivo al figlio rischia di portare ad una produzione di un figlio
che non è un soggetto con il quale confrontarsi, ma l’oggetto desiderato, prodotto, ed infine avuto provocando di fatto il declassamento del figlio da persona
a oggetto, da fine a mezzo.
L’interesse del figlio viene a perdere consistenza, schiacciato com’è dal preponderante valore dell’autonomia del soggetto che lo vuole.
Le varie posizioni e ogni giudizio etico e giuridico intorno alle tecniche di
procreazione assistita devono, però, fare i conti con un ulteriore elemento
essenziale e decisivo: il valore dell’embrione umano.
Intorno al valore dell’embrione dobbiamo chiederci:
a) quando inizia la vita umana? Ovvero in che momento l’embrione è qualcuno e non qualcosa? L’embrione è sin dall’inizio un essere umano o lo diviene
in un secondo momento del suo sviluppo?
b) è giusto trattare l’embrione come un “altro” o è sempre e comunque sottoposto all’autodeterminazione della donna che lo possiede17?
Il nodo da sciogliere, quindi, è rappresentato dalla carta di identità che daremo
all’embrione umano: essa sarà fondamentale per decidere dell’eticità della FIVET.
Questa tecnica, infatti, prevede, come abbiamo visto, la produzione di
embrioni in soprannumero.
Se si accetta il punto di vista anglosassone, la circostanza che la fecondazione in provetta comporti un surplus di embrioni congelati prima del quattordicesimo giorno dalla fecondazione, la cui sorte non potrà essere che la loro
103
distruzione, non può esercitare alcuna interferenza sulla liceità o sulla illiceità
del trattamento di maternità assistita.
La eliminazione, infatti, di ciò che non è ancora qualificabile come vita
umana, sia pure prenatale, non potrà in nessun modo essere giudicata violazione di interesse meritevole di tutela giuridica.
Nel caso, invece, del riconoscimento di una vita umana prenatale sin dal
momento del concepimento, ogni soppressione di questa vita dovrà fare i conti
con il diritto penale che tutela i beni di primaria importanza, fra i quali non può
evidentemente non essere annoverata la vita umana.
In questo senso, sarà molto difficile permettere una tecnica fecondativa come
la FIVET, poiché il bene proveniente dal soddisfacimento del desiderio di maternità non è proporzionale al sacrificio indispensabile di vite umane prenatali.
104
1
Cfr. H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958 (trad. it. Vita
activa, a cura di S. Finzi, Milano, Bompiani, 1964).
2
La necessità nella nostra epoca del richiamo alla ricerca del vero è sottolineato da Giovanni
Paolo II nella sua tredicesima Enciclica Fides et Ratio: “[…] più l’uomo conosce la realtà e il mondo
e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa sempre più impellente la domanda sul
senso delle cose e della sua stessa esistenza”.
Quanto viene a porsi come oggetto della nostra conoscenza diventa per ciò stesso parte della
nostra vita. Il monito Conosci te stesso era scolpito sull’architrave del tempio di Delfi, a testimonianza di una verità basilare che deve essere assunta come regola minima da ogni uomo desideroso di
distinguersi, in mezzo a tutto il creato, qualificandosi come “uomo” appunto in quanto “ conoscitore
di se stesso ” (cfr. Fides et Ratio, n.1).
3
Cfr. Fides et Ratio n. 47.
4
Cfr. F. D’AGOSTINO, Medicina e diritto. Riflessioni filosofiche, in “Iustitia”, 40 (1987), pp. 69-71;
ID., Medical humanites : da dove verso dove. Diritto, in ”L’Arco di Giano” 1 (1992), pp. 51-59.
5
Sull’argomento cfr. F. D’AGOSTINO, Dalla bioetica alla biogiuridica, in “Transizione”, 13-14
(1989), pp. 289-299.
6
A. BOMPIANI, Bioetica dalla parte dei deboli, Bologna, 1994, pp. 142-143.
7
Legge n.35 del 1988
8
Legge n. 1139 e 1140 del 1984; Legge n. 711 del 1988; Legge n. 114 e 115 del 1991.
9
Legge del 13 dicembre 1990 sulla tutela degli embrioni.
10
Legge del 12 giugno 1987 n. 68.
11
Dichiarazione del 1981.
12
Legge federale del 1° luglio 1992.
13
Legge n. 353 del 3 giugno 1987; Legge n. 315 del 16 maggio 1990; Legge n. 503 del 24 giugno 1992; Legge n.650 del 22 luglio 1992 sugli ovociti.
14
Legge 21 aprile 1978.
15
Decreto del Ministro della Sanità n.12 del 1981.
16
Decreto del Ministro della Sanità dell’11 novembre 1982 sull’inseminazione artificiale.
17
Sul punto di vista della donna in un ottica obiettivistica, cfr. A. RAND, Lexicon:Objectivism from
A to Z, New York, New American Library, 1986.
Le edizioni Espasa-Calpe di Madrid in occasione delle commemorazioni per il
centenario (1898-1998) dalla formazione in Spagna di quel famoso gruppo di
intellettuali che prese il nome di generación del ‘98, ripropone l’importante studio
di Pedro Laín Entralgo sull’argomento, già pubblicato nel 1947. Meglio: lo stesso
Autore precisa nella sua “Avvertenza preliminare” alla nuova edizione (pp. 1112), che il testo in realtà è stato già pubblicato anteriormente al 1947, cioè nel
1945; poco dopo le edizioni Espasa-Calpe, interessate a pubblicarlo nella
“Colección Austral”, gli proposero di ridurlo per questioni di spazio, venendo così
meno capitoli come: Epístola a Dionisio Ridruejo, ¿Generación del ‘98? e De la
acción al ensueño importanti per una migliore comprensione del tema e che vengono ora riproposti in questa nuova edizione.
Pedro Laín è sicuro di offrire con il suo testo un contributo rilevante, come in
effetti è, per chiarire una parte della vita spagnola che sicuramente sarebbe stata
diversa se diversa fosse stata la sorte di Villalar, o non si fosse scritto il
Chisciotte, o non fosse esistita la stessa generación del ’98; ossia gli spagnoli
contemporanei non penserebbero, non sentirebbero e non opererebbero come
oggi fanno, se non ci fosse stato quel gruppo di uomini (pp.14-15).
Prima tappa importante nella trattazione della tematica è quella di chiarire se
effettivamente è esistita una generación del ’98. Se cioè, evidenzia l’A., quel
gruppo di intellettuali, cui primo compito fu quello di far conoscere agli spagnoli i
paesaggi di Spagna con i suoi abitanti e in genere la vita del popolo che i più
ignoravano, con interpretazioni varie che vanno: da quella teologica del paesaggio castigliano, infinito, grave ed intenso, di fronte al quale l’uomo avverte la sua
pochezza rispetto a Dio (=Unamuno); a distinzioni fra simili emozioni suscitate
dal paesaggio e l’idea della storia di Spagna, fatta alternativamente di esaltazioni
ed angustie (= Azorín); ad emozioni suscitate in seguito alla perdita di persone
care seppellite in quel paesaggio (= A. Machado); alle continue peregrinazioni in
esso (= Baroja) ed infine a descrizioni meno desolate, più realiste e meno esaltate (= Mènendez Pidal) (pp. 27-51 e pp. 388412), possa realmente prendere tale
denominazione. Il fondatore di questo gruppo è Azorín che accortosi della disgregazione dai valori della generazione romantica e naturalista, cerca di arrivare ad
una nuova sintesi; in un articolo comparso su “ABC” parla di questa nuova generazione del 1896 -che tre anni dopo ribattezzerà con il nome di generación del
’98-, dicendo i suoi componenti (= Unamuno, Ganivet, Baroja, A. Machado, ValleInclán, Maetzu, Benavente, Mannel Bueno, Zuloaga…) ed evidenziandone le
caratteristiche: I’amore per l’arte, la protesta per le ‘formule” anteriori,
I’indipendenza, I’idealità, I’ambizione.... Ora l’interrogativo sorto fra i critici che
Pedro Laín illustra in maniera esemplare ed al quale risponde con una personale
interpretazione, alla quale tutto il testo è dedicato come sua dimostrazione, è
questo: si può parlare di una vera e propria generación del ’98? In merito a ciò
occorre dire prima di tutto che la polemica si è aperta all’interno degli stessi componenti il gruppo e che l’A. riassume attraverso due posizioni: quella di Baroja,
per il quale non si può parlare di generazione data l’assenza di punti di vista
comuni, di eguali aspirazioni, di solidarietà spirituale e cosa più importante
RECENSIONI
P. ENTRALGO, La generación del ’98, ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1997, pp. 518.
105
106
manca il nesso dell’età perchè si possa defınirla una generazione. Maetzu, al
contrario, afferma che la generación del ‘98 fu per la Spagna, ciò che fu per la
Germania lo “Sturm und Drang” (pp. 52-82). P. Laín pur ammettendo una sostanziale indefinizione ed una differenziazione interna che funge da struttura, individua i motivi per i quali si può parlare di una generación del ’98 (pp. 75-82), attraverso la descrizione della “biografia” dei suoi componenti, alla ricerca di quello
che lui defınisce “el parecido generacionál”. Ed è quello che fa evidenziando il
modo di descrivere il ricordo della propria terra nativa, comune perchè tutti uomini di “finis terrae”, basato su tre punti fondamentali: 1) la terra incontaminata che
è sempre quella di Castiglia; 2) I’uomo come perturbatore del paesaggio; 3) colui
che osserva il paesaggio, per lo più un personaggio immaginario che incarna la
personalità dell’autore. Così avviene in Paz en la guerra di Unamuno –e qui inizia la dimostrazione, da parte dell’A., di come Unamuno sia effettivamente il
capo spirituale del gruppo, nonostante Azorín ne sia stato il fondatore, per modi
di sentire ed esprimere le cose in modo esemplare–, dove Pachico è l’uomo che
in contrapposizione alla continua ed acerba lotta della vita degli uomini, preferisce il paesaggio naturale dove ritrova l’armonia della propria esistenza e viene
considerato favorevolmente solo l’uomo che smette di essere soggetto della
historia per essere protagonista della intrahistoria. Stesse sensazioni ed atteggiamenti nei confronti dell’uomo si riscontrano in Azorín ed in A. Machado; quest’ultimo, contrariamente alla vera concezione che ha della sua terra, è portato a
definirla páramo maldito. Se Baroda è più clemente nei confronti degli abitanti del
suo paesaggio natale, in Valle-Inclán ritorna la nota perturbatrice dell’uomo in un
paesaggio misto fra la Galizia e la Castiglia (pp. 83-109). Ora la comune interpretazione del paesaggio spagnolo, in contrapposizione con la diversità di questi
uomini, fa pensare a Laín Entralgo che fra essi ci siano comuni esperienze storiche. Una di esse è sicuramente –per rimanere in tema di paesaggio– Madrid,
città nella quale tutti i componenti del gruppo si recano a compiere i loro studi.
Non è buona, come per ogni altra città, l’impressione suscitata in Unamuno che
la vede come città triste e deprimente, dinanzi alla quale preferisce uscire dalla
historia per sprofondare nella intrahistoria, nel puro paesaggio. Non diversa da
questa è l’attitudine di Azorín, nel quale gli elementi evidenziati sono: la
sporcizia, la morte, il rumore. Baroda che nella sua prima visione non si discosta
dagli altri, arriva nella sua maturità a giudicare il popolo di Madrid come allegro e
pittoresco. Simile alla visione di Unamuno è quella di A. Machado, mentre il dolore è l’elemento che distingue le descrizioni di Valle-Inclán, quale elemento in
assenza del quale la vita madrilena diventa pura jarsa grottesca (pp. 153-179).
L’A. comunque sottolinea come di Madrid gli uomini del ‘98 fanno solo una
descrizione letteraria e non oggettiva; in realtà essa rappresenta una condizione
storica a loro non gradita. Solo gli anni e la nostalgia per un tempo ormai passato
cambierà il loro risentimento per quella situazione storica ed ammorbidirà il loro
giudizio (pp. 180-182).
Ma qual è l’attitudine di questi uomini nei confronti della storia? E quale l’interpretazione della storia di Spagna? Tutti gli uomini del gruppo –evidenzia l’A.– si
formano negli anni che vanno dalla Restaurazione all’ultima guerra carlista (18801895), un periodo nel quale si registra una disaffezione nei confronti della politica,
RECENSIONI
la nascita di movimenti regionali separatisti nonostante la proclamata unità spagnola, la perdita degli ultimi possedimenti d’oltremare, un disorientamento circa il
destino storico ed una mancanza di volontà per la Spagna di far parte di quei
popoli che decidono la Storia Universale (pp. 110-126). Ciò che evidenzia l’A. è
che si riscontra un giudizio negativo una critica degli uomini del ‘98 sul passato
della Spagna, a partire in particolare dalle imprese esterne del sec. XVI. In seguito
ad esse infatti, secondo Azorín, le tendenze naturali della razza espresse liberamente dagli scrittori primitivi, vengono soffocate nel concettismo ; mentre
Unamuno decade il sogno di una Spagna originaria e pura, quale sogno di una
libertà anteriore a quella storica, contemplata nella Castiglia primitiva. Entrambi
però vantano la peculiarità e le glorie castize, evidenziando l’africanismo ed il
medioevalismo dello spirito della Spagna autentica; così Baroda propone un’interpretazione semi-europea e semi-africana della Spagna, ed insieme a Valle-Inclán
e A. Machado un certo medioevalismo. È per una genealogia araba ed africana
della mistica spagnola e del Chisciotte, Ganivet per il quale assieme al mito di
Castiglia, costituiscono le due vene d’energia spirituale degli spagnoli (pp. 440454). Di fronte a ciò, onde poter fornire una spinta rigenerazionista alla Spagna,
gli intellettuali della generación del ’98 si pongono in contatto con la storia
d’Europa tramite la lettura, per tutti riguardante tre temi: la Letteratura, la Storia e
la Filosofia europee e moderne perchè più consoni alle loro esigenze di conoscenza (pp. 126-136) e dalle quali scaturirà il loro progetto di azione politica. In
realtà, ben presto tutti i componenti finiscono col preferire all’azione esteriore, la
creazione, o meglio il sogno letterario; Unamuno per primo con la sua preferenza
per l’azione esercitata dal verbo, dalla parola: cosa vissuta che diventa mezzo e
fine della sua esistenza (pp. 336-352). P. Laín Entralgo riesce cioè a mettere in
evidenza come, di fronte a tendenze rigenerazioniste che guardano ai progressi in
campo agricolo, industriale, sociale, educativo… di altri paesi, ossia esterne, gli
uomini del ‘98 compiano il cammino inverso: hacia dentro. Ed è a partire da ciò
che Unamuno ritiene che la scossa più grande per il risveglio della Spagna deve
avvenire in campo spirituale e religioso –ed a proposito di religione l’A. qui coglie
un’altra simiglianza negli uomini del ‘98 che, in mancanza di una religiosità socialmente vigorosa, si separano dalla fede ingenua dell’infanzia, uscendo dall’ortodossia cattolica pur mantenendo tutti sostanzialmente uno spirito religioso; così
come tutti sostituiscono l’antica fede umana nella ragione, con un’affermazione
entusiasta della vita, irriducibile a ragioni (pp. 138-152)–, un ambito che deve
essere avvertito in un modo diverso da quello del tempo. Per ciò gli spagnoli
devono conoscere la prima verità del loro essere, velata dalla storia cui Unamuno
giunge percorrendo quattro tappe, attraverso le quali cerca di portare alla luce la
casta intima spagnola, la sua interiorità. Essa si rivela attraverso lo studio del paesaggio, l’attenzione verso la realtà viva della patria, lo studio della intrahistoria
(pp. 367-378), ossia della lingua, della letteratura rivelante la continuità, in contrapposizione alla historia, che descrive gli avvenimenti (= sucesos) passeggeri
(pp. 289-308). Non bisogna comunque pensare, sottolinea l’A., che la casta intima
sia in Unamuno sinonimo di una casticismo stretto –come invece accade in
Ganivet, che distingue nella vita spagnola due modi di vivere simultanei e distinti
fra loro: uno superficiale e falso (= i fatti della storia spagnola), un altro profondo e
107
108
genuino (= la geografia e l’indole psicologica spagnola) (pp. 318-319)-; il suo piuttosto è un modo di essere uomo, e tanto più lo si sa essere tanto maggior gloria si
riscuote. Azorin e Baroda confessano anch’essi il loro interiorismo, che si avvicina
molto all’attitudine unamuniana, esprimendo l’intenzione di far conoscere la vera
Spagna agli spagnoli, così come, evidenzia l’A., chiara è l’influenza della dottrina
storicistica di Unamuno che in Azorin vede la distinzione fra Historia ed intrahistoria ridotta a materia estetica (pp. 308-317), mentre in Baroda è evidente nella divisione mentale dell’epoca storica in: strato superficiale o dei grandi avvenimenti e
strato profondo e popolare (pp. 320-324). Così è anche per Valle-Inclán, che preferisce la via della speculazione estetica, e per A. Machado che preferisce invece
la poesia ed il paesaggio (pp. 367-386): entrambi influenzati dalla storiografia unamuniana e dalla storiografia estetica di Azorin (pp. 324333). Tutti riversano una
dura critica alla Spagna che hanno sotto i loro occhi, evidenzia l’A., per: la vita
moderna, civilizzata che cerca di assimilare dall’Europa ma che non gli è consona; per la sua Storia a partire dalla quale cercano però di renderla un paese
moderno e civilizzato. Questo si può vedere soprattutto nei testi di Unamuno, che,
insieme a Ganivet, è il solo ad avere una dottrina relativamente sistematica in
merito alla storia della Spagna. Affìne all’intendimento di Unamuno si rivela la
posizione di Azorin che riserva un particolare culto al Chisciotte; mentre Baroda
avverte su se stesso il peso della storia giudicando negativamente l’azione esterna della Spagna, in tal modo sviata da un destino più perfetto. A. Machado, fedele
seguace di Unamuno, compie una stima migliorativa del Medio-Evo spagnolo e
ritiene sia prossima una nuova alba per la storia di Spagna (pp. 183-262). C’è
quindi un sogno della Spagna, di un mondo ideale diverso da quello reale (pp.
353-367) e quindi, evidenzia Lain Entralgo, I’interpretazione di un futuro per la
Spagna che in Unamuno è speranza religiosa agonicamente sentita per un uomo,
per il suo essere e per il suo voler essere, cui non riesce a giungere, nel momento
in cui lo desidera. É evidente quindi che lo spirito di Unamuno vive sempre nel
futuro piuttosto che nel presente ed in relazione a ciò si spiega il suo pensare a
tre età successive nella Storia umana: l’età della Natura già compiuta, I’età della
ragione in cui si trova Unamuno e l’età dello spirito che è quella futura in cui gli
uomini saranno sinceri ed alla quale si può arrivare tramite: la libertà ,
I’inquietudine, la predicazione del principio. Parallelamente a ciò l’uomo ha due
modi di arrivare al dorato avvenire: I’immersione nel popolo, con cui l’uomo conquista quanto in esso vi è di umano e che tradisce il metodo chiscianico di
Unamuno; la collaborazione come scambio spirituale di tutti gli uomini, che tradisce il suo metodo chisciottesco (pp. 456-470). A questo proposito l’A. ci mostra
come don Miguel avverta in modo particolare il problema dell’uomo nuovo come
rinnovamento di tutti gli altri, quale via per la sobrehumanidad: un’Umanità che
compirà il proprio destino tramite la sua ricapitolazione in Cristo, verso cui può
guidarla solo l’uomo chisciottizzato. Quest’uomo diventa in don Miguel simbolo di
somma cultura e di eroismo per la civiltà, parte della intrahistoria spagnola che
lotta, affronta il ridicolo, impegna la sua esistenza nelle due problematiche centrali: la vita e la morte ed è mosso da una profonda passione per l’immortalità. Ma
proprio per queste sue caratteristiche l’uomo di Unamuno non si realizzerà mai,
sarà eternamente futuro, conservando –sottolinea l’A.– la sua preziosa idealità
Carmine Luigi Ferraro
RECENSIONI
che ci vivifica (pp. 414-428). Anche in Azorin è riscontrabile una visione analoga a
quella di Unamuno, nel senso che Pedro Lain mostra come attraverso alcune
catastrofi l’autore sogna l’accesso ad una nuova era di maggiore giustizia e
benessere, quasi compimento di una storia della Spagna rimasta interrotta (pp.
470-477). Anche Azorin assume don Chisciotte come archetipo, anzi la sua stessa vita è un’avventura chisciottesca perchè opera vivificato da un’illusione, senza
premio, per un ideale che non vedrà mai realizzato (pp. 430-435). La Spagna
sognata da Baroda è invece di una desolata nudità che la rende più pura e che
egli vorrebbe volta alla conquista della scienza europea e moderna, alla cura e
potenziamento della sua peculiarità nell’arte e nell’etica come nei regionalismi, sì
da poter avere il vero tipo umano dello spagnolo (pp. 478-481), le cui caratteristiche saranno: I’individualismo, I’azione, fede e volontà che faranno della sua vita
una fonte d’energia, pensiero ed azione (pp. 435-436).
Se Valle-Inclán contempla il futuro della Spagna passando per una riforma
dell’idioma, Ganivet ritiene che deve trovare in se stessa la massima perfezione
spirituale. Di ciò, mostra l’A., è testimone anche la sua interpretazione del
Chisciotte come tipo di uomo ideale, espressione dell’impegno per essere spagnoli autentici (pp. 428-430). Maetzu sogna invece la Hispanidad, ossia il coronamento dell’opera iniziata e mai finita nel sec. XVII per l’unione spirituale di tutti
i popoli di lingua spagnola (pp. 486-487); non a caso il suo ideale di uomo spagnolo è el Caballero de la Hispanidad che porta a fine l’opera incompiuta della
Spagna classica (pp. 437-438). Parallelamente al sogno di un futuro della
Spagna fatto di libertà e speranza, laboriosità e riflessione così da ricreare espanolamente tutto ciò che il mondo moderno offre (pp. 487-492), A. Machado –evidenzia Laín Entralgo- sogna uno spagnolo dalla vita giovane da cui scaturisce un
germoglio castizo, capace di ira e di riflessione, perchè la sua Spagna dev’essere quella della rabbia e dell’idea (pp. 438-440).
Pedro Laín Entralgo ha dimostrato così con particolare acume analitico gli elementi che accomunano gli uomini della generación del ’98 e soprattutto il fatto che si
deve al loro sogno i tre «miti storici, che vanno ad operare in modo visibile o invisibile sugli spagnoli che dopo essa (= la generación del ’98) si svegliano alla storia di
Spagna: il mito della Castiglia, la terza uscita di don Chisciotte ed una Spagna futura nella quale si devono unire in maniera nuziale e feconda la sua peculiarità storica
ed intrahistorica e le esigenze dell’attualità universale» (p. 492).
Infine l’A. dedica un capitolo a chiarire che certamente la vita degli intellettuali
del ‘98 non è solamente un sogno, giacchè anche la loro vita è piena di necessità, tematica che lascia approfondire ad altri, sottolineando tuttavia il contrasto
che si genera all’interno della loro esistenza (pp. 493-502). Un altro capitolo è
invece dedicato alla disputa circa l’appartenenza di M. Machado alla generación
del ’98, di cui l’A. è sicuro oltre che per «il suo credo estetico» anche «per la sua
sensibilità di fronte alle cose della Spagna» (pp. 503-514).
109
E. STEIN, Introduzione alla filosofia, trad. it. a c. di A. M. Pezzella, Prefazione di A.
Ales Bello, Roma, Città Nuova, 1998, pp. 296.
110
Nell’attuale rinascita di studi fenomenologici, rispondenti all’idea di un recupero metodologico del filosofare improntato ad un criterio di razionalità argomentativa, nonché nel quadro della ripresa di interesse per la produzione intellettuale di
Edith Stein, si inserisce la pubblicazione, in traduzione italiana, della sua opera
Introduzione alla filosofia. Ciò evidenzia, nel contesto del pensiero della Stein,
due caratteristiche speculative rappresentate, da un lato, dall’originalità del suo
pensare al femminile (si pensi alla sua opera “La donna”, che ne approfondisce il
compito secondo la natura e secondo la grazia) e, dall’altro, dalla fedeltà all’itinerario intellettuale di un rigoroso pensare filosofico; si pensi che questo è rimasto pienamente produttivo anche nel periodo dell’appassionato impegno della
Stein nella sua vocazione religiosa che, nel rigore spirituale del Carmelo, la
doveva condurre alla santità.
Non va dimenticato che il presente studio della Stein è stato da lei elaborato,
a più riprese, nell’arco di un lungo periodo di tempo, compreso tra il 1919 e il
1931. Sappiamo anche che il manoscritto autografo del medesimo è giunto fino
a noi attraverso vicende fortunose, che ne hanno permesso il recupero dopo la
distruzione del convento olandese delle Carmelitane avvenuta verso la fine del
secondo conflitto mondiale.
Il volume, ora proposto alle stampe in Italia, presenta una lineare
“Introduzione” di A. Ales Bello che, come noto, ha già curato studi su E.Stein e
traduzioni delle sue opere. Va inoltre sottolineato che la chiara e agile traduzione
italiana del medesimo è stata effettuata da A. M. Pezzella (collaboratrice di A.
Ales Bello e da questa introdotta allo studio del pensiero della Stein), la quale ha
al suo attivo traduzioni di altre opere della pensatrice tedesca.
Lo studio introduttivo pone in luce, in modo efficace e chiarificatore, le relazioni tra E. Stein e il suo maestro, fondatore della fenomenologia, Edmund Husserl.
Pertanto, l’opera appare improntata alla utilizzazione della “ metodologia” fenomenologica nella direzione di un ripensamento personale dell’autrice, secondo
precise esigenze critiche e ricostruttive, dettate da una rivisitazione del problema
fondamentale dell’ontologia. Questo disegno filosofico colloca la Stein nell’itinerario specifico di un pensare i problemi della conoscenza secondo una direzione
fondamentalmente realistica, che avanza per ciò stesso riserve critiche nei confronti dell’idealismo, dello psiclogismo e dello storicismo.
È quindi evidente che, nel suo intento di fondo, la presente opera rivela l’originalità filosofica della Stein consapevolmente impegnata nel suo tentativo di elaborare delle proposte costruttive nell’ambito del rinnovamento della filosofia contemporana. Tali proposte, sia pure derivanti dalla fenomenologia husserliana, le
permettono pertanto di affermare la sua personalità intellettuale, senza indulgere
a quegli studi metafisici, legati alla filosofia medioevale, che dipendono strettamente dalla svolta religiosa del suo pensiero destinato, come noto, ad approdare
poi ad una visione mistica del cristianesimo, con tutte le implicazioni della cultura
religiosa ad esso relativa.
L’opera della Stein, probabilmente predisposta dall’autrice allo scopo di con-
RECENSIONI
seguire l’abilitazione all’insegnamento nell’università di Breslavia, è divisa in due
parti. Nella prima parte, viene trattato “Il problema della filosofia della natura”
passando dall’atteggiamento naturale all’atteggiamento teoretico, per inquadrare
la conoscenza a partire dai fenomeni e per giungere, attraverso il sapere scientifico, ad una filosofia fenomenologica capace di cogliere l’essenza del mondo
naturale.
Nella seconda parte, invece, vengono affrontati “I problemi della soggettvità”,
che sono inquadrati in un duplice orizzonte: quello della psicologia e quello delle
scienze dello spirito. A tal riguardo, vengono poste in luce le tematiche della soggettività, della coscienza, della psiche, della corporeità e della persona. Ciò al
fine di impostare, nel più ampio quadro delle conoscenze relative al sapere
scientifico del mondo della soggettività, il grande problema della storia che rapporta la Stein all’autore della “scuola storica tedesca” L. von Ranke, nonché al
filosofo storicista G. Simmel.
È ovvio quindi che l’opera della nostra pensatrice, nel tentativo di fornire, allo
scopo introduttivo di uno studio della filosofia, un’ampia rasegna di problematiche, finisce poi per elaborare una interessante tematizzazione fenomenologica
del filosofare; questa, a sua volta, si rivela capace di costituire un’importante
ancoraggio ontologico delle sue riflessioni, concernenti il sapere scientifico nonché la conoscenza filosofica, rapportabile al duplice ambito del mondo della
natura e del mondo dello spirito.
Aurelio Rizzacasa
111
A. ALES BELLO, Edith Stein. La passione per la verità, Padova, Edizioni del
Messaggero, 1998, pp. 139.
Il libro di Angela Ales Bello, rappresenta il primo profilo completo, unitario e
sistematico, dell’opera filosofica, che colpisce per la singolare personalità da cui
sorge. Al termine della letteratura, infatti, ci si sente legati da stringente necessità a riconoscere fino a che punto in questo caso “non è possibile separare il
contributo intellettuale dalla vicenda esistenziale e spirituale che l’accompagna”
(Prefazione, p. 5). Di questa figura ci viene offerto un quadro policromo: l’ambiente familiare, gli studi, le amicizie intellettuali ed il dialogo con gli eventi dei
tempi sempre più cupi, fino alla catastrofe –che ispirò a Husserl, suo maestro,
quella grande sinfonia tragica che è La Crisi delle scienze europee.
Il percorso di vita e di pensiero di E. Stein ha una sua cifra, assolutamente
singolare e sorprendente: ella è, come persona e come intellettuale, creatura
delle unioni e delle lacerazioni, delle fedeltà sostanziali e delle scelte decisive.
Ebraismo e cristianesimo, agostinismo e fenomenologia, concezione tomistica e
soggettivismo moderno: di questi poli ella cerca con passione il filo di una congiunzione possibile, e, nella sua lucidità intellettuale, ripercorre le divergenze.
Fino alla polarità più comprensiva, ove si dispiega la distanza massima: scienza
–rigorosa, nel senso husserliano– e mistica; nella reclusa solitudine del Carmelo
di Colonia, la fanciulla ebrea, la brillante studiosa, se in segreto dischiude le
112
porte del mistico castello dell’anima (Seelenburg), compone la grande opera teoretica, le milletrecentosessanta pagine in cui si consolida un pensiero, ricco dell’esperienza scientifica della psicologia e sociologia del Novecento, affinato nell’esercizio dell’analisi fenomenologica, che non cede d’un punto sul piano della
metodica rigorosa, tuttavia incontrando l’altro del sapere, l’ulteriorità che richiede
la figura dell’essere. “Nel 1936 –scrive Angela A. Bello, che coglie ed offre di ogni
dato la risonanza assiologica– il manoscritto di milletrecentosessanta pagine era
già pronto e fu intitolato Essere finito ed Essere eterno. Tentativo di un’ascesa al
senso dell’essere” (p. 25), e noi non soltanto leggiamo il deliberato confronto con
Heidegger, come Ales Bello lo sintetizza: “Heidegger […] si chiude nella necessaria ed essenziale finitezza dell’essere di ogni ente”, mentre la Stein compie
una “ricerca dell’essere umano a Dio e poi di nuovo in particolare all’anima
umana” (p. 26); ma siamo colpiti alla carica simbolica che c’investe nella coincidenza cronologica: nel 1936 Husserl concludeva il suo cammino di pensiero scavando al fondo dello spirito smarrito dell’Europa le radici della sua dissoluzione,
ed evocava il telos della ragione contro il prevalere di un “oscuro destino”.
I momenti che, tra l’inizio e la fine, presentano una significativa corrispondenza, nel contenuto e nel metodo, sono due. Innanzi tutto vi è il tema antropologico, che si affaccia con lo studio su L’empatia: “Non è un caso –scrive Ales
Bello– che E. Stein nel momento di scegliere la sua tesi di laurea si orienti
verso la trattazione di questo tema” (p. 44). In questo campo, infatti, ella prosegue da un lato approfondendo le ricerche di Husserl attraverso il “lavoro di revisione da lei condotto del secondo volume delle Idee” (p. 31), ma anche confrontandosi con Scheler, Tönnies ed altri a proposito di società e comunità,
massa e Stato. D’altra parte, il suo metodo, come sottolinea Ales Bello, è orientato “ad una lettura della realtà che la coglie nella sua totalità, ma la totalità
non è un cerchio che chiude tutto, individuando un punto di forza teorico unitario, che potrebbe essere la storia, l’economia, la ragione, l’inconscio, ma è una
totalità che si delinea per espansione in una duplice direzione di approfondimento e progressivo sondaggio della parte […] al tutto che essa rivela in se
stessa e a cui rimanda per poter essere compresa” (pp. 42-43).
L’antropologia di E. Stein ha alla sua base un concetto originale, rimasto
estraneo alla fenomenologia husserliana: il concetto di forza vitale, che ha la funzione d’interpretare sia il rapporto corpo-anima sia quello tra individuo e relazione, nelle diverse forme e modalità, che sono: società, comunità, Stato; e massa,
popolo. La forza vitale è un elemento mobile, che attraversa gli strati ‘meccanici’
e ‘psichici’ per giungere fino al centro della persona, lo spirito. Nella sua ricostruzione fedele all’’esattezza’ fenomenologica, che ripercorre gli strati genealogici,
Ales Bello è sempre attenta al significato etico che le sorregge. Nel tema della
forza vitale si conserva la fenomenologica rivalutazione della corporeità come
dimensione a pieno titolo soggettiva, e nello stesso tempo si disegnano le articolazioni che connettono, dinamicamente, l’individuo agli altri in forme concrete e
stabili: “la forza vitale appartiene ai singoli che contribuiscono a formare la comunità, ma, una volta oggettivata, essa può servire da stimolo al singolo” (p. 47).
L’antropologia è d’altra parte il centro vivo del confronto più intenso e drammatico che la Stein affronta, nel momento della svolta cruciale dalla fenomenolo-
RECENSIONI
gia alla metafisica. Si tratta dello studio su S. Tommaso e Husserl, che Ales Bello
così commenta: “In tutto l’articolo è riscontrabile un duplice atteggiamento: desiderio di stabilire un accordo, ma anche di sottolineare la distinzione che indica
uno sforzo teoretico comprensibile sulla base del nuovo indirizzo che la sua speculazione stava assumendo. Il confronto fra le due posizioni è stabilito in relazione ad alcuni temi di fondo: il significato dalla filosofia, la ragione e la fede, il teocentrismo e l’egocentrismo, l’ontologia e la metafisica, il valore dell’intuizione,
quindi sotto il duplice aspetto metafisico e gnoseologico” (p. 60).
Il razionalismo di Tommaso, che “crede nella possibilità di una scoperta razionale delle cose” è il punto di maggior vicinanza tra i due filosofi– ciò che li
disgiunge è la “modernità stessa”, quel “punto di partenza indubitabile e contemporaneamente critico” (p. 62), così lontano dallo spirito della filosofia medievale.
L’esperienza di vita di Edith Stein fu segnata da un sistematico, sempre più
feroce rifiuto, che le fu inflitto in molteplici forme. Prima con la negazione della
libera docenza, poi con la privazione del suo posto d’insegnante; della vita stessa, infine, con la deportazione e morte ad Auschwitz. La forza del suo spirito non
fu mai spezzata, e la sua voce parla ancora della speranza di unione, di ciò che
fu così tragicamente diviso.
Bianca M. d’Ippolito
S. COSTATINO, La verifica dell’incontro – Socializzazione e persona nell’universo
teilhardiano, Cosenza, Jonia Editrice, 1998.
Si tratta dell’ultima fatica di Salvatore Costantino docente di Filosofia teoretica
e Didattica della filosofia presso l’Università della Calabria.
Il volume non è una generica esposizione del pensiero del gesuita francese
Teilhard de Chardin, paleontologo, teologo, filosofo, geologo, al centro di accese
polemiche e controversie per la sua teoria dell’evoluzione cosmica integrale che
sembrava inconciliabile con la rivelazione divina.
Teilhard aveva la consapevolezza di essere “un uomo di rottura” e con sottile
umorismo lui stesso si definì “un elefante a passeggio nelle ordinate aiuole dello
scolasticismo”, tanto stupore, interrogativi e dure opposizioni doveva suscitare!
Le sue idee risultano venate di tracce panteistiche e trasformiste.
Scienziato e pensatore incompreso, ritenuto un sovversivo, autore postumo,
geniale “franco tiratore” a cui, in definitiva, è stata riconosciuta la sincerità della
sua liturgia cosmica.
Profeta e precursore dei tempi nuovi. Il suo influsso vibrante d’ottimismo confluì sotterraneamente nella costituzione “Gaudium et spes” del Concilio Vaticano
II che con le sue ardite e feconde intuizioni aveva acceso tante aspettative ed
attese, in parte andate deluse.
Costantino offre non solo una sintesi equilibrata ed armonica del sistema filosofico, teologico e scietifico di Teilhard de Chardin, ma ha la pretesa, del resto
ben riuscita, di offrire all’attento lettore un blik specifico ed originale su cui ruota
l’intera sua ricerca: il personalismo socializzante di Teilhard de Chardin. L’Autore
113
114
realizza un’antica aspirazione risalente agli studi giovanili: proporre uno tudio
accurato su Teilhard de Chardin ora che le polemiche attorno alle sue concezioni
sono superate. La bibliografia sulle opere di Teilhard ( 13 volumi, oltre agli scritti
scientifici, all’epistolario e al diario) appare sterminata e ben assortita.
Costantino ha con cura studiato le opere del “gesuita proibito” prestando particolare attenzione alle interpretazioni fornite da estimatori ed amici di Teilhard:
Padre Henri de Lubac e Padre René d’Ouince che colpiscono per la loro obiettività e per la loro ponderazione.
Teilhard de Chardin appare come un grande e fine aristocratico del pensiero
ed insieme un ineffabile mistico: basti pensare alla Messa sul mondo ed alle
sublimi parole pronunciate di fronte al deserto degli Ordos in Mongolia.
Liturgia solenne e offerta mistica affidata alla pietà della memoria: “ Poiché
ancora una volta, Signore, non più nelle foreste dell’Aisne, ma nelle steppe desolate dell’Asia, non ho né pane né vino, né altare, mi eleverò al di sopra dei simboli sino alla pura maestà del Reale, e ti offrirò, io tuo sacerdote, sull’altare della
Terra intera, il lavoro e la sofferenza del mondo”.
Marguerite Teilhard-Chambon così ricorda suo cugino: “Pierre Teilhard, questo grande ottimista, mai soddisfatto di sé, […] visse con le vele spiegate al
vento dell’avventura, il vento che lo spingeva alla più grande evasione, la sola
che lo appassionasse: la ricerca e l’Incontro di Dio”.
Il primo articolo, poi, del credo teilhardiano è: “credo che l’Universo è un’evoluzione”. In questo Teilhard si ricollega al grande filone stoico agostiniano ad alla
generazione degli scienziati moderni per i quali l’evoluzione non è un dogma, ma
un’evidenza.
Di Bergson, Teilhard ha conservato l’orogenesi, il dinamismo, l’élan vital (lo
slancio vitale), la cavalcata fantastica dell’umanità protesa nell’abbattere gli ostacoli… Ha apprezzato di meno la ricaduta plotiniana nella materia, la stagnazione
dell’istinto, il ricorso all’intuizione: per Teilhard l’evoluzione non è che un trampolino, la base di una grande speranza. Occorre, però, dare all’evoluzione e al
mondo non soltanto “un supplemento d’anima”, ma la sua anima: il Cristo, che
nella sua terminologia chiama il “Cristo Evolutore”. Se l’uomo è la freccia dell’evoluzione, il Cristo ne è l’arciere e il fine, il bersaglio: l’Alfa e l’Omega, “ il punto
Omega”. Il completamento dell’uomo ha il suo compimento nel Cristo, nel Cristo
totale, nel Cristo parusiaco si ha la “pleromizzazione” -Efesini (4,10)- Col. (1,1223). Questo leitmotiv percorre tutte le pagine di Teilhard.
Il testo di Costantino, come tutte le sue indagini filosofiche, oltre ad avere un
notevole spessore scientifico e rigore culturale, ha un interessante mordente
d’attualità in questa fase di transizione verso una vera unità europea che, pertanto, dovrà essere, oltre che politica ed economica, anche sociale e spirituale. Il
Teilhard coniuga insieme, afferma Costantino, personalismo e socializzazione,
rifiuta Teilhard l’organizzazine sociale del formicaio, dell’alveare umano; ripugna
al gesuita la costruzione del “Termitière” ed esprime la sua opposizione radicale
alla “supersocieté sans coeur et sans visage”.
Il divenire dell’umanità è verso una socializzazione d’espansione e una
socializzazione di compressione. Secondo Teilhard, c’è in atto una tendenza
irreversibile verso la definizione di un “super-organismo” che deve essere com-
Giuseppe Ferrari
K. LÖWITH, Il nichilismo europeo, Bari-Roma, Laterza, 1999.
Pubblicato come articolo di rivista in giapponese nel 1940 è stato in più occasioni ripreso e rielaborato dall’Autore stesso.
Il nichilismo europeo –il titolo è apertamente nietzschiano, mentre il sottotitolo
RECENSIONI
posto da tutti gli individui umani, così come il singolo individuo biologico è composto da tantissime cellule, che v’è decisamente una differenza sostanziale col
personalismo comunitario elaborato dal Mounier. In Mounier la natura resta il
luogo dell’impersonale e dell’oggettivo, “dell’indecifrabile”, del ribelle.
Per Teilhard il personale non è uno stato, ma una direzione, una energia: è dunque in termini di sintesi che bisogna parlarne. “C’è in Teilhard una dialettica della personalizzazione che parte dal protozoico e si innalza verso una sintesi superiore in cui
l’individuo ed il sociale formano un solo essere che si completerebbe in Dio, il quale,
così sarebbe la Personalizzazione Assoluta” (pag. 153 del testo).
In Teilhard, afferma Costantino, certamente l’apologia della fede cristiana si
radica sulla riserva di una grande speranza che è la risorsa più necessaria all’umana fatica del vivere quotidiano. L’ottimismo teilhardiano si alimenta della certezza della Resurrezione di Cristo, evento centrale della storia della salvezza e
momento epocale della Signoria di Cristo su tutte le cose, sul cosmo intero. Il
libro di Costantino è una doviziosa miniera di notizie, annotazioni e puntualizzazioni; merita la più ampia diffusione e conoscenza non solo tra i docenti, ma
anche tra i giovani che ignorano le grandi intuizioni della polivalente personalità
di Teilhard de Chardin.
Desidero terminare le mie riflessioni sul testo di Salvatore Costantino con uno
scritto abbastanza noto di Teilhard de Chardin, coerente fino in fondo con le sue
idee di uomo, cristiano e cittadino del mondo. È una preghiera che sintetizza la
sua opera in modo sublime:
“Quando sul mio corpo (e ancor più sulla mia anima) comincerà ad imprimere
i suoi segni l’usura dell’età; quando piomberà su di me dal di fuori, o dall’interno
nascerà in me il male che impicciolisce e demolisce; nel momento doloroso in cui
prenderò improvvisamente coscienza che sono ammalato o che divento vecchio;
in questo ultimo momento soprattutto, in cui sentirò che sfuggo a me stesso,
assolutamente impotente nelle mani delle grandi forze sconosciute che mi hanno
formato: in queste ore oscure, fammi, Dio mio, comprendere che sei Tu (purché
la mia fede sia abbastanza grande) che sposti dolorosamente le fibre del mio
essere, per penetrare fino al midollo della mia sostanza, per portarmi via in Te
[…] oh Energia del mio Signore, Forza irresistibile e vivente, poiché tra noi due
Tu sei il più forte infinitamente, è a te che compete il ruolo di bruciarmi nell’unione che ci deve fondere assieme […] Non è sufficiente che io muoia comunicandomi. Insegnami a comunicarmi morendo […]”.
E morì Teilhard, come aveva sempre desiderato, in un’alba senza tramonto:
domenica di Pasqua del 1955.
115
Considerazioni sugli antefatti spirituali della guerra europea, è forse un’implicita
citazione da Burckardt –è quindi in parte già conosciuto, ma presenta nondimeno
motivi di interesse perché in forma sintetica e con montaggio originale Löwith torna
a ripercorrere la storia di passione dello Spirito europeo e la sua dissoluzione.
Lo Spirito della vecchia Europa va in crisi politicamente, a partire dalla metà
dell’800 per l’emergere di potenze esterne come Russia, Stati Uniti e Giappone e
per fattori esterni, in primo luogo il proletariato e successivamente il nichilismo
irrazionalista.
Il punto cruciale della crisi, che si conclude nella seconda metà del secolo, è
rappresentato dalla frattura rivoluzionaria che si colloca nel pensiero tedesco
dopo la filosofia di Hegel. Ed è proprio attraverso l’analisi attenta di pensatori, da
Hegel a Heidegger, che Löwith riconduce l’immane dimensione del conflitto e
della violenza che ha segnato il XX sec. al nichilismo, esito della modernità e allo
stesso tempo suo tradimento.
La stessa lotta contro il nichilismo porterà Löwith a posizioni orientate a non
riconoscere e ad accettare il destino nichilistico del Moderno, ad accompagnare
quel tramonto che dell’Europa è il destino, quanto piuttosto a porvi in qualche
modo rimedio.
In questo lavoro si esplica il tentativo dell’Autore di sottrarsi alla morsa teorica
dei radicalismi dell’irrazionalismo e del marxismo, senza cessare di filosofare e
senza abbracciare il sionismo. La filosofia impegnata ma non militante e la tradizione europea viene salvata come tradizione critica.
Daniela De Leo
116
A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Bologna, Il Mulino, 1997.
In questo volume si affrontano questioni importanti: dalla tutela della salute ai
problemi economici legati al sovrasviluppo demografico, dalla ricerca delle risorse naturali ai problemi eco ambientali.
L’argomento veramente molto vasto è schematicamente diviso in quattro settori: demografico, gestione delle risorse naturali, economico e istituzioni e strumenti nazionali e internazionali.
Nello studio dell’area demografica si analizzano: il numero degli abitanti che il
pianeta può sostenere, la loro distribuzione e le diverse domande fra paesi ricchi
e paesi poveri. Il discorso ruota intorno alle conclusioni a cui si è pervenuti con la
Conferenza del Cairo del 1994.
Nella seconda area legata al tema delle gestioni delle risorse naturali viene
affrontato il problema dell’inquinamento.
Nella terza area, che l’Autore ritiene rilevante nel dibattito sullo sviluppo
sostenibile, quella economica, si analizzano i problemi relativi alla crescita del
reddito e alla sua distribuzione fra i cittadini di uno stesso paese e fra i cittadini
del mondo, importante a questo proposito è il saggio Crescita economica, popolazione e ambiente, in cui oltre ad una analisi dettagliata degli indicatori economici e di quelli ambientali e alla distribuzione del reddito, ci si sofferma ad osserva-
RECENSIONI
re la transizione demografica e quella ecologica con dei grafici che sintetizzano
l’esigenza di una tecnologia più efficiente e la cooperazione tra i paesi, quali elementi cruciali per la sostenibilità dello sviluppo.
Infine l’Autore considera una quarta area, relativa alle istituzioni e agli strumenti nazionali e internazionali necessari ad affrontare il tema dello sviluppo.
I concetti guida di tutto il volume –incentivi, razionalità, pragmatismo– sono
tra di loro collegati: gli incentivi economici indirizzano la politica economica, la
mancanza di un giusto incentivo e l’assenza di pragmatismo non permettono il
decollo di una politica internazionale per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, sottolinea l’Autore, non è possibile, né auspicabile disegnare una società che si ispiri e
si muova solamente attraverso queste motivazioni, in quanto il mondo e i suoi
abitanti continuano a mantenere sia forti sentimenti ed emozioni, sia una base
che può essere definita etica, e che contribuisce a indirizzare le loro scelte e il
loro comportamento. Una base etica dunque che unisce i membri di una società
intorno a valori come la solidarietà, la generosità, l’attenzione verso la tutela dei
più deboli.
Il volume appare dunque utile sia per ricomporre il difficile mosaico dello sviluppo sostenibile, conoscere tutti gli aspetti del problema, ma soprattutto ricercare soluzioni globali capaci di soddisfare le necessità degli uomini di oggi e di
domani.
Daniela De Leo
P. PRINI, Lo scisma sommerso, Roma, Ed. Studio g.due, 1998, pp.104.
Di fronte alla crisi del telos teoretico del sapere scientifico, posta in luce sin
dalla “Krisis” husserliana, e di fronte alla negatività della tecnica già rilevata da
Heidegger, l’odierno mondo della vita quotidiana è andato ormai molto oltre; e
tale spostamento d’orizzonte trascina inevitabilmente l’universo dei valori, e non
solo della conoscenza, verso la caduta semantica dei vissuti etico-culturali, che
rischia di travolgere tanto la religione quanto l’etica e la politica.
Se vogliamo, poi, ampliare ulteriormente il panorama delle nostre osservazioni preliminari al discorso di P. Prini, dobbiamo rilevare che, in questo quadro di
fine millennio, alla drammatica consapevolezza della “morte di Dio” e della
“morte dell’uomo”, si aggiunge il rischio ecologico della morte del mondo.
Tuttavia, nel contempo,viene in luce, in maniera sempre più chiara e impellente,
un nuovo compito del pensiero filosofico, chiamato ad avviarsi verso una riflessione capace di recuperare il “nuovo inizio”, dopo la fine, e l’autenticità dopo la
banalizzazione generalizzata delle problematiche più urgenti proveniente soprattutto dal mondo delle comunicaziomi multimediali.
Ciò si può constatare senza indulgere all’indifferenza di un ateismo semantico, ma anche senza cadere nell’irenismo eclettico di un certo atteggiamento tipico della New-Age.
In una situazione del genere, complessa e disorientante, nella quale molti filosofi si rassegnano ad assumere un atteggiamento spettacolare orientato alla
117
118
“pietas” per l’effimero atto fuggente, P. Prini si inserisce nel dibattito con una
posizione di carattere esistenziale ed ermeneutico. Essa, desumendo dalla tradizione giudaico-cristiana i motivi di fondo della riflessione, scava con coraggio e
senza pregiudizi nelle questioni più scottanti, ma d’altra parte più ineludibili, vissute dall’uomo contemporaneo. Tali riflessioni del filosofo italiano vengono sviluppate, appunto, in questo suo ultimo saggio dal titolo emblematico “Lo scisma
sommerso”.
Con tale titolo, l’autore vuole alludere ad una serie di questioni nei confronti
delle quali i cattolici del nostro tempo assumono, nel comportamento pratico di
tutti i giorni, una condotta divergente rispetto ai principi universali sostenuti dal
Magistero della Chiesa, che la fede cristiana considera quale depositario della
verità “eterna” su questa terra. I problemi, quindi, vengono affrontati dal nostro
filosofo all’interno del pensiero cattolico, in base al principio, da lui sostenuto da
tempo,secondo il quale il filosofo cristiano non muove da una filosofia oggettiva
già pre-costituita, ma è condotto ad interrogarsi e a pensare all’interno del proprio orizzonte di fede.
In tale prospettiva metodologica, dunque, P. Prini sviluppa una serie di tematiche che comprendono: la “questione degli ebrei” nel mondo antico, nella tradizione storica e nella società contemporanea, affrontata con un riferimento complessivo al messaggio biblico della “Genesi”; il problema del “peccato originale”
con il connesso significato del male universale, quale “misterium iniquitatis” e
quale presenza del “demoniaco” nella vita e nella storia umana; gli interrogativi
sul senso e il significato del “castigo eterno” con il corollario concernente la presunta “de-fabulazione dell’infernale”cui si ricollega la desacralizzazine del
mondo, dei valori e dei comportamenti umani; gli argomenti relativi al “potere”
della chiesa in merito alla soluzione e alla condanna della colpa, nonché al condono o alla commutazione delle pene, da cui dipendono molte pratiche sacramentali e devozionali, che vanno dalla confessione alle indulgenze; le riflessioni
sulla condanna del piacere in rapporto all’etica della sessualità, con il proposito
di condurre al superamento delle tradizionali riserve del cristianesimo nei confronti del problema sessuale; ciò al fine di un recupero fenomenologico-esistenziale della sessualità, quale forma di comunicazione profonda nei rapporti interpersonali; infine, viene affrontato l’attualissimo tema della “bioetica” in chiave
interpersonalistica, soprattutto in merito alle questioni dell’ “ingegneria genetica”
e delle decisioni concernenti il concepimento e la nascita dell’essere umano.
Nonostante la varietà degli argomenti affrontati dal nostro autore, si può evidenziare come sia ugualmente presente, nell’intero lavoro, una unità di fondo
costituita da una precisa intenzionalità, costantemente emergente nell’itinerario
argomentativo, sia pure ora in forma esplicita e ora in forma implicita; essa consiste nel voler recuperare la libertà responsabile e sofferta dell’uomo, come singolo,
immerso nelle proprie scelte che si maturano nel contesto, spesso ambiguo e
complesso, delle situazioni esistenziali. Tale obiettivo di fondo, perseguito con l’intento di giungere al fondamento ultimo delle questioni contingenti, senza necessariamente passare per la via speculativa strettamente ontologica, rende possibile al
nostro pensatore il recupero dell’ineludibile “istanza del fondamento” attraverso la
via antropologico-esistenziale del cammino della fede cristiana. In tal modo, l’uo-
RECENSIONI
mo viene rapportato in forma privilegiata a Dio nella dimensione del “mistero” connotato, a sua volta, da una dinamica di svelamento e di occultamento di senso,
nonché ritmato dall’intercalarsi della parola e del silenzio, insieme all’apparire e
allo scomparire dei “segni” del sacro.
È quindi evidente che il presente lavoro di P. Prini si colloca nel contesto multiforme e costante delle problematiche caratterizzanti gran parte della sua nota
produzione filosofica, che qui approda alla chiarificazione degli interrogativi sempre “aperti” del pensiero cristiano. Infatti questo, a motivo del carattere essenzialmente storico del cristianesimo, è inevitabilmente e continuamente posto a confronto sia con le culture di ogni tempo sia con le tradizioni religiose dei vari popoli. Del resto, non dimentichiamolo, tale fenomeno, causato dalla profonda e
incessante interazione cultura-religione, fa sì che i problemi aperti ritornino pressanti, oggi più che mai, nella coscienza di molti credenti che vivono con intensa e
responsabile partecipazione i timori, le speranze e le attese più serie tipiche della
vigilia del “Terzo Millennio”.
Aurelio Rizzacasa
M. VIANELLO-E. Caramazza, Donne e metamorfosi della politica, Roma, Editori
Riuniti, 1998, pp. 175.
La tematica della presenza e della specificità femminile, della differenza sessuale, ha investito con intensità sempre più crescente, numerosi comparti delle
scienze umane: dalla storia alla filosofia dalle scienze sociali a quelle politiche.
Oggi si parla maggiormente di “differenza sessuale”, superata la fase dell’antagonismo e della competizione che ha caratterizzato gli anni della rivendicazione
femminista. Questo nuovo orientamento ha di fatto mutato la modalità di pensare
le stesse scienze umane, la struttura epistemica e disciplinare di diversi campi
del sapere che sono stati sottoposti a nuova lettura e a una diversa interpretazione in base anche e soprattutto ad una presenza femminile sempre più protagonista della produzione culturale, legittimata dalla società. Gli autori di questo testo
vogliono mettere in luce proprio questo processo evolutivo, la conquista appunto
di nuovi spazi sociali, culturali ma anche più semplicemente “fisici”. Il grande
sforzo compiuto nei secoli dalle donne, secondo gli autori di questo libro, non è
stato solo rappresentato dall’acquisizione del “diritto di parola” di uno “spazio d’ascolto” ma anche del più semplice ma vitale accesso ad uno “spazio fisico” e
socialmente legittimato. Uno spazio che vada oltre i ruoli da secoli accreditati alla
presenza femminile, compiti e ruoli già determinati e saldati da secoli nel tessuto
storico e sociale ma di uno “spazio scelto”, vivo e partecipato, luogo di decisioni,
relazioni ed azioni compiute in prima persona. Questo è l’oggetto di riflessione
affrontato dagli autori di questo libro che, partendo dalla convinzione che la politica sia appunto uno “spazio di partecipazione alla vita pubblica” (questo almeno
anche nella concezione della polis greca ), si interrogano sui motivi sociali, culturali, storici della emarginazione delle donne da questo spazio divenuto progressivamente appannaggio maschile.
119
120
Ciò ha comunque implicato molteplici conseguenze proprio nella vita della
società e nella sua crescita civile. L’ipotesi degli autori di questo libro è che le
donne siano state intenzionalmente escluse da uno spazio di scelta e di decisione proprio per l’incapacità degli uomini di condividere spazio e potere in maniera
complementare. Il mancato apporto che dalle donne sarebbe potuto venire alla
vita pubblica e la distorsione con cui essa è stata organizzata dagli uomini, ha
prodotto un tipo di storia caratterizzato largamente dalla violenza. A questo
riguardo gli autori di questo libro hanno voluto mettere in risalto ad inizio del testo
un’affermazione di Gandhi: “Se la non violenza è la legge del nostro essere, il
futuro appartiene alle donne” così come nell’analisi del costume e della tradizione di gran parte dei popoli ed in ogni tempo, si può constatare un unico filo conduttore costante: il culto dell’eroe e della violenza come positiva connotazione
intrinseca maschile. Così allo stesso modo anche per l’uso ed il significato attribuito allo spazio: per i maschi lo spazio è sempre in funzione delle cose, ovvero
dei rapporti di potere relativamente alle cose; per le donne lo spazio non è strumentale ma è sempre rivolto verso se stesse, la propria interiorità e quella altrui,
verso il mondo degli affetti e quindi dello “spazio interiore”. Spazio pubblico e
potere per gli uomini, spazio interiore per le donne. Per gli autori è necessario
capovolgere nell’uomo proprio la visione dello spazio, portarlo a guardare verso il
dentro, abituarlo al valore del dettaglio concreto anche legato al quotidiano.
È questo il solo modo per condividere veramente lo spazio e realizzare un’effettiva parità secondo la logica della complementarietà, del “fare le stesse cose,
ma in modo diverso” che è alla base appunto dell’uguaglianza nella diversità.
Nella seconda parte di questo libro gli autori si soffermano a notare come le
donne siano estranee alle discipline delle scienze sociali, non esistono quasi
donne (almeno fino al Novecento) che abbiano contribuito in modo considerevole alla storia di queste discipline e ciò perché la produzione culturale è sempre
stata appannaggio maschile. Di qui la difficoltà che le donne sperimentano nell’esprimere se stesse. Semplicemente, per questi autori non esistono schemi
adatti a loro. Il “come” e il “che cosa” dire contribuiscono già un problema,
anche solo per il fatto di non possedere nemmeno gli strumenti linguistici autonomi, di essere sempre oggetto di un “pensiero pregiudiziale” che ostacola la
libera espressione. L’esperienza femminile non è formulabile, non dispone di
metodi di analisi né di teorie (almeno socialmente e culturalmente accettate).
Ecco il motivo della assenza delle donne, oggi intenzionale, dalle “scienze”
già costruite dagli esperti e la decisione maturata sul piano intellettuale da parte
di molti gruppi femministi di iniziare a partire da se (basti pensare in Italia all’esperienza del gruppo di filosofe di “Diotima” a Verona).
Anche la stessa psicologia ha sempre dimostrato di non riuscire a pensare
alla donna partendo dalla donna ma di farlo sempre in relazione alla identità
maschile (basti pensare alla teoria freudiana della gelosia femminile per il pene e
quindi della figura della donna concepita come mancanza).
In conclusione dunque, gli autori di questo libro, hanno voluto dimostrare
come, l’esclusione e l’emarginazione femminile è da ricercare nel profondo delle
strutture psichiche e sociali e quindi nello spazio mentale ed in quello fisico.
La soluzione proposta è di espandere lo spazio della vita pubblica e quindi
M. Camilla Briganti
M. MANCIA, Coscienza sogno memoria, Roma, Borla, 1998, pp. 175.
Il testo recente di Mauro Mancia, Coscienza, sogno, memoria, affronta uno
dei problemi più importanti e significativi della vita umana, sia dal punto di vista
scientifico-epistemologico, che sociale e culturale. L’uomo è solo cervello o
anche mente?
Se l’uomo è solo cervello, allora unicamente le neuroscienze sono in grado di
dare spiegazioni soddisfacenti non solo in relazione alle malattie fisiche e psichiche, ma anche ai problemi culturali e sociali. Se invece l’uomo è anche mente,
allora si tratta di scoprire la natura, le caratteristiche di questa realtà mentale.
Come si può vedere, il problema è di estrema importanza. Vengono presi in considerazioni gli scritti più recenti e più significativi di neuroscienziati in relazione
alla coscienza, al sogno e alla memoria, individuandone sia gli aspetti positivi
che i limiti e le contraddizioni. Si tratta di un’analisi, ricca ed approfondita, delle
opere di studiosi: Popper e Eccles (1977), Eccles (1979, 1990, 1993), Dennet
(1991), Bateson (1979), Damasio (1994), Jouvet (1991), Gazzaniga (1997) e
tanti altri studiosi.
Mancia non ritiene sostenibile la tesi secondo la quale la mente sarebbe
“isomorfica” al cervello in quanto “un darwinismo neurale non può essere confuso con un darwinismo mentale” (p. 9) poiché il cambiamento culturale segue
leggi lamarkiane, e non quelle dell’evoluzione darwiniana. Infatti il cervello non
sembra abbia avuto delle “variazioni significative, considerando sempre questo
millennio, in termini di volume, numero di neuroni e di sinapsi”. La mente, invece, può registrare grandi trasformazioni, come lo dimostrano l’enorme sviluppo
tecnologico e, soprattutto, “la profonda trasformazione della qualità della vita cui
è andata incontro l’intera umanità” (p. 137). Questa tesi è riconosciuta, almeno
in parte, nonostante le “cadute in ambiguità”, anche dai neuroscienziati, come
ad esempio da Edelman (1992) il quale ha scritto che “nessun ammontare di
dati delle neuroscienze di per sé solo, non potrà mai spiegare il pensiero, non
c’è nulla di misterioso né di mistico; una spiegazione in termini neuroscientifici è
necessaria ma non sufficiente come spiegazione ultima” (citato p. 70).
Per quanto riguarda gli ambiti e i limiti delle scoperte delle neuroscienze,
Mancia rileva come il grande sviluppo di queste discipline, dalla neurofisiologia
alla biologia molecolare, pur avendo accresciuto le conoscenze delle funzioni
cerebrali, non ha portato alcun contributo di conoscenza per quanto riguarda il
rapporto di casualità tra l’aspetto organico e quello mentale.
Altrettanto si può affermare per quanto riguarda la psicofarmacologia, sulla
quale si basa la psichiatria biologica, in quanto, pur potendo modificare stati
affettivi, cognitivi e percettivi, non è in grado di “formulare una teoria della mente
né di conoscere i suoi meccanismi più intimi” (p. 10). Gli stessi risultati si hanno
RECENSIONI
della democrazia e della partecipazione sociale anche alle donne aprendo le
porte ad una società che gli autori definiscono, “la società post maschilista”.
121
122
relativamente agli stati di coscienza nel senso che è possibile riconoscere “i vari
livelli di funzionamento neurologico per spiegare i diversi meccanismi che sono
alla base della vigilanza” (ivi), ma rimangono sconosciuti i meccanismi cerebrali
che presiedono alle emozioni, agli affetti, alla coscienza più elevata, ai sentimenti
e alle astrazioni del pensiero.
La giustificazione epistemologica di questa tesi sta nel fatto che il cervello “è il
referente specifico delle neuroscienze che sono però metodologicamente del
tutto inadeguate ad affrontare lo studio della mente”. (39). Infatti, quest’ultima è
“il referente della psicologia e della psicoanalisi” (ivi). Sono gli strumenti operativi
delle neuroscienze, sorti storicamente su intesa intersoggettiva, a posteriori, tra
gli studiosi delle neuroscienze, che “ritagliano” il referente specifico di queste
discipline e sono del tutto inadeguati per la conoscenza della mente, come di
ogni altro referente. “Non è possibile studiare la mente con gli strumenti con cui
si studia il cervello” (p. 72). Ma come cogliere le caratteristiche della mente e
quelle del cervello?
Innanzitutto, occorre ricordare che è riduttivo ritenere reale solo ciò che
appartiene a un determinato tipo di realtà, ad esempio, quella fisica e materiale.
È, invece, reale anche quella psichica o mentale. Sapere poi, quali e quante
siano le caratteristiche della mente e della psicanalisi o della psicologia.
Pertanto, se “modello biologico appare riduttivo in quanto tende a identificare gli
eventi psichici con particolari processi neurofisiologici”, anche il modello mentalistico va criticato ogni qualvolta tende a concepire la mente “come un semplice
sistema di funzioni” (p. 12).
Non è possibile, infatti, affermare che i neuroni sono tristi, frustrati, invidiosi,
gelosi, o che fanno belli o brutti sogni, o che mettono in atto processi mentali di
idealizzazione, di negazione, demonizzazione e di identificazione. E questi processi psicologici non sono registrabili od osservabili da nessuno degli strumenti
propri delle neuroscienze, come i Raggi X, la Tac o la Pet. Tali strumenti potranno solo registrare gli effetti nell’ambito fisico.
Il presupposto teorico della psicoanalisi è che ogni evento della vita tende,
soprattutto dal punto di vista emotivo, affettivo, rappresentazionale, a ricalcare
quelli dell’infanzia, ripetendone le caratteristiche e definendone gli aspetti transferali di ogni relazione. Il transfert analitico può essere immaginato come un
potente microscopio che permette di osservare e conoscere le figure genitoriali
interne vissute quali dei o demòni, o mostri che hanno caratterizzato la vita
affettivo-rappresentazionale di ogni individuo fin dall’infanzia. Come mai alcuni
bambini sono in grado di tollerare frustrazioni, mentre altri non lo sono? Dalla
capacità di tolleranza di questo scarto, esistente tra il desiderio e la sua soddisfazione, dipende “il destino affettivo e cognitivo dell’“uomo” (p. 148).
Dal punto di vista antropologico e sociologico, non possono essere sottovalutati alcuni aspetti della personalità umana, quali conseguenze della incapacità di
tolleranza della frustrazione, aspetti caratterizzati dalla violenza e dalla distruttività. In queste personalità violente e distruttive, sono dominanti i sentimenti
negativi: invidia, gelosia delirante, odio, competitività esasperata, ambivalenza
eccessiva e incapacità di “tenere buone relazioni con il mondo” (p. 147). Causa
di questa struttura mentale sono sia i macrotraumi della vita infantile, come la
RECENSIONI
morte di uno dei genitori o la loro separazione, sia i microtraumi relazionali, ripetuti nel tempo, i quali sono la fonte di distorsione e fraintendimento nella relazione del bambino con i genitori e di conseguenza di sofferenza mentale.
Il modello fisiologico è riduttivo e unilaterale in quanto tende a identificare gli
eventi psichici con particolari processi neurofisiologici e a concepirli come dei
semplici fatti separati dai contenuti culturali-simbolici e dall’ambito esperenziale
nel quale nascono e si sviluppano. È necessaria una visione sistemica del problema mente-corpo nella quale è possibile porre l’attenzione non sull’homo natura, ma sull’homo persona, quale referente di diversi punti di vista, in una concezione secondo la quale l’unità di tutte le componenti è fondamentale al fine di
uscire dalla frantumazione operata dal comportamentismo, funzionalismo e dallo
strutturalismo.
In conclusione, è difficilmente sostenibile la concezione diffusa in alcune
scienze umane: dalla bio-psicologia alla socio-biologia, dalla bio-linguistica alla
bio-antropologia –secondo la quale l’essenza dell’uomo è esclusivamente biologica. Questo non significa sottovalutare e tanto meno escludere un approccio
biologico all’uomo, ma significa affermare che un’interpretazione esclusivamente naturalistica e biologistica dell’uomo è fortemente unilaterale e riduzionistica
e, pertanto, “vera per quello che afferma, ma falsa per quello che nega” (p. 12).
Infatti, è difficile non riconoscere l’esistenza anche di un’altra realtà umana, cioè
quella culturale, simbolica, rappresentazionale, affettiva, emotiva, intrapsichica.
Luigi Longhin
123
“Αρχη′”, –Rivista di filosofia, I, 1: Filosofia, scienza, teoria della politica
La rivista di filosofia “Αρχη′”, a cura di Sandro Ciurlia, sorge dalla connessione di programmi di ricerca orientati al preciso recupero dell’idea della necessità
del riscontro di un’identità definita del concetto di ragione nella deriva dei relativismi contemporanei.
Se la filosofia sorge, quale ineliminabile esigenza, sin dai suoi albori, dall’ardore della “meraviglia”, e si sviluppa come lotta per la ragione intorno al centro
aggregatore del rigore dell’argomentazione razionale, allora l’assunzione del
pieno rispetto della sua vocazione volta al Logos equivarrà al progetto del seguire i pluriversi itinerari speculativi che la ragione ha, di volta in volta, intrapreso.
La com-posizione di una rivista, per la sua stessa natura complessiva di differenti contributi ed esperienze teoriche, sorge sempre dall’esigenza di assestarsi
nel solco di profondità variabile del dibattito filosofico che alimenta il proprio
tempo e lo induce all’autocomprensione, stanando difficoltà irriducibili o esperendo situazioni di passaggio al “limite”.
Tutto ciò confrontando scuole e tradizioni diverse, coordinando le ragioni della
storia con la prudenza della molteplicità dell’analisi storico-filologica e della pratica ermeneutica, assieme alle logiche esigenze fondative e sistematiche protese
a figurare nuovi orizzonti di sviluppo per il Pensiero.
L’accumulazione di significati razionalmente condotti a muovere dal classico
124
malioso pendio del “Taumazein”, propone i primi tratti del senso di una forma
nuova e specifica d’indagine, raccolta nella ricerca della verità e dell’universale,
quella filosofica, che, nel solco d’una tradizione ormai bimillenaria, attraversa le
differenze incarnando la vocazione pura del “Teorein”, per così dire flesso sull’oggetto nella maniera del vedere con gli occhi della mente.
È, di certo, lo spirito del primo libro del massimo sistema dell’essere dell’antichità, la Metafisica di Aristotele, ad aver contribuito ad abbattere la tenace resistenza dell’ignoto, ponendosi ai confini dei “flammanda moenia mundi”, verso la
delineazione della splendida superficie sia dell’universo fisico sia del cosmo della
spiritualità umana.
Questa costruzione di un sapere sistematico è sempre stata caratterizzata,
sopra ogni altra esigenza logica e filosofica, dalla ricerca di solidi basamenti fondativi. Da qui la scelta di un termine quale “Αρχη′” a designare nominalmente
una Rivista di filosofia: la differente strutturazione e sedimentazione semantica
del termine originale greco (come s’avvide lo stesso Aristotele in Metafisica V, 1,
1012 b 33 – 1013 a 23), bene rivela l’intento di raccogliere la molteplicità delle
direzioni della ricerca teoretica in una qualche versione unitaria e fondativa, al
fine di un costante riferimento critico alla natura ed ai principi del Pensiero.
Ma è inesatto pensare ad una radicalizzazione specifica ed esclusiva degli
intenti programmatici della Rivista, poiché la sua fisionomia teorica si erige su un
concetto fenomenologico di enciclopedia teso ad acclarare i termini di una dinamica sintetica e circolare dell’Idea, capace, tuttavia, di sottrarsi alle liquidatorie
chiusure di costituzioni sistematiche e conclusive dei limiti dello scire.
Tant’è che nel programma di presentazione degli intenti teoretici di Αρχη’
(Αρχη’: fenomenologia di un progetto) si trova un esplicito richiamo all’etimologia
dell’Εν−Κυκλο−Παιδεια (dalla quale risulta perspicuo il rinvio all’agglomerazione
dell’unità), a cui fa seguito la costituzione di “un’idea di filosofia che contempli un
allargamento controllato (vigile e prudente nelle concessioni) della nozione di
oggetto filosofico, senza con ciò produrre un fiacco appiattimento della filosofia
stessa sull’amorfa rena di una generica nozione di cultura, contesa da sin troppe
forme di sapere collocate nell’area delle cosiddette scienze umane” (ivi, p. 5).
Superate forme di edificazioni storicistiche e di altrettanto anguste genuflessioni filologistiche, le linee guida del progetto della Rivista si esplicano nell’assunzione di un concetto di ragione inteso nei termini di possibilità nell’elaborazione di una “teoretica topografia di un multivoco tragitto” di ricerca, esso stesso
rilucente della molteplicità delle sue componenti. Da qui l’idea di un olismo in
senso ermeneutico roso dalla necessità del ri-accesso teoretico ed interpretativo.
Nel corso della trattazione programmatica, in posizione di crinale si colloca la
leva euristica del dubbio, motivata da esigenze procedurali –e fondative– volte al
recupero delle radici delle prime certezze. In tal modo il richiamo a Kant, o, in
altri termini, alla filosofia dell’equilibrio critico fra il dogmatismo della ragione
rischiarante e lo scetticismo della giubilazione d’ogni pretesa di verità, diviene
evidente oltre che necessario.
La nascita di una concezione della filosofia in possesso d’una identità definita
non poteva non identificare gli spettri più perigliosi nello stesso scetticismo e nell’inconcludente relativismo, nelle cui fantasmatiche nebulose sono cadute gran
RECENSIONI
parte delle esperienze di maggiore seguito della filosofia contemporanea, dal
pensiero debole di italiana formulazione al rizomorfismo alla maniera di Deleuze.
Sottolineano gli autori: “Un concetto adeguato di ragione non si costituisce,
per così dire, su di un “piano di estensione indeterminabile”, i cui limiti siano riconosciuti solo in generale, ma deve essere piuttosto paragonabile –per dirla ancora con Kant– al concetto di “sfera”, “il cui raggio può essere determinato dalla
curvatura di un arco della sua superficie, in modo tale che sia possibile stabilire
con sicurezza il volume e la delimitazione di questa sfera” (ivi, p. 6).
L’osservazione del realizzarsi filosofico di questa sorta di palingenesi della
finitezza, propria dell’età susseguente alle grandi costruzioni della metafisica,
conduce ad un appello alla ragione ed alle sue tecniche (quasi di sapore neoillumunistico), una ragione non più intesa quale superiore facoltà sistematizzante,
ma letta come idea “proficuamente modellata sui contenuti molteplici che da
essa rampollano, nonché curvata sulle linee variabili delle ragioni a cui si riduce
scomponendosi” (ibidem), un’idea di ragione sorta nel mezzo degli estremi rappresentati, per un verso, dal modello unico e, per l’altro, dal pluralismo scatenato
di una post-modernità dai non mai sufficientemente chiariti pericoli.
Il fondamento costituito dall’“identità variabile della differenza” elabora un’idea
di ragione “che si presenta senza più drappeggi, priva di mandarinismi accademici, anche graficamente minuscola, ma consapevole della propria indecentrabile
rilevanza fondativa per quanto convinta dell’irriducibilità dei modi di pensare. E di
pensarla. Una ragione libera e congetturale, fluida e dinamica, modesta e orgogliosa […], alimentata dall’arsura contemplativa del “ taumazein”, […] sedotta
dalle malie irrefragabili dell’annosa domanda sul “perché” delle cose” (ivi, p. 7).
Una ragione, dunque, bramosa di riscoprirsi, rifuggendo dai sempre più meccanicistici modelli di comprensione elaborati dalla tecnica del pensiero meramente computazionale, ed irriverente verso circoli o statiche museificazioni, tutta protesa alla celebrazione di una ritrovata dynamis nello spirito avventuroso ed assieme sacro della ricerca, una ragione comunque convinta, con Wittgenstein, che
“ogni spiegazione è un’ipotesi”.
Per questi ordini di questioni, i numeri di “Αρχη′” che sfileranno nel tempo
vedranno il succedersi di contributi variamente vertenti sull’aporetica dei fondamenti dell’indagine scientifica, sul ruolo dell’analisi logica per una corretta teoria
dell’argomentazione, senza trascurare i sottili e fascinosi legami che, nel crocicchio di vie in cui verità e certezza –al punto di consertare se stesse– ritrovano i
lineamenti della propria identità nella distinzione, il sistema della ragione intreccia
con la dimensione del limite; un limite non privativo di superfici di dominio ma
elemento ineludibile della resa del significato delle sue parti; non limitativo ma
carico di direzioni inesplorate, a guisa dei richiami dei “sentieri interrotti” lungo i
quali il lucore della “radura” infittisce i suoi accenni. Un limite irto di difficoltà,
costantemente assiso ad abisso ed a baluardo, in un intercalare continuo d’umbratili balugini, quantunque la sua lacerante ricerca sia motivata dalla rassicurante persuasione hölderliniana secondo la quale “là dove c’è maggior pericolo cresce ciò che salva”.
Una deriva… un approdo.
La Rivista –per gettare un rapido e conclusivo sguardo alla sua composizione
125
126
strutturale– risulta articolata in sezioni, sicché, dopo i Saggi, trova luogo una
sezione di discussione (Forum: sentieri del pensare) intorno a temi di maggiore
attualità nell’odierno dibattito filosofico (in questo numero è messa a tema
L’espressione del pensiero fra autarchia e divulgazione), ed una successiva
(Effemeridi filosofiche) nella quale s’intendono proporre all’attenzione dello studioso la traduzione ed il commento di brevi e scarsamente note pagine di autori
altrettanto malconosciuti (in questa circostanza ha attratto l’attenzione l’opera di
uno dei primi maestri di Einstein, A. Stadler).
In questo primo numero il curatore, Sandro Ciurlia, ha ritenuto di poter giustificare il titolo monografico attraverso una trattazione della natura accomunante del
concetto di “comprensione” (La comprensione come unità della differenza.
Meditazioni di confine fra filosofia, scienza e politica. Per un’Introduzione).
Lo stesso autore ha proposto, di seguito, alcune riflessioni sull’identificazione
di un vero linguaggio del silenzio nella prima opera di Wittgenstein, frutto di
un’autentica resezione logica del linguaggio ed orientato a costruire una sua
semantica in funzione della dizione del trascendentale (Il linguaggio del silenzio
nel Wittgenstein del Tractatus).
In fondo, problematicamente legato a questo tema supremo della ricerca e
dello svelamento dell’Inizio, è il saggio, sempre di S. Ciurlia, sull’aporetica
dell’Anfang nel primo libro della principale opera logica di Hegel, nel quale si
dimostra il percorso hegeliano del relarsi tetico della scansione delle determinazioni logico-ontologiche nella sintesi dialettica, condizionate dallo status del sistema che induce a mutare il concetto ordinale di mero cominciamento in principio
(Per un’illustrazione fenomenologica dell’Inizio: l’Anfang fra cominciamento e
principio nella Scienza della Logica di Hegel).
Trovare il principio significa trovare il fondamento, da qui la trattazione della
questione, da parte del medesimo autore, mediata per tramite di un intendimento
matematico del concetto di relazione, l’unico responsabile dell’accadere logicoordinale del fondamento-principio in generale (L’evenire del fondamento: la relazione).
Con Giorgio J. Mastrobisi han ricevuto puntigliosa trattazione, invece, la spinosa questione storiografica delle fonti responsabili della formazione scientifica
di Einstein negli anni del Politecnico (Fonti weberiane nei primi studi di Einstein
su termodinamica ed elettrodinamica al Politecnico di Zurigo) e gli spunti teorici
contenuti nel saggio einsteiniano del 1905 Nuova determinazione delle dimensioni molecolari (Sviluppi teorici e implicazioni matematiche nelle ricerche einsteiniane sulla Nuova determinazione delle dimensioni molecolari).
Sulla questione della globalizzazione si è soffermato, infine, Andrea
Gabbianelli, interpretando l’ecologismo come una forma ed una garanzia culturale di pluralismo (Le culture verdi nel villaggio globale: l’ecologismo come pluralismo culturale), Michele Gaetani ha proposto alcune riflessioni sul concetto di
Persona (Ecce homo), mentre Francesco Torre ha ripercorso le tappe dell’autocostituzione teoretico-scientifica del concetto di tempo (Riflessioni sul tempo).
Francesca Scardia
Volumi:
A.ARGEMÌ, P.GROENEWEGEN, C.PERROTTA, T.RAFFAELLI, Reflections on economic development, a c. di
G.Forges Davanzati e V.Gioia, Lecce, Milella, 1999, pp.86;
G.BACHELARD, La filosofia del non. Saggio di una filosofia del nuovo spirito scientifico, a c. di
G.Quarta, Roma, Armando, 1998, pp.160;
G.BARLETTA, Carte marine. Ricerche in filosofia, Bari, Dedalo, 1999, pp.130;
L.BATTAGLIA, M.CERUTI (a c. di), Bioetica e cultura della complessità, Cesena, Macro, 1998, pp.174;
S.BERNI, Soggetti al potere. Per una genealogia del pensiero di M.Foucault, Milano, Mimemis,
1998, pp.114;
R.BORTONE, Una formazione per la società complessa, Lecce, Agorà, 1998, pp.158;
V.CAMERINO, Il cinema e il ‘68. Le sfide dell’immaginario, intr. di S.Tomeo, Manduria, Barbieri, 1998,
pp.198;
A.C APITINI , Scritti filosofici e religiosi , a c. di M.Martini, Perugia, Fondazione Centro Sudi
“A.Capitini”, 1998, pp-XXXII, 660;
E.CIULLO, Handicap svantaggio istituzioni, Lecce, Pensa, 1998, pp.188;
S.CRESTANI, Ruth la spigolatrice, Vicenza, s.e., 1999, pp.56;
M.DEUTSCH, Sit venia verbo. Heidegger e il nazismo, a. di S.Arcoleo, con un saggio di M.Conche,
Novara, Interlinea, 1998, pp.110;
C. Di MARCO, Critica e cura di sé. L’etica di M.Foucault, Milano, Angeli, 1999, pp.234;
D.FELICE (a c. di), Leggere “L’esprit des lois”. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu,
Napoli, Liguori, 1998, pp.287;
G.FARINA, L’ Alterità. Lo sguardo nel pensiero di Sartre, Roma, Bulzoni, 1998. pp.128;
C.L.FERRARO, Studi unamuniani, Lecce, Milella, 1999, pp.252;
E.FIORANI (a c. di), Il rito alimentare. Una prospettiva antropologica per una riflessione etica ,
“Quaderni di bioetica”, Cesena, Macro Edizioni, 1999, pp.206;
F.FORTINI-F.LOI, Dialoghi franchi, present. di D.Margarito, Lecce, Manni, 1998, pp. 124;
C.GUASTELLA, Opera omnia, vol. I, tomo III, Saggi sulla teoria della conoscenza. Appendice della
parte prima, a c. di C.Dollo, Comune di Misilmeri, Università di Catania, 1998, pp.XXVIII, 428;
E.HUSSERL-M.HEIDEGGER, Fenomenologia, a c. di R.Cristin, Milano, Unicopli, 1999, pp.258;
G.INVITTO, Alain. Un filosofo dei segni, Lecce, Manni, 1999, pp.206;
G.INVITTO, Narrare fatti e concetti, Lecce, Milella, 1999, pp.204;
M.-F.-P. M AINE DE B IRAN , Frammenti sui fondamenti della morale e della religione , a c. di
S.Cavaciuti, Gaeta, Bibliotheca, 1998, pp.94;
R.LAPORTA, C.MAUCERI, A.SANTONI RUGIU, A.SEMERARO, M.VIGLI, Scuola pubblica Scuola privata.
Parità e costituzione, Scandicci, La Nuova Italia, 1988, pp.164;
L.LEPRI (a c. di), Identità culturale e valori universali: Comenio e Vico, Roma, Armando-Fond. Nova
Spes, 1998, pp.128;
R.LOURAU, La chiave dei campi. Un’introduzione all’analisi istituzionale, Lecce, Sensibili alle foglie,
1999, pp. 120;
A.MARTONE, Verità e comunità in Merleau-Ponty, Napoli, La Città del sole, 1998, pp.262;
V.MATHIEU e L.PAOLETTI (a c. di), Il problema della fedeltà ermeneutica, Roma, Armando-Fond. Nova
Spes, 1998, pp.352;
P.MICCOLI, Homo loquens. Oralità e scrittura in Occidente, Roma, Urbaniana University Press,
1998, pp.160;
A.NEGRI, Modernità e tecnica, Roma, Seam, 1998, pp.X-318;
RECENSIONI
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA SEGNI E COMPRENSIONE
(oltre quelle recensite nella rivista)
127
M PÉREZ JULIÀ, Rutinas de la escritura. Un estudio perceptivo de la unidad parrafo; Valencia,
Universitat, Departament de Teoria des llenguatges, 1998, pp.200;
A.PINOTTI, Il corpo dello stile. Storia dell’arte come storia dell’estetica a partire da Semper, Riegl,
Wolfflin, Centro Internazionale di Estetica, Palermo, Suplementa, n.2, 1998, pp.268;
F.RAVAGLIOLI, Rileggendo Hegel, Roma, Armando, 1999, pp.128;
R.ROMANI, Theoretica, libro III, Fiesole, Cadmo, 1998, pp.192;
P.A.ROVATTI, Il paiolo bucato. La nostra condizione paradossale, Milano, Cortina, 1998, pp.210;
A.TARANTINO e R.ROCCO (a c. di), Il Processo di Norimberga a cinquant’anni dalla sua celebrazione,
Milano, Giuffré, 1998, pp.354;
TOMMASO D’AQUINO, Il Male, a c. di F.Fiorentino, Milano, Rusconi, 1999, pp.1428;
S.VUSKOVIC ROJO, Breviario de Platon, Valparaiso, Universidad de Playa Ancha, 1998, pp.276;
Periodici:
128
Aesthetica Preprint, n.54, dicembre 1998: Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica;
Acta Philosophica, f.II, v.7, 1998;
Alternative Europa, n.7, ottobre-novembre; n.8, dicembre 1998; n.9, febbraio 1999;
Antologia Vieusseux, n.s., a.IV, n.11-12, maggio-dicembre 1998;
Aquinas, a.XLI, f.1 e f.2, 1998;
Cahiers du Centre Intedisciplinaire des Sciences du Langage, Université de Toulouse-Le Miral,
n.12. 1997;
Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano, v.V, n.5, 1997; v.VI, n.6, 1998;
Economia e società, n.0, ottobre 1998;
Escritos de Filosofia, n.32, a.XVI, 1997: Historia e interioridad II;
Estudios Mindonienses, 28 n.14, 1998;
Fonti e documenti, Centro studi per la storia del Modernismo, n.25-27, 1996-1998;
Hermeneutica, n.s., 1998: Diritto e teologia;
Il gallo silvestre, n.10: Scritture d’Africa
Interculturel, Alliance Française, Lecce, n.1, 1998;
Itinerari, n.2, 1998; n.3, 1998;
Le carte 3, Fondazione “R.Murri”, 1998;
Les études merleau-pontiennes, n.3, september 1997; n.4, september;
Liber Ars, n.1, febbraio n.5-6, a.III, 1998;
L’immaginazione, n.150, ottobre; n.151, novembre; n.152, dicembre 1998; n.153, gennaio; n.154
febbraio 1999;
L’incantiere, a.XII, n.46, giugno 1998;
Louvain international, n.2, 1998;
Notes et documents, Inst. Internat. J. Maritain, n.s., n.51-52, janvier-aout 1998;
Paradigmi, n.s., a.XVI, n.47, maggio-agosto 1998; Leopardi: pensiero e poesia; n.48, settembredicembre 1998: Filosofia sociale, oggi;
Quaderni del Centro Studi “C. Trabucco” e della Fondazione “C.Donat-Cattin”, Torino, n.23, 1998:
Lettere pastorali dei vescovi delle diocesi di Biella e Ivrea, a c. di M.Neiretti e R.Reinerio; n.24,
1998, Lettere pastorali dei vescovi delle diocesi di Alessandria, Asti, Pinerolo, Saluzzo;
Recherches husserliennes, v.10, 1998;
Rinascita della scuola, n. 5, n.6, 1998; n.1, 1999;
Rivista di filosofia, vol.LXXXIX, n.3, dicembre 1998; n.6
Symbolon, a.II, n.3-4;
Studi storici e religiosi, a.VII, n.1, gennaio-giugno 1998;
Uomini e idee, n.4, 1998;
129
130
131
SAGGI