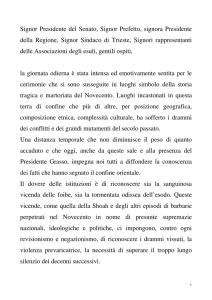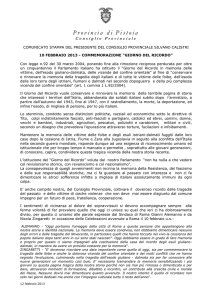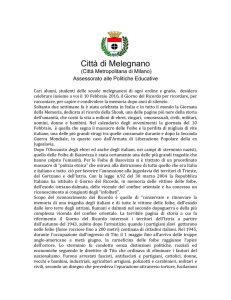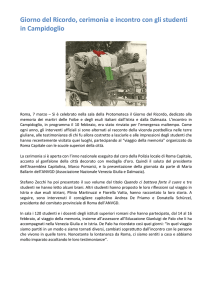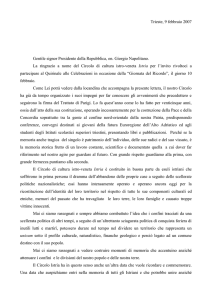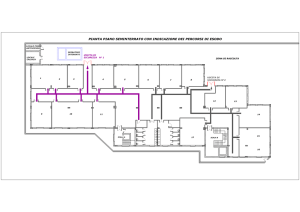Beni che si perdono e che si conservano. Case e
masserizie nella memoria dell’esodo istriano a
Trieste
Stefano Pontiggia
Università degli Studi di Ferrara
Direi che la memoria, soprattutto, è una questione di responsabilità nei confronti di qualcosa di cui spesso non si è autori. D’altronde credo che non si diventi veramente uomini se non
nella misura in cui si è capaci di rispondere di
ciò di cui non si è direttamente gli autori, e di
colui con cui, apparentemente, non si ha nulla
in comune1.
Padriciano è una località non molto lontana da Trieste nelle colline del Carso. È un piccolo
borgo di circa ottocento abitanti ed è conosciuto in zona per essere la sede del più grande parco tecnologico e scientifico d’Italia nonché il luogo che ospitò un campo profughi in cui centinaia di persone che avevano abbandonato la regione dell’Istria nel secondo dopoguerra trovarono un primo rifugio2. Oggi ciò che resta del campo è adibito a Museo dell'esodo ma la sua
struttura era imponente, avendo la capacità di ospitare sino a cinquemila persone. Nel terreno
che circonda l’edificio principale posso ancora osservare le fondamenta delle baracche in cui
furono ospitati singoli e famiglie. Sulla parete rossa dell’edificio principale tre gigantografie
mi accolgono mentre salgo i pochi scalini che conducono all’interno. Sono tre ritratti di bambini, due di loro li conosco, siamo rimasti amici nel corso di tutti questi anni.
A far da padrone in questo luogo sono gli oggetti di uso comune. All’ingresso è possibile notare una bicicletta e alcuni strumenti di lavoro a rappresentare il materiale che gli esuli portarono con sé durante il viaggio. Proseguendo lungo l’interno, la prima cosa che si para dinanzi
agli occhi è un muro ricoperto con le copie dei documenti identificativi prodotti durante le
procedure di accoglienza. Vi sono segnati la data di ingresso in Italia, il luogo di nascita e
quello di residenza alla data del 6 giugno 1940, giorno in cui l’esercito italiano entrò in guerra. Quella che un tempo era la sala comune, nell’ala destra dell’edificio, ora ospita uno spazio
congressi in cui è possibile visionare documentari e servizi del cinegiornale dell’epoca. Tornando verso l’ingresso si aprono sulla destra due piccole stanze che riproducono le cellule
abitative predisposte per i profughi: aventi normalmente un perimetro di quattro metri per
quattro, erano provviste di un letto e di una piccola cucina per scaldare le vivande. Documenti
e fotografie dell’epoca, vestiti e strumenti di lavoro sono appesi alle pareti ed esposti sui semplici tavoli in legno che arredano le stanze. In fondo a sinistra rispetto all’entrata si trova la
stanza delle masserizie. Sono accatastate nel centro, fin quasi a raggiungere il soffitto, a ricordarne la disposizione casuale in cui furono raccolte al Porto vecchio.
1
A. Mebmbe, Che cos’è il pensiero postcoloniale?, «Aut Aut», vol. 339, 2008, p. 64.
P. Delbello (a cura di), C. R. P. Per una storia dei campi profughi istriani, fiumani e dalmati in Italia, Istituto Regionale
per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata (IRCI), Trieste 2004.
2
L’effetto emotivo provocato dalla vista degli oggetti è toccante, poiché questi sembrano
incorporare la fuga di quella moltitudine di persone e, allo stesso tempo, traggono la loro legittimità dall’essere stati trasformati in oggetti museali e dal processo sociale che li ha condotti sino a lì. La storia e l’oggetto chiamato a testimoniarla si confermano a vicenda. Durante la
mia prima visita al campo, nel mese di febbraio 2007, il cielo era sereno. Il freddo intenso e la
luce che filtrava dalle finestre poste sui lati della stanza evidenziavano leggermente la segatura che ricopre il pavimento donando all’atmosfera un aspetto irreale. La massa di valigie e
bauli si ergeva come un monumento nel museo, ulteriore segno di quelle dimensioni del fenomeno che per molto tempo hanno creato problemi di contabilità3.
Gli esuli assegnano un valore particolare alle masserizie, che intendono come veri e propri
oggetti di memoria. Ricordo ancora le parole di un responsabile dell'Istituto di Ricerca sulla
Cultura Istriana, Fiumana e Dalmata (IRCI). Parlando dell’esodo giuliano egli affermava che
sebbene nel corso del secondo dopoguerra ci fossero stati altri spostamenti forzati di persone,
anche molto più ingenti di quello istriano4, quest’episodio poteva dirsi unico proprio perché,
anche a causa delle particolari modalità di evacuazione5, conservava la traccia fisica delle
masserizie a testimonianza dell’evento. Soprattutto, questi beni perduti e conservati svolgono
un ruolo fondamentale nel processo di integrazione degli esuli in seno alle associazioni diasporiche presenti nel territorio di Trieste. Una breve storia di vita ne mostrerà il meccanismo.
Francesca
Gabriella Turnaturi, esaminando da una prospettiva sociologica un racconto di Philip
Dick6, afferma che ogni società deve la sua coesione anche a un determinato set di memorie e
narrazioni condivise che, soprattutto in presenza di regimi totalitari, vengono immesse nella
sfera pubblica sotto forma di souvenir sempre uguali a se stessi e in grado di annichilire il ricordo individuale necessario a mantenere nel tempo la propria identità e a proiettarsi nel futuro in quanto testimoni7. Questo processo, che mette in luce il ruolo fondamentale del potere,
porta l'autrice ad affermare che le società che si affidano a queste memorie standardizzate sono senza futuro. Da un punto di vista antropologico, tuttavia, non possiamo dimenticare che
qualunque potere, anche quello di ricordare per gli altri, non si impone mai in modo soverchiante su soggetti passivi e sottomessi: esistono sempre degli spazi di agency e di partecipazione, in senso contrastivo o cooperativo, attraverso cui gli attori sociali sono in grado di posizionarsi nel mondo in modo consapevole. Può anzi accadere che sia proprio la narrazione
del potere a dotare di coerenza e prospettiva futura dei ricordi sparsi e senza legami.
Francesca è una donna minuta di circa settant’anni, capelli lisci castani e un paio di occhiali dalla montatura spessa. Lavorò in fabbrica sino alla pensione e per qualche anno fu attivista
nel movimento radicale. Primogenita di sei figli, appartenente a una famiglia contadina che
possedeva alcune proprietà espropriate dal governo civile jugoslavo, esodata insieme a fratelli
e genitori, giunse a Padriciano nel 1955. La situazione di precarietà della famiglia e sua personale, frutto di anni vissuti fra un collegio di cui conserva un ricordo forse più sofferto di
3
Le cifre oscillano fra le 250.000 unità ipotizzate dagli storici accademici e le 350.000 affermate negli ambienti esuli.
M. Cattaruzza, M. Dogo, R. Pupo, Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo, ESI (Quaderni di
Clio, n.s., 3), Napoli 2000.
5
Rispetto a quanto accadde in Europa Centrale, in questo caso non ci fu in genere l’ingiunzione di abbandonare le case
entro un tempo prestabilito. Questo permise a una buona fetta di profughi di raccogliere parte dei beni a loro disposizione.
Famose in questo senso, almeno a livello locale, sono le immagini di Pola/Pula, dove furono prelevate anche le insegne dei
negozi e le bare.
6
P. Dick, «Ricordiamo per voi», in Id., Rapporto di minoranza e altri racconti, Fanucci, Roma 2002 [1966], pp. 155185.
7
G. Turnaturi, «“Ricordiamo per voi”», in M. Rampazi, A.N. Tota, Il linguaggio del passato. Memoria collettiva, mass
media e discorso pubblico, Carocci, Roma 2005, pp. 45-57.
4
quello del campo stesso e il successivo periodo a Padriciano, durò dodici anni. Quando parla
della sua infanzia e giovinezza Francesca mi descrive un doppio abbandono causato della forzata lontananza dai genitori seguita allo spostamento dall’Istria.
Quegli anni e le successive difficoltà sul posto di lavoro le avevano lasciato un senso di
malessere rimasto per anni non indagato, anche a causa della tenera età all’epoca dei fatti e
del silenzio dei genitori riguardo alla vicenda («Avevo sempre una sensazione di inferiorità,
in fabbrica all’inizio mi chiamavano “la fascista”»). La sensazione di sradicamento, le difficoltà del campo, i traumi della vita in collegio e i problemi di un faticoso reinserimento nella
vita civile, insieme a una fondamentale incomprensione di quanto era accaduto, avevano provocato una presa di distanza dal suo passato rimasto senza elaborazione.
Le cose cambiarono alla morte dei suoi genitori. Nel 1997, spinta dalla curiosità, si avvicinò a una manifestazione che un’associazione di rappresentanza degli esuli aveva organizzato
in Piazza Unità d’Italia e incontrò un’insegnante, figlia di esuli, che la invitò a partecipare alle
loro attività. Dapprima assistendo a un convegno, poi con maggiore assiduità, si legò a questo
mondo. Fu in quel periodo che iniziò a formarsi un’idea di quanto le era capitato: gli incontri
in associazione, le spiegazioni dei responsabili, la lettura delle riviste e della memorialistica la
aiutarono a fare ordine in un’esperienza di espatrio e profuganza rimasta fino ad allora confusa. Acquisì informazioni sul periodo storico che aveva attraversato, sulla guerra e il dopoguerra, e questa narrazione divenne fondativa della sua identità poiché permise il passaggio da
un lutto non elaborato a quella che definisce una riscoperta identitaria. La narrazione che
l’accolse ebbe l'effetto di fornirle uno strumento di definizione di sé e di trasformarla, con gli
anni, in una fonte narrativa essa stessa: collaborò a un paio di pubblicazioni per le quali scrisse le sue memorie e, soprattutto, aderì al progetto del campo-museo di Padriciano nella veste
di testimone privilegiata. Francesca è stata per anni una delle guide che descrivono ai visitatori le condizioni di vita e la quotidianità in quell’istituzione totale.
Il racconto di quest’esperienza mi fa tornare alla mente una riflessione dell’antropologo
Michael Fischer8. L’autore analizza alcune autobiografie di statunitensi dalle origini meticce
in cui è descritto il loro percorso verso una maggiore consapevolezza etnica. Attraverso le pagine i narratori snodano la ricerca delle origini extra-americane delle loro famiglie in un percorso che solitamente si conclude con una raggiunta coerenza tra il sé attuale e il proprio passato. A questo proposito, Fischer utilizza la nozione di trasfert definendola nei seguenti termini:
L’approssimarsi–allontanarsi di un passato più grande di noi, che definisce la nostra identità, ma non necessariamente proviene dalla nostra esperienza. E noi ci troviamo senza controllo sul nostro essere. È un principio storico di realtà: l’esperienza individuale non è di per sé sufficiente. È essa stessa ripetizione […].
L’ansia si riduce stabilendo un punto di continuità con il passato là dove c’era la rottura, il silenzio9.
Esistono grosse divergenze tra l’esperienza di Francesca e quelle descritte da Fischer. Per
prima cosa, e soprattutto, la mia interlocutrice sapeva da dove arrivava, avendo vissuto per alcuni anni in Istria. Sapeva cosa aveva abbandonato, e conservava ricordi molto vividi della
sua casa natale, dei suoi parenti e della sua infanzia in Istria. Ciononostante, gli eventi bellici
che segnarono il suo passato come quello di moltissime altre persone trascendevano la sua
singola esperienza al punto da essere per lei incomprensibili senza una voce che li riordinasse.
Questo passato incerto emerge dalle sue parole come mobile, sfumato.
L’aspetto fondamentale della sua ricerca risiede nel suo essere pubblica e socialmente condivisa. Solo attraverso il contatto e la frequentazione con le associazioni esuli Francesca era
8
M. Fischer, «Etnicità e arti postmoderne della memoria», in J. Clifford, G.E. Marcus, Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, Roma 1997 [1986], pp. 267-314.
9
Ivi, pp. 279-280.
stata in grado di ricevere quel materiale connettivo utile a reinserire i propri ricordi e le proprie sensazioni in un quadro di coerenza, e solo il raggiungimento di quest’ultima aveva aperto a un’altra dimensione temporale, il futuro. Dice ancora Fischer:
La ricerca o la lotta per l’acquisizione di un’identità etnica è una (re-)invenzione e una scoperta di una visione etica orientata al futuro. Mentre la ricerca di una coerenza si fonda sul collegamento con il passato, il significato che da esso viene estratto – un criterio decisivo per la coerenza – è un’etica utilizzabile nel futuro10.
La raggiunta coerenza rispetto a quanto accaduto consente oggi a Francesca di darsi
un’identità di esule, di testimone privilegiata, di sopravvissuta alla vita nei campi e nei collegi, legando la sua condizione attuale a un passato più chiaro e a un futuro in cui la sua storia,
o meglio il significato che essa ne trae, è divenuta spinta etica al ricordo pubblico attraverso la
testimonianza. Lo snodo fondamentale è la proposta narrativa delle associazioni esuli e il particolare processo sociale di produzione di uno sguardo sul passato e di quella che si può definire una «cultura della nostalgia».
Cultura della nostalgia
Nel suo lavoro etnografico11, l’antropologa Pamela Ballinger afferma che l’immagine della
foiba può essere assunta a metafora della condizione in cui si trova la memoria dell’esodo, nascosta tra le pieghe di un passato nazionale con molti punti ciechi12. Anche se oggi, a dieci
anni dalla promulgazione della legge di istituzione della Giornata del Ricordo, non possiamo
più sostenere con forza la sua affermazione, possiamo comunque affermare che il lavoro svolto nelle associazioni è ancora interpretabile come un’opera costante di esumazione dei ricordi
e di loro ricomposizione in un quadro di coerenza che integri le esperienze individuali in un
modello generale di riferimento. Gli strumenti di tale operazione sono prodotti all’interno delle associazioni stesse. Per Dario, che aveva vissuto per molti anni a Padriciano e che attualmente risiede a Roma, l’incontro con il mondo associativo ha favorito il colmare lacune rimaste fino a quel momento irrisolte attraverso le interazioni intrattenute e il materiale ricevuto
e studiato:
Quando hai cominciato a capire qualcosa sulla storia? C’è stato un momento, una lettura, un incontro, che ti
hanno aiutato?
No, io devo dire la verità, io ho cominciato a riflettere, come tutti del resto, sette-otto anni fa. Allora io sapevo che esistevano le famiglie istriane, però a livello solo di associazione così, nuda e cruda, senza sapere di
che cosa si interessavano, quali erano i fini, le finalità... Poi ho conosciuto l’IRCI, l’Istituto per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, lì c’è un mio parente, o quasi, che è direttore generale, e quando venivo su ho cominciato a frequentare qua, a frequentare là, a sentire un po’ loro, han cominciato a darmi delle pubblicazioni,
ho cominciato ad andare a un po’ di manifestazioni che ci sono state, e da qui mi sono appassionato del tutto.
Oltre a fornire una maggior consapevolezza storica, molto spesso la partecipazione permette l’ingresso in spazi di condivisione e di riflessione collettiva. L’età alla partenza dall’Istria
gioca un ruolo molto importante nel successivo lavoro di comprensione degli avvenimenti
bellici. Laura, esule che oggi ha circa settant’anni, fuggita dalla zona del Capodistriano e frequentatrice di più associazioni, era partita in età adolescenziale. Per questo motivo era in pos-
10
Ivi, pp. 268-269.
P. Ballinger, History in Exile. Memory and identity at the borders of the Balkans, Princeton University Press, Princeton, NJ 2003. Una versione italiana è uscita per i tipi di Il vetro con il titolo Memoria dell’esilio. Esodo e identità al confine
dei Balcani.
12
Ivi, pp. 129-135.
11
sesso di una certa preparazione storica, frutto di ricerche e letture precedenti all’ingresso in
associazione e favorita dalla consapevolezza di quanto accaduto oltre confine:
Cominciare a frequentare queste due associazioni con più frequenza le ha dato una mano a capire cosa le
era successo in Istria, oppure ha avuto la possibilità di capire anche prima?
Questo forse capita alle persone più giovani, guarda, io a casa mia il discorso di ogni giorno finché sono morti mia mamma e mio papà era questo. Intanto io mi sono documentata con libri, pochi, quelli che c’erano, però ho sempre cercato di capire, di parlare, di sapere tutto... Perciò quando sono venuta sapevo tutto, e ho cominciato anzi a scrivere le cose. Sono cresciuta con questo, con la consapevolezza di quello che avevamo subito, che avevamo perduto…
Anche in questi casi, lo spazio associativo è in grado di assumere una funzione di connessione tra i soggetti, di scambio e di integrazione delle diverse esperienze. Ricordo che ogni
volta entrassi nella sede di una delle associazioni potevo imbattermi in piccoli capannelli di
persone intente a raccontarsi vicendevolmente le proprie storie, oppure a discutere degli argomenti più svariati, come le politiche slovene e croate riguardanti i vecchi cimiteri. A turno,
chi in precedenza aveva fatto parte dell’audience diveniva testimone e narratore.
Le sedi stesse sono strutturate in modo da rendere sempre possibile una continua attualizzazione del ricordo grazie all’esposizione di beni, oggetti e immagini. Ai muri sono appese
vecchie mappe della regione istriana, manifesti elettorali, gonfaloni recanti gli stemmi delle
varie cittadine; nelle bacheche sono esposti testi di memorialistica e brevi trattati storici editi
dalle stesse associazioni, i cui autori sono sovente gli stessi associati. Sale comuni ospitano le
prove del coro istriano insieme a numerose proiezioni fotografiche e visioni di documentari, e
la stampa associativa passa di mano in mano, commentata e discussa dagli astanti. In questo
modo, la memoria collettiva dell’esodo prende forma quotidianamente, permettendo
l’incontro e la fusione di narrazioni personali in un grande racconto continuamente rappresentato ed elaborato. La riscoperta di legami passati, la costruzione sociale di ricordi diffusi e
condivisi e l’esposizione alle narrazioni prodotte dai responsabili associativi creano percorsi
lungo i quali gli esuli non solo approfondiscono le loro conoscenze, ma le inseriscono in un
quadro caratterizzato da una maggiore coerenza.
Il mondo associativo è uno spazio molto articolato e fluido in cui interazioni quotidiane,
oggetti e attività più o meno routinarie creano un milieu che favorisce l’emersione e la continua attualizzazione delle memorie. Accanto alle pubblicazioni e ai seminari di taglio storico
sono organizzate gite nell'entroterra e manifestazioni che si snodano in varie zone della città.
Il concatenarsi di queste micro-interazioni ed eventi pubblici favorisce il senso di appartenenza a una comunità morale immaginata come unita, omogenea e storicamente localizzabile nei
territori a Est del confine orientale d’Italia.
Una domenica di metà maggio 2007 fui invitato per una gita in Istria. Il programma prevedeva di addentrarsi lungo la Strada Costiera che scende fino a Pola/Pula, attraversando le regioni dette «Terre Rosse» e «Terre Bianche»13. Entrammo in Slovenia lungo il confine del
Rabuiese lasciandoci alle spalle il paese di Portorose/Portorož, e da subito ogni luogo osservato divenne lo sfondo su cui erano proiettati ricordi e storie che i miei compagni di viaggio
raccontavano per fornirmi informazioni aggiuntive.
Il transitare nei dintorni dei luoghi di origine favoriva il racconto di episodi del passato che
si intrecciavano gli uni agli altri, trovando il loro senso non tanto negli aspetti contenutistici
quanto nella configurazione corale del commemorare. Alcuni commenti erano nostalgici. Ricordo Libero, un uomo di circa sessantacinque anni con cui avevo più volte attraversato il
confine durante alcune sue brevi trasferte lavorative a Rovigno/Rovinj, affermare: «Guarda
che bella terra abbiamo perso!». Frequenti erano le esclamazioni di rabbia e tristezza per la
13
I nomi richiamano il colore che la terra, nelle varie zone della regione istriana, assume a causa degli elementi chimici
che la compongono.
situazione geo-politica che gli eventi della II Guerra mondiale avevano causato e per i cambiamenti nell’assetto urbano che nel volgere degli anni avevano coinvolto i vari paesi.
Indirizzati dalla voce del presidente, che narrava storie locali ed esprimeva commenti
sull’operato dei politici italiani durante le trattative propedeutiche al Trattato di pace, i miei
compagni di viaggio osservavano regioni note e meno note, rammaricandosi per ciò che definivano la perdita di un territorio incantevole nel paesaggio e ricco di testimonianze di un passato italiano. La nostalgia presente nelle interviste ed espressa nelle comunicazioni personali
diveniva durante il viaggio una pratica collettiva di riappropriazione simbolica dei luoghi14.
Attraverso il richiamo nostalgico alla propria infanzia, alla casa perduta e alle prospettive interrotte dalla guerra e dalla fuga, l’Istria contemporanea era trasfigurata in un Paradiso perduto. Più che configurarsi come una condizione individuale, la nostalgia espressa nei commenti
e nei racconti che ascoltavo a bordo del bus assumeva lo status di uno strumento semantico,
socialmente costruito, con cui evidenziare allo stesso tempo sia un’origine localmente situata,
necessaria a una definizione di sé in senso etnico e geografico, sia la distanza morale dal paesaggio istriano contemporaneo che costituiva una risorsa simbolica fondamentale per potersi
definire in quanto esuli.
In questo contesto, le emozioni divengono non solo mezzo di espressione di uno stato
dell’essere ma strumenti per interpretare un paesaggio, una biografia, una condizione comune.
Se, come dice l’antropologo Arjun Appadurai15, «le emozioni, per molti aspetti, si imparano»,
il viaggio in bus era senz’altro parte di un apprendimento che aveva già visto altri snodi concretizzarsi nelle riunioni oppure nello stile degli scritti rintracciabili nella stampa associativa.
I miei interlocutori imparavano a vivere e ricostruire le loro emozioni mettendole in risonanza
con l’habitus affettivo16 adeguato al processo di immaginazione sociale dell’Istria in quanto
Paradiso perduto. Quali sono le caratteristiche di questo luogo dell’immaginario?
Paradiso perduto
Anna è una donna nata a Capodistria/Koper che all’epoca della ricerca aveva quasi settant’anni. Era partita alla volta dell’Italia nel 1947. Molto legata affettivamente alla sua città,
racconta la sua storia immergendosi nel tempo delle origini, legandolo al passato prossimo
senza una reale soluzione di continuità. La genealogia, dice lo storico dell’antichità Jan Assmann17, permette di colmare la distanza tra il presente e il tempo delle origini. Questo legame
tra presente e tempo delle origini funge da strumento di legittimazione di un’istanza attuale.
Ha inoltre la funzione di costruire un legame strettissimo con la terra: «Ecco, allora, la mia
famiglia è a Capodistria, almeno da quello che mi risulta, che sono riuscita a andare indietro,
dal 1411, all'epoca delle crociate…».
La genealogia è, sempre, anche un fatto di geografia. Nel mostrare l’antica presenza della
sua famiglia sulle coste istriane, Anna tratteggia un’origine comprendente una più vasta comunità di persone di sentimenti italiani. La metafora agricola è funzionale al racconto18: l’idea
di una cultura radicata nel suolo istriano è un’immagine che, nel descrivere una comunità morale, assume sovente la funzione di rintracciare un forte legame fra terra, comunità e appartenenza nazionale al di là delle divisioni campanilistiche pur presenti fra i vari paesi. È possibile
14
L. Abu-Lughod, C. Lutz, «Emozione, discorso e politiche della vita quotidiana», in C. Pussetti (a cura di), Antropologia. Annuario, anno 5, numero 6, Meltemi, Roma 2005, pp. 15-35.
15
A. Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi, Roma 2001, p. 190.
16
A. Donzelli, D. Hollan, «La disciplina delle emozioni tra introspezione e perfomance: pratiche e discorsi del controllo
a Toraja (Indonesia)», in C. Pussetti (a cura di), Antropologia. Annuario, cit., pp. 15-35.
17
J. Assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino
1997 [1992], p. 42.
18
P. Ballinger, History in Exile, cit., p. 183.
rilevare un legame che unisce le operazioni retoriche del riavvolgere il filo del tempo per rintracciare le origini familiari o comunitarie e dello scendere in profondità nella terra, per far
riemergere le «radici» della presenza italiana in Istria. In questo senso, si comprende come
una costante attenzione sia da lei, dedicata, nel parlarmi, alla rivendicazione della composizione etnica della regione istriana. Il punto centrale è costituito dall’affermazione di un carattere italiano dell’area, incorporato in un’idea di «venezianità» di elementi materiali come lo
stile architettonico, e in un riferimento alla «cultura» italiana intesa come bagaglio letterario,
artistico e religioso. Attraverso lo spiegarsi di un filo rosso tendente a mostrare una storia che,
escluse poche regioni dell’interno istriano e alcune epoche ben circoscritte, parlava italiano, si
configura un passato ricreato attraverso l’espulsione della differenza.
Giulio, profugo da Pirano/Piran, ha settant’anni all’epoca del nostro incontro. Ha girato il
mondo come fotografo e documentarista, ma non perde la sua vis polemica quando ripensa alla storia e all’attualità delle regioni istriana e dalmata:
Perché [la costa istriana e dalmata] era di Venezia, scusa, prima dell’Austria, prima di Napoleone di chi era?
Non era di Venezia la costa? Poi è arrivato Napoleone, ha fatto cadere Venezia, poi è caduto Napoleone e tutto quanto è stato dato all’Austria, per cento anni, no? Circa. Poi è caduta l’Austria. Allora? [La chiamano]
Croazia… Ma prima non era Venezia? Allora? Io non so dove hanno… Sì d’accordo, le campagne erano slave, ma i centri erano italiani, i sindaci di Spalato, di Traù, di Sebenico, erano città italiane.
L’identità territoriale italiana richiamata dagli esuli è, generalmente, egemone19 e testimoniata esemplarmente dall’esistenza di iscrizioni in lingua italiana e dalle tombe di famiglia,
segno tangibile e materico di una presenza sul suolo istriano e dalmata che si perde
nell’intreccio delle generazioni. Giulio insiste molto su quest’argomento20:
Io vedo epigrafi tutte scritte in latino, vedo fuori dalle chiese tutto scritto in italiano, non vedo scritte in croato, o sloveno, magari, gli darei anche ragione, ma non c’è. Non c’è, non c’è. Le tombe, ma le tombe, ma vai a
vedere le tombe, di Ragusa, delle corporazioni… le tombe in croato e sloveno sono solo nel dopoguerra, non
c’erano. Sì c’erano uno o due, nelle campagne c’erano ma nelle città non c’erano.
Molti dichiarano di appartenere a famiglie di proprietari terrieri; nei racconti, le descrizioni
della casa natale e del luogo di nascita assumono un carattere pastorale, descrivendo con nostalgia un mondo di vita ancora in equilibrio21. Laura, esule dal Capodistriano a quindici anni,
racconta dei possedimenti di famiglia:
Voi avevate dei pezzi di terra?
Avevamo dieci ettari di terreno, una grande casa di campagna, pinete, boschi, una famiglia di sette persone
che viveva con decoro, viveva bene... Fino diciamo all’avvento della Jugoslavia, che poi ci hanno cominciato
a vessare, non vendere più le nostre cose. Mio papà aveva tante vigne, si vendeva il vino qua a Trieste, di anno in anno venivano a prendere il nostro vino, le nostre frutte, ecco con questo si viveva, si comperava le cose…
Il passato mitico di una regione si costruisce anche attraverso un riferimento alla propria
terra di origine come a un paradiso perduto, e al tempo interrotto dalla violenza come a un’età
dell’oro che nemmeno il ricordo della guerra può intaccare22. Quest’immagine svolge un ruolo contrastivo rispetto alla descrizione della violenza attribuita al periodo di governo jugoslavo.
19
P. Ballinger, «The Istrian Esodo: Silences and Presences in the Construction of Exodus», in R. Jambrešić Kirin, M.
Povrzanović (a cura di), War, Exile, Everyday Life. Cultural perspectives, Institute of Technology and Folklore Research,
Zagreb 1996, pp. 117-132.
20
Ivi, pp. 120-121.
21
E. Miletto, Con il mare negli occhi. Storia, luoghi e memorie dell'esodo istriano a Torino, Franco Angeli, Milano 2005.
22
P. Ballinger, «The Istrian Esodo», cit., p. 183.
La rappresentazione bucolica della vita istriana è un tema molto presente nelle pubblicazioni edite dalle associazioni. Nel testo «Dai lunghi inverni»23, raccolta di memorie e racconti
sull’Istria e sull’esodo, il brano «C’era una volta Lussino» riporta un colloquio fra l’autore
Giorgio Martinolli e un esule lussinese24. Il testo si chiude con la descrizione dell’esule Mario
che, nella tranquillità di una sera monfalconese, rivive i suoi ricordi:
Oltre quei monti naturali, lanciati verso il mare aperto, Mario […] rivive interiormente gli anni della sua
spensieratezza isolana. […] Mario comprende con estrema chiarezza l’immensa felicità che ha illuminato la
sua infanzia e la prima giovinezza25.
Interessante risulta osservare come l’autore sia originario di Monfalcone, dunque non abbia esperienza diretta dell’esodo. Ciononostante, si inserisce appieno nei meccanismi di riproduzione di quest’immaginario. Ancora più esplicito è un brano di Luigi Papo de Montona, autore di numerose pubblicazioni26. In un breve racconto27 egli sviluppa un contrasto tra il tempo eterno e ciclico della vita precedente l’esodo nel paese di Montona d’Istria/Motovun e
l’irruzione della Storia, incorporata nelle armate titine, che fa sparire le tracce degli abitanti.
L’incipit del testo, «Da millenni …», presenta immediatamente un affresco di pratiche quotidiane di origine secolare, fortemente caratterizzate in senso religioso, che la violenza dell'esercito jugoslavo ha sradicato. L’intero brano poggia su un continuo parallelismo tra i bambini che l’autore descrive e l’immagine di fiori «in attesa di essere colti tanto lontano negli anni,
al maturare della vita»28.
Attraverso i brevi bozzetti di vita quotidiana che Papo De Montona tratteggia si concretizza la visione idealizzata di una regione che non esiste più, ma che funge da orizzonte ideologico e morale nella percezione dell’autore. In questo luogo della memoria il tempo si è fermato decenni addietro. L’Istria diventa il luogo idealizzato della nostalgia, svuotato dei rumori e
del vociare della vita «nativa» e riempito col silenzio della morte. Interessante è notare
l’enfasi nella conclusione del testo, basata interamente su rapporti di coordinazione tra i vari
elementi; tale scelta fornisce vivacità e trasporto al richiamo della terra del ricordo:
I fiori sbocciati all’ombra della Torre in quella primavera che sembrò durare una vita e fu interminabile
più di una vita e continua perché è la primavera e quei volti non sono mutati e Italia ha sempre i pomelli
rossi e Assunta infila le sue spine in quella macchina diabolica che era il telefono d’un tempo e Antonietta continua a cantare la sua «Ave Maria» e si fa silenzio29.
In una memoria costruita su una continua contrapposizione di immagini l’Istria bucolica e
serena creata nel ricordo si scontra, come nelle parole di Anna, con la visione del territorio
così come attualmente si presenta: «Ritornando a Capodistria, siccome è talmente cambiata,
talmente demolita, talmente con grattacieli dove c'erano i campielli veneziani, mi sembra di
andare in un qualsiasi altro posto, ma non vedo la mia città là...». Due visioni dell’Istria contemporanea contrastano e rafforzano l’immaginario del paradiso perduto. Da un lato, lungo la
23
AA. VV., Dai lunghi inverni, Unione degli Istriani, Trieste 1995.
Ivi, pp. 17-31.
25
Ivi, p. 31.
26
Luigi Papo de Montona (1922-2010) ha diretto per trent'anni il Centro Studi Adriatici e per lungo tempo è stato vicepresidente di Unione degli Istriani. Arruolatosi durante la guerra nella Compagnia Volontari Universitari, dopo l'armistizio
costituì in Istria un'unità combattente che confluì nella Milizia Difesa Territoriale (allora sotto controllo tedesco). Fatto prigioniero a Trieste nel maggio 1945, riuscì a evitare l'esecuzione capitale. Scrittore prolifico e poliedrico, è conosciuto negli
ambienti esuli per i suoi testi sull'esodo e sulla storia d'Italia. In particolare, v.: L. Papo De Montona, Albo d’oro. La Venezia
Giulia e la Dalmazia nell’ultimo conflitto mondiale, Unione degli Istriani, Trieste 1989; Id., L’Istria e le sue foibe. Storia e
tragedia senza la parola fine, Volume I, Settimo Sigillo, Roma 1999; Id., L’Istria tradita. Storia e tragedia senza la parola
fine, Volume II, Settimo Sigillo, Roma 1999.
27
L. Papo De Montona, «L'ultima primavera», in AA.VV., Dai lunghi inverni, cit., pp. 43-52.
28
Ivi, p. 44.
29
Ivi, p. 51.
24
costa, un paese ormai radicalmente cambiato, un luogo dell’alterità in cui diviene impossibile
riconoscere il senso della propria esperienza passata e rintracciare i ricordi, persi nelle modificazioni che il paesaggio ha subito. Dall’altro, nei paesini dell’interno, una terra morta, vuota e
silenziosa, assurta nei racconti a muto promemoria degli eventi bellici. In questo modo si crea
una scollatura profonda tra la regione come effettivamente si presenta e la regione a cui idealmente si ricollega il «popolo dell’esodo»30. In quanto comunità morale delocalizzata, questo
necessita di una patria morale riprodotta nei ricordi, nelle foto, nelle pubblicazioni.
Beni che si perdono
Il passato elaborato, condiviso e propagato nel mondo associativo assolve anche la funzione di validare il racconto di un furto o, usando le parole dei miei interlocutori, di una truffa
che lo Stato italiano avrebbe operato ai danni dei cittadini istriani, costretti ad abbandonare le
proprie abitazioni e i beni immobili per cercare rifugio nell’allora Territorio Libero di Trieste.
L’importanza di questo racconto è dimostrata dall’insistenza con cui gli esuli affiliati alle varie associazioni ne parlano.
Il 16 settembre 1947 entrò in vigore il Trattato di pace di Parigi. Il punto 9 dell’Allegato
XIV, che regolava i diritti dei cittadini italiani residenti nei territori ceduti e di coloro che se
ne erano allontanati, afferma che i beni privati non potevano essere alienati o nazionalizzati,
né utilizzati per abbattere il debito di guerra contratto con la Jugoslavia. Di fatto, pare che le
cose siano andate ben diversamente. Nonostante il Trattato di pace garantisse il rispetto dei
diritti di proprietà privata, il governo jugoslavo iniziò molto presto una campagna di espropri
e nazionalizzazioni operata a danno di tutti i cittadini, comprese le popolazioni italiane
dell’Istria. Fu chiaro abbastanza in fretta che non sarebbe stato possibile richiedere una restituzione dei beni; di conseguenza i governi italiano e jugoslavo iniziarono ad accordarsi per un
risarcimento in denaro attraverso una serie di Trattati internazionali31. Per questo motivo, il
lavoro delle associazioni è pensabile come diviso in due campi che interagiscono strettamente
tra loro. Come mi spiega Roberto, membro di una delle associazioni esuli:
Io direi che ci sono due aspetti della, chiamiamola battaglia che il mondo dell’esodo sta facendo per vedere riconosciuta la sua storia e i suoi diritti. Proprio sono questi due i due temi, no? L’attività strettamente culturale, quindi il tentativo che si porta avanti ormai da decenni e decenni come associazione,
cioè quello di riuscire a porgere all’opinione pubblica una versione corretta e accettabile della nostra
storia, senza cadere in opposti estremismi interpretativi che naturalmente distorcono la realtà, e questa è
una cosa… È un campo d’azione, diciamo... Poi invece le associazioni, che ovviamente nascono con
spiriti diversi da quello di un istituto culturale, lavorano sui prodotti culturali per raggiungere invece
degli obiettivi concreti dal punto di vista proprio della difesa dei diritti degli associati, no? Quindi son
due… due pilastri differenti, che si completano uno rispetto all’altro.
L’aspetto interessante è che il ricordo di questi avvenimenti è socialmente costruito. Poiché
la maggior parte delle persone che partecipano attivamente alla vita associativa è oramai appartenente a quella generazione di esuli che partì in tenera età, si è venuta a creare una lacuna
nella conoscenza relativa alla diatriba legale, che viene colmata da un lavoro informativo per
opera degli stessi responsabili associativi. L’accusa mossa ai governi italiani che si sono succeduti nel secondo Dopoguerra, articolata in modo sistematico nelle pubblicazioni associative,
è invece confusa e lacunosa nei miei informatori. Una delle prove della realtà storica della
«truffa» sta in un atto di vendita, più probabilmente un modulo di conferma di cessione del
bene, che lo Stato italiano avrebbe fatto firmare ai singoli proprietari e attraverso cui le pro30
31
P. Ballinger, History in Exile, cit., pp. 174-181.
Per un approfondimento sulla questione, cfr. il contributo di Giovanni De Vergottini nel presente volume.
prietà private sarebbero state alienate per essere poi cedute allo Stato jugoslavo. Federico, un
generale in pensione all’epoca presidente del Libero Comune di Pola in esilio, mi racconta di
una carta che suo nonno aveva posseduto e che si era persa negli anni:
Nel Trattato di pace è sancito il nostro diritto al mantenimento della proprietà, cosa invece che non si è verificata… Non si è verificata in parte per un atto volontario del mondo esule che ha affidato, non di sicuro con
una scelta libera ma perché il male minore del momento, ha affidato il proprio bene allo Stato italiano che
come contropartita garantiva un indennizzo, e in parte sono stati espropriati dal regime comunista di Tito, in
violazione a quelle che erano le clausole del Trattato. Non è un problema che coinvolge più paesi, quindi trattati, accordi bilaterali, no… È un problema italiano, e il governo italiano si è assunto un impegno nei nostri
confronti, ha usato i nostri beni per pagare i danni di guerra dell’Italia, e non sta tenendo fede a questo debito
che ha contratto con noi.
Due sono i temi portanti: il racconto della cessione più o meno forzata dei beni privati allo
Stato italiano in cambio di un indennizzo, e il richiamo all’uso che lo Stato avrebbe fatto dei
beni per abbattere il debito di guerra nei confronti della Jugoslavia. La faccenda si complica
quando entra in causa l’accordo di cessione dei beni che gli esuli avrebbero stipulato con le
istituzioni italiane. Tutto è dimostrato da un documento che non riesco a visionare. Federico
cerca di spiegarmi in cosa consistesse tale atto di cessione, pur ammettendo di non averne mai
preso visione:
Io so che chi affidava il proprio bene firmava una carta. Della mia famiglia io so che ho in corso una pratica,
quella della nostra casa, una villetta borghese. Io personalmente non ce l’ho più, perché prima ce l’aveva mio
nonno, poi deve essere passata a mio padre, ammesso che sia passata a mio padre, ma io non l’ho mai avuta,
e questo è un altro dei problemi sui quali gioca il governo…
Quindi insomma c’è stato quantomeno questa specie di acquisto…
Diciamo una specie neanche di donazione, perché è stata fatta dietro la promessa di un indennizzo, e tutto
sommato quello che noi abbiamo firmato è stato un atto legale compiuto dallo Stato italiano, e questo lo abbiamo saputo proprio in tempi recenti, dopo che l’Unione degli Istriani in particolare si è rivolta all’Europa
per questa problematica. Perché dall’Europa, dal Consiglio d’Europa, ci è stata rilevata l’illegalità dell’atto
da noi sottoscritto perché nell’atto non appare né il valore del bene, né i tempi dell’indennizzo, quindi una
cosa molto campata in aria, che ci è stata estorta, no?
Non ho mai visto questo documento. Solo una volta ebbi la possibilità di prendere visione
di un atto di esproprio che una donna mi mostrò, ma stabiliva la cessione del bene direttamente allo Stato jugoslavo ed era scritto in croato. Questa versione dei fatti non era condivisa indistintamente da tutti i miei interlocutori: un’esule mi raccontò eventi abbastanza differenti
durante la gita in Istria. Secondo la sua versione, la Jugoslavia avrebbe proceduto a nazionalizzare i beni e le terre a partire dagli anni Settanta, dunque molti anni dopo la conclusione del
conflitto bellico e la stipula del Trattato di pace, e successivamente sarebbero stati firmati accordi di indennizzo tra i due Stati. Non era a conoscenza di carte e documenti che testimoniassero di un accordo tra lo Stato italiano e singoli cittadini. Era persuasa che il tutto fosse
stato fatto in modo anonimo e nascosto. Era invece sicura della data relativa alle nazionalizzazioni, avendo visto le carte in possesso di suo marito. La Storia dunque inizia non dalle date
ufficiali, ma quando ci tocca personalmente.
Esiste quindi una forte ambiguità in questi racconti, frutto di un mancato passaggio di informazioni ed eventuali documenti tra una generazione e l’altra. È molto difficile trovare versioni concordanti della storia, sostituite da generiche affermazioni di un’ingiustizia subita e
dalla presenza fantasmatica di documenti stipulati con lo Stato italiano che sembravano legittimare il racconto con la loro semplice evocazione32.
Al di là della veridicità o meno dell’episodio, ciò che risulta interessante è proprio
l’impossibilità di far combaciare le varie versioni, da un lato, e dall’altro lo stretto legame che
la memoria dell’esodo mantiene con una definizione di giustizia che si cristallizza esplicitamente in una richiesta di risorse materiali, siano esse beni ancora in disponibilità oppure soldi.
Ricordo di averne parlato col presidente di una delle associazioni. Ragionavamo sulla scarsità di conoscenze che gli esuli mostravano di possedere riguardo a questi argomenti. Trovandosi d’accordo con la mia riflessione, mi disse che uno degli scopi della sua dirigenza era
proprio quello di costruire un sapere là dove l’interruzione del dialogo intergenerazionale aveva creato dei vuoti che non si limitavano a masse di informazioni, ma andavano a toccare il
valore morale della conoscenza e della difesa dei propri diritti. Conoscere la propria traiettoria
in quanto popolo, e venire alla comprensione dei fatti seguenti all’abbandono dell’Istria, assumeva immediatamente il carattere morale di una preparazione del riscatto di un’ingiustizia
che, proprio perché sentita come perpetrata dalla madre patria, era per questo ancora più dolorosa, scioccante e scandalosa. La conoscenza era dunque foriera di azione morale, operazione
di cura e riscatto per sé e per le generazioni precedenti. Quando ci si riferisce alla storia
dell’esodo non è sufficiente concentrare l’attenzione sugli anni compresi tra l’otto settembre
1943 e i tardi anni Cinquanta, quando più alto fu il numero di persone che si spostò. Questa
storia è vissuta al giorno d’oggi anche sotto un aspetto legale e politico; la possibilità di considerare chiuso un lungo capitolo del proprio passato necessita, per molti dei soggetti affiliati
al mondo associativo, anche di un riconoscimento economico dei sacrifici patiti.
Vittime tra memoria e oblio
Le identità sono dei costrutti storici e situati nel tempo. In quanto tali, spesso producono
una temporalità, anche di stampo mitico, cui fanno riferimento nel tentativo di legittimare
come un fatto naturale la loro stessa presenza nel mondo. Pensare ai fenomeni identitari come
fossero essenze immutabili slegate dalla loro dimensione temporale non fa altro che reificarli,
e ciò porta all’impossibilità di analizzarli per quello che sono: prodotti sociali di interazioni
sociali. Al contempo, pensare a un’idea di memoria come elemento fortemente circoscrivibile
e trasmissibile, avente in se stesso la sua sola ragion d’essere, porta a perdere per strada gli effetti di realtà che le pratiche del ricordo producono, nonché gli scopi che sostengono le operazioni. Non parliamo mai del passato per il solo gusto di farlo: lo sguardo retrospettivo, sempre
prodotto socialmente, è uno strumento fondamentale per rispondere alle più gravi domande di
senso.
Cosa possiamo dire rispetto ai meccanismi di produzione della memoria all’interno del
mondo associativo istriano? Da una parte questa memoria, e soprattutto il suo farsi nelle interazioni quotidiane e nel rapporto materiale e simbolico con beni e oggetti, favorisce la possibilità di pensarsi e vivere in un luogo altro rispetto alla terra natale. Dall’altra, la narrazione
dell’esodo è frutto di una selezione di tratti, una invenzione33, un atto creativo, e questa operazione cancella e dimentica elementi che sarebbero incongruenti rispetto all’immagine nostalgica della vita in Istria e a quella politico-religiosa del sacrificio compiuto in nome della
patria. Quali? Innanzitutto le divisioni interne alla regione, una vita essenzialmente urbana
che viene occultata e sostituita retoricamente da una rappresentazione dell’Istria come regione
32
Per il racconto di una ricerca di documenti per certi simile, e un’analisi del potere evocativo che esercitano, cfr. R. Malighetti, Il Quilombo di Frechal, Identità e lavoro sul campo in una comunità brasiliana di discendenti di schiavi, Raffaello
Cortina, Milano 2004.
33
R. Wagner, L’invenzione della cultura, Mursia, Milano 1992 [1975].
omogenea e non percorsa da tensioni interne e campanilismi. Secondariamente, si dimentica
che anche in Istria furono operanti le strutture del regime fascista con le sue politiche di confine34 e il suo sistema concentrazionario35. Ci si dimentica, inoltre, di considerare le altre esperienze del confine36 e di analizzare le dinamiche egemoniche che, nei centri della costa, legavano e contrapponevano le popolazioni di lingua italiana a quelle di lingua «slava».
Come si definisce, dunque, il popolo dell’esodo? È in primo piano una vistosa retorica di
vittimizzazione supportata da un’affermazione di unicità della sofferenza che si afferma, secondo lo storico Giovanni De Luna, secondo dei canoni diffusi a livello europeo dal secondo
dopoguerra37. Più di un informatore mi ha confidato di ritenere che gli esuli istriani, fiumani e
dalmati siano gli unici italiani ad aver pagato i disastrosi effetti di una guerra che non avrebbe
mai dovuto combattersi, e tale unicità è stata più volta rafforzata dal significato quasi sacrificale attribuito all’esodo. L’idea di un popolo martire per una patria che non ne ha riconosciuto
il sacrificio è parte integrante di questa rappresentazione.
Questa definizione presenta molti aspetti di ordine morale che fanno sì che inserirsi in questa narrazione sia un’esperienza di ingresso in un mondo connotato da emozioni e sentimenti
quali vergogna pregressa, rabbia, orgoglio e riscatto. Vivere la vita in associazione, in un sistema di segni e simboli che si producono in modo diffuso, permette a uomini e donne di costruire uno spazio di rielaborazione personale in grado di dotare di senso una quotidianità in
cui tempo presente e tempo passato sfumano l’uno nell’altro, e in cui il mondo dell’Istria perduta è attivamente creato in canti, manifestazioni, libri, spazi arredati. Chi partecipa a questo
mondo diasporico ne viene dunque esposto, contribuendo alla sua riproduzione sociale. Tale
operazione non è sempre emotivamente facile. Vivere costantemente in un mondo fantasmatico, in cui la nostalgia prodotta socialmente in numerosi momenti di condivisione è la molla
che spinge al continuo lavoro della memoria, è operazione dolorosa.
Senza questo forte accento morale non sarebbe possibile, per chi frequenta le associazioni
esuli, proseguire nel lavoro della memoria e della giustizia. È il caso delle diatribe legali relative alla questione dei beni abbandonati così come di tutte le iniziative volte a mostrare
l’effettiva realtà dell’esodo. In questo mondo le idee e i discorsi sulla memoria vanno a braccetto con le idee e i discorsi sulla giustizia. Questi sono intrecciati l’uno nell’altro.
34
M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Il Mulino, Bologna 2008.
A. Kersevan, Un campo di concentramento fascista. Gonars 1942-1943, Kappa Vu, Udine 2003; Id., Lager italiani,
Nutrimenti, Roma 2008.
36
M. Verginella, Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena, Donzelli, Roma 2008.
37
G. De Luna, La Repubblica del dolore, Feltrinelli, Milano 2011.
35