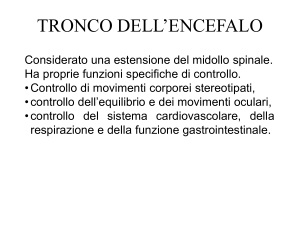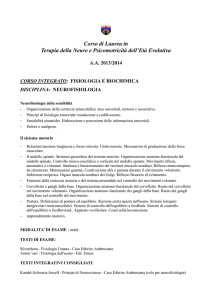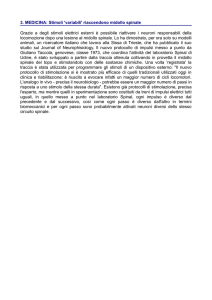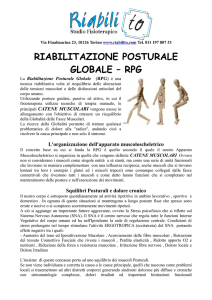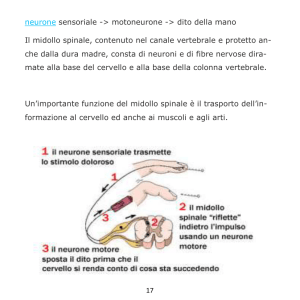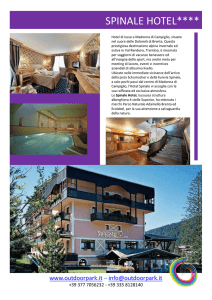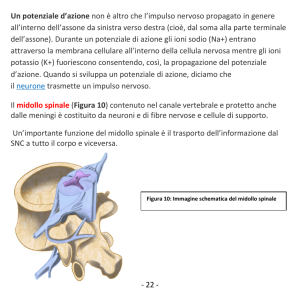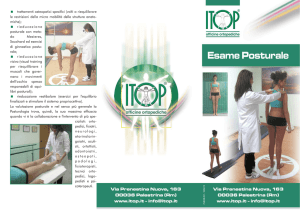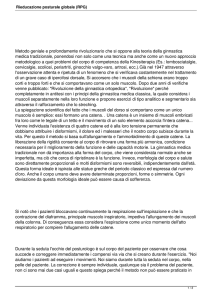UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DIMILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
Direttore Prof. Dott. A.M. Previtera
Corso di
Valutazione Funzionale
Neuromuscoloscheletrica 1 B
Docente
Ft. CRISTINA LOSA
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Policlinico Milano
MOVIMENTO
MOVIMENTO
Interazione tra l’individuo il compito e l’ambiente
(Shumway-Cook e Woollacott 2007)
movimento
task
individual
environment
MOVIMENTO
L’individuo genera un movimento per soddisfare
la richiesta del compito svolto in un ambiente specifico.
L’organizzazione del movimento è determinata quindi da
fattori intrinseci all’individuo, al compito e all’ambiente.
La capacità dell’individuo di soddisfare l’interazione tra
compito e domanda dell’ambiente
determina la capacità funzionale della persona
MOVIMENTO
Fattori che influenzano l’organizzazione del movimento
appartengono
all’individuo interazione tra processi
al compito
interazione tra
all’ambiente
fattori
Cognitivi
Percettivi
Motori/Posturali
Mobilità
Stabiltà
Manipolazione
Regolatori
Non regolatori
CONTROLLO MOTORIO
sistema cognitivo
Percezione
Azione
Sensibilità
percezione interpretazione
concettualizzazione
Rec.perif.
Cortec
aree di elabor.
Corteccia prefrontale Area corticale
Corteccia
Neuroni
sensoriale
sensoriale a più
Aree di associazione supplementare
motoria
motori
1° e 2°
alti livelli nei lobi
a più alti livelli
pianificazione
attivazione
motoria
parietale,occipitale
Gangli della base
e temporale
Cervelletto
esecuzione
Muscoli
Articolaz.
MOVIMENTO
E’ caratterizzato da
Aspetto motorio
Aspetto sensoriale
Aspetto cognitivo
Aspetto percettivo
Aspetto biomeccanico
attività relative alla postura e al compito
attenzione selettiva a stimoli rilevanti
motivazione , capacità di giudizio,
pianificazione e problem-solving
spaziale e visivo
articolazioni, muscoli, allineamento
( Mayston 1999)
MOVIMENTO
Organizzazione del movimento
Le risposte motorie possono essere
Movimenti riflessi
risposte involontarie ,coordinate , proporzionali
allo stimolo
Movimenti ritmici
l’inizio e la fine del movimento sono volontari
Aggiustamenti posturali sono soggetti ad un controllo a feeddback e a
feedforword
Movimenti volontari
sono diretti ad uno scopo ,sensibili all’esperienza,
sono soggetti ad un controllo a feedback e a
feedforword
CONTROLLO MOTORIO
Una teoria del controllo motorio è un gruppo di idee astratte
circa la natura e il controllo del movimento.
Nella storia :
_ Sherrington e la Teoria dei Riflessi (inizi del 1900)
_Jackson e la Teoria Gerarchica (inizi del 1900)
_N. Bernstein e la Teoria dei sistemi o cibernetica (1967)
_Mulder e Hochstenbach e la Teoria dei Sistemi (2001)
CONTROLLO MOTORIO
Abilità del S.N.C. nel regolare o dirigere
i meccanismi essenziali al movimento.
• Interazione tra sistemi percettivi , motori e cognitivi.
• In ciascun sistema molti livelli di elaborazione
• coinvolgimento di molte strutture cerebrali organizzate in modo
gerarchico e in parallelo
CONTROLLO MOTORIO
• Il SNC ha un organizzazione gerarchica e in parallelo
Gli alti livelli di controllo influenzano non solo quelli inferiori ma
possono agire indipendentemente e direttamente sui motoneuroni
spinali.
La combinazione di controllo gerarchico e in parallelo permette la
sovrapposizione di funzioni cosi che un sistema è capace di sostituirsi
ad un altro quando le condizioni dell’ambiente o del compito le esigono
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI
I processi alla base del controllo motorio includono strutture
• Midollo spinale
• Tronco cerebrale
• Cervelletto
• Talamo
• Gangli della base
• Corteccia Cerebrale
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI
Midollo spinale
•
Funzione di controllo a » cancello»
•
Ricezione iniziale ed elaborazione delle informazioni
somatosensoriali e trasmissione dei segnali dal cervello ai
neuroni che direttamente controllano il movimento
•
Controllo riflesso e volontario della postura e del movimento
attraverso i motoneuroni
Si tratta di una organizzazione di riflessi, risposte stereotipate a stimoli
sensoriali, schemi base di flessione ed estensione dei muscoli coinvolti nei
movimenti degli arti inferiori(Kicking e Locomozione)
(Kandell2000,Amaral 2000)
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI
CPG generatori di pattern centrali
Reti neurali nel midollo spinale capaci di produrre movimenti ritmici senza uno sforzo
cosciente e senza l’aiuto di un feedback afferente(MacKay-Lyons,2002)
Forniscono un’attività automatica che coordina le due metà del corpo
Sono schemi motori elaborati ,prodotti attraverso circuiti prefissati
Sono attivati per operare al momento opportuno e aggiustati in base alle richieste posturali
o ambientali attraverso feedback a livello spinale e mesencefalico .
CPG separati controllano ciascuno degli arti .Sono collegati tra loro attraverso una rete
interneuronale. Gli interneuroni sono fibre propriospinali lunghe che coordinano il lato
destro e sinistro del corpo durante la deambulazione e l’interscambio ritmico tra i due lati
con funzione di pace-maker.
Sono nella loro forma originaria indipendenti dalle informazioni somatosensoriali tuttavia il
feedback somato sensoriale è essenziale per modificare i programmi motori dei CPG
generati per facilitare costanti adattamenti all’ambiente.
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI
•
•
•
•
•
TRONCO ENCEFALICO(midollo allungato- ponte -mesencefalo )
Vie ascendenti e discendenti che trasmettono informazioni sensoriali e
motorie alle altri parti del SNC
Riceve input somato sensoriali dalla pelle e dai muscoli del capo e inputs
dai sistemi vestibolare e visivo
Tutti i sistemi discendenti motori eccetto il tratto cortico spinale originano
nel tronco encefalico
Nuclei coinvolti nel controllo posturale(Sistema vestibolare influenza i
muscoli assiali profondi del tronco e prossimali degli arti) e nel cammino
Formazione reticolare(integra l’informazione sensoriale e corticale,regola
l’attività motoria ,modula le informazioni nocicettive/dolore)
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
Sostanza reticolare
• Sistema di integrazione(attiva sia i livelli più alti che quelli più bassi)
• Invia proiezioni al talamo, alla corteccia, al cervelletto e al midollo
spinale
• Riceve connessioni afferenti dalla maggior parte dei recettori, dal
cervelletto, dalla corteccia, dai gangli della base e da impulsi
vestibolari
• Eccita ed inibisce l’attività
• Collabora con i sistemi all’interno del SNC
• Ha un ruolo nel movimento prossimale e distale
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
Cervelletto
•
•
•
•
•
•
•
•
Riceve input dal midollo spinale(riceve feedback circa il movimento)
Riceve input dalla corteccia cerebrale(riceve informazioni sulla
programmazione del movimento)
Invia outputs al tronco encefalico
Ha la funzione di aggiustare le nostre risposte motorie confrontando gli
autputs di programmazione con i segnali sensoriali e di correggere il
movimento se si allontana dalla traiettoria programmata
Ruolo essenziale in relazione al controllo posturale dinamico
Modula la forza e l’ampiezza del movimento
E’ coinvolto nell’apprendimento motorio (passaggio di attività rilevanti e stop a
a quelle non rilevanti )
Controllo dei CPG midollari
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
•
•
•
•
•
Talamo
Agisce da filtro per la corteccia cerebrale orientando l’attenzione verso
informazioni importanti attraverso la regolazione del flusso di informazioni
verso la corteccia e in questo modo regola il livello di attività dei neuroni
corticali
Elabora la maggior parte delle informazioni che arrivano alla
corteccia dal midollo spinale, dai gangli della base ,dal cervelletto e dal
tronco encefalico
Elabora informazioni emotive e mnesiche
Integra differenti tipi di informazioni(ex. informazioni tattili e visive)
Regola la coscienza , la vigilanza e l’attenzione
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
Gangli della base
Hanno profondi effetti sul movimento ma non hanno autput diretti su LMN
• (I) aree mot .talamo (F)Cort.Mot.UMN,(F) tratto cortico spinale ,(F) LMN.
Movimento volontario
• (I)nucleo VL peduncolo pontino,(I)tratto reticolospinale, (F)LMN muscoli
posturali e dei cingoli(quindi tono posturale )
• (I)regione locomotoria del midbrain,(F) tratti reticolospinali, (F)stepping
pattern generator,(F) LMN locomozione
• Alcune funzioni dei gangli della base coinvolgono aspetti cognitivi del
controllo motorio come la pianificazione delle strategie motorie
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
Corteccia Cerebrale
Composta da diverse aree che sono specializzate per mettere in atto una varietà di
funzioni. Sulla base delle loro funzioni si identificano 5 categorie di corteccia
- Corteccia sensitiva primaria: discrimina tra differenti intensità e
qualità delle informazioni sensoriali
- Corteccia sensitiva secondaria : esegue un’analisi più complessa della sensazione
- Aree di programmazione motoria : organizzano i movimenti
- Corteccia motoria primaria : Provvede al controllo discendente dell’autput
motorio
- Corteccia di associazione : comportamento, emozioni e memoria,percezione
CONTROLLO MOTORIO
FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI
Corteccia cerebrale
Le differenti aree hanno una rete di contatti reciproci e con altre parti
del SNC
Aree parietale e premotorie sono coinvolte nell’identificazione
delle traiettorie spaziali,scegliendo un percorso di azione e
programmando il movimento
Aree premotorie inviano autputs alla corteccia motoria
Area motoria invia questi comandi al tronco encefalico e al
midollo spinale attraverso il tratto cortico spinale e al sistema cortico
bulbare
SISTEMA MOTORIO
Sistemi motori discendenti
I motoneuroni superiori UMN forniscono tutti i segnali che provengono
dal cervello (corteccia e tronco encefalico ) ai motoneuroni inferiori
LMN(alpha e gamma nel midollo spinale),agli inter neuroni nel tronco
encefalico e nel midollo spinale.
SISTEMA MOTORI0
Sistemi motori discendenti
SISTEMI VENTROMEDIALI
SISTEMI DORSOLATERALI
CORTICO RETICOLO SPINALE
CORTICO SPINALE LATERALE
TRATTO RETICOLO SPINALE
RUBRO SPINALE
CORTICO SPINALE VENTRALE
TETTO SPINALE E INTERSTIZIO SPINALE
VESTIBOLO SPINALE
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
SISTEMA CORTICO RETICOLO SPINALE (CRSS)
Ha origine principalmente dalla CMP e da M1 e termina bilateralmente
alla Formazione Reticolare Ponto Midollare
Innerva muscoli prossimali e assiali
Coinvolto nel controllo posturale e nella locomozione
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
TRATTO RETICOLO SPINALE
E’il più grande sistema discendente con 18 milioni di fibre su ogni lato
Le vie discendenti reticolo spinali originano nella formazione reticolare che è
un insieme di nuclei che corrono lungo l’intera lunghezza dell’encefalo.
Facilitano bilateralmente i LMN che innervano i muscoli posturali e quelli
deputati al movimento grossolano degli arti
I neuroni del tratto reticolospinale sono coinvolti negli aggiustamenti
posturali anticipatori
I neuroni del tratto reticolospinale sono influenzati dalla corteccia cerebrale
e dal cervelletto e dagli input sensoriali che arrivano alla formazione
reticolare
VIA MEDIALE PONTINA
VIA LATERALE MIDOLLARE
ipsilaterale
Ipsilaterale e controlaterale
Eccita muscoli estensori assiali
Eccita i muscoli estensori degli AAII per mantenere
l’appoggio
Eccita e inibisce bilateralmente gli estensori prossimali
degli arti
Rinforza l’attività del tratto vestibolo
spinale(equilibrio)
Ha un ruolo nell’inizio della deambulazione
(Yeo et al,2012,Felten&Shetty,2009)
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
•
•
•
•
FORMAZIONE RETICOLO PONTO MIDOLLARE
Coordinazione di postura e movimento
Potrebbe influenzare l’attività muscolare in tutti i livelli del midollo spinale
sia ipsilateralmente che controlateralmente(Schepens &Drew,2006)
E’ un luogo di integrazioni di segnali corticali e sottocorticali che assicurano
che le risposte posturali siano regolate nel tempo e in ampiezza rispetto al
movimento pianificato(Schepens & Drew 2004)
Il segnale dalla corteccia motoria è amplificato nella FRPM per produrre un
segnale più estensivo durante i pAPA ed assicurare una risposta coordinata
in tutti e quattro gli arti(Yakovenko & Drew,2009)
Il segnale dalla corteccia motoria alla FRPM assicura una risposta
coordinata all’interno di qualsiasi arto. Assicura l’attivazione appropriata
dei muscoli (Yakovenko & Drew,2009)
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
SISTEMA VESTIBOLO SPINALE
Ha la funzione di mantenere la postura in modo automatico .E’ veloce
nell’attivazione ,produce una risposta non corticale rispetto alla gravità
ma controllata solo dal cervelletto
Un aumento dell’attività nel tratto vestibolo spinale sembra sia
responsabile della postura del braccio in flessione dopo stroke
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
Tratto vestibolo spinale mediale
riceve informazioni circa la posizione e i movimenti del capo
dall’apparato vestibolare ed eccita bilateralmente i motoneuroni
del collo
Tratto vestibolo spinale laterale
Eccita ipsi - lateralmente i motoneuroni dei muscoli estensori e
inibisce quelli dei muscoli flessori
In stazione eretta mantiene il centro di gravità nella base di appoggio e risponde a
destabilizzazioni lievi .
Eccita i muscoli degli occhi per produrre il riflesso vestibolo oculare che consente di
mantenere il capo fermo e guardare di lato o occhi fermi e girare il capo
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
TRATTO TETTOSPINALE E INTERSTIZIO SPINALE
Originano dal collicolo superiore e dal nucleo interstiziale di Cajal
Discendono bilateralmente ,influenzano i muscoli del capo e del collo e
degli occhi
Contribuiscono alla stabilità cervicale
Eccitano la muscolatura assiale del tronco coinvolta nei movimenti di
rotazione
(Felten &Shetty,2009;Ruhland &Van Kan 2003)
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI VENTROMEDIALI
TRATTO CORTICO SPINALE VENTRALE
Origina dai neuroni pre motori dell’area 6 e 4 che controllano collo e
tronco
I neuroni di questo tratto proiettano ipsi - lateralmente e contro lateralmente nel midollo spinale
Inviano rami collaterali alle vie mediali del tronco dell’encefalo
Eccitano la muscolatura assiale del tronco ,la muscolatura dei cingoli
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI DORSOLATERALI
• Circa un milione di fibre provenienti dalla corteccia motoria primaria
che raggiungono la parte dorsolaterale del midollo spinale
• Hanno la funzione di controllare i movimenti degli arti diretti ad uno
scopo di raggiungimento e manipolazione
• Sono responsabili del FRAZIONAMENTO , dell’abilità di attivare singoli
muscoli indipendentemente dall’attivazione degli altri (mano)
• Influenzano motoneuroni per i muscoli distali
• Sono coinvolte nella capacità dell’uso indipendente delle estremità,
particolarmente della mano.
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI DORSOLATERALI
•
•
•
•
•
•
•
TRATTO CORTICO SPINALE LATERALE
Origina da due aree motorie 4 e 6 e da tre aree sensitive 3,2,1.
Decussa nelle piramidi ma il 10%delle fibre proietta IPSILATERALMENTE
Controlla il movimento degli arti e delle singole dita
Modifica la quantità e il tipo di informazioni sensoriali ascendenti
Inizia , finisce e modifica l’attività dei CPG
In cooperazione con il cervelletto controlla la velocità, la precisione e la
destrezza della mano
Contribuisce alla produzione degli APA precedente ai movimenti di
reaching e coordinazione multiarticolare tra gli arti durante il reaching
SISTEMA MOTORIO
SISTEMI DORSO LATERALI
TRATTO CORTICO SPINALE LATERALE
• 10%/20% delle fibre del tratto corticospinale sono mono sinaptiche ,
solo eccitatorie ed innervano direttamente i muscoli della mano
• 50% terminano a livello cervicale (attivano arto superiore e mano
• 20% terminano nel torace per la stabilità toraco scapolare
• 30% terminano a livello del midollo lombosacrale
SISTEMI DORSOLATERALI
TRATTO RUBRO SPINALE
• Dal Nucleo rosso al midollo spinale
• Ha molte connessioni con il cervelletto,l’0liva inferiore e il sistema
reticolare
• E’ molto attivo nell’apprendimento motorio per l’arto superiore
SISTEMI DISCENDENTI
• SISTEMA CORTICO RETICOLO SPINALE
Ternina bilateralmente
Innerva i muscoli assiali prossimali
E’ coinvolto nel controllo posturale
E’ coinvolto nella locomozione
SISTEMI DISCENDENTI
• S.CORTICOSPINALE PONTINO
Ipsilaterale
Eccitatorio muscolatura assiale
estensoria
Rinforza l’azione del S.Vestibolo
spinale
• S.CORTICO SPINALE BULBARE
Ipsilaterale
Controlaterale
Inizia il cammino attraverso i CPG
SISTEMI DISCENDENTI
• SISTEMA VESTIBOLO SPINALE
Eccita i motoneuroni estensori ipsilaterali
Mantiene la postura eretta
Un aumento dell’eccitabilità delle vie vestibolospinali dopo stroke
potrebbe portare alla postura a braccio flesso durante il cammino
SISTEMI DISCENDENTI
• S.TETTO SPINALE
Discende controlaterlmente
Riceve input dalla retina
Innerva i muscoli prossimali del
collo e degli Arti Superiori
• S.INTERSTIZIO SPINALE
Decorre ipsilaterlmente
Innerva la muscolatura assiale del
tronco coinvolta nei movimenti di
rotazione
SISTEMI DISCENDENTI
• S.VENTRO MEDIALI
Pattern di attivazione muscolare
complessi
Gruppi muscolari:
Estensori prossimali e muscoli
posturali sotto un controllo
afferente.
Muscoli antigravitari: estensori arti
inferiori/flessori arti superiori
• S.LATERALI
Collegamento diretto cortico alfamotoneuroni
Gruppi muscolari:
Principalmente arti superiori
Principalmente distali
Principalmente flessori
PLASTICITA’ MUSCOLARE
PLASTICITA MUSCOLARE
• Le fibre muscolari hanno la possibilità di modificare il loro tipo di fibra in
relazione all’uso : plasticità muscolare che è una base importante per
l’adattamento fisiologico all’ambiente esterno, ogni aspetto strutturale del
muscolo ha un potenziale di cambiamento se opportunamente stimolato
(Dietz 1992; Pette 1998; Mercier et al. 1999; Lieber 2002) .
• I muscoli possono essere condizionati o decondizionati secondo le richieste
a cui il muscolo è sottoposto. Il disuso produce deperimento e atrofia
(Mercier et al. 1999; Lieber 2002).
• L’inattività in una posizione accorciata produce un aumento di tessuto
connettivo, un aumento nella rigidità e nella resistenza allo stiramento
passivo (Williams & Goldspink 1973).
SISTEMA SENSORIALE PERCETTIVO
La somato sensazione contribuisce a rendere morbido e accurato il
movimento, a prevenire o minimizzare un danno e a farci comprendere il
mondo
La sensazione è interdipendente con una normale performance motoria
• L’input sensoriale serve come stimolo per i movimenti riflessi organizzati a
livello del midollo spinale.
• Modula l’autput del movimento che risulta dall’attività dei GPG.
• Modula movimenti che risultano dal comando proveniente da centri
superiori.
Sistema sensoriale percettivo
• La sensibilità è spesso usata per preparare il movimento oltre ad
essere necessaria durante e dopo .(feedforward e feedback)
• L’informazione propriocettiva è analizzata per pianificare il
movimento coordinato di più articolazioni
• L’informazione vestibolare è necessaria per l’equilibrio
• L’informazione somato sensoriale è importante durante
l’apprendimento motorio
Sistema Sensoriale Percettivo
• Le informazioni sensoriali originano da
• Sistema somato sensoriale (Midollo spinale Vie ascendenti)
• Sistema vestibolare
• Sistema visivo
• Sistema uditivo
le informazioni prevalentemente arrivano dal midollo spinale, il 90%
non raggiungono la percezione cosciente e non sono testabili .Ciò non
significa che la persona non sente , solo non è consapevole
SISTEMA SENSORIALE
• SCHEMA CORPOREO
E’ la rappresentazione interna della postura del corpo e comprende
-la geometria del corpo
-la cinetica
-l’orientamento rispetto alla gravità
E’il risultato finale di un processo di integrazione multisensoriale fra
differenti modalità sensitive di rapprentazioni di parti del corpo.IL talamo
ha il ruolo di mantenere questa rappresentazione interna (Maravita)
Il modello posturale è alla base del movimento .Conoscendo la posizione
delle parti del corpo possiamo sapere
CHE COSA,QUANDO,COME DOBBIAMO MUOVERCI
SISTEMA SENSORIALE
SCHEMA CORPOREO è sostenuto da
afferenze muscolari (propriocettive) cervelletto
afferenze cutanee schema corporeo corticale
afferenze articolari
afferenze vestibolare
afferenze visione
gravicettori(verticalità)
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
• Tutte le vie che portano informazioni somato sensoriali (pelle e
muscoli )mostrano simili arrangiamenti anatomici
recettore periferico
generazione del potenziale d’azione nell’assone periferico
corpo nel ganglio radice dorsale
assone prossimale al midollo spinale
salita attraverso gli assoni a varie regioni del cervello
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
RECETTORI PERIFERICI
Fusi muscolari organi recettoriali specializzati che si trovano tra le
fibre muscolari (in parallelo nei muscoli scheletrici) Informano il SNC
circa la lunghezza del muscolo, sui cambiamenti di lunghezza e sulla
velocita di cambiamento .
Sono formati da fibre muscolari ,terminazioni sensoriali e terminazioni
motorie
SISTEMA SOMATOSENSORIALE
OTG rilevano la tensione nei tendini .Rispondono alla tensione
esercitata sia da una contrazione attiva che da uno stiramento passivo.
Sono propriocettori. Forniscono il senso di posizione dell’arto.
Le informazioni vengono inviate al midollo spinale, cervelletto e
corteccia
Recettori articolari rispondono ad una deformazione meccanica della
capsula e dei legamenti
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
• Recettori cutanei (Ruffini, dischi di Merkel, corpuscoli diMeissner,
corpuscoli di Pacini) sono meccanorecettori. Localizzati nel derma e
nell’epiderma. Si possono adattare allo stimolo sia rapidamente che
lentamente. Rispondono sia al tocco passivo che attivo.
La maggior quantità di recettori cutanei è nella mano
• Terminazioni Libere sono molto dense sui polpastrelli e controllano
l’attività dei flessori dell’avambraccio
• Gravicettori partono dalle viscere del tronco e raggiungono il talamo e
l’area parietale .Sensibili alla variazione della pressione
intraaddominale.Sono necessari per percepire l’orientamento del corpo in
relazione alla gravità (Karnat 2001 )
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI
• VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA
Sistema lemniscale o dorsale
Sistema anterolaterale
• VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
Tratto spino cerebellare dorsale e ventrale
Tratto rostro spino cerebellare
Tratto cuneo cerebellare
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA
• SISTEMA LEMNISCALE
• senso tattile discriminativo, vibratorio e senso di posizione cosciente
• le fibre che inviano informazioni relative agli ARTI INFERIORI
prendono il nome di FASCICOLO GRACILE
• le fibre che inviano informazioni circa gli ARTI SUPERIORI prendono
il nome di FASCICOLO CUNEATO
• Decussano presso il lemnisco mediale, vanno al nucleo VPL del
Talamo e alle aree della corteccia somato sensitiva primaria e
secondaria
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA
SISTEMA ANTEROLATERALE
tratto spinotalamico
tratto spinoreticolare
tratto spinomesencefalico
tratto spinotettale
tratto spinoipotalamico
Trasportano sensazioni dolorifiche, temperatura, pressione, tatto non
discriminativo e alcune sensazioni propriocettive.
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
Vie somato sensoriali alla corteccia del cervelletto
- posteriore
- anteriore
- rostrale
• Trasportano primariamente informazioni PROPRIOCETTIVE e POSTURALI
(ma anche dolore e pressione )
• Informazioni non coscienti usate per gli aggiustamenti non coscienti del
movimento e della postura
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
Tratto spino cerebellare dorsale (posteriore)
• informazioni dal tronco inferiore e dall’arto inferiore IPSILATERALE
circa la coordinazione dei movimenti dei muscoli degli arti inferiori e della
postura
Tratto spino cerebellare ventrale ( anteriore )
•
informazioni provenienti dal midollo spinale toraco-lombare
CONTROLARETALE
•
Sinapsi nel tronco encefalico e raggiungono il cervelletto.
Molte fibre re-incrociano prima di arrivare al cervelletto cosi che ciascuna parte del
cervelletto riceve informazioni da tutte due le parti della parte inferiore del corpo
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
I tratti spino cerebellare ventrale e dorsale mandano informazioni
somato sensitive principalmente dagli arti inferiori attraverso recettori
cutanei, fusi , OTG
Entrambi servono a modulare ritmicamente il ciclo del passo
Le informazioni afferenti dai recettori dell’arto sono processate per
dare una rappresentazione globale dei parametri dell’arto inferiore
piuttosto che una rappresentazione muscolo per muscolo(Bosco e
Poppele 2001)
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
Tratto rostro spino cerebellare
trasmette informazioni dal midollo spinale cervicale al cervelletto
ipsilaterale.
SISTEMA SOMATO SENSORIALE
VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO
Tratto cuneo cerebellare
gangli radici dorsali trasmettono informazioni alle cellule nel
nucleo cuneato che mandano i loro assoni al cervelletto
IPSILATERALE e trasmettono informazioni PROPRIOCETTIVE dal
braccio e dal collo al cervelletto per coordinare i movimenti della
testa e arto superiore
CONTROLLO SENSORIALE
• Le informazioni sensitive sono usate dalla corteccia sensomotoria e dal
cervelletto e passano attraverso il talamo.
• Importanza delle PROIEZIONI DISCENDENTI dalla
corteccia somatosensitiva
dal nucleo magno del rafe
dalla formazione reticolare pontina
al talamo, al nucleo di relay somato sensitivo del tronco encefalico e del midollo
spinale
Le proiezioni discendenti modulano il flusso ascendente delle informazioni
sensoriali per far passare quelle informazioni che sono veramente importanti
SISTEMA VISIVO
Il Sistema Visivo fornisce
• La vista per il riconoscimento e la localizzazione degli oggetti e
determinare il loro movimento
• La vista ci dà informazioni circa la posizione del nostro corpo nello
spazio, le relazioni tra le parti del corpo
• Il controllo dei movimenti oculari
• Ruolo importante nel controllo posturale e nei movimenti degli arti
SISTEMA VISIVO
• La corteccia riceve tantissime informazioni visive
• Due tipi di visione :
Visione centrale orientata alle attività di raggiungimento e di
afferramento. Situata nella corteccia visiva. Associata ai compiti per la
mano.
Visione periferica serve all’equilibrio, alla stabilizzazione dello
sguardo, alle abilità di orientamento e all’ orientamento della
linea mediana . Situata nel collicolo superiore. Comprende tutto
quello che ci arrriva dai lati in modo da poterlo evitare.
Usare solo la visione centrale produce più flessione, previene la capacità di trasferire il
carico, perdita di equilibrio
SISTEMA UDITIVO
• Ruolo fondamentale nell’equilibrio e nell’orientamento spaziale
• Sistema uditivo è situato fuori dal cervello
• Enormi vie dirette al cervelletto e alla corteccia
SISTEMA VESTIBOLARE
• E’un sistema più reattivo che proattivo , ascolta costantemente le
informazioni dei recettori sensoriali.
• I recettori sensoriali rispondono a
accellerazione lineare (otoliti)
accellerazione angolare(canali semicircolari)
• Dai nuclei vestibolari gli input vanno direttamente al cervelletto(lobo
flocculonodulare)
SISTEMA SENSORIALE
• Gli input sensitivi
-collaborano a mantenere e riattualizzare lo schema corporeo
-gli imput afferenti dai propriocettori dei muscoli contribui
scono alla rappresentazione interna della cinematica corporea
-gli OTG degli estensori sono uno dei principali input per
verificare l’asse in relazione alla gravità
PERCEZIONE
Integrazione di impressioni sensoriali in
informazioni psicologicamente significative.
PERCEZIONE
Include meccanismi sensoriali e processi a livelli più alti che
aggiungono interpretazione e significato alle informazioni afferenti in
arrivo .
E’ un processo attivo che richiede interazione tra il cervello, il corpo e
l’ambiente.
Coinvolge la memoria di esperienze passate, la motivazione, le
aspettative ,la selezione di informazioni sensoriali e la ricerca attiva di
informazioni sensoriali .
PERCEZIONE
• AREA SENSITIVA PRIMARIA: discrimina tra differenti intensità e qualità delle
informazioni sensoriali.
• AREA SECONDARIA somato SENSORIALE: integra informazioni tattili e
propriocettive ottenute dalla manipolazione degli oggetti
Stereognosi : compara le informazioni somatosensoriali provenienti dagli
oggetti con la memoria di altri oggetti.
• AREE ASSOCIATIVE CEREBRALI : area associativa parieto temporale( area di
wernicke) relazioni spaziali immagine del corpo e pianificazione del
movimento
• TALAMO : è un filtro selettivo per la corteccia cerebrale regolandone il
flusso di informazioni , integra differenti tipi di informazioni (tatto e vista)
CONTROLLO POSTURALE
L’abilità di controllare la posizione del nostro corpo nello spazio
contro la forza di gravità usando i meccanismi appropriati per mantenere
l’equilibrio (Horak-Macpherson 1996 )
Gli obiettivi funzionali del controllo posturale sono
mantenere l’orientamento
mantenere la stabilità
CONTROLLO POSTURALE
L’Orientamento è la capacità di mantenere un’appropriata relazione
tra i segmenti corporei e tra il corpo e l’ambiente per eseguire un
compito (verticalità)
La Stabilità è la capacità di controllare il centro di massa COM in
relazione alla base di appoggio
CONTROLLO POSTURALE
La stabilità posturale è definita come l’abilità a mantenere la proiezione del
COM entro limiti di stabilità, confini entro cui è possibile mantenere la
stabilità senza dover cambiare la base d’appoggio. (Shumway - Cook and Woollacott ,2001)
Non sono limiti fissi ,dipendono dal compito, e dalla velocita della
perturbazione ,dalla paura di cadere e dalla percezione di sicurezza
L’ orientamento posturale è la possibilità di stabilire un orientamento
verticale per contrastare la forza di gravità .E’ dato da un allineamento
attivo del tronco e del capo rispetto alla gravità ,le superfici d’appoggio ,la
visione e i riferimenti interni.
CONTROLLO POSTURALE
Emerge dall’interazione tra individuo,compito e ambiente
task
individual
environmet
CONTROLLO POSTURALE
Ogni compito ha una componente di stabilità e una di orientamento.
In ciascun compito può esserci più domanda di stabilità rispetto a
quella di orientamento e viceversa.
La richiesta di controllo posturale varia rispetto al compito
(Horak&Macpherson,1996,Shumway cook& McCollum 1990)
CONTROLLO POSTURALE
Non è regolato da un singolo sistema ma emerge dall’interazione di più
sistemi che lavorano insieme
Muscoloscheletrico
Nervoso - Sensoriale
Processi ad alti livelli che assicurano gli aspetti anticipatori ed
adattativi del controllo posturale
CONTROLLO POSTURALE
Sistemi motori sottostanti il controllo posturale
• Sistemi di pianificazione (corteccia motoria e frontale)
• Sistemi di coordinazione (tronco encefalico e spinali )
• Sistemi di generazione di forza e di movimento ( moto neuroni e
muscoli)
CONTROLLO POSTURALE
Strutture cerebrali che controllano la stabilità e l’orientamento
• Sembra che la stabilità posturale non sia organizzata a livello spinale
(Macpherson et al.1997,Macpherson & Fung 1999 )
• Nuclei del tronco encefalico sono attivi nella regolazione del tono
posturale ,integrano informazioni sensitive necessarie al controllo
della postura e dell’equilibrio ,contribuiscono agli aggiustamenti
posturali anticipatori che accompagnano il movimento volontario
• Cervelletto controlla l’adattamento delle risposte posturali
• Nuclei della base sono coinvolti nel cambiamento rapido di patterns
in risposta a cambiamenti del compito e dell’ambiente
CONTROLLO POSTURALE
ORIENTAMENTO
Aspetto
Senso-percettivo
STABILITA’
Aspetto
motorio
Vista
componenti
vestibolari
Schema
corporeo
Somato sen
Controllo
feedforward
Correzione errori
Forza muscolarelunghezza
AFFERENTE
EFFERENTE
CONTROLLO POSTURALE
Sistemi percettivi sottostanti il controllo posturale
AFFERENTE
Necessari a dare informazioni su quando e come applicare le risposte
posturali
Danno al SNC un quadro preciso su dove si trova il corpo nello spazio ,
se è fermo o in movimento
Sistema visivo - permette di stabilire relazioni con gli oggetti e con lo
spazio
Sistema vestibolare -posizione del capo rispetto alla gravità
Sistema somato sensoriale (propriocettori, esterocettori, gravicettori)
posizione del corpo, base di sostegno ,orientamento rispetto alla gravità.
CONTROLLO POSTURALE
Meccanismi motori sottostanti il controllo posturale EFFERENTE
Controllo a feedforward
Correzione degli errori feeddback
Lunghezza e forza muscolare
CONTROLLO POSTURALE
Le risposte posturali avvengono in due modi
FEEDBACK CONTROL in risposta ad una perturbazione esterna
inaspettata .Avvengono sulla base di stimoli visivi ,vestibolari e
somatosensoriali
FEEDFORWARD CONTROL anticipatoriamente rispetto al
movimento volontario(p APA ) e durante il movimento ( a APA )
CONTROLLO POSTURALE
A.P.A
FEEDFORWARD CONTROL
Sono aggiustamenti anticipatori, non implicano un controllo
consapevole(volontario), preparano il corpo per la perturbazione
aspettata da un movimento volontario
CONTROLLO POSTURALE
p APA
Aggiustamenti preparatori che si
attivano prima dell’inizio del
movimento anche senza che il
movimento avvenga
effettivamente .
a APA
Aggiustamenti che avvengono
durante il movimento volontario,
lo accompagnano e incrementano
il controllo posturale aumentando
la stabilizzazione dei segmenti
corporei durante l’attività
CONTROLLO POSTURALE
STRATEGIE DI CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO
CONTROLLO A FEEDBACK
Aggiustamenti o strategie che permettono di correggere rapidamente o
recuperare la postura dopo la perturbazione inaspettata
CONTROLLO POSTURALE
Strategia d’anca Controlla i movimenti del COM producendo ampi
movimenti dell’articolazione dell’anca con rotazione antifasica delle
caviglie. E’usata per ristabilire l’equilibrio in risposta a perturbazioni
rapide e ampie
Strategia di caviglia Riporta il COM in una posizione di stabilità
attraverso il movimento del corpo centrato sulla caviglia (articolazioni
metatarsali medie)
Passo di protezione In risposta a perturbazioni che portano il COM
fuori dalla base di supporto
CONTROLLO POSTURALE
CORE STABILITY
E’ la stabilità centrale del corpo data dall’attivazione simultanea dei
muscoli addominali profondi (trasverso dell’addome )e degli estensori
della colonna (multifido)sostenuta dalle informazioni provenienti dai
gravicettori.
E’ la capacità di controllare la postura e il movimento del tronco per
consentire un’ottimale produzione ,trasferimento e controllo di forza
e di movimento ai segmenti corporei terminali nelle attività in catena
cinetica integrata (Kibler,2006)
CONTROLLO POSTURALE
CORE STABILITY
L’apparato muscolo scheletrico centrale comprende la colonna ,le anche,il bacino,
la parte prossimale degli arti inferiori e le strutture addominali (Kibler , 2006 )
La muscolatura centrale include i muscoli del tronco e del bacino che sono
responsabili della stabilità della colonna e del bacino , partecipando alla
generazione ed al trasferimento dell’energia dalle parti più grandi del corpo a
quelle più piccole durante le principali attivita (Kibler , 2006 )
CONTROLLO POSTURALE
Elementi necessari al controllo posturale
• Allineamento (scapola)
• Schema corporeo (informazioni sensoriali )
• Tono posturale
• Meccanismi a feedforward e a feedback
• Core stability
• Mobilità
• Strategie posturali di risposta
CONTROLLO POSTURALE
Ogni movimento che un individuo compie è costituito da una
COMPONENTE POSTURALE, che stabilizza il corpo e dal PRIMO
MOVIMENTO ,che è relativo ad un particolare obbiettivo
(Massion & Woollacott 1996 )
CONTROLLO POSTURALE
E’ l ‘organizzazione dell‘orientamento ,stabilità e mobilità
dell’articolazione della catena multicinetica al fine di ottenere
mantenere e riguadagnare e restaurare il balance durante il
movimento in ogni postura o attività
(Vaughan-Graham& Lynch-Ellerington)
SEGNI E SINTOMI
Pathofysiology
Lesion in descending motor system
Primary neuromuscolar impairments
Paresis /hypertonicity
Secondary muscoloskeleta
Structural & Functional
Changes in muscles and Joints
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Sindrome dell’UMN
Paralisi/Plegia
Diminuita capacità di reclutare o modulare l’attivazione volontaria di
unità motorie
(Gracies,2005.Petit,2003.Ghez,1991.)
Interruzione totale o parziale del Tratto Cortico Spinale.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Perdita di forza
dopo stroke la perdita di forza è dovuta all’impossibilità di
attivazione volontaria (inabilità ad inviare adeguati segnali a
specifici muscoli) e all’atrofia muscolare. Nei Pazienti con Ictus
la perdita di forza è bilaterale
Mioplasticità : cambi adattivi in un muscolo in risposta a cambia
menti nel livello di attività neuromuscolare e a un mantenimento
prolungato di una posizione. Contratture e aumento di legami
di actina e miosina(che si producono nel muscolo a riposo)
producono resistenza all’allungamento e aumentata resistenza nel
movimento attivo
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
TONO MUSCOLARE ANORMALE
- Ipotonia: anormale bassa resistenza all’allungamento muscolare passivo.
E’ transitoriamente presente durante la fase di shock che segue una lesione
dell’UMN , determinata da una diminuzione dell’attività discendente e da una
eccessiva lunghezza muscolare
- Ipertonia: eccessiva resistenza all’allungamento muscolare passivo
Prodotta da una eccessiva attività del tratto reticolo spinale e/o vestibolo spinale
durante la contrazione attiva del muscolo.
E’velocità dipendente causata da cambiamenti muscolari (mioplasticitàe/o dalla spasticità)
-
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
SPASTICITA’
disordinato controllo senso motorio risultante da una lesione del
motoneurone superiore UMN che si presenta come una
involontaria attivazione muscolare intermittente(non contro
gravita) o sostenuta (contro gravità ).
(Pandyan e al. 2005)
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Spasticità (Pandyan)
meccanismi responsabili sono
NEURONALI iper reflessia cutanea
iper eccitabilità dei motoneuroni
alterazione del principio di Hennemann
L’attività motoria di un muscolo e reclutata in maniera sequenziale (Hennemann e Mendell )in cui le UM piu
piccole sono attivate prima di quelle piu grandi ( attivita posturale prima del movimento )
NON NEURONALI cambi delle proprietà strutturali del muscolo
e biomeccanici della muscolatura come
l’allineamento e l’accorciamento
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Perdita della capacità di frazionare i movimenti
incapacità di attivare singoli muscoli indipendentemente da altri
Dovuta all’interruzione del segnale del tratto cortico spinale laterale
incapacità ad usare singolarmente le dita della mano o la
dorsiflessione del piede.
Aumento del riflesso allo stiramento
Eccessiva risposta dei LMN agli imput afferenti dei recettori sensibili allo
stiramento . Dovuta ad una diminuzione dell’attività inibitoria del tratto
cortico spinale combinata con uno sviluppo di un aumentata eccitabilità
dei LMN e degli interneuroni . Non contribuisce all’ipertonia
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Anormali sinergie
Anormale accoppiamento di movimenti all’articolazione adiacente
dovuta ad una coattivazione stereotipata dei muscoli. Causata dalla
perdita di inibizione corticale sul tratto reticolo spinale
Anormale co-contrazione
Temporanea coincidenza di contrazione di agonista ed antagonista
Necessaria nei compiti di stabilità diventa anormale quando appare
nei movimenti funzionali .
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Reazioni associate
"sono reazioni posturali senza controllo volontario "
(walshe 1923 )
Attività incontrollate ed involontarie in alcuni muscoli che non sono
direttamente interessati al movimento.
Sono interpretate come una risposta motoria compensatoria involontaria
associata ad uno sforzo o ad una situazione di insicurezza.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Non sono reazioni ipertoniche e non fanno parte della spasticità
Le EMG mostrano parametri normali nell’attività dei muscoli che
presentano la reazione ; i muscoli non sono ipertonici
Vanno interpretate come una reazione alla perdita di stabilità
necessaria a mantenere la postura o durante il movimento
Si modificano se il controllo posturale aumenta la sua efficacia
Nel tempo si trasformano in attività stereotipate.
Sono un processo di apprendimento attività dipendente
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
• L’emiplegia è usualmente causata dall’interruzione dei tratti cortico
spinali laterali e mediali in un emisfero.
• Una lesione nella capsula interna causa perdita di forza che riguarda
maggiormente gli Arti rispetto al tronco e al cingoli perchè i LMN del
tronco e del cingolo ricevono segnali dal tratto non interrotto reticolo
spinale e vestibolo spinale
• Ipsilateralmente alla lesione si ha un minor interessamento della
paresi dovuta alla perdita degli stimoli provenienti dal tratto cortico
spinale. Distalmente i LMN ricevono segnali dal tratto rubro spinale e
reticolo spinale oltre al cortico spinale laterale
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
lesioni che coinvolgono il cervelletto
Alterata capacità ad iniziare e terminare un movimento : dovuta ad
una inabilità a controllare la forza appropriata nei muscoli agonisti
ed antagonisti
Scomposizione del movimento : dovuta ad un’alterata capacità di
prevedere la sincronizzazione (timing ) del movimento che
comprende più articolazioni
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Dismetria (ipo /ipermetria) errore nel range e nella direzione del
movimento dovuta ad una mancanza di controllo posturale
(p APA) che garantisce stabilità e mobilità
Tremore intenzionale è prodotto dalla decomposizione della cocontrazione posturale volontaria di muscoli avversari e consiste
in movimenti correttivi inaccurati verso posizioni volontarie di
un arto o dell’intero corpo.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Disfunzioni nel controllo del rapporto tronco/arti
Fissazione posturale : troppa co-contrazione dei muscoli
posturali. Anormalità di coordinazione all’interno degli
arti. Instabilità posturale dovuta ad una mancanza di timing
muscolare. Paura di cadere
Problemi di controllo della presa
Eccessivo livello di forza nel prendere ,sollevare e trasportare un
oggetto: dovuto ad un deficit nel PGFC (predictiv grip force
control).
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Problemi nell’acquisizione dei dati sensoriali
Sembra che tutti i segni imputati ad un disturbo cerebellare non siano
dovuti direttamente al cervelletto ma siano una conseguenza
secondaria ad una degradazione nella qualità dei dati sensoriali
acquisiti da altri sistemi ( corteccia,gangli della base e midollo spinale)
Atassia : comprende instabilità posturale , difficoltà nella
coordinazione muscolare
Cammino atassico : il pz tende ad inciampare e a virare. Il tallone e le
dita toccano simultaneamente il terreno con la scomparsa del
trasferimento del COP
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Lesioni che coinvolgono i Nuclei della base
Segni negativi
Rigidità :aumentata resistenza al movimento in tutti i muscoli.
Contrariamente alla spasticità, la rigidità risulta da una facilitazione
diretta dell’ UMN degli α- motoneuroni
Acinesia/ipocinesia : diminuzione del range del movimento attivo e
nella perdita del movimento automatico . E’ correlata alla diminuita
abilità a controllare la produzione di forza muscolare.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Instabilità posturale: secondaria all’estrema rigidità nei muscoli
flessori ed estensori
Tremore a riposo: involontari, ritmici tremori degli arti prodotte dalle
contrazioni dei muscoli antagonisti
Segni positivi
Corea: movimenti involontari rapidi e convulsivi
Distonia: contrazioni muscolari involontarie e continue che causano
posture anormali e torsioni.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO
Lesioni che coinvolgono il Sistema vestibolare
Instabilità posturale : interessamento del tratto vestibolo spinale
laterale che controlla i muscoli posturali degli arti e del tronco.
Interessamento del tratto vestibolo spinale mediale che controlla
la posizione del capo.
Disequilibrio ed Atassia Vestibolare : Appare durante il cammino.
la stazione eretta è più stabile se mantenuta con occhi aperti.
Dovuta ad una anormale attività dei tratti vestibolo spinali, cortico
spinali e reticolo spinali .
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA SENSORIALE
Lesioni che coinvolgono Corteccia somatosensoriale
Perdita della sensibilità discriminativa:
- propriocezione cosciente
- discriminazione tra due punti
- stereognosi
- localizzazione del tocco
Questi segni sono contro laterali alla lesione.
SEGNI DI DANNO AL SISTEMA SENSORIALE
Lesione dei tratti propriocettivi
Atassia sensoriale : perdita di informazioni somatosensoriali
dovuta ad interessamento dei nervi periferici ,
delle colonne dorsali del midollo spinale ,del tratto lemniscale
mediale. Difficoltà di equilibrio soprattutto ad occhi chiusi
SEGNI DI DANNO PERCETTIVO
AGNOSIA
termine generale per identificare l’inabilità a riconoscere gli oggetti quando si
usa un senso specifico nonostante sia intatta l’abilità discriminativa del senso
stesso
-astereognosi : inabilità a riconoscere l’oggetto attraverso il tatto e la
manipolazione (area somato sensoriale )
APRASSIA
impossibilità ad eseguire un movimento funzionale nonostante siano conservate la
sensibilità, la forza e la coordinazione(area motoria planning )
SEGNI DI DANNO PERCETTIVO
NEGLECT
tendenza a comportarsi come se una metà del corpo o dello spazio
non esistesse. Interessa la parte sinistra del corpo perché
l’attenzione e le relazioni spaziali sono controllate dall’area
parietale destra e dall’area di Wernicke nell’emisfero destro.
Può essere personale o spaziale .
SEGNI DI DANNO PERCETTIVO
NEGLECT PERSONALE /EMI-INATTENZIONE
impossibilità a dirigere l’attenzione sul proprio corpo.
Colpisce la consapevolezza di un intero lato del proprio corpo
NEGLECT SPAZIALE
perdita unilaterale di comprensione delle relazioni spaziali che produce
una squilibrata rappresentazione interna dello spazio
ANOSOGNOSIA
negazione della propria inabilità ad usare i propri arti paretici
SEGNI DI DANNO PERCETTIVO
LATEROPULSIONE/PUSHER SYNDROME
forte spinta lontano dal lato meno paretico in posizione seduta,
durante i trasferimenti, in stazione eretta e durante il cammino.
Il Paziente estende il braccio e la gamba non paretica e spinge
verso il lato opposto (quello paretico).
E’ un deficit specifico della sensazione dell’allineamento posturale
relativo alla gravità dovuto ad una lesione posteriore del talamo
o ad una lesione midollare che influenza i nuclei vestibolari.
MOVIMENTO EFFICIENTE
Normalità verso Efficienza
Ciascuna azione è una capacità acquisita attraverso l’apprendimento
per ottenere un movimento o l’esecuzione di un dato compito
in modo efficiente ed economico.
Tale capacità è specifica per ogni individuo
(Edwards 2002)
MOVIMENTO EFFICIENTE
Pattern di movimento nella popolazione normale sono compresi in
uno spettro che ha ai suoi estremi il movimento
GOFFO/ALTERATO -----------------------------------PERFETTO/SPECIFICO
(Latash & Anson 1996 )
I termini INEFFICIENTE /EFFICIENTE sono descrittori migliori per
definire il movimento rispetto a ANORMALE/NORMALE
MOVIMENTO EFFICIENTE
DEFINIZIONE
Il movimento efficiente è la risposta coordinata, adattata
ed adeguata del SNC ad uno stimolo per raggiungere un obbiettivo
sensori- motorio
MOVIMENTO EFFICIENTE
Movimento efficiente
diretto ad un obbiettivo
economico :minimo dispendio energetico, max risultato ,minima
usura
adattato : modulabile e adattabile alle circostanze
coordinato : timing di attivazione
(Schmidt & Wrisberg 2000)
MOVIMENTO EFFICIENTE
Per potersi muovere nel campo d’azione della gravità è necessario
possedere
tono posturale idoneo
consente di mantenere la stazione eretta, di adattarsi alle
variazioni della base d’appoggio e permette l’esecuzione del
movimento selettivo funzionale (Edwards 2002)
MOVIMENTO EFFICIENTE
vari gradi di innervazione reciproca
Modulazione tra eccitazione ed inibizione che permette l’attività armonica in patterns di movimento selettivi
Consente la modulazione tra :
Emicorpo destro e sinistro
Cranio-Caudale : testa/cingolo scapolare
cingolo scapolare/pelvico
braccia /gambe
Prossimale/distale :spalla stabile/braccio mobile
anca mobile/piede stabile
polso stabile/dita mobili
Intermuscolare :agonosta/antagonista
Intramuscolare : muscoli biarticolari
MOVIMENTO EFFICIENTE
Controllo sensoriale propriocettivo
Sistema GRAVICETTORE
Via autonoma necessaria per percepire l’orientamento del corpo in relazione alla gravità(viscere
del tronco → talamo e area parietale)
(Karnath 2001 )
Sistema PERCETTIVO
Elaborazione attraverso i recettori di un processo intrinseco ed estrinseco dell’informazione
sensomotoria
(F. Affolter)
CORPO MONDO
Spaziale
Schema corporeo
MOVIMENTO EFFICIENTE
Controllo posturale
garantire stabilità /selettività e orientamento
possibilità di scelta di schemi di movimento
tra sequenze di movimento selettivo all’interno di un
appropriato allineamento per il raggiungimento di un obbiettivo
MOVIMENTO EFFICIENTE
Allineamento
Tutte le parti di un’articolazione hanno una certa collocazione
in relazione alla postura e al movimento
L’allineamento adeguato facilita il reclutamento del tono
Postura
Posizione relativa delle differenti parti del corpo rispetto a loro
stesse e all’ambiente
SET POSTURALI
• POSTURA SEDUTA
Elementi costitutivi di un’efficiente postura seduta
Estensione lineare lungo la direzione della forza di gravità
Sviluppo dell’estensione a partire dal bacino
Stabilità della scapola bilateralmente
Stabilità/mobilità del rachide
Attività stabilizzatrice dei muscoli profondi(trasverso dell’addome, multifido,estensori
spinali profondi , porzione prossimale ischio crurali,piccolo e medio gluteo )
Alto livello di innervazione reciproca
Libertà di movimento del capo
Libertà di movimento degli Arti Superiori
SET POSTURALI
• STAZIONE ERETTA
Elementi costitutivi di un’efficiente stazione eretta
Estensione lineare
Capo in linea mediana
Libertà di movimento del cingolo scapolare bilateralmente
Estensione dinamica e capacità di rilasciamento in flessione delle anche e delle ginocchia
Tilt attivo laterale e stabilità bacino
Piede mobile
Flessione dorsale e plantare attive
Motricità intrinseca del piede
Innervazione reciproca piede/caviglia per permettere stabilità e dinamicità per il movimento
al di sopra e al di sotto
Innervazione reciproca del bacino per permettere stabilità e dinamicità al di sopra e al di
sotto
SET POSTURALI
• SIT TO STAND
Caratteristiche necessarie per un’efficiente passaggio da SIT TO STAND
Stabilità e mobilità di piede e caviglia: i muscoli dorsi flessori assistono la
stabilizzazione della tibia in avanti
Leggera flessione delle anche durante la fase di spostamento orizzontale
Estensione di anca e ginocchio durante la fase di spostamento in verticale
Buona innervazione reciproca tra ischio crurali e quadricipite e tra ischio
crurali e retto femorale : essedo biarticolari (anca e ginocchio )devono fornire
stabilità al ginocchio per dare mobilità all’anca e viceversa .
Tilt anteriore durante lo spostamento in orizzontale e tilt posteriore durante
quello verticale
SET POSTURALI
Buona innervazione reciproca tra addominali ed estensori
Stabilità del cingolo scapolare con la gabbia toracica
Il capo mantiene l’orientamento verticale
Il capo necessita di una buona innervazione reciproca tra i muscoli del collo e
quelli del cingolo
SET POSTURALI
Fasi del SIT to STAND
• Fase di flessione
iniziale estensione tronco superiore
Bacino in tilt anteriore
Lieve flessione in avanti del tronco
Coattivazione degli estensori del tronco e degli addominali per l’estensione
lineare sopra la base degli arti inferiori
SET POSTURALI
• Fase di trasferimento
COM si sposta in avanti e in alto
COM si sposta da una BOS grande ad una più piccola
Necessita stabilità dinamica
Controllo eccentrico della muscolatura del tronco e delle anche per
accompagnare la progressione del corpo in avanti
Massima innervazione reciproca tra muscolatura dell’anca e del ginocchio
SET POSTURALI
• Fase di estensione
Alto livello di controllo posturale
Attivazione coordinata degli estensori di anca , ginocchia e caviglia per
portare il corpo contro la forza di gravità
Il tilt pelvico anteriore si riduce
• Fase di stabilizzazione
SET POSTURALI
• REACHING
Piazzamento volontario della mano in un luogo desiderato in modo che
si possa interagire con l’ambiente
"La stabilità dinamica del tronco superiore e inferiore, con la scapola
stabile sulla gabbia toracica, permette agli arti superiori di muoversi
lontano dal corpo liberando la mano per il reaching"
(Massion 2004, Brown 2006 )
SET POSTURALI
• REACHING /GRASP
Il SNC deve risolvere due compiti :
produrre una attività corretta della mano e una traiettoria del
braccio verso l’obbiettivo
necessario aggiustamento posturale associato agli arti e al tronco
per il mantenimento dell’equilibrio
SET POSTURALI
La fase di trasporto REACHING e la fase di presa GRASP accadono
sincronicamente ma sono controllati da diversi meccanismi neuronali
RUBRO SPINALE
RETICOLO SPINALE
Movimenti prox per Reaching
CORTICOSPINALE
Controllo manipolazione
SET POSTURALI
Elementi fondamentali del R e del G funzionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Localizzazione del target
Riconoscimento della funzione dell’oggetto
Intenzione di raggiungere l’oggetto
Informazioni riguardanti il corpo e l’oggetto (schema corporeo)
Pianificazione stabilità e mobilità
Attivazione controllo a FFW
Attivazione della componente del Reaching
Premodellamento della mano
Manipolazione
SET POSTURALI
• Elementi costitutivi del Reaching
Stabilità scapolare sul torace
Ritmo scapolo omerale
Estensione del tronco
APA del tronco
Attivazione della CORE
SET POSTURALI
• Un tronco con una bassa attività antigravitaria provoca una instabilità
della gleno omerale e un mal allineamento della scapola
• Una spalla ipotonica rende l’A.S. pesante che inibisce l’estensione
efficiente del tronco con un impatto sugli APA e sull’equilibrio
SET POSTURALI
• CAMMINO
Requisiti essenziali per la locomozione
Progressione : assicurata da un pattern locomotorio di base che produce e
coordina patterns ritmici di attivazione muscolare negli arti inferiori e nel
tronco che muovono il corpo nella direzione desiderata (Patla,1997)
Controllo posturale : necessità di stabilire e mantenere un’appropriata
postura per il cammino e garantire una stabilità dinamica del movimento del
corpo(Patla,1997)
Adattabilità : agli scopi dell’individuo e alle richieste dell’ambiente
SET POSTURALI
• Fasi del ciclo del passo
Il ciclo di ciascun passo consiste in due fasi principali
STANCE : inizia quando il piede tocca il terreno. Divisa in 5 sottofasi
-contatto iniziale del tallone
-risposta al carico (fase del doppio supporto)
-intermedia
- finale (supporto singolo)
- preswing (doppio supporto)
SET POSTURALI
SWING : divisa in tre sottofasi ; tutte in supporto singolo
• Iniziale
• Intermedia
• Terminale
SET POSTURALI
• L’arto in fase di STANCE deve supportare il corpo(controllo posturale) e spingerlo in avanti.
Iniziale flessione del ginocchio per assorbire l’impatto dato dall’appoggio del tallone a terra.
Attivazione eccentrica dell’estensore del ginocchio (quadricipite)per controllare la flessione .
Attivazione eccentrica dei dorsiflex di caviglia(tibiale anteriore)decelara la flessione plantare
del piede
muscoli estensori anca ginocchio e caviglia sono attivi per garantire stabilità posturale e
impedire che capo tronco e arti collassino per gravità.
• In midstance : il quadricipite è inattivo
• Nella fase di preswing : generazione della forza propulsiva contrazione concentrica del
gastrocnemio e soleo (flessori plantari)e attivazione del quadricipite
SET POSTURALI
• L’attività muscolare nell’arto in SWING è presente soprattutto all’inizio
e alla fine della fase
• Scopo della swing fase è riposizionare l’arto inferiore per continuare la
progressione in avanti ; questo richiede accelerazione in avanti del
ginocchio e svincolo delle dita dal terreno
SET POSTURALI
• Contrazione flessori anca(ileopsoas) porta la gaba avanti mentre il
ginocchio si flette passivamente
• Gli ischiocrurali si contraggono vicino alla fine dello swing per frenare
il movimento
• Avviene l’appoggio del tallone
SET POSTURALI
• Meccanismo di controllo del cammino
input sovraspinali provenienti dalla corteccia e dalle strutture sotto
corticali
CPG
Feedback somatosensoriale
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
• MISURARE : quantificare un’ osservazione relativa a oggetti o eventi
in rapporto ad un sistema di riferimento predeterminato .
• VALUTARE : attribuire un significato ad un dato ,ad una misura o ad
un insieme di misure in un specifico contesto.
VALUTAZIONE
VALUTARE
MISURARE
PROCESSO
ATTRIBUIRE UN PESO
VALUTAZIONE
PROCESSO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI
In riabilitazione neurologica serve
• Ad identificare i problemi del paziente
• A prevedere un outcome (risultato) riabilitativo
• A selezionare un appropriato intervento fisioterapico per il pz con il
fine di ottenere un risultato
VALUTAZIONE
PROCESSO DI VALUTAZIONE
E’ inestricabilmente legato al Ragionamento Clinico
E’ un processo di problem - solving
Esplora il potenziale di miglioramento nelle attività motorie del
paziente
E’ specifica per ciascun paziente
Prevede l’utilizzo di misurazioni (scale o test)
VALUTAZIONE
RAGIONAMENTO CLINICO
E’ una intelaiatura per interpretare e risolvere i vari problemi presentati dal
Paziente e valutare il suo potenziale di miglioramento.
Si basa su un ragionamento Ipotetico – deduttivo che consiste nella raccolta
di un considerevole numero di dati che vengono usati per generare ipotesi
attraverso una relazione di causa-effetto
Queste ipotesi generali orientano una ulteriore valutazione che porta ad un
raffinamento di un’ipotesi che è poi verificata con l’applicazione di alcune
forme di interventi clinici
(Doody & McAteer 2002; Hayes Fleming & Mattingly 2008)
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
POTENZIALE DI MIGLIORAMENTO
Si esplora il potenziale di miglioramento ponendo l’attenzione circa le
caratteristiche del controllo di movimento del paziente che sono la
base del miglioramento della funzione . Questa esplorazione ha lo
scopo di ridurre la severità della menomazione e l’inefficenza delle
strategie di compenso con l’obbiettivo di migliorare la funzione.
VALUTAZIONE
INTERAZIONE CON IL TRATTAMENTO
Serve a cogliere sia i problemi e le abilità presenti sia cambiamenti potenziali e
che emergono dal recupero.
“ragionamento clinico in azione”: l’ipotesi viene verificata durante l’intervento e
confermata o confutata.
Non è un processo per “prove ed errori “ma piuttosto una sistematica attività di
presa di decisioni con costante valutazione del risultato dell’intervento
Identificazione e valutazione dei problemi CHIAVE delle limitazini funzionali .
VALUTAZIONE
Scale di misura
La misurazione rappresenta il mezzo per superare il livello di
valutazione soggettiva, verso l’oggettivazione ed il controllo dei
risultati.
E’ indispensabile in fisioterapia poter disporre di strumenti e procedure
specifiche per la misurazione multidimensionale dello stato di salute,
rilevando dati su funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione
dell’individuo al fine di documentare e monitorare l’efficacia degli
interventi riabilitativi/fisioterapici, impostare protocolli di ricerca,
identificare indici prognostici
VALUTAZIONE
Scale di misura
La misurazione è il processo che permette di associare in modo univoco
ad una grandezza un valore numerico. Consiste nel mettere in relazione
proprietà degli eventi (Sistema Empirico) con proprietà dei numeri reali
(Sistema Numerico)
VALUTAZIONE
Scale di misura
Livelli di misurazione :
nominale (misura qualitativa) in cui sono possibili confronti del tipo dicotomici,
“uguale” o “diverso”, senza definire ordini gerarchici di importanza o priorità; (ex.
suddivisione in gruppi per genere, per stato civile, localizzazione di paralisi per arti
ecc )
ordinale (misura semi-quantitativa) in cui la variabile è classificata secondo un
criterio maggiore-minore e in cui gli intervalli tra categorie non sono uguali fra loro
per cui non è possibile affermare che la voce con punteggio 2 corrisponda al
doppio della voce con punteggio 1; (ex. forza misurata con l’esame muscolare
manuale)
VALUTAZIONE
Scale di misura
• intervallare(quantitativa ) in cui nel sistema di misura è previsto un
intervallo costante e definito tra due consecutive unità;
(ex. l’articolarità misurata in gradi angolari, la temperatura in gradi
Celsius, il tempo.)
Una scala intervallare permette di effettuare operazioni aritmetiche
(addizioni/sottrazioni), ma non rapporti in quanto lo zero,
corrispondente all’assenza della quantità in oggetto, non è assoluto,
bensì un valore di riferimento scelto arbitrariamente
VALUTAZIONE
Scale di misura
di rapporto(quantitativa) in cui la scala intervallare ha uno zero
assoluto per cui fra le misure è possibile individuare diversità,
definirne la differenza o il rapporto;
(ex. la lunghezza, la forza misurata con dinamometro, la velocità, la
temperatura con gradi Kelvin, ecc.)
VALUTAZIONE
Scale di misura
Requisiti psicometrici di una scala di misura
Affidabilità capacità del sistema di misura di fornire risultati costanti,
anche se effettuata in tempi e da operatori diversi, a patto
ovviamente che la grandezza in esame non abbia subito variazioni.
VALUTAZIONE
Scale di misura
Validità si riferisce a quanto accuratamente un test misura
effettivamente ciò che intende misurare.
Di costrutto: aderente al modello teorico
Predittiva :in grado di predire una situazione futura
Di contenuto: quanto un insieme di misure sia realmente
rappresentativo dell’oggetto fenomeno osservato
Apparente: quanto uno strumento offre a chi lo usa
l’impressione di misurare ciò che veramente vuole osservare
VALUTAZIONE
Scale di misura
• Sensibilità al cambiamento : capacità dello strumento di registrare i
cambiamenti sulla variabile presa in esame. L’evidenza di sensibilità
consiste nel rilevare differenze significative nei punteggi medi ottenuti
in differenti fasi di valutazione, ad esempio prima e dopo il
trattamento. Tale evidenza è rafforzata quando i cambiamenti nei
punteggi sono correlati con altri indicatori di cambiamento, come ad
esempio i cambiamenti clinici.
VALUTAZIONE
Scale di misura
Criteri di selezione delle scale di misura più idonee
Appropriatezza: il contenuto dello strumento è adeguato alle richieste
a cui cerca di rispondere?
Accettabilità: lo strumento è accettabile per i pazienti?
Fattibilità: lo strumento è facile da somministrare e da gestire?
Interpretabilità: come sono interpretabili i punteggi dello strumento?
Precisione: quanto sono precisi i punteggi dello strumento?
VALUTAZIONE
Affidabilità: lo strumento è in grado di produrre risultati che siano
riproducibili e internamente coerenti?
Validità: lo strumento misura ciò che dice di misurare?
Sensitività o responsività: lo strumento è in grado di rilevare i
cambiamenti nel tempo, che sono importanti e significativi per i
pazienti?
Specificità : lo strumento è in grado di rilevare le risposte negative per
i soggetti non malati?
VALUTAZIONE
Modified Barthel Index ;misura il grado di indipendenza nelle ADL.
10 variabili, ogni variabile 5 punteggi .Elevata affidabilità ,sensibile
alle modificazioni funzionali e ai trattamenti riabilitativi.
Ashworth modificata . Quantificazione del tono muscolare. Scala a 5
punti. Il limite principale è che fornisce informazioni limitate allo stato
del paziente osservato in condizioni di riposo. La scala presenta un
basso livello di sensibilità, costringendo l'esaminatore a raggruppare
la maggior parte dei pazienti nei gradi intermedi della scala (gradi 2 e
3), criticata anche per la mancanza di riproducibilità, nel tempo e tra
diversi esaminatori.
VALUTAZIONE
MRC :Valutazione della forza muscolare. Valori da 0 a 5. Semplice e
rapida .Limite la resistenza dell’esaminatore
Berg Balance: scala funzionale dell’equilibrio, 13 items con un
punteggio da 0 a 4. Buona correlazione con Tinetti e Timed up and go.
Affidabilità intra operatore molto alta. Sensibilità e specificità variano
secondo gli studi
Timed up and go : misura il tempo di percorrenza di tre
metri(normale 10 sec.) E’ correlata con la velocità del cammino,
l’equilibrio,il livello funzionale, la possibilità di camminare all’aperto.
VALUTAZIONE
Functional reach :misura la capacità dell’individuo di mantenere
l’equilibrio durante un’attività funzionale.
Motricity index : misura la forza dell’Arto Superiore e di quello
inferiore dopo stroke.( presa a pinza, flex gomito,abduzione spalla
/dorsiflex caviglia, estensione ginicchio,flex anca )
Mobility scale for acute stoke patients : serve a predire la dimissione
dopo la fase acuta/ospedaliera del paziente con stroke.
VALUTAZIONE
I.C.F
Classificazione Internazionale
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
L’ICF racchiude tutti gli aspetti della salute umana e alcune componenti del benessere rilevanti per
la salute e li descrive come domini della salute e domini ad essa correlati. Le informazioni fornite
dall’ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento umano e le sue
restrizioni, e la classificazione serve da modello di riferimento per l’organizzazione di queste
informazioni, strutturandole in modo significativo, interrelato e facilmente accessibile. L’ICF
organizza le informazioni in due parti. Ogni parte è composta da due componenti:
Funzionamento e Disabilità
Fattori Contestuali(ambientali e personali)
VALUTAZIONE
DIAGNOSI
Emorraggia
talamica destra
MENOMAZIONI
Emiplegia A.S.sin
Emiparesi A.I.Sin
LIMITAZIONI
ATTIVITA’
Non
cammina
FATTORI
PERSONALI
Motivato
supporto familiare
RESTRIZIONI
ALLA
PARTECIPAZIO
NE
Non può
riprendere il
lavoro
FATTORI
AMBIENTALI
Abitazione senza
ascensore
VALUTAZIONE
Processo di valutazione
Raccolta dati anamnestici
Raccolta dati basata sull’osservazione dei segni e analisi del
movimento
Generazione di ipotesi iniziali
Perfezionamento e verifica dell’ipotesi con interventi specifici
Valutazione del risultato e successive generazioni di ipotesi
VALUTAZIONE
ANAMNESI
Diagnosi
Co-morbilità
Risultati esami clinici e strumentali
Funzione mentale
Percezione della propria disabilità
Livello funzionale precedente
Precedenti trattamenti fisioterapici
Aspetti sociali
VALUTAZIONE
OSSERVAZIONE
COSA sa fare il Paziente in autonomia
Può camminare
Può alzarsi e sedersi da varie basi di appoggio
Può vestirsi e svestirsi
Può raggiungere un oggetto
Può alzarlo da una superficie d’appoggio
Può manipolare
Può uscire di casa
Può fare le scale
…………………………………………………..
VALUTAZIONE
ANALISI SENSITIVO-MOTORIA
COME il paziente si muove
Analisi segni positivi e negativi
Analisi biomeccanica: limitazioni articolari (cause neurali o non neurali),
squilibri muscolari/lunghezze, relazione tra COM e BOS
VALUTAZIONE
COME il paziente si muove
Analisi delle sinergie motorie (patologiche e funzionali):
timing, velocità, selettività
Analisi del controllo posturale:
adattabilità alla superficie di supporto
stabilità vs mobilità
Analisi dei compensi
Esame della sensibilità
VALUTAZIONE
• ESAME DELLA SENSIBILITA
Clinicamente si testa
s. tattile discriminativa
s. propriocettiva cosciente
s. dolorifica
s. discriminativa della temperatura
VALUTAZIONE
• Dà informazioni che possono essere usate per localizzare la lesione
• Non testa l’abilità di usare le informazioni per aggiustare il movimento
• Molte informazioni sono non coscienti
• Per poter fare una prognosi sul recupero della funzionalità
della mano è importante testare la s.discriminativa tra due punti.
VALUTAZIONE
PROBLEM SOLVING
PERCHE ‘ il Paziente si muove così
Analizzare le possibili cause dei singoli elementi dell’analisi sensitivo-motoria.
Determinare il rapporto causa-effetto tra le varie cause emerse in modo da:
IDENTIFICARE i problemi del paziente
SPIEGARNE logicamente la presentazione clinica
INDIRIZZARE il trattamento
VALUTAZIONE
Bibliografia
- Anne Shumway-Cook & Marjorie H.Woollacott "MOTOR CONTROL" Wolters Kluwer
- Laurie Lundy-Ekman "NEUROSCIENCE .Foundamentals for Rehabilitation " Elsevier