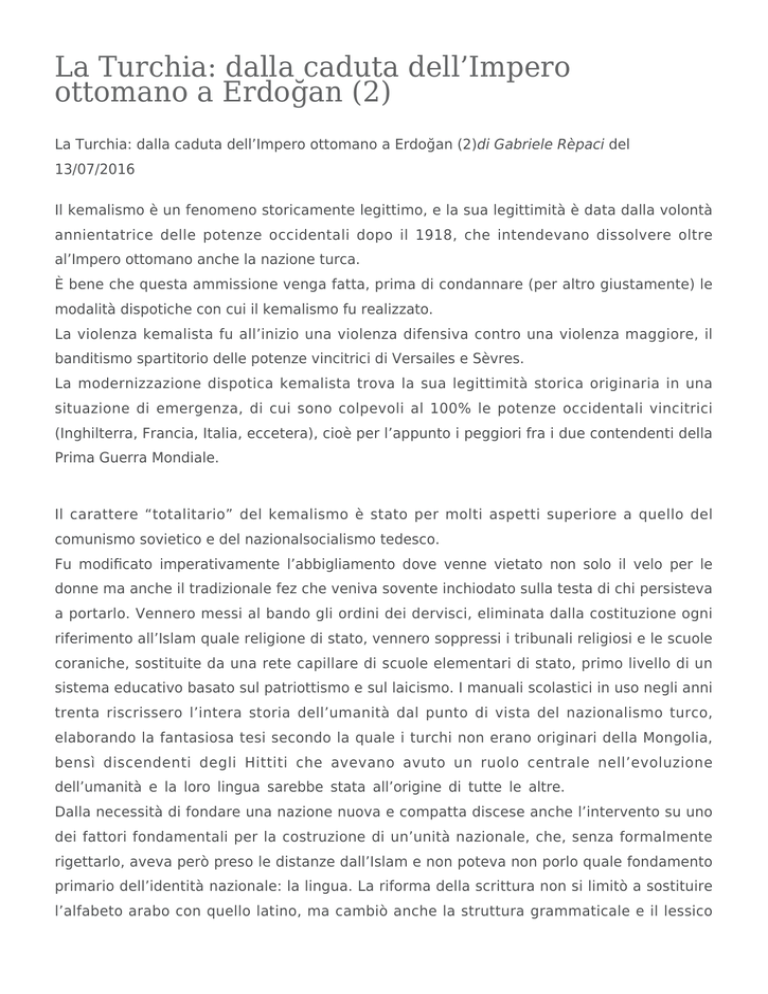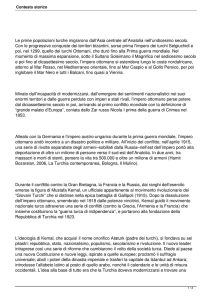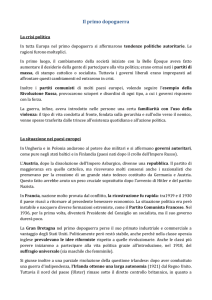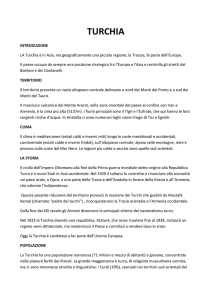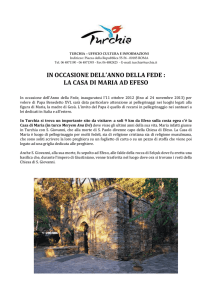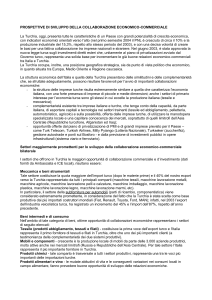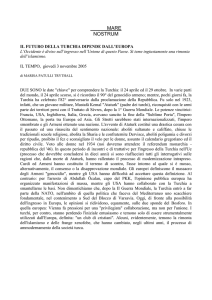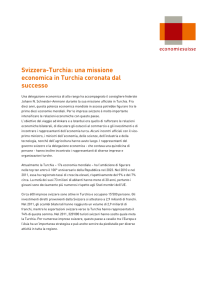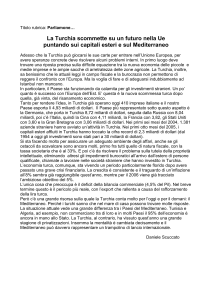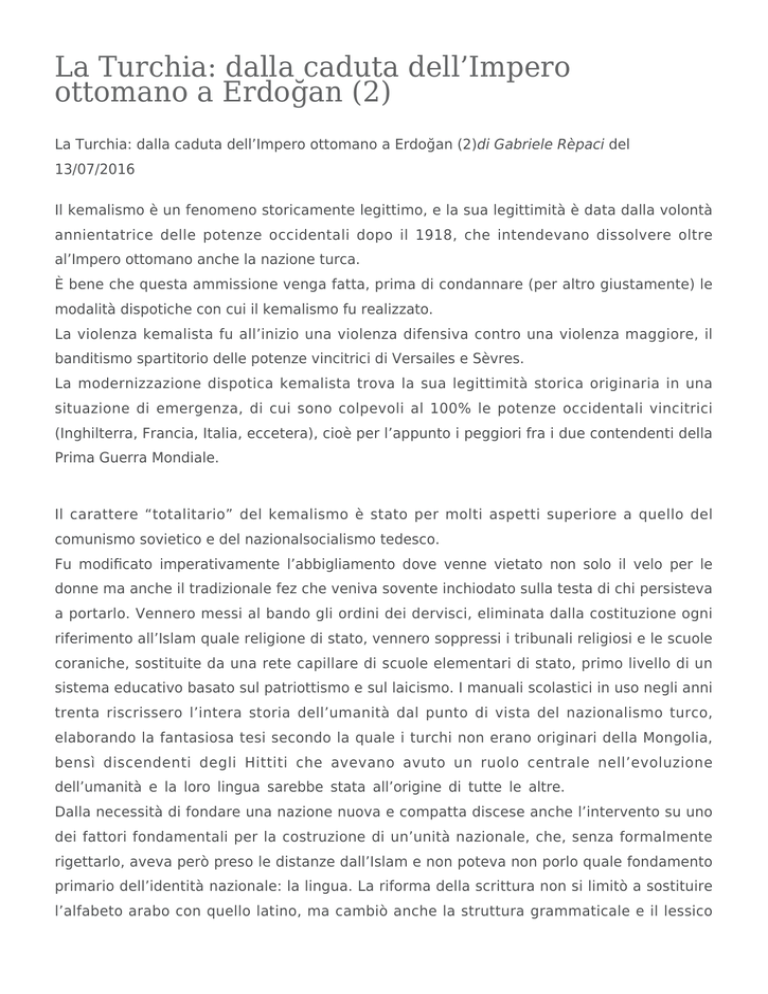
La Turchia: dalla caduta dell’Impero
ottomano a Erdoğan (2)
La Turchia: dalla caduta dell’Impero ottomano a Erdoğan (2)di Gabriele Rèpaci del
13/07/2016
Il kemalismo è un fenomeno storicamente legittimo, e la sua legittimità è data dalla volontà
annientatrice delle potenze occidentali dopo il 1918, che intendevano dissolvere oltre
al’Impero ottomano anche la nazione turca.
È bene che questa ammissione venga fatta, prima di condannare (per altro giustamente) le
modalità dispotiche con cui il kemalismo fu realizzato.
La violenza kemalista fu all’inizio una violenza difensiva contro una violenza maggiore, il
banditismo spartitorio delle potenze vincitrici di Versailes e Sèvres.
La modernizzazione dispotica kemalista trova la sua legittimità storica originaria in una
situazione di emergenza, di cui sono colpevoli al 100% le potenze occidentali vincitrici
(Inghilterra, Francia, Italia, eccetera), cioè per l’appunto i peggiori fra i due contendenti della
Prima Guerra Mondiale.
Il carattere “totalitario” del kemalismo è stato per molti aspetti superiore a quello del
comunismo sovietico e del nazionalsocialismo tedesco.
Fu modificato imperativamente l’abbigliamento dove venne vietato non solo il velo per le
donne ma anche il tradizionale fez che veniva sovente inchiodato sulla testa di chi persisteva
a portarlo. Vennero messi al bando gli ordini dei dervisci, eliminata dalla costituzione ogni
riferimento all’Islam quale religione di stato, vennero soppressi i tribunali religiosi e le scuole
coraniche, sostituite da una rete capillare di scuole elementari di stato, primo livello di un
sistema educativo basato sul patriottismo e sul laicismo. I manuali scolastici in uso negli anni
trenta riscrissero l’intera storia dell’umanità dal punto di vista del nazionalismo turco,
elaborando la fantasiosa tesi secondo la quale i turchi non erano originari della Mongolia,
bensì discendenti degli Hittiti che avevano avuto un ruolo centrale nell’evoluzione
dell’umanità e la loro lingua sarebbe stata all’origine di tutte le altre.
Dalla necessità di fondare una nazione nuova e compatta discese anche l’intervento su uno
dei fattori fondamentali per la costruzione di un’unità nazionale, che, senza formalmente
rigettarlo, aveva però preso le distanze dall’Islam e non poteva non porlo quale fondamento
primario dell’identità nazionale: la lingua. La riforma della scrittura non si limitò a sostituire
l’alfabeto arabo con quello latino, ma cambiò anche la struttura grammaticale e il lessico
(con eliminazione amministrativa delle parole arabe e persiane in uso da secoli).
Il mutamento dell’alfabeto fu soprattutto un fenomeno religioso, perché l’alfabeto arabo è
strettamente legato alla religione islamica. Dall’ora in poi, l’unica lingua ufficiale, persino
nelle funzioni religiose, fu la lingua turca definita e sancita dal Türk Dil Kurumu,
un’associazione per la lingua turca fondata da Kemal.
E insieme con le lingue, vennero negate l’esistenza di altri popoli o di altre culture. Dei Greci,
dei quali non poteva essere negata l’esistenza – avendo ormai un’identità forte e,
soprattutto, il sostegno di uno stato riconosciuto internazionalmente – Atatürk ottenne di
sbarazzarsene con lo scambio coatto di popolazioni sancito dal trattato di Losanna (1923):
circa un milione e mezzo di cristiani ortodossi, in larga parte linguisticamente greci (ma
anche di altre minoranze cristiane) furono espulsi dal territorio turco e insediati in quello
greco, mentre circa 800.000 musulmani fecero il percorso opposto.
I greci rimasti ad Istanbul – una consistente comunità di 100.000 persone – verranno
attaccati nel settembre 1955 da un pogrom che ne accelererà fortemente l’emigrazione,
riducendoli dai 200.000 che si contavano ancora nel 1924 agli appena 5.000 del 2005.
Le altre minoranze, curda, armena e araba, furono perseguitate e fu colpita ogni espressione
della loro nazionalità. Tale nazionalismo esasperato si tradusse nel rifiuto di ammettere che
in Turchia esistessero popolazioni non turche.
Gli armeni, già prima dell’avvento al potere di Atatürk, erano stati oggetto di persecuzioni e
repressioni: nella campagna del 1894-1896 condotta contro di essi dal sanguinario sultano
ottomano Abdul Hamid II, poi, negli anni 1915-1916, durante la Grande guerra, accusati di
tradimento (parte degli armeni si arruolarono nell’esercito zarista), furono deportati
dall’Anatolia, dove abitavano da millenni, verso i deserti della Siria e della Mesopotamia e
morirono a centinaia di migliaia (secondo alcune fonti si supera il milione: un genocidio).
I curdi, che avevano ancora una presenza rilevante nel sud-est del paese, furono chiamati
“turchi di montagna” e si proibì loro di parlare la propria lingua.La politica estera della
repubblica turca tra le due guerre mondiali oscillò tra l’alleanza con la Germania hitleriana,
riprendendo anche la tradizionale collaborazione con il paese che ebbe la maggior influenza
sull’Impero ottomano, e di cui Atatürk ammirava l’accentramento del potere e il nazionalismo
revanscista, e le liberaldemocrazie occidentali eredi dell’Intesa, con cui si era in parte
riconciliata nel 1923, quando a Losanna avevano accettato di rovesciare il verdetto di Sèvres,
e più tardi, nel 1936, alla conferenza di Montreux, dove Ankara ottenne il diritto di fortificare
gli Stretti, aprendo quasi una crisi con l’URSS, e nel 1939, quando stipulò il Patto di mutua
assistenza con Gran Bretagna e Francia, che le cedeva il controllo del sangiaccato di
Alessandretta (ribattezzato Hatay), in precedenza sotto amministrazione francese. La
seconda guerra mondiale è stata decisiva per la definizione del campo in cui la Turchia si
schiererà. Essa, ammaestrata dalla dura esperienza della Grande guerra, che determinò il
crollo del suo impero, decise di rimanere neutrale, in attesa di scegliere la carta da giocare. Il
30 gennaio 1943, in un treno fermo alla stazione di Adana, Churchill incontrò segretamente
İnӧnü, il successore di Atatürk (morto nel 1938) e alla fine dell’anno lo rincontrò, insieme con
Roosevelt , alla conferenza del Cairo. I due statisti anglosassoni riuscirono a evitare che la
Turchia aderisse all’Asse. Del resto, dopo la vittoria sovietica di Stalingrado, le fortune del
blocco nazifascista erano decisamente in declino. La Turchia, quando fu ormai evidente la
disfatta hitleriana dichiarò guerra alla Germania e giocò la sua carta per l’adesione al campo
occidentale in funzione anticomunista. Per la sua posizione geografica, essa era preziosa
nella strategia di Churchill nel Mediterraneo, dove l’insurrezione dei comunisti greci sarebbe
stata fermata in un bagno di sangue dagli anglo-americani. Si gettarono così le basi per
l’adesione della Turchia al campo occidentale. Essa diverrà il bastione antisovietico, il paese
dove la Russia si ferma. L’orientamento anticomunista del nazionalismo turco venne
confermato. E così, alle potenze occidentali, agli anglosassoni in particolare, riuscì il colpo
gobbo di riprendersi come alleato stabile e fedelissimo quella Turchia che era nata con
Atatürk proprio per opporsi ad esse, e in questa lotta era stata sostenuta dalla rivoluzione
russa, anche dopo il massacro del gruppo dirigente del partito comunista turco. La classe
dirigente turca fece una scelta di campo ormai ben precisa, accettando anche di trasformare,
in omaggio formale agli Usa e all’Occidente, il sistema politico, inventandosi il
multipartitismo. Il regime di partito unico del CHP rimase in vita fino al 1946. Durante la
discussione sulla riforma agraria in parlamento, nel 1945, alcuni membri del CHP
presentarono una mozione che dichiarava maturi i tempi di democratizzazione della vita
politica turca. Questa istanza trovava nel presidente della repubblica Ismet Inӧnü una
inaspettata, importante condivisione. Del resto, anche fattori esterni incidevano su questo
passaggio: primo fra tutti, l’esigenza di propiziarsi la fiducia dell’Occidente, rispetto alla
pericolosa vicinanza sovietica. Il punto di svolta fu segnato dalla nascita del Partito
democratico (Demokrat Parti – DP), Il 7 gennaio 1946, sotto la leadership di Celal Bayar,
espressione dei gruppi, anche parlamentari, che si erano opposti alla riforma agraria in
discussione. L’inedito nascente pluralismo favoriva anche il riemergere delle questioni
religiose. Il DP fece proprie le istanze del Partito nazionale (Millet Partisi – MP) per il
riconoscimento di forme di moderata apertura religiosa per l’educazione primaria e il
riconoscimento delle Facoltà di teologia: e con questa mossa, vide crescere il suo sostegno
sociale. La vittoria del DP arrivò nelle elezioni politiche del 14 maggio 1950 con il 52,6%
contro il 39,5% del CHP. Giornalisti e osservatori indipendenti annunciarono l’avvento della
«tirannia della maggioranza». L’esito elettorale si spiegava proprio per l’apertura alle frange
islamiste presenti nelle province periferiche del paese, deluse dall’accentramento
kemalista. Infatti, in nome del kemalismo, il governo del DP venne interrotto dal colpo di
stato del 27 maggio 1960. Un consiglio di unità nazionale, guidato dal capo delle forze
armate Cemal Gürsel e composto da 36 ufficiali, assunse le funzioni di governo.
La tipologia di questo brusco evento è particolare: tipicamente «turca» nelle sue connotazioni
interne se si pensa, ad esempio, che tra gli ufficiali che vi aderirono ci fu anche Alparslan
Türkeş, di lì a poco leader del partito ultranazionalista turco; del tutto discontinua nel
confronto con i regimi dittatoriali allora presenti nell’area mediterranea (Grecia, Spagna,
Portogallo).
I militari dichiararono di voler ripristinare l’ordine costituzionale, recuperandone l’originario
spirito di unità nazionale. Ma il sentimento di fedeltà alla Costituzione kemalista si espresse
in modi diversi, tra loro difficilmente conciliabili.
Da una parte, sulla spinta delle frange oltranziste, molti esponenti del DP e del suoi governo
vennero arrestati. Di loro, 15 esponenti furono addirittura condannati a morte, e fra questi
l’ex Primo ministro Menderes.
Dall’altra, i militari moderati provvidero a far redigere la nuova Costituzione del 1961, a
contenuto fortemente paternalistico e allo stesso tempo progressista, con la
istituzionalizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale (Milli Güvenlik Kuruluk) quale organo
fondamentale dello stato, la introduzione del sistema elettorale proporzionale per impedire
nuove derive autoritarie, il riconoscimento di importanti diritti sociali come il diritto di
sciopero, l’incoraggiamento del pluralismo sindacale, un controllo statale dell’economia che
assumeva sempre più un carattere sociale e collettivo e l’istituzione addirittura di una Corte
costituzionale indipendente.
Ci fu chi all’epoca definì la magna carta turca, non senza qualche forzatura, come “aperta al
socialismo”.
In politica estera la giunta si distinse per un timido avvicinamento ai paesi non allineati e, in
nome del patriottismo kemalista e del richiamo all’unità nazionale, operò un raffreddamento
dei rapporti con gli Stati Uniti e l’Occidente sia pure senza mettere in discussione
l’appartenenza della Turchia alla NATO e al blocco antisovietico.
Il 13 gennaio 1961, i militari abrogarono il divieto di attività politica e fissarono nuove elezioni
politiche per il 15 ottobre successivo. Due nuove formazioni si contesero i voti del disciolto
DP: il Partito della giustizia (Adalet Partisi – AP) e il Partito della nuova Turchia (Yeni Türkiye
Partisi – YTP). Tra le due formazioni non si registravano particolari differenze di reclutamento
e di ispirazione politica. Riemerse anche una formazione nata nel 1948, come espressione dei
gruppi nazionalisti più radicali: il Partito contadino nazionalista repubblicano (Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi – CKMP). Il CHP, ancora sotto la leadership di İnӧnü, conquistò il 36,7% dei
voti e ritornò al potere dopo undici anni di opposizione.
Ora, però, per la prima volta nella storia repubblicana il kemalismo politico doveva
sperimentare la prassi delle coalizioni di governo. Infatti, il suo primo esecutivo nacque in
accordo con il Partito della giustizia, ma ebbe vita effimera.
La scarsa capacità di coalizione costrinse il partito kemalista a revisionare il proprio impianto
ideologico, adottando nel Congresso nazionale dell’ottobre 1964, la dichiarazione
programmatica intitolata «il nostro ideale di Turchia progressista» sottoscritta anche da un
giovane esponente, Bülent Ecevit, che avrebbe fatto carriera. Essa prefigurava una politica di
coalizione di «sinistra-centro», impegnata in un disegno riformatore della Turchia in senso
pluripartitico, di sicurezza sociale e decentramento dei poteri.
Tuttavia, sarà proprio questo slancio riformatore del CHP a dar forza all’alternativa dell’AP. Il
suo nuovo ambizioso leader, Süleyman Demirel, rimproverava all’èlite kemalista una deriva
di sinistra, di stampo filosovietico, ideologicamente condizionata dal contesto internazionale.
La crisi delle aperture di coalizione di sinistra fu confermata dalle elezioni politiche del 1965,
che conferirono la maggioranza al Partito della giustizia, consegnando il governo al nuovo
leader. L’AP ottenne, infatti, il 52,9% dei voti, contro il 28,9% del CHP.
Elezioni parlamentari in Turchia del 1961 – Elezioni parlamentari in Turchia del 1965
Tra l’altro, in quella tornata elettorale, un’altra formazione contribuì alla radicalizzazione dello
scontro politico: il neonato Partito socialista dei Lavoratori (Tїp), favorito, per la sua
organizzazione e composizione, dal riconoscimento dei diritti associativi tutelati dalla nuova
Costituzione del 1961. Questa discontinuità pesò su due fronti: si inaugurerà una fase di
radicalizzazione extraparlamentare dei movimenti sindacali e dei lavoratori, che sfocerà nella
nascita del Partito rivoluzionario dei lavoratori (DİSK); si acutizzeranno le contrapposizioni tra
destra e sinistra parlamentare ed extraparlamentare, con la nascita, nel 1968, della Società
per la lotta contro il comunismo e il compattamento dei movimenti nazionalistici intorno al
Partito di azione nazionale turco (Milliyetçi Hareket Partisi – MHP), nato dal precedente Partito
contadino nazionalista (CKMP).
Diversamente, il Partito dell’ordine nazionale (Milli Nazam Partisi –MNP), di Necmettin
Erbakan, sarà contraddistinto dalla critica alla secolarizzazione repubblicana e kemalista, in
nome di un recupero politico dell’unità turca per mezzo della identità islamica del popolo.
Il 12 marzo 1971, i Generali delle forze armate turche inviarono al Primo ministro un
Memorandum, con cui invitavano il governo ad «assumersi le responsabilità» delle difficoltà
politico-sociali del momento, minacciando un intervento di forza per ripristinare l’ordine
secondo lo «spirito kemalista».
Fu una vera e propria dichiarazione di sfiducia extraparlamentare al governo.
Alle inevitabili dimissioni di Demirel seguì la composizione di un esecutivo tecnico controllato
dai militari, che reintrodusse la legge marziale e sciolse movimenti estremisti di sinistra e di
destra, compresi il TїP e il MNP.
Süleyman Demirel, leader del Partito della Giustizia, in turco Adalet Partisi, sigla AP
Nelle successive elezioni del 1973, il Partito della salvezza nazionale (Milli Selamet Partisi –
MSP) conquistò 48 seggi parlamentari, costringendo il CHP a nuove coalizioni instabili e
trasformiste. Il PKK, ossia il Partito dei lavoratori curdi ( in curdo, Partiya Kerkoran Kurdistan),
approfittando della situazione, esplicitò la rivendicazione del separatismo etnico, finalizzato
alla costituzione di una repubblica indipendente del «Kurdistan marxista-leninista», con
ricorso alla violenza e atti di terrorismo.
Un nuovo colpo di stato militare del 1980 portò all’ennesima composizione, il 21 settembre,
di un gabinetto tecnico guidato dall’ammiraglio Bülend Ulusu, composto in prevalenza da
militari, con 27 alti ufficiali, e, per il resto alti burocrati e accademici.
Ancora una volta gli attori politici del precedente regime furono sottoposti a processo. I partiti
vennero dichiarati illegali così come i sindacati insieme a ogni libertà politica e civile.
Chiunque fosse sospettato di nutrire simpatie per la sinistra era passibile d’arresto. Sia
Erbakan, leader del MSP che Türkeş, leader dell’MNP, vennero accusati di alto tradimento e
attentato alla Costituzione, rispettivamente per aver messo in discussione i principi del
secolarismo turco e per aver istigato alla guerra civile e alla soppressione fisica degli
avversari politici. I tre anni di potere militare in Turchia sembravano concretizzare un’idea
che sin dagli anni settanta aveva raccolto consensi nella specificità politico-istituzionale
nazionale: la cosiddetta «sintesi turco-islamica» (Türk-Islam sentez – TIS). Con essa , si
tendeva a prefigurare l’evoluzione politica della Turchia non in termini di contrapposizioni
ideologiche di destra/sinistra, funzionale alla suddivisione in due blocchi del contesto
geopolitico mondiale, bensì in termini di valorizzazione dei caratteri culturali turchi e dei suoi
predicati istituzionali, in sé non riconducibili né a una «falsa vernice occidentale» né a una
ortodossia religiosa «araba e fondamentalista».
Del resto, questa chiave di lettura sembrò trovare conferma nell’esito del colpo di stato del
1980: ancora una volta venne riscritta una nuova Costituzione, una delle più retrive che il
paese abbia mai conosciuto e che sostanzialmente cancellava tutti i diritti sociali contenuti in
quella redatta nel 1961.
Le elezioni del 6 novembre 1983 riaprirono la dinamica democratica, sempre sotto controllo
militare, che provvide non solo a organizzarle ma persino a conformarle nelle liste elettorali
in competizione. Infatti, alle elezioni poterono partecipare solo tre partiti: il Partito
democratico nazionalista (Milliyetçi Demokrasi Partisi –MDP) fondato dagli stessi militari; il
Partito populista (Halkçi Parti – HP), anch’esso sostanzialmente incoraggiato dai militari per
intercettare i voti di sinistra; infine il Partito della madrepatria (Anavatan Partisi – ANAP),
formazione autonoma di orientamento conservatore. In questo modo, nonostante il
prevedibile successo dell’ANAP, con il 45% dei consensi, il voto agli altri due partiti consentì
ai militari l’ingresso parlamentare attraverso i propri rappresentanti, quello che non si era
verificato negli interventi precedenti, con la conseguente «messa in sicurezza» della
dialettica endoparlamentare. Sul fronte sociale questa asimmetria rappresentativa acutizzò la
radicalizzazione dei partiti «spontanei» della società: da un lato, si registrò l’attivismo del
PKK, ormai sfociato nella lotta armata; dall’altro aumentava nei consensi il Partito della
prosperità (Refah Partisi – RP), nato nel 1983 dalle ceneri dell’MSP di Erbakan.
Turgut Özal, a capo dell’ANAP, ufficializzò la strategia parlamentare dell’Orta Direk
(letteralmente, «pilastro portante» della società), ossia un percorso di convergenza al centro
gestito secondo un pragmatismo aperto a tutte le istanze sociali, indipendentemente dalle
proiezioni religiose ideologiche. In questo modo, egli tentò di rispondere ai movimenti
extraparlamentari. Nel contempo, sotto la spinta della parte laica dell’opinione pubblica,
annunciò un referendum per la modifica costituzionale e della riabilitazione dei politici banditi
dal regime militare. Tuttavia, le concrete misure di governo tradirono la moderazione
annunciata. La repressione colpì sia il dissenso politico, con numerose condanne per reati di
opinione, che la mobilitazione sociale, con la limitazione del diritto di sciopero. Persino dopo
l’abrogazione della legge marziale, avvenuta nel luglio del 1987, gli atti di governo
continuarono extra ordinem.
L’esito favorevole del referendum, nel settembre 1987, costrinse comunque il governo a
nuove elezioni, che, nel novembre successivo, permisero il ritorno in parlamento di alcuni
vecchi leader di partito: Demirel, alla guida del Partito della vera via (Doğru Yol Partisi –DYP),
ed Ecevit, con il Partito della sinistra democratica (Demokratik Sol Partisi –DSP).
Il Refah Partisi, pur non essendo riuscito a superare la soglia di sbarramento del 10% per
l’ingresso parlamentare, vide aumentare i propri consensi a livello delle elezioni municipali,
con le vittorie del 1984 e del 1989.
Nel 1990, quando Özal venne eletto presidente della repubblica, la guida dell’esecutivo passò
a Yildїrїm Akbulut.
Le consultazioni politiche generali del 1991, segnarono una nuova discontinuità sulla scena
politica. Infatti, aumentarono i consensi per le nuove formazioni, compreso il Refah Partisi,
che ottenne il 16,9%dei voti e 62 seggi.
Intanto con la morte di Özal, il cambio di leadership nel DYP portò al governo una donna
Tansu Çiller, e, alla presidenza della repubblica, Demirel. Questa specie di «coabitazione» tra
leader, nelle rispettive vesti di Primo ministro e presidente della repubblica, in un paese,
come si è visto a rigida concentrazione monopartitica dei due ruoli ma ora in assetto di
coalizione, produrrà non secondarie discontinuità nelle consuetudini costituzionali turche,
sopravvissute alle diverse costituzioni formali succedutesi dal 1924.
Il protagonismo della presidenza della repubblica emerse come contrappeso alla potenziale
instabilità di coalizione.
Ma anche questa discontinuità fu bruscamente interrotta. Nella notte del 28 febbraio 1997, il
Consiglio di sicurezza nazionale adottò il cosiddetto «colpo di stato post-moderno» o
«processo 28 febbraio», dettando una serie di misure legislative e di ordine pubblico, a
garanzia del «rispetto del carattere secolare della Repubblica». Inoltre, dopo appena un
anno, nonostante la decisione della Corte costituzionale, del 16 gennaio 1998, di
scioglimento del partito islamico e di interdizione politica per cinque anni di Erbakan, una
nuova formazione venne messa in piedi: il Partitò della virtù (Fazilet Partisi – FP), destinato a
ereditare politiche e consensi dell’RP.
Nelle elezioni per l’aprile del 1999, il Dsp di Ecevit ottenne la maggioranza relativa con 136
seggi, mentre per la prima volta dal 1923, il CHP non riuscì a entrare in parlamento. Il
secondo raggruppamento fu il Partito di azione nazionale, che portava con sé il legato del
movimento di estrema destra dei «Lupi Grigi». Il neo costituito Partito della virtù conseguì
infine 111 seggi, con il 14,79% di voti. Ora, senza il CHP in Assemblea, le coalizione avrebbe
orbitato completamente fuori da ogni diretta reminiscenza kemalista. Infatti, il nuovo governo
di coalizione, tra DSP, ANAP e MHP fu ancora a guida di Bülent Ecevit, ma con una politica
considerata dalla maggior parte degli osservatori «meno turca».
Intanto, all’interno dell’FP, un gruppo di giovani iscritti guidati da Recep Tayyip Erdoğan e
Abdüllah Gül, sfidava apertamente il segretario dell’FP, Recai Kutan, subentrato a seguito
dello scioglimento dell’RP e dell’allontanamento di Erbakan.
Il consenso a questa alternativa «di centro», ispirata al modello tedesco della Cdu, non arrivò
subito, ma venne facilitato da un prevedibile evento costituzionale.
Il Procuratore generale Vural Savaş aveva promosso, sin dal maggio 1999, l’inchiesta per la
chiusura dell’FP in quanto partito antisecolare e illegale continuatore del disciolto RP.
La Corte costituzionale, il 22 giugno 2001, accolse il primo dei motivi, sulla base dell’art. 69
della Costituzione, costringendo anche l’FP alla chiusura e favorendo, di fatto, la fronda
interna minoritaria. Infatti, a seguito di questo evento, i fuoriusciti diedero subito vita a due
diverse organizzazioni: quella riformista e moderata del Partito della giustizia e del progresso
(Adalet ve Kalkinma Partisi – AKP), con leader acclamato Erdoğan; quella dei tradizionalisti,
confluiti nel Partito della felicità (Saadet Partisi –SP) guidato dal precedente leader Kutan.
Recep Tayyip Erdoğan
Le elezioni del novembre 2002 portarono all’ingresso in parlamento dell’AKP, con il ritorno del
CHP. L’inaspettato bipartitismo, favorito dalla soglia di sbarramento elettorale, consentì un
governo monocolore dell’AKP, ma privo della guida del suo leader, interdetto dall’assunzione
di qualsiasi carica istituzionale pubblica, per via di una sanzione a lui comminata nel 1997,
per un discorso filo islamista pronunciato a Siirt. Infatti il primo ministro diventò il suo braccio
destro, il pragmatico islamico Abdüllah Gül.
Con appositi emendamenti ad personam, nonostante l’apposizione del veto da parte del
presidente della repubblica Sezer, si riuscì a eludere l’ostacolo e alle prime elezioni
suppletive utili, tenutesi proprio nella città di Siirt, la città dell’arresto del 1997, Erdoğan
conquistò il seggio parlamentare negato dai giudici, per diventare finalmente Primo ministro
nel 2003.
Il governo di Erdoğan si è proposto come un modello per i paesi musulmani del Mediterraneo,
in particolare quelli che hanno vissuto le cosiddette «primavere arabe» caratterizzandosi per
il tentativo, al quanto ambizioso, di conciliare Islam e democrazia, sharia e capitalismo,
richiamo alla grandezza imperiale ottomana e adesione al campo geopolitico occidentale,
solidarietà con il popolo palestinese e mantenimento delle relazioni diplomatiche con lo Stato
d’Israele.
Il cosiddetto “neo-ottomanesimo” di Ankara, il cui presupposto si basa sul recupero di
influenza politica nei territori appartenuti all’Impero ottomano, avrebbe potuto giocare un
ruolo positivo, tuttavia il contributo dato dalla Turchia al terrorismo jihadista in Siria dimostra
che il tanto decantato “neo-ottomanesimo” non ha altra funzione che quella di fare da
gendarme agli Stati Uniti d’America nell’area balcanica e arabo-islamica.
Si dice spesso che senza Mustafa Kemal l’attuale Turchia non sarebbe esistita.
Ma si può anche immaginare che, con o senza di lui, un’altra Turchia avrebbe potuto vedere
la luce. Si rimane infatti colpiti nel vedere che dal 1908 al 2003 il paese si è trovato spesso di
fronte a scelte difficili; e che ogni volta si è indirizzato verso una politica di repressione di
massa, di integralismo, di violenze e crisi acute. Un solo esempio basterà a illustrare questo
punto. All’inizio degli anni Novanta, mentre crollava l’Unione Sovietica e i cambiamenti senza
precedenti sconvolgevano i Balcani e il Medio Oriente, molti osservatori erano piuttosto
ottimisti sul futuro della Turchia: la soluzione pacifica della questione curda e l’integrazione di
un islam politico garante della legalità, capace di evolvere in quadro democratico, avrebbero
liberato le immense potenzialità economiche e umane del paese per farne la principale
potenza ai confini di tre regioni.
Anche i curdi iracheni parlavano apertamente, se non della loro integrazione in questo paese
erede dell’impero ottomano, quanto meno di un’autonomia prospera in armonia con esso. Al
contrario la Turchia degli anni Novanta, in balia della guerra civile e dei conflitti di religione,
si è vista completamente emarginata nei Balcani, per non parlare poi dell’Asia Centrale, dove
è una potenza inesistente, mentre continua a spendere miliardi di dollari in offensive
«antiterrorismo» nel Kurdistan dove ormai il suo nome ispira solo odio e disprezzo.
Tuttavia non è necessario ricorrere al fatalismo o alla maledizione per spiegare questa
situazione. Bisogna storicizzare l’esperienza turca e le sue numerose crisi, a cominciare dalla
fine dell’impero ottomano, che ha assunto un ruolo traumatico e rafforzato le tendenze
repressive e nazionaliste nel paese. Ultima componente di un impero multietnico e
multiconfessionale, la repubblica turca è stata fondata sulla negazione radicale del suo
passato più recente e delle sue stesse basi storiche.
Per assicurarsi la proprietà di una terra ottenuta a prezzo di grandi sacrifici ma anche – lo si
dimentica spesso – di stermini e pulizie etniche, il paese ha «turchizzato» la sua storia
cacciando le popolazioni cristiane (armeni, greci, assiro-caldei).
Interpretando ogni identità non turca come una patologia mortale, la Turchia è arrivata al
punto di censurare lo stesso Mustafa Kemal, che aveva evocato l’ipotesi di un’autonomia
curda. Considerando l’Islam come la principale causa di morte dell’«uomo malato», il paese
ha negato che la sua guerra di indipendenza fosse stata condotta, almeno in parte, in nome
dell’Islam e del Califfato. Per paura di perdere la propria «identità nazionale», che si
confondeva per altro con l’Islam, la Turchia ha negato l’esistenza della sua comunità alevita.
Infine la presenza nella sua popolazione di un gran numero di balcanici (a cominciare dallo
stesso Mustafa Kemal, originario di Salonicco) e caucasici rafforzava e continua a rafforzare
l’impressione di insicurezza e di assenza di punti di riferimento. Tutto ciò ha portato a una
forte identificazione in una turchizzazione acquisita di recente e in una Turchia come ultimo
rifugio.
Il dramma del kemalismo, per concludere, è in un certo senso un dramma parallelo a quello
del comunismo: all’inizio il suo dispotismo viene giustificato con l’argomento dell’emergenza,
poi l’emergenza diviene permanente e finisce con il costituire il tessuto portante della realtà
civile e costituzionale.
Per approfondimenti:
_Hamit Bozarslan, La Turchia contemporanea, Il Mulino, 2004
_Lea Nocera, La Turchia contemporanea. Dalla repubblica kemalista al governo dell’AKP,
Carocci, 2011
_Alessandro Aruffo, Il pendolo turco. La Turchia contemporanea tra passato e futuro,
Datanews, 2011
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata
La Turchia: dalla caduta dell’Impero
ottomano a Erdoğan (1)
La Turchia: dalla caduta dell’Impero ottomano a Erdoğan (1)di Gabriele Rèpaci del
12/07/2016Il breve saggio che segue si propone di analizzare – senza pretesa di completezza
né esaustività – come la dissoluzione dello spazio politico e culturale dell’Impero ottomano
debba essere conosciuta e correttamente valutata per comprendere una serie di fenomeni
storico-politici novecenteschi.
In particolare la storia della Turchia moderna è una miniera di insegnamenti per comprendere
molti degli avvenimenti che ci coinvolgono in prima persona.
La storia dell’Impero Ottomano, dopo la presa di Costantinopoli, può essere divisa in tre
periodi: espansionistico, fino alla morte di Solimano il Magnifico, nel 1566; di equilibrio, fino al
fallimento della seconda spedizione contro Vienna, nel 1683; di decadenza, dal 1683 alla
deposizione dell’ultimo Sultano Mehmet VI, nel 1922.
L’identità politica europea risale alla fondazione della potenza dello stato ottomano, a partire
dal 1291, con la sconfitta dei bizantini e la guerra santa in Anatolia. È tuttavia nel XIV secolo,
con il Sultano Murad I, che il campo d’azione dell’Impero si protende tutto verso l’Europa,
approfittando delle rivalità tra gli stati balcanici, delle lotte tra Venezia e Genova, del conflitto
tra Bisanzio e Roma.
La minacciosa irruzione ottomana fu fronteggiata da una prima coalizione di principi cristiani,
promossa da papa Urbano V e sconfitta nella battaglia della Marica del 1363. La vittoria
indusse Murad a trasferire, nel 1365, la capitale da Busra ad Adrianopoli di Bitinia, in Asia
Minore, proprio per sancire il nuovo fulcro della spinta a nord dell’Impero. Sotto il regno del
suo successore, Bayazid I, anche la Grecia e la Serbia divennero protettorati ottomani.
Intanto, l’affacciarsi a est delle orde mongole di Tamerlano (Tämūr Lenk) contribuì
ulteriormente all’occidentalizzazione del dominio ottomano. I mongoli, pur avendo fatto
prigioniero il Sultano ad Ankara, non vollero approfittare della debolezza ottomana e
arrestarono la loro espansione, abbandonando l’Impero alle sue lotte intestine per la
successione a Bayazid.
Tra i suoi figli ebbe la meglio Mehmet, divenuto Sultano con il nome di Mehmet I. A lui si deve
il consolidamento dei confini dell’Impero, mentre il figlio, Murad II, avviò l’opera di
edificazione di una vera e propria amministrazione imperiale, finalizzata a organizzare e
beneficiare delle grandi risorse naturali e di attività umana, che i vasti territori conquistati
potevano offrire.
Con il successo di Mehmet II, si otterrà la conquista, nel 1453 e dopo due anni di assedio, di
Costantinopoli, finalmente eletta a nuova capitale dell’Impero Ottomano.
Affresco di Tintoretto risalente al 1580 che racconta la presa di Costantinopoli da parte dei
turchi.
Costantinopoli capitale fu ribattezzata Istanbul, dalla locuzione greca εις την πολιν (“verso la
città”).
Da questo momento, l’espansione ottomana a ovest sembrava inarrestabile. Mehmet II era
ormai identificato come Fatih, il conquistatore, e in effetti, dal 1474 in poi, l’Impero proseguì
verso l’Europa centrale, con il primo assedio di Vienna, nel 1529, ad opera di Süleyman II.
Con lui, ricordato come Solimano il Magnifico o il Legislatore, l’Impero raggiunse anche il
massimo della sua potenza militare, del prestigio internazionale e della razionalizzazione
organizzativa interna.
Quest’ultima, infatti, si caratterizzò per essere largamente tollerante nei confronti dei paesi
conquistati e persino liberale nel riconoscimento dell’uso pubblico delle lingue e delle
religioni.
Dopo Süleyman II, ebbe inizio la decadenza, scandita da lotte interne tra monarca e corpo
militare dei «Giannizzeri» (costituito sin dal 1334 da ex cristiani, rapiti da fanciulli ed educati
all’Islam), dalla battaglia di Lepanto del 1571, dal secondo fallito assedio di Vienna, nel 1683,
dalla Pace di Carlowitz del 1699, con cui gli Asburgo ottennero la sovranità sul Regno di
Ungheria, dal Trattato di Passarowitz del 1718, sempre nel segno dell’espansione austriaca.
Con quest’ultimo accordo l’alleanza austro-russa contro l’Impero ottomano decretò il nuovo
equilibrio europeo, sfociato nella guerra del 1736, strenuamente combattuta dall’esercito
ottomano, e nella pace del 1774, con cui la Russia conseguì, tra l’altro, il diritto di libera
navigazione nel mar Nero e il passaggio della sua flotta dagli stretti per il Mediterraneo.
Tra Settecento e Ottocento, l’Impero ottomano visse una nuova fase di stabilizzazione,
dovuta al clima inaugurato in Europa dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche,
che permisero all’Impero ottomano, da un lato, di sentirsi tranquillo sulle proprie frontiere
verso la Russia, e, dall’altro, di concentrarsi sull’ammodernamento militare e
dell’amministrazione interna.
Il Congresso di Parigi, nel 1856, scandì una nuova fase dell’identità europea dell’Impero:
l’integrità dei confini era salvaguardata, ma l’indipendenza riconosciuta alla Grecia e
l’autonomia accordata alla Romania inaugurarono inedite lotte delle altre nazionalità per la
loro separazione dal potere del Sultano. L’Impero ormai era in crisi e il processo di
disgregazione irreversibile.
Lungo questa china fin de siècle, nacquero il movimento dei Giovani ottomani e l’ideologia
dell’Ottomanesimo, mirata a ridimensionare lo sfaldamento dell’Impero attraverso un
percorso di riforme nel richiamo alla grande tradizione ottomana. Le novità prodotte da
questo movimento si sintetizzano in una formula: Tanzimat e Khayriyya o «leggi benefiche»,
avviate nel 1856, per indicare il complesso di disposizioni di riforma della giustizia, culminate
nella Costituzione ottomana del 1876. Si trattò di tentativi coraggiosi di grande impatto
formale, evocati anche in altri contesti musulmani come la Tunisia, ma di scarsa aderenza
sostanziale.
Non meno contraddittorio si rivelò il movimento dei Giovani turchi. Creato clandestinamente
a Istanbul nel 1889, il movimento si organizzò nel Comitato unione e progresso (Ittihad ve
Terakki Cemiyeti) e si dichiarò erede dei giovani ottomani del 1876. Il movimento era
composto prevalentemente da ufficiali dell’esercito, sotto la guida di Enver Bey, ma
raccoglieva idee libertarie e socialiste collegandosi anche, tramite alcuni suoi affiliati europei,
alla massoneria: per questo non si presentava con un programma ben definito e omogeneo.
Sul piano retorico, esso riecheggiava il «panturanesimo» o «panturchismo» che i musulmani
dell’Impero ottomano avevano importato dalla Russia e le cui idee si sintetizzavano nella
formula del ripristino del «focolare turco» (Türk Ocaği).
Invece, sul fronte istituzionale, due sembravano le rivendicazioni: il ritorno alla Costituzione
liberale del 1876; il recupero del consenso delle minoranze non turche, di cui i Giovani turchi
interpretavano le istanze autonomistiche dopo la crisi dell’unità ottomana.
Certo, le ideologie costituzionali di questa élite furono fortemente suggestionate da eventi
esterni: le istanze rivoluzionarie russe, ideologicamente ben marcate; l’esempio giapponese,
la cui modernizzazione era iniziata proprio dopo la vittoria sulla Russia ed era passata
attraverso la costituzionalizzazione del potere; l’esperimento di monarchia costituzionale in
Iran, del 1905-1906.
Il 23 luglio 1908, Enver Bey intimò al Sultano Abdül Hamid II, denominato «rosso» per la sua
crudeltà sanguinaria, di ristabilire la Costituzione del 1876. Il giorno seguente il Sultano
cedette e annunciò, in attuazione della ripristinata Carta, la convocazione di elezioni politiche
generali.
La prima camera elettiva fu solennemente convocata e inaugurata il 4 dicembre 1908. In
quei mesi, si organizzarono i primi sindacati e si verificarono i primi scioperi della storia
ottomana.
L’obiettivo di coniugare la grandezza imperiale con la costituzionalizzazione del potere
sembrò raggiunto. Invece, il 13 aprile 1909, Instabul fu scossa da una sommossa degli
studenti di teologia che rivendicavano il ritorno alla legge coranica e le dimissioni del
governo. Gli insorti non incontrarono alcuna resistenza e si imposero nella capitale.
Disorientati, i Giovani turchi trovarono rifugio a Salonicco per riorganizzarsi. Rientrato in
Turchia, Enver riprese la marcia verso Istanbul proprio con l’aiuto delle armate di Macedonia
e, il 24 aprile reintegrò nei poteri la Camera elettiva, riuscendo a far designare Mehmet V
quale successore di Hamid.
In verità l’ammutinamento studentesco del 13 aprile aveva manifestato la debolezza
congenita del movimento dei Giovani turchi: tradizionalismo e costituzionalismo non
potevano essere semplicemente sommati attraverso imitazioni esterne e rievocazioni del
passato. Il cuore dell’Impero dei primi anni del Novecento si scopriva «europeo» anche nel
vivere il dilemma, determinante nella storia del costituzionalismo, tra riforma, tradizione e
rivoluzione.
Intanto, il ritrovato sodalizio con il nuovo Sultano, in quanto caldeggiato soprattutto
dall’esercito, produrrà due ulteriori effetti di lungo periodo: la emarginazione dei gruppi
autonomistici delle periferie dell’Impero, originariamente vicini al movimento di insurrezione;
la deviazione militarista dell’esperienza di rivendicazione costituzionale, con il conseguente
abbandono di tutti i progetti di decentramento riformistico e il progressivo accentramento dei
poteri, sfociato nel «triumvirato militare» di Enver-Cemal-Talat, avallato dal Sultano e
legittimato con la elevazione di Enver al rango di Paşa.
Legato alla Germania dal trattato di alleanza del 2 agosto 1914, L’Impero ottomano entrò in
guerra il 29 ottobre. La guerra, ancorché condotta sotto la direzione strategica di Enver Paşa,
produsse un susseguirsi di disfatte, conclusesi con l’armistizio firmato a Mudros il 30 ottobre
1918. Le grandi potenze europee imposero lo smembramento dell’Impero, la confisca della
flotta ottomana, l’occupazione di Istanbul da parte delle truppe dell’Intesa balcanica,
l’affidamento dei territori a patti segreti per la suddivisione delle province imperiali, le Vilayet
tra inglesi (Mossul e Mesopotamia), francesi (Siria e Cilicia), italiani (Koniya e Antalya). Il
governo si trovò a non detenere alcun ruolo concreto, tant’è che il nuovo Sultano, Mehmet VI,
compose un Consiglio di ministri senza Enver, agli ordini dei vincitori.
È in questo difficile passaggio che riemersero le istanze costituzionali, ancora una volta di
confusa identificazione. Cellule del Comitato unione e progresso si ricostituirono lontano dalle
città.
Fu proprio per stanarne la presenza che il Sultano inviò il giovane e valoroso ufficiale Mustafà
Kemal a recarsi nella regione di Samsun. Gli esperimenti costituzionali insurrezionali questa
volta tentarono forme di governo repubblicane e autonomiste, apertamente ostili al Sultano e
al suo asservimento allo straniero. Nacquero così: il Comitato per la difesa della Tracia, in
lotta contro le mire espansionistiche della Grecia; il governo per la Caucasia, separato dagli
armeni, autoproclamatisi indipendenti.
In Anatolia, si insediò nel 1919 il movimento di resistenza armata «Associazione per la difesa
dei diritti» (Müdaafayi Hukuk Cemiyetleri). Contemporaneamente si verificarono ovunque
significativi moti contadini, tesi a sperimentare rudimentali forme di soviet.
All’arrivo a Samsun, Kemal si convinse della bontà di queste rivendicazioni repubblicane
rispetto all’indifferenza della borghesia musulmana cittadina, economicamente interessata al
mantenimento dell’occupazione straniera, e comprese che la disgregazione imperiale non era
da imputare all’autonomismo, quanto alla totale sfiducia popolare nelle istituzioni centrali del
paese.
Così, il 22 giugno 1919, Kemal lanciò il suo primo appello pubblico alla resistenza, invitando i
militari a unirsi a lui e annunciando la convocazione di un Congresso nazionale a Sivas,
rappresentativo di tutte le forze del territorio per ricomporre l’identità turca.
Subito dopo, il 23 luglio, approfittando della campagna di resistenza contro la costituzione
della Grande Armenia, egli promosse l’Assemblea generale preliminare di Erzurum,
finalizzata a fissare gli obiettivi del Congresso nazionale di Sivas: separazione degli interessi
della Turchia da quelli dell’Impero ottomano; proclamazione della indivisibilità dei paesi
turchi dell’antico Impero; indipendenza dagli europei.
Aperto a Sivas il 13 settembre, il Congresso si trasferì ad Ankara alla fine dell’anno.
Le proclamazioni di Sivas non mettevano in discussione il potere del Sultano. Infatti, l’opzione
repubblicana non risultava ancora pienamente condivisa. In ogni caso, però, il Sultano si
mostrò da subito ostile al progetto di Kemal, strumentalizzando contro di lui le sollevazioni
autonomistiche dei curdi, mal viste dai partecipanti al Congresso di Sivas, spiazzando il suo
progetto politico di unificazione nazionale con l’annuncio di elezioni politiche anticipate,
evidentemente alternative all’Assemblea insediata ad Ankara, modificando, inoltre, la
composizione del governo di Istanbul per renderlo meno filoeuropeo. In effetti, le mosse del
Sultano disorientarono la strategia di Kemal. L’Assemblea nazionale non solo decise di
trasferirsi a Istanbul contro il suo parere, ma accelerò inopinatamente il processo
rivoluzionario, adottando un Patto nazionale che riprendeva senza mezze misure il
programma di Sivas. Questo colpo di forza provocò una crudele repressione britannica: i
lavori dell’Assemblea vennero soppressi e i deputati nazionalisti confinati a Malta. Il Sultano,
dal canto suo, emise un Fètva, un decreto che dichiarava fuori legge tutti gli aderenti ai
movimenti nazionalisti riconosciuti a Sivas. Kemal, che si era rifiutato di recarsi a Istanbul,
sfuggì alla retata inglese e poté riorganizzare altre mobilitazioni che costringeranno a nuove
elezioni, contro la volontà del Sultano. La partecipazione alla nuova consultazione popolare
sancì la nascita del sentimento repubblicano turco: la nuova Grande Assemblea (Büyük Millet
Meclisi) era a maggioranza nazionalista e repubblicana e inaugurò i suoi lavori il 23 aprile
1920, eleggendo suo presidente Kemal. Questi, sempre con l’appoggio soprattutto
dell’esercito guidato dal colonnello İsmet (il futuro İnӧnü), nominò il primo governo
nazionalista turco.
Il governo nasceva formalmente illegale al cospetto del Fètva del Sultano, ma
sostanzialmente legittimo per il consenso ricevuto, tanto da vedersi di lì a poco riconosciuto a
livello internazionale, con la partecipazione dei suoi membri all’armistizio franco-turco.
La politica nazionalista si misurò da subito con due diverse prospettive presenti tra i
repubblicani: il cosiddetto «ideale occidentale» (Garb Mefkulersi), che avocava il recupero
dell’esperienza delle Tanzimat; l’«ideale orientale» (Sark Mefkurersi), teso invece alla
discontinuità su tutti i fronti, con il passato ottomano come anche con i valori occidentali
dell’«asservimento imperiale».
Su quest’ultima prospettiva pesava certamente l’influsso ideologico della Russia bolscevica,
che aveva appoggiato il movimento nazionalista nella sua triplice lotta contro il Sultano, gli
alleati europei e gli armeni.
L’«ideale orientale» predicava la lotta contro l’imperialismo anglo-francese, ma sul piano
delle proposte politiche si dimostrava piuttosto confuso. In ogni caso, Kemal reputò
opportuno assecondare l’«ideale orientale», per non perdere l’appoggio popolare di quelle
forze contadine che avevano contribuito non poco alla riuscita della rivolta nazionalista. Per
tale ragione, egli provvide a creare un doppione islamico dell’Armata Rossa: l’Armata Verde
(Yeşil Ordu), con funzioni di ordine pubblico e sicurezza sui confini. Questa Armata sfuggirà
subito di mano al suo ideatore. In nome della lotta contro l’imperialismo europeo in Asia, i
miliziani «verdi» predicavano l’eliminazione della proprietà privata e la distribuzione delle
terre e delle ricchezze. Ma il «populismo» di Kemal mirava ad altro: riconoscersi in uno stato
nuovo, sotto la cui guida promuovere giustizia e sviluppo.
Per la definitiva discontinuità dal passato, questa idea repubblicana doveva innanzitutto
emanciparsi dalla legittimazione del Sultano. Con il Trattato di Sèvres, del 10 agosto 1920,
cadde quest’ultima ipoteca. La sottoscrizione da parte del Sultano di condizioni palesemente
umilianti per la Turchia, fece perdere ogni credibilità all’istituzione monarchica.
Con tale accordo l’Impero ottomano, già drasticamente ridimensionato col Trattato di Londra
del 1913, si ritrovò ridotto ad un modesto stato entro i limiti della penisola anatolica, privato
di tutti i territori arabi e della sovranità sugli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che furono
smilitarizzati. Ai greci fu assegnata nell’Asia minore la zona gravitante su Smirne, ai bordi
meridionali della penisola anatolica erano previste zone d’influenza dell’Italia (golfo di
Adalia), della Francia (Cilicia) e della Gran Bretagna (Kurdistan). L’Armenia fu riconosciuta
come stato indipendente con i Vilayet di Erzerum, Erivan e Trebisonda. Dei paesi arabi, Siria
e Libano andarono ai francesi, la Palestina e l’Iraq agli inglesi come “mandati” sotto il
controllo della Società delle Nazioni (una forma speciale di neocolonialismo). Infine, l’esercito
veniva esautorato di qualsiasi funzione decisionale. Fu proprio questo passaggio che colse a
suo favore Kemal.
Il 20 gennaio 1921, egli propose l’adozione di una Costituzione provvisoria per la transizione
definitiva alla repubblica laica, fondata sulla sovranità della nazione. Intanto, a «sinistra»
dello schieramento kemalista forte dell’appoggio dell’Armata Verde, si affacciava la fronda
estremista, che spingeva per la lotta di classe e la rivoluzione proletaria. A questo punto,
Kemal richiamò l’esercito e decise di liquidare l’Armata Verde, promuovendo contro di essa
un piano di attacco destinato a sortire importanti effetti : da una parte, verrà sancita la
sconfitta dell’«ideale orientale»; dall’altra, l’esercito assumerà il ruolo di tutore istituzionale
della identità repubblicana, ancora in costruzione; infine, si accentueranno le rivendicazioni
greche a nord, grazie al ritiro delle truppe militari a Bursa per fronteggiare l’Armata. La
ripresa del conflitto con la Grecia riavvicinò la Turchia alla Russia, fino alla firma del patto di
amicizia sovietico-turco, del 16 marzo 1921, che consentì alla Turchia di risolvere anche il
problema di una grande Armenia indipendente, di fatto consegnata all’Urss come repubblica
sovietica.
L’entrata dell’esercito turco a Izmir (Liberazione di Smirne) il 9 settembre 1922, a seguito del
successo della Grande offensiva di Smirne, sigillando efficacemente la vittoria turca e
concludendo la guerra.
Con la pace di Losanna del 1923, la Turchia assumeva il suo aspetto attuale e con il recupero
pieno dell’indipendenza, il processo di edificazione repubblicana finalmente si consolidava. I
passaggi fondamentali furono quattro: il voto dell’Assemblea di Ankara, adottato
all’unanimità il 1 novembre 1922, con cui venne proclamata la sovranità del governo di
Ankara su tutto il territorio nazionale e di fatto si disconosceva la legittimità del Sultano; la
creazione, nell’agosto del 1923, del Partito repubblicano del popolo (Cumhuriyet Halk Partisi –
CHP), come partito unico della Turchia indipendente; la proclamazione della repubblica il 29
ottobre 1923; la soppressione del Califfato nel 1924. Kemal fu eletto dal parlamento
presidente della repubblica e nominò come Primo ministro İsmet Paşa, conosciuto ormai
come İnӧnü. Furono questi due uomini politici a redigere la Costituzione repubblicana e laica
della moderna Turchia. A suggello del suo operato, l’Assemblea nazionale conferirà a Kemal,
nel 1934, il titolo di Atatürk, ovvero «Padre dei turchi».
Mustafà Kemal Atatürk (padre dei turchi) è stato il fondatore della nazione turca
contemporanea, attraverso un’operazione complessiva di riformismo dispotico dall’alto che
trova pochi altri precedenti storici (da Pietro il Grande in Russia ai primi del Settecento alla
cosiddetta Restaurazione Meiji in Giappone dopo il 1868). È interessante (e non casuale) che
sia stato un uomo nato e cresciuto nella Rumelia (a Salonicco, nella Turchia europea perduta
nel 1913) a rifondare una Turchia largamente immaginaria e mitica nell’Anatolia, una zona
geografica in cui prima del 1071 (battaglia di Manzikert) non abitava praticamente nessun
turco, ed in cui per circa mille anni abitarono almeno quattro popoli principali (turchi, greci,
armeni, curdi), più molti altri popoli minori (lazi, circassi, georgiani, arabi, assiri, eccetera). Il
sogno europeo dei riformatori turchi dell’Ottocento, nato e cresciuto in Rumelia, venne
trapiantato in un’Anatolia largamente immaginaria.
Per approfondimenti:
_Hamit Bozarslan, La Turchia contemporanea, Il Mulino, 2004
_Lea Nocera, La Turchia contemporanea. Dalla repubblica kemalista al governo dell’AKP,
Carocci, 2011
_Alessandro Aruffo, Il pendolo turco. La Turchia contemporanea tra passato e futuro,
Datanews, 2011
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata
La mutazione della Turchia (4)
La mutazione della Turchia (4)di Francesco Di Turi del 30/06/2016
Quando si parla di “storicità” un termine che riprendiamo da Heidegger, intendiamo
nient’altro che la concentrazione attiva e sempre operante di tutte le esperienze che forgiano
un determinato popolo, uno specifico individuo nella sua irripetibile unicità, o una particolare
comunità religiosa. Essa è cosa diversa dalla mera «storia» di ognuno di essi. É per questo
che nei contributi pubblicati si usa questo termine in alcuni contesti. Lo «storia di un popolo»,
infatti, così come il suo studio, è solo un passato messo a disposizione di ognuno, o per
intrattenere la curiosità di qualche studioso, o perché si accresca qualche nozione e
conoscenza astratta sulle vicende di quel determinato popolo. La «storicità di un popolo», al
contrario, non è mai declinabile come «studio», non è qualcosa che possiamo maneggiare
con le nostre mani e le nostre menti; essa è carne viva, agisce al di là di ogni volontà di
manipolazione e non ha nulla a che vedere con la conoscenza, la cultura o il sapere; è,
semmai, un fenomeno che sempre accompagna le individualità e le comunità. Verso di essa
ciò che conta non si valuta sul piano della conoscenza bensì su quello dell’adesione o meno
al senso di questa «storicità».
L’esperienza della grande religione islamica si rivela essere ciò che essa è già stata e ciò che
è in quanto sua propria «storicità»: un’esperienza religiosa dal forte «spirito guerriero»
(Giovanni Paolo II) capace di esprimere ancor oggi una direzione storica che, in fin dei conti,
aveva subito solo una battuta d’arresto egemonica, nella sua forma a partire dalla fine della
esperienza sultaniale turco-ottomana (1924), nella sua sostanza già con il concludersi del
XVIII secolo. Riconoscere questo dato non significa, ovviamente, né disconoscere i tanti
elementi di positività culturale e neppure attuare un semplicistico e gretto riduzionismo della
complessa natura dell’Islam in funzione della sua espansività o aggressività. L’esperienza
spirituale islamica è troppo ricca e feconda perché si sia giustificati nell’operare un simile
riduzionismo.
Sottolineare e marcare oggi lo “spirito guerriero” dell’Islam in funzione della sua storicità
significa solo ricollocare sul suo giusto piano storico una grande esperienza politica e
religiosa la quale pensa, ad esempio, il senso di un’espressione linguistica qual è «jihad»
(«sforzo», «lotta»), in forme più o meno spiritualizzate e più o meno rese operanti nella loro
bruta letteralità, e ciò a seconda dei momenti storici in cui essa si colloca, al grado di
aderenza alla rivelazione coranica quale diretta emanazione divina, nonché all’effettiva
praticabilità storico-politica della propria missione religiosa. Sarebbe infatti necessario ed
utile attuare una meditazione approfondita rispetto alla specifica natura che la questione del
«linguaggio» presenta nell’Islam; ci condurrebbe su sentieri decisivi per comprendere la
natura di alcuni fenomeni provenienti da questo mondo e non solo da questo; perché, quando
si parla in questa sede di rifluire storico, non si fa riferimento ad una semplice opzione
teorica, ma si intende un fenomeno che agisce realmente, non in senso astratto ma concreto,
proprio nelle modificazione dei dispositivi di senso linguistici, nella creazione di ordini del
discorso nuovi che si pongono in strutturale connessione con l’epoca nascente da cui il nuovo
linguaggio emerge a partire dalla provenienza storica analogica che ritorna.
Bene, un esempio eminente di quella che abbiamo chiamato nel precedente contributo la
“tempesta storica perfetta” seguita alla caduta dell’Impero sovietico è quello della Turchia.
L’ordine mediorientale seguito alla fine della Grande Guerra è dunque dissolto. Gli Stati
costruiti a tavolino dalle Potenze europee sono in via di disfacimento mentre il nuovo ordine
(per ora solo disordine) è la posta in gioco dei conflitti oggi in atto in quegli spazi geopolitici.
Cosa significa tutto questo per la Turchia?
La considerazione da cui partire è quella che indica il coincidere del dissolvimento dell’ordine
mediorientale con il dissolvimento all’interno della storia turca di quasi un secolo di
kemalismo.
Questi due fatti storici non possono e non devono essere tenuti separati poiché sono
nient’altro che un unico e medesimo fenomeno.
Al defluire storico della sua vita, la dissolta potenza turco-ottomana, grazie a Mustafa Kemal
(questo dömne di Salonicco più tardi proclamato «Atatürk», padre dei turchi), uno degli
uomini più geniali, ambiziosi e rivoluzionari del XX secolo, ha operato una modificazione dei
propri connotati fondamentali attuando, in quello che era stato il cuore pulsante dell’unità
islamica sotto l’egida della fu Sublime porta (Costantinopoli), un processo di laicizzazione e di
occidentalizzazione radicale su tutti i piani e a tutti i livelli: cambiamento dell’alfabeto da
quello semitico arabo a quello latino occidentale; abolizione del califfato; proibizione del velo
islamico per le donne; eliminazione di ogni influenza religiosa islamica nel diritto; proibizione
per gli uomini di portare barba e baffi; divieto d’indossare il famoso copricapo turco, il Fez;
proibizione dell’uso della grande moschea di Santa Sophia, già Basilica cristiana, per qualsiasi
uso religioso.
Questo solo per citare alcuni dei provvedimenti che segnarono la nascita della nuova Turchia
dalle ceneri del sultanato Ottomano.
Ebbene, oggi è la stessa rivoluzione kemalista che è messa di fatto in discussione da un corso
politico islamista al potere ormai dal 2002 che conta notevoli successi economi e consenso
ampio della popolazione. Anche per la Turchia vale lo stesso che si è detto in riferimento a
qualsiasi altro popolo.
Il corso islamista rappresentato dalla politica di T. Erdogan, proprio perché si situa in
un’esperienza storica come quella della Turchia kemalista – formalmente ancora operante ma
sostanzialmente ormai defluita, dissolta – che così a fondo aveva modificato il vecchio corso
turco-ottomano è un ottimo esempio di ciò che si intende con il concetto di «analogia
sostanziale del rifluire storico». Non vi è e non vi sarà in Turchia, ovviamente, un ritorno sic et
simpliciter alla situazione storico politica turco-ottomana, certo; più concretamente è in atto
un riflusso che si pone con essa in termini di sostanziale analogia.
Si prenda il nuovo ricollocamento geopolitico turco. Ormai, la Turchia, non guarderà più nei
fatti e con gli stessi occhi all’integrazione politica con l’Unione Europea. Questa modificazione
politica accadrà, accade, proprio perché si riscoprono caratteri storici, una propria storicità
intrinseca, che va ben al di là delle pur rivoluzionarie e profonde modificazioni kemaliste e
che, inevitabilmente, la riproiettano come potenza di primissimo piano nello scacchiere
mediorientale, con caratteri non dissimili, sostanzialmente analoghi, a quelli vigenti quanto
meno alla fine del XIX secolo: l’esatta provenienza storica che in senso analogico oggi in quel
territorio rifluisce. La politica interna, ma direi soprattutto la politica culturale della Turchia
dell’ultimo tredicennio ha oggettivo successo perché intercetta, governandola, una dinamica
storica che, nell’attualità propria e regionale, refluisce da un passato vivo, ancora capace di
proiettarsi positivamente verso il futuro. Nel prossimo futuro non ci troveremo più, insomma,
in una situazione in cui da una parte avremo una Turchia desiderosa di maggior
coinvolgimento europeo e che quindi spingerà verso l’integrazione nel processo storico
dell’Europa istituzionale con quest’ultima divisa al suo interno tra i favorevoli e i contrari;
semmai, già oggi e a maggior ragione domani, a distanza di pochissimi anni dai sogni europei
della Turchia, avverrà l’esatto opposto; sarà la Turchia stessa che probabilmente non
mostrerà più alcun interesse concreto di coinvolgimento istituzionale con la UE, e se al
contrario essa mostrerà interesse in questa direzione, dovremo riflettere attentamente sulle
reali ragioni che spingono la Turchia del XXI secolo verso una maggiore integrazione europea.
La Turchia del principio del XXI secolo, rispetto a quella della fine del XX, di identico, ha solo il
nome, essendo divenuta nel giro di un ventennio, quello a cavallo tra i due millenni, molto più
simile nella sua psicologia all’epoca antecedente la rivoluzione kemalista che, ormai, ha
concluso la sua proiezione storica e ha smesso di essere il principio guida che in senso
egemonico esprime l’anima del popolo turco. Perché questo accada, cioè perché una vicenda
storica smetta di esprimere il proprio dominio lasciando spazio ad un’altra, non è affatto
necessario che si prendano da parte turca o di qualsiasi nazionalità, misure ufficiali o
legislative che ne sanciscano l’effettività. I fenomeni di questa natura agiscono a prescindere
dalla forma con cui chi ne è soggetto ne riconosce l’accadere; allo stesso modo con cui il
papato, per fare un esempio, mentre l’Italia già era fatta come Stato nel 1861 e procedeva
senza remore storiche alla presa di Roma nel 1870, restava ancora convinto che Roma fosse
politicamente sua, sia per diritto divino sia per quello legale. Un mondo, anche allora, si era
dissolto; c’era chi lo aveva compreso e chi no.
Dunque, è soprattutto in considerazione con quanto si è appena detto che vanno interpretate
sia le turbolenze interne degli ultimi tre anni sia la politica ambigua (per usare un eufemismo)
della Turchia nei confronti dello «Stato islamico». Rispetto a questa ambiguità nei confronti
dello «Stato islamico» l’unica cosa certa ed assodata è che, la Turchia, non combatte il
califfato a causa della questione curda, ossia in connessione al suo grande e classico
problema geopolitico, quello di impedire la costituzione di uno Stato curdo nei territori siroiracheni che faccia da possibile catalizzatore per i loro fratelli di Turchia; tuttavia noi siamo
più che convinti che le reali ragioni che spingono Ankara a guadare con interesse allo Stato
islamico siano ben più profonde e radicali che non il semplice fatto geopolitico curdo, che
pure resta primario. Questo perché lo scenario non solo non è più lo stesso in un senso
geopolitico ma si è anche totalmente riconfigurato su piani psicologici e antropologici che non
possono minimamente essere sottovalutati o espunti nell’attuazione di qualsiasi analisi
geopolitica.
Cosa significa non espungere dalle analisi il fattore psicologico o il fattore antropologico?
Molto semplicemente significa che il nuovo corso turco non pensa più se stesso e la sua
azione interna ed esterna principalmente in termini di equilibrio fra Potenze, spazi geopolitici,
fattori economici ed energetici, cioè in un senso che prescinde in linea di principio da quella
che è anche una missione al tempo stesso intrinsecamente religiosa che sempre più diverrà il
fattore decisivo che detterà le linee guida di ogni sua decisione politica fondamentale. La
storicità del popolo turco, dopo un secolo di abbandono del fattore religioso, degradato a
elemento residuale ed ininfluente delle proprie scelte strategiche, diverrà sempre più
l’elemento che in senso architettonico, ossia ponendosi quale sovrastruttura dominante,
indicherà la vera direzione e il senso da perseguire; che un elemento si ponga in senso
architettonico significa che ogni altro fattore che costituisce l’organismo comunitario resta
subordinato al nuovo principio il quale riempie di senso e fortifica la struttura di cui è
divenuto sovrastruttura scalzando ciò che in precedenza fungeva da principio architettonico.
Con la fine dell’URSS si è davvero conclusa un’epoca dello Spirito. Solo quando impareremo a
capire ed assimilare il senso e le reali implicazioni di questo evento avremo gli strumenti
adeguati per poter comprendere ed agire nelle crisi che nascono a causa di questa
modificazione.
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata