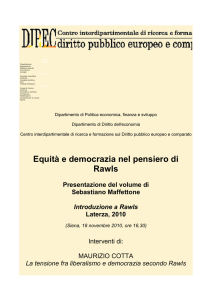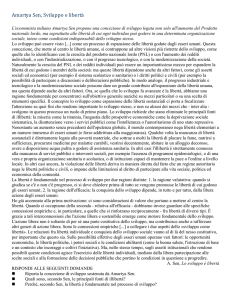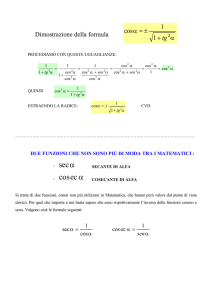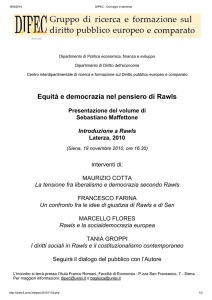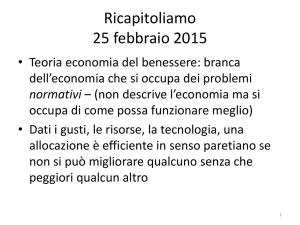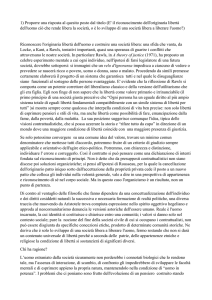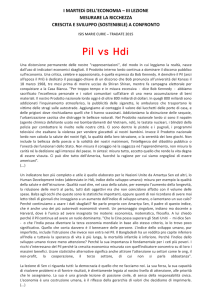Teorie su equità e giustizia sociale - (Franco Angeli Editore)
a cura di Antonio Maturo
L’obiettivo di questo testo, nato dalla collaborazione di più esperti della materia
e con la coordinazione del prof. Antonio Maturo, docente della cattedra di
“Giustizia ed Equità sociale” dell’Università “Alma Mater” di Bologna, è quello,
in una società complessa e in crisi di sviluppo, a più latitudini, come è l’attuale,
di indicare, attraverso la conoscenza concettuale di alcuni autori canonici, i
concetti idonei a fornire strumenti di percorso in merito appunto a “giustizia”
ed “equità”, concetti pari oggi, potremmo dire, quasi a
fantasmi shakespeariani, che dal piano teorico si
traducano, per gradi, all’interno delle istituzioni
pubbliche
e/o private, successivamente, in un
esercizio concreto e rispondente a quelli che sono gli
effettivi bisogni del territorio.
Parlare di giustizia e di equità sociale, per chi intende
impostare una procedura-habitus che nella realtà le
contempli in sé, significa innanzitutto avere chiare le
idee in materia di sicurezza, di benessere, di politica
della differenza, di multiculturalismo, di riconoscimento, di “capabilities”, di
violenza strutturale, di codici di sistema, di democrazia deliberativa e di virtù.
Balza evidente, allora, l’imprescindibilità da un percorso formativo continuato e
continuativo (data l’ampiezza dei campi del sapere coinvolti) da parte di tutti
gli attori politici e sociali per il raggiungimento, inizialmente almeno parziale,
della meta.
Raggiungimento che poi, nel tempo e per gradi, può e deve pervenire (si
spera) all’efficienza e all’efficacia reale negli ambienti deputati.
Si devono fare i conti e si spazia, infatti, dal diritto alla filosofia, dalla politica
alla sociologia, al diritto, all’antropologia, alla psicologia, alla biologia sociale,
all’economia in senso lato.
Discipline che devono tutte essere tratte fuori dai manuali di studio e dai
dibattiti accademici (nulla più di libresco ma vita vera) per essere
effettivamente ruminate e fatte “bolo”, nutrimento dunque, soprattutto da chi
è chiamato a esercitare determinate funzioni in società.
Ma non solo da costui. Anche dall’ultimo cittadino se la democrazia vuole
essere un’autentica democrazia partecipata.
Una democrazia, in poche parole, “adulta”.
Lasciando al momento da parte, per poi riprenderle magari più avanti, alcune
delle trattazioni riguardanti il multiculturalismo, l’etica politica e lo svantaggio
di sistema, che se non imbrigliato a sufficienza conduce senza scampo,
quest’ultimo, a quella che si definisce violenza strutturale di difficile se non
impossibile gestione, mi fermo adesso all’equità intesa come sviluppo delle
“capabilities” in Amartya Sen, trattate nel libro di cui sopra dalla relazione del
prof. Carmine Clemente.
Il nostro mondo abitato (lo sappiamo bene) è oggi, a tutti gli effetti, quasi
paragonabile a un pianeta di naufraghi, che si barcamenano tra flutti agitati di
svariate e differenti crisi, per uscire dalle quali pare sia difficilissimo, anche agli
“esperti”, individuarne il bandolo.
Naufraghi, tuttavia, che non intendono rinunciare alla “ciambella” di
salvataggio.
Poiché non s’accetta di subire il naufragio e neanche di rinunciare con esso ad
alcune sicurezze, quelle conquistate, a fatica, in precedenza, che ci
trascinerebbero tutti, senza scampo, in un’apartheid globale, ecco allora che
Amartya Sen, il noto economista e premio Nobel, ci offre una ricetta.
Proprio come il medico al malato.
Il Nobel per l’economia, l’indiano Amartya Sen, da anni ormai docente nei più
prestigiosi atenei degli USA, abile conferenziere e presidente di numerose
associazioni accademiche, ci dice a chiare lettere che non possiamo e non
dobbiamo, per nessuna ragione al mondo, rinunciare a quelle che si
definiscono “priorità” democratiche, che altro non sono che l’esercizio di una
“governance” gestita tramite discussione.
Importanza della parola, dunque. Della parola libera e intelligente, che è
prerogativa esclusiva dell’essere umano.
Ma perché questo sia, necessita assolutamente l’acquisizione o la riacquisizione
del valore delle “human capabilities” di aristotelica memoria e cioè di una
intelligente applicazione del principio di uguaglianza, che conduca dritto a
quello che si chiama “buon governo” efficiente.
E si perviene al “buon governo” soltanto se, chi se ne è assunto il compito,
tiene conto dei necessari parametri di sviluppo della vita umana. E quindi, ad
esempio, della nutrizione, della salute, dell’educazione e degli aspetti
relazionali.
La delicatezza del tema, in un periodo di crisi economico-finanziaria
internazionale a tutto campo, è enorme. E se poi si fa riferimento ai Paesi in
via di sviluppo (specie l’Africa), quasi tutti sotto il tallone di schiaccianti e
inumane dittature, lo è ancora di più.
Occorre, dal momento che Nord e Sud del mondo vivono oggi, e quasi
ovunque, lo stesso clima di precarietà e d’incertezza, prestare da parte di tutti
una maggiore attenzione al concetto di uguaglianza, che altro non è poi che
l’equità in rapporto all’influenza esercitata da chi viene preposto a governare
sulla vita delle persone.
Noi siamo, appunto, come siamo percepiti.
Ecco così che la questione etica, solo apparentemente di lieve peso in politica e
in economia, s’integra di diritto con tutte le altre discipline economiche e il
“buon governo”, che ne scaturisce, è quello che non toglie certo benefit ai
cittadini meno abbienti come, al contrario, si verifica nella quasi totalità dei
governi di nostra conoscenza. (Africa e dittature latino-americane in primis ma
non solo esse).
Esso, il “buon governo” è soltanto per Amartya Sen quello che è capace di
declinare con intelligenza l’uguaglianza nelle scelte politiche.
Quindi formazione degli attori politici e sociali in senso lato, in questo caso,
diviene azione intelligente e rispettosa della giustizia sociale, e quindi
dell’equità, nei fatti.
Jurgen Habermas invece, a proposito di giustizia come “democrazia
deliberativa”, il saggio è del prof. Emilio Cocco, si spinge, ancora più avanti di
Amartya Sen nella sua analisi di “buon governo”.
Perché per Habermas è fondamentale che il cittadino eserciti all’interno del
contesto sociale di appartenenza soprattutto il diritto di elettore attivo con la
sua partecipazione, cioè che abbia la libera possibilità di farsi ascoltare, frutto il
suo “parlare” di un’informazione e di una formazione mirata e permanente.
Nessuna decisione, secondo il nostro, può essere presa se la decisione di una
qualunque assemblea non risulti essere unanime. Prescindendo dalla
lungaggine dei tempi.
E’ in teoria, bisogna dirlo, un’affascinante ipotesi, che ricorda un po’ l’antica
Grecia. Nella realtà però, almeno oggi, nelle nostre moderne assemblee, risulta
essere di difficile applicabilità.
E’ applicabile, ad esempio, anche da noi solo in quelle piccole. E con qualche
limite come ben sappiamo.
E, ancora, qualcosa del genere si sperimenta politicamente, senza costituire
problema, in alcuni Paesi dell’America Latina, dove le decisioni per cultura e
tradizione non osteggiano i tempi lunghi.
Per Habermas, proprio perché la democrazia, è un sistema mutevole e insieme
vulnerabile, come sostiene anche Ginsborg, il quale in merito esprime
addirittura un pessimismo di fondo notevole fino a dire con chiarezza che essa
non c’è, non esiste, la tecnica allora – precisa il filosofo e sociologo tedesco padrona quasi assoluta ormai del nostro tempo, essendo una scelta ideologica
umana, potrebbe tradursi in una manipolazione strumentale della realtà e per
questo è indispensabile che essa sia tenuta sotto controllo. Pena una certa
limitazione per l’uomo, per la società stessa, del momento creativo ed
espressivo libero.
Un punto questo del pensiero del “nostro” su cui, comunque, non è mai
abbastanza il tempo per soffermarsi a fare una qualche riflessione. Anche
senza volere disconoscere (sarebbe assurdo e anti-storico), a priori, i benefici
apportati dalle molteplici applicazioni della tecnologia nel mondo d’oggi.
Nello scritto del prof. Fabio Lelli, sempre all’interno del nostro testo di
riferimento, si argomenta, invece, della giustizia intesa come equità, tenendo
presente il pensiero di John Rawls.
Come già nella sua epoca sosteneva il Montesquieu nel noto “Lo spirito delle
leggi”, John Rawls sottolinea che tutti i beni sociali principali devono essere
distribuiti in modo uguale, tenendo ben presente quelli che nella società sono i
soggetti più svantaggiati. Punti di partenza e opportunità, secondo Rawls,
devono essere pari se parliamo di giustizia equa.
Le disuguaglianze di reddito, che scaturiscono dalle abilità effettive del singolo
sono ammissibili. Quello che non lo è, è quando esse sono tali perché legate a
condizioni irreversibili sia sociali che naturali.
Le differenti condizioni di vita,di salute e d’istruzione, per esempio, di un
bambino che nasce, cresce e vive in Europa e di un altro che, invece, nasce e
cresce nel continente africano o nei paesi poveri del sud-est asiatico o
dell’America latina, non si equivalgono affatto.
In questo secondo caso occorre intervenire politicamente ed economicamente
per fare in modo che il “gap” gradualmente si colmi. Ma lo stesso “gap” può
riscontrarsi e si riscontra realmente, purtroppo, anche nelle nostre stesse
società del Nord del mondo (Europa-Usa..etc.).
Ecco che la proposta di Rawls è quella di creare allora, in quello che lui chiama
“lo statuto fondamentale di un’associazione umana bene - ordinata”, la
convergenza di un comune accordo sui criteri dell’ “equa distribuzione”, pur
nella consapevolezza certa che obiettivi e fini degli individui variano da società
a società. Insomma il pensiero di Rawls è che è indispensabile per un effettivo
cambiamento stabilire, in via preliminare, una “pubblica concezione di
giustizia” per un’equa distribuzione dei beni essenziali. E perché questo sia,
necessita lacerare il “velo d’ignoranza”, la cosiddetta “finzione teorica”, che è la
posizione originaria che impedisce la cooperazione tra individui.
Se sono ingiuste, leggi e istituzioni, devono essere abolite o riformate.
Referente principale di un governo “civile” è la persona con tutto il suo
bagaglio di bisogni e desideri e l’accordo sarà figlio di una scelta morale, al
tempo stesso individuale e collettiva, fatta però in autonomia, piena
razionalità, libertà e uguaglianza dalle persone.
Massimizzare i beni principali (maximum minimorum), fermo restando
l’esistenza di ineguaglianze, è quel percorso che può portare a migliorare il più
possibile le posizioni più svantaggiate del gruppo meno fortunato anche se,
magari, nel lungo periodo.
Con il prof. Marco Galletti viene affrontato il tema della giustizia intesa come
virtù in Alasdair MacIntyre, filosofo scozzese, nativo di Glasgow, appartenente
come formazione alla scuola di Oxford, docente di filosofia morale e di religioni.
Egli, innamorato di Aristotele e del pensiero di Tommaso d’Aquino, nella sua
visione teoretica, al di fuori delle mode culturali del tempo, riesce a dimostrare
che, prima ancora di Marx, con gli scritti di Hegel il giovane e quelli poi della
piena maturità, il marxismo è figlio del cristianesimo.
Perché nella religione cristiana, e in tutte le religioni, abbiamo comunque
l’espressione di determinate strutture sociali e di particolari concezioni
politiche. Esse, infatti, giustificano per autorità divina un certo ordine sociale e
insieme forniscono un modello di comportamento umano.
MacIntyre contesta le visioni di pensiero di Nozick e di Rawls in quanto le
trova, in merito ai concetti di giustizia e società, oltre che incompatibili tra loro
come realmente sono, un semplice insieme di regole buone per una concezione
liberal-individualistica nel caso del primo, diametralmente all’opposto nel caso
del secondo, il quale privilegia una democrazia che deve tenere conto
essenzialmente di quella parte della società, che si trova in condizione di forte
svantaggio, offrendole poi strumenti per uscire dall’impasse.
E così il filosofo scozzese difende e propone la tradizione della virtù, che è
risultata essere incompatibile con l’ordinamento politico moderno, il quale
sovrappone a tutto e a tutti il “mercato” e i suoi valori, come constatiamo ogni
giorno, e naturalmente con esso l’individualismo più sfacciato.
MacIntyre paragona il nostro tempo un po’ ai secoli bui dell’alto Medioevo
quando, appunto per uscire dal fondo di una terribile crisi, quella della
decadenza dell’impero romano, si ricorse a privilegiare la comunità locale e le
sue istituzioni, lavorando per esse.
Il monachesimo di San Benedetto, ad esempio, è un paradigma che fu
fondamentale per quei tempi.
Infatti il nostro “dice” con Aristotele che la giustizia è la virtù principale della
vita politica.
Una comunità, che è priva del concetto di giustizia, non è una comunità
politica. I cittadini non hanno in essa alcun diritto di cittadinanza ed è cosa
assai triste.
Il pensiero, in questo caso, corre alle numerose dittature sparse per il mondo
conosciuto.
Le sue parole sono: “Ciò che conta è la costruzione delle “forme” locali di
comunità al cui interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possono essere
conservate”.
In sostanza un localismo, forse, un tantino esasperato, considerate le
dinamiche delle società odierne sotto qualunque cielo.
“Se il PIL di un determinato Paese cresce, ma non diminuisce il numero di
persone deprivate dei diritti all’istruzione, alla salute e ad altre opportunità di
realizzazione individuale, possiamo sul serio dire che quel Paese progredisce?”
Questo è l’interrogativo giustamente provocatorio che si pone e ci pone Martha
Nussbaum, statunitense, docente eclettica di filosofia, molto nota negli
ambienti accademici di mezzo mondo, di cui tratta nel suo saggio la
professoressa Silvia Zullo, all’interno del testo, di cui sopra, “Teorie su equità e
giustizia sociale” (Franco Angeli-editore), a cura di Antonio Maturo.
Ed è un interrogativo che ci riporta dritto diritto tanto alle posizioni di pensiero
di Amartya Sen quanto soprattutto, per le proposte implicite, a John Rawls, cui
la Nussbaum si rifà ampiamente ma andando oltre.
In sostanza ciò che si chiede la Nussbaum è di quali opportunità dispongono
realmente le persone di un determinato contesto, urbano o rurale, vicino o
lontano, preso in esame. E per opportunità intende, ad esempio, la longevità,
lo stato di salute, l’accesso all’educazione, la facoltà per le donne di proteggere
la loro integrità corporea come per i lavoratori di godere di pari opportunità e
non subire discriminazioni. E con queste di poter liberamente usufruire
ovviamente di libertà politica e religiosa.
Questi fattori devono, a suo parere, essere oggetto di valutazione e
riscontrabili e presenti se si vuole poter contare su un minimo di giustizia
sociale. Quanto è scritto nelle Costituzioni dei diversi Paesi deve trovare
assolutamente giusti percorsi per dare poi, gradualmente, nel tempo,
attuazione a tali diritti.
Infatti, puntualizza la Nussbaum nei suoi molteplici scritti, oggi, sia la Banca
Mondiale che il Development Programme delle Nazioni Unite (Undp) ma anche
Paesi come la Francia e il Regno Unito e, ultimamente la stessa Germania,
hanno accettato di porre alla propria attenzione le capacità delle persone, cioè
le condizioni per poter sviluppare le potenzialità e abilità di ciascuno in una
società che consenta effettivamente di utilizzarle successivamente come
criterio di valutazione del benessere. E, negli ultimi dieci anni, si è assistito
anche alla crescita e al rafforzamento della Human Development and Capability
Assocition, di cui fanno parte almeno un migliaio di membri di 80 Paesi
differenti. Quest’ultima, per altro, è un’associazione fortemente voluta da
Amartya Sen e dalla Nussbaum stessa, di cui essi sono fondatori e presidenti
entrambi.
Soffermandosi in particolare sull’educazione, è imprescindibile, a parere della
Nussbaum, non solo sviluppare le competenze utili sotto il profilo economico
ma anche quelle abilità come il pensiero critico, che stimola l’empatia, la
comprensione dell’economia globale e della storia del mondo. E, inoltre, ampio
terreno di attenzione e di studio deve essere offerto alle cosiddette “capacità
combinate” ossia quelle che più che competenze sono opportunità, che
esistono solo quando il governo e il sistema legale di una nazione le rendono
possibili, consentendo alla persona di scegliere come agire. Tutto questo, a
cose fatte, è un’autentica conquista della filosofia e, al contempo,
l’introduzione nella storia del mondo di un nuovo paradigma riguardante il
concetto di dignità e di sviluppo umano.
Axel Honneth, studioso della terza generazione della Scuola di Francoforte,
dopo Adorno e Habermas, di cui argomenta la professoressa Susanna
Vezzadini, nel suo scritto, osserva, in merito allo studio delle società che le
note metodologie della ricerca sociale d’ispirazione marxista e marxiana (il
“nostro” predilige gli scritti del giovane Marx) propongono, l’esistenza di un
“vulnus” originario in quanto esse metodologie includono un riconoscimento,
che si erge a rango di una autentica costante antropologica per tutti i gruppi
umani e, parimenti, per i singoli individui nella loro propria singolarità.
In questo modo il principio del “riconoscimento” (leggi giustizia) si innalza a
veste universale.
E se questo meccanismo può effettivamente valere per quei gruppi umani, che
sono dominanti (leggi classi) non è la stessa cosa per realtà minoritarie o
emarginate.
Infatti questi gruppi ultimi non posseggono affatto un orizzonte normativo
uguale ai primi e si limitano ad ereditarlo dai primi solo in maniera passiva.
Sono i gruppi dominanti i legittimi produttori e detentori.
Nel caso delle realtà minoritarie, invece, esso va cercato con acume. E con
strumenti differenti.
Il punto di coagulo del discorso di Honneth è da ricercare, allora, nelle sue
riflessioni sul concetto di lavoro.
E concetti come quello di “contratto sociale implicito” diventano, in lui e per
lui, il percorso auspicato che conduce alla formulazione della dialettica del
“riconoscimento” nella veste di costante antropologica.
Il prof. Andrea Antonilli affronta dettagliatamente il “multiculturalismo tra
identità e riconoscimento”, tema per altro attualissimo ai nostri giorni, del
filosofo canadese Charles Taylor, esperto di filosofia politica e di filosofia delle
scienze sociali oltre che di storia della filosofia. Taylor si è formato all’università
di Oxford negli anni ’50 e ha provato attraverso i suoi scritti, riuscendoci in
parte, ad attrarre l’attenzione del mondo accademico sull’imprescindibilità di
fondere la filosofia analitica di scuola anglosassone con quella di connotazione
prettamente storica del continente. E molto del suo pensiero a noi pervenuto,
nel corso degli anni, è stato influenzato sui temi etici e morali da quello del
filosofo e pensatore francese Merleau Ponty.
Nel 1991, ormai docente notissimo in tutti gi ambienti accademici e grande
divulgatore di scienze sociali, con il suo libro “Il disagio della modernità” ha
attaccato la tradizionale tematizzazione dell’identità individuale, propria del
liberalismo, che considera fortemente astratta.
Calandosi nel reale, in quella che è la società autentica, fatta di persone,
uomini e donne in carne e ossa, con bisogni e desideri, egli parla di quelli che
definisce “orizzonti di significato”, termine mutuato a sua volta da Gadamer,
che altro non sono che il contesto delle relazioni sociali e di dialogo con gli altri,
un contesto comunitario al cui interno sono importantissime le scelte etiche
tanto del singolo che della collettività.
Successivamente ricostruisce il percorso del riconoscimento dell’origine della
modernità, collegandolo all’eguale dignità degli esseri umani e alla specifica
identità dei singoli e dei gruppi (politica del riconoscimento e multiculturalismo,
appunto).
L’aspetto problematico del multiculturalismo resta però la difficoltà di tenere
insieme il riconoscimento di eguale dignità e rispetto dovuto a ciascun essere
umano con quello della identità particolare di ogni singolo gruppo nella propria
diversità.
Il primo tipo di riconoscimento, dice Taylor, sotteso storicamente al
conferimento dei diritti soggettivi, si è storicamente realizzato nello Stato
liberale, da lui criticato, con la neutralità pubblica alle differenze.
Il secondo, invece, sembra richiedere una revisione dei diritti soggettivi e del
principio di neutralità per fare spazio alle differenze di gruppo sentite come
essenziali per l’identità e l’integrità dei suoi membri.
La tensione tra liberalismo e multiculturalismo nasce, secondo Taylor, da
un’interpretazione ristretta del liberalismo dei diritti, che non può conciliarsi
con la tutela delle differenze e dei fini collettivi nel momento in cui il primo
privilegia, ad ampio spettro, l’individualismo di determinati ceti sociali e li
difende.
Se si adotta una versione più ampia di liberalismo, dove alla difesa di alcuni
diritti viene associata la possibilità di trattamenti differenziati per gruppi diversi
e in posizione subordinata, c’è la possibilità, egli dice, di accordare particolari
immunità a minoranze culturali a difesa della loro differenza e integrità.
Resta, tuttavia, per Taylor la difficoltà di riconoscere a tutte le culture eguale
valore indipendentemente da considerazioni di merito.
Ma in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, alla prova dei fatti, quando si sono
creati autentici laboratori sociali, che hanno fortemente privilegiato il
multiculturalismo, i risultati sono stati spesso quasi sempre deludenti.
Il che dimostra, innanzitutto, la difficoltà di passare dal teorico al pratico
oppure, quanto meno, di continuare ad approfondire questa pista di ricerca,
tenendo presente che immigrazione e meticciato sono, oggi giorno, quasi
ovunque nel mondo, realtà che pongono domande e chiedono urgenti risposte
serie.
Il prof. Giancarlo Corsi, nel suo scritto, tratta invece di giustizia ed equità nella
“teoria dei sistemi”.
Ma cosa s’intende in sociologia per “teoria dei sistemi”?
Nata, ad opera dell’epistemologo Ludwig von Bertalanffy (Palo Alto-1954) e
arricchitasi del contributo di molteplici discipline nel corso degli anni successivi
(cibernetica, tecnica dei sistemi meccanici..etc.), e dando vita ex-novo al
neofunzionalismo di Luhmann, poi alla teoria dell’organizzazione di Crozier e
Friedberg, nonché a quelle dello scambio di Homans, Blau ed Emerson,
prende in esame una qualsiasi realtà complessa, come appunto quella di un
sistema, analizzando gli elementi che all’interno di esso interagiscono
reciprocamente secondo un modello dato di circolarità.
E, per farlo, è indispensabile ricorrere al modello matematico di funzione
(interdipendenza tra variabili differenti).
L’esame di un sistema, a differenza di quello che potrebbe essere, in una
precedente visione ingenua, un sistema già dato, come semmai è nell’ottica
funzionalista, parte piuttosto da un processo di selezione, che è l’osservatore
stesso a compiere (observer dependance). E che viene fatto in base agli
interessi scientifici dell’osservatore stesso.
Ciò vuol dire che il sistema non è mai qualcosa di statico quanto piuttosto di
dinamico e può presentare indifferentemente caratteristiche di evoluzione o di
involuzione. Specie poi se il sistema è “aperto” e quindi quando le relazioni di
esso, che si vengono ogni volta a creare, interagiscono con l’ambiente
circostante.
Le differenti variazioni dinamiche, tanto in positivo che in negativo, portano il
tutto sempre ad una situazione di nuovo equilibrio.
Per Niklas Luhmann tanto il sistema che il mondo sono parte di una
complessità indeterminabile, che include e sottintende illimitate possibilità.
L’ambiente è, infatti, l’insieme delle possibilità determinabili presenti in una
situazione concreta, il sistema, invece, è il prodotto che deriva dalla selezione
reale di alcune possibilità a giudizio dell’osservatore, alcune accettate, altre
negate.
Il sistema sociale, pertanto, serve a mediare nella complessità del rapporto
uomo-mondo. E, in questo modo, semplifica la complessità, stabilendo una
differenza tra un dentro e fuori del sistema, dandogli così un ambito di senso.
I sistemi sociali, di cui comunemente parliamo, altro non sono per Luhmann
che delle isole a complessità ridotta. Ma Alessandro Pizzorno, più avanti nel
tempo (anni ’70), parla piuttosto in proposito di incompletezza dei sistemi.
La loro complessità si differenzia in basa allo sviluppo, alla capacità di
selezione, e di organizzazione strutturale dei sistemi stessi.
Questo è il pensiero di Luhmann.
E poiché i sistemi sociali si costituiscono in base a un senso condiviso, l’analisi
dei processi comunicativi risulta essere imprescindibile all’interno della stessa
ricerca sociale.
Il senso è un’indicazione selettiva di orientamento che rende accessibile agli
attori (sistema-ambiente) la doppia contingenza e cioè di comunicare tra loro.
Ma perché ciò sia possibile nel concreto necessita che le indicazioni selettive,
poste a disposizione dello stesso senso, assumano una forma simbolicamente
codificata.
Sono cioé i codici simbolici, quelli che Parson chiama “simbolic media of
interchange”, che rendono possibile il coordinamento delle attese nelle forme
specializzate, richieste da ogni sistema differenziato: l’economia, il diritto, la
politica, la scienza, la vita privata, e altro.
Il prof. Antonio Maturo, a proposito di giustizia sociale tra svantaggio
sistematico e violenza strutturale, prende in esame le rispettive visioni di
pensiero di Madison Powers, di Ruth Faden e di Paul Farmer.
I primi due, Powers e Faden, sono mossi da un’angolazione riformista, sulla
scia di Sen e della Nussbaum e in parte, ma solo in parte, di John Rawls,
rispetto alla precedente “letteratura” del settore; Paul Farmer , invece medicoantropologo, un autentico radical, è colui che parte nell’argomentare da quelle
che sono assolutamente delle testimonianze concrete di violenza strutturale, di
cui ha conoscenza diretta e non certo manualistica.
Compito di chi studia il fenomeno è per lui, quindi, essenzialmente denunciare
il carattere contingente di quei meccanismi, fondati su di un particolare
sistema economico, meccanismi spesso dati per imprescindibili. Mentre così
non è affatto.
Powers e Faden – scrive Maturo – mettono al centro della loro riflessione il
concetto di benessere e ne individuano le dimensioni costitutive.
Giustizia sociale, a loro avviso, è il raggiungimento di un livello minimo in ogni
dimensione del benessere, che essi propongono e che ravvisano in numero di
sei.
Si tratta di salute, sicurezza personale, capacità cognitive e ragionamento
pratico (reasoning), rispetto, affettività e autodeterminazione.
Perciò se manca o è deficitaria nell’esistenza di una persona una di queste
dimensioni non si arriverà mai a quel benessere minimo auspicato.
Se la giustizia sociale poi privilegia solo le urgenze morali e prescinde dai
progetti e dagli scopi della persona, sbaglia ed è fuori pista.
Per la ”salute”, molto centrale nel loro pensiero, i due studiosi parlano
d’integrità del funzionamento biologico e di mancanza di dolore. E si mostrano
critici nei confronti della definizione che di salute propone l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), che parlando di benessere fisico, psichico e
sociale generalizza e ascrive qualsiasi deficit di benessere semplicemente ad
un deficit di salute. Mentre le rimanenti dimensioni del loro schema, secondo
Powers e Faden, sono altrettanto fondamentali, perché s’interconnettono tutte
nel raggiungimento dell’obiettivo. E cioè quello appunto del benessere minimo
della persona e di giustizia sociale tradotta in concreto.
Essi, comunque, non ritengono che il benessere tra le persone debba essere
distribuito in maniera uguale ma ritengono assolutamente necessario il
raggiungimento della soglia minima.
Questo, però, significa per loro che per tutti ci devono essere uguali possibilità
alla partenza. Pertanto per il pensiero di Powers e Faden si può tranquillamente
parlare di egualitarismo.
Se così non fosse, come poi è nella realtà effettuale e non nel bel libro dei
sogni, povertà è sinonimo di vulnerabilità, il che significa che, ciò che per chi
povero non è, è problematico, per il povero diviene inderogabilmente tragico.
E, ancora, gli effetti della povertà tendono ad amplificare i differenti problemi
presenti e si diffondo anche in ambiti non strettamente economici.
Si ritorna, pertanto, ai sei punti della tabella iniziale proposta.
Paul Farmer, preso in prestito da Galtung il concetto di violenza strutturale,
mostra attraverso esempi concreti che, a partire dalla matrice sociale in cui
l’individuo è inserito, il suo destino è già bello che confezionato.
Assolutamente da leggere di lui “Pathologies of power”, in cui racconta tante e
diversissime storie a testimonianza della sua tesi di ricercatore sul campo.
Come, ad esempio, la bellissima quanto tragica storia dell’haitiana Acéphie,
giovane in seguito ad aver contratto l’aids, per dimostrarci che la violenza
strutturale, che nasce da forze e processi storicamente dati e, spesso,
economicamente pilotati, limita le capacità d’azione della persona.
Pertanto per Farmer il compito delle scienze sociali è quello di disvelare,
togliere appunto il famoso velo, da quei meccanismi del potere che generano e
alimentano violenza strutturale (e i casi sono tantissimi anche a casa nostra). E
soprattutto non scambiare ciò che è assolutamente contingente con ciò che si
vorrebbe far passare per ontologico.
Più che assolutizzare il “come” tra violenza strutturale e giustizia sociale è
imprescindibile indagare semmai sul perché.
In conclusione Paul Farmer fornisce, mediante i suoi casi-studio, le spiegazione
del “come” e del “perché” è possibile agire sulle dimensioni del benessere,
individuate da Powers e Faden.
Arbitrio e violenza/ Sul banco degli imputati economia-politica
credenze ancestrali secondo Paul Farmer, medico e antropologo.
e anche le
La famiglia di Acephie, una giovanissima e piacente haitiana, che appartiene al
famoso popolo delle “acque”, quello che è soltanto un misero insediamento di
profughi, in una zona impervia dell’isola, è molto povera e vive (siamo negli
anni ’80 in un’Haiti oltre che povera anche e soprattutto violenta) un contesto
di degrado ambientale e sociale.
Tutto questo perché il villaggio in cui la famiglia stava prima, a causa della
costruzione di una diga, un progetto degli Usa fatto solo a tavolino, senza
tenere conto della gente, era stato allagato e la popolazione, affamata,
costretta ad andare ad abitare (si fa per dire) altrove.
Un giorno, che la ragazza accompagna a piedi la madre al mercato s’imbatte,
come accade spesso in quei luoghi, in una pattuglia di soldati del posto che,
approfittando della loro posizione (i militari hanno una paga) e della superiorità
numerica, la canzonano.
E tra questi c’è il capitano Jacques Honorat, che s’innamora della bella fanciulla
e le chiede all’istante,dopo avere fatto sesso con lei, pur già sposato, di andare
a vivere con lui.
Acephie accetta subito e anche la famiglia sua, e la gente del villaggio in cui
vive, trova la storia più che normale.
Quando si è poveri non sempre si fanno i grandi distinguo e non si ragiona del
sesso degli angeli.
Il capitano, però, è più anziano, e di parecchio, rispetto ad Acephie.
Un bel giorno si ammala e, pertanto, decide di fare ritorno dalla sua legittima
moglie.
Acephie, abbandonata, per cercare di sopravvivere e vincere i morsi della fame
e quanto ad essi ne consegue in termini di disagio, si mette alla ricerca di un
lavoro di domestica nella capitale dell’isola e, in effetti, lo trova a Port au
Prince presso una famiglia facoltosa della città
Ma a Port au Prince Acephie non impiega molto a conoscere un giovane, che
proviene anch’egli da Kay, il suo stesso villaggio, quello appunto del “popolo
delle acque”.
Blanco è il nome del giovane, che fa progetti matrimoniali con Acephie e le
chiede a breve di sposarlo.
Quando, però, Acephie gli comunica di essere rimasta incinta e di aspettare un
bambino, Blanco si tira indietro, anzi scompare.
E la padrona di Acephie pensa bene, anch’ella, di licenziarla in quanto è
sconveniente avere in casa, per gli ospiti, la vista di una cameriera col
pancione.
E così Acephie è di nuovo sulla strada.
Attende un figlio e in contemporanea scopre di essere ammalata di Aids.
La poveretta o sciagurata (fate voi!) ritorna al villaggio da dove era partita e,
dopo aver dato alla luce una bambina, trascina la propria esistenza in maniera
penosa.
La gente del villaggio dice di lei che è vittima della stregoneria.
Ed è un classico per quei contesti.
Qualche tempo dopo, divenuta ormai una larva umana, Acephie muore.
Il padre di Acephie non regge al dolore e si toglie inaspettatamente la vita.
Quanto all’Aids Acephie però non è l’unica vittima.
C’è senz’altro per primo il capitano Honorat, il suo untore; la moglie di lui e
due suoi figli; c’è forse Blanco.
E certamente tanti altri tra soldati, giovani donne e adolescenti maschi e
femmine indifferentemente.
Ora la domanda è: se Acephie avesse avuto risorse economiche, se i “profughi
delle acque” avessero avuto più soldi, se Acephie avesse avuto più istruzione
(all’epoca frequentava a mala pena le elementari ancora), se ci fosse stata in
tutti una dose maggiore di autostima e di capacità pratiche e sopratutto di
autodeterminazione, sarebbe accaduto tutto quanto è poi accaduto nei fatti?
Risposta non c’è. O almeno no, semplicisticamente parlando.
Quello accaduto ad Haiti può verificarsi e di fatto si
verifica
anche
ad
Harlem,
nella
promiscuità
incontrollata delle megalopoli africane, asiatiche o
latino -americane o nelle periferie degradate delle
nostre città europee.
E le dinamiche riscontrate, con pochissime varianti,
sono quasi sempre più o meno le stesse della storia di
Acephie.
Garantire certi diritti umani significa allora, specie sul
piano della ricerca sociale, abbattere l’idea che, ciò
che è dato, è naturale.
E non è né semplice, né facile.
Marianna Micheluzzi