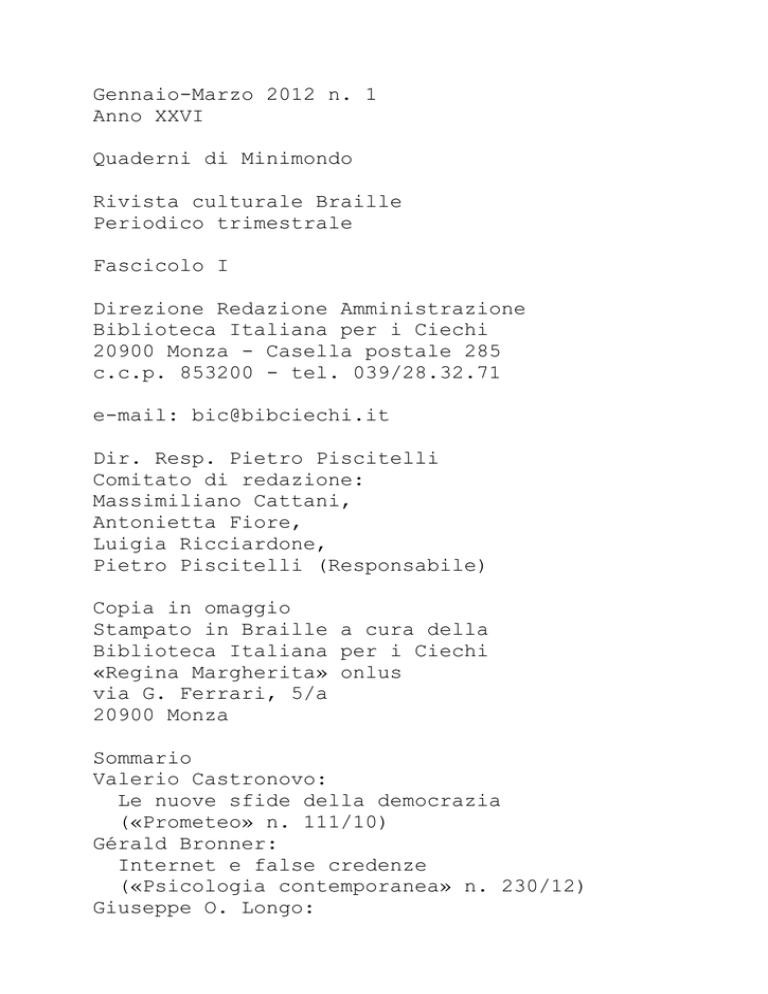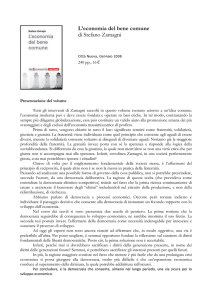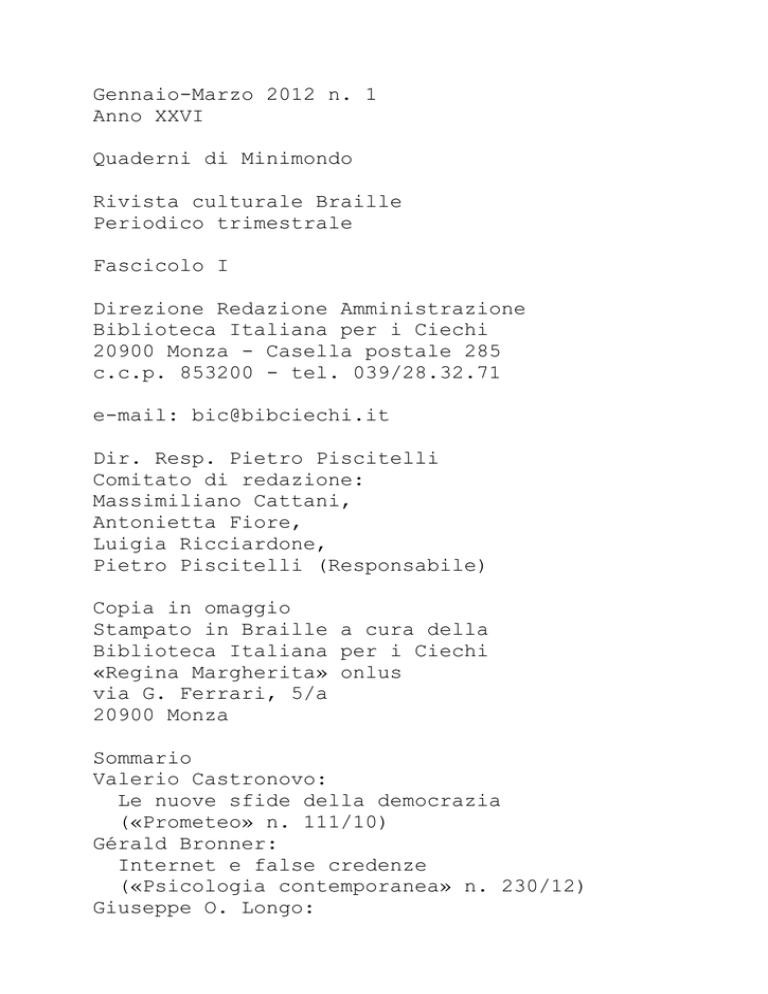
Gennaio-Marzo 2012 n. 1
Anno XXVI
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo I
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20900 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Luigia Ricciardone,
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
«Regina Margherita» onlus
via G. Ferrari, 5/a
20900 Monza
Sommario
Valerio Castronovo:
Le nuove sfide della democrazia
(«Prometeo» n. 111/10)
Gérald Bronner:
Internet e false credenze
(«Psicologia contemporanea» n. 230/12)
Giuseppe O. Longo:
Sarà l'uomo a provocare la sesta estinzione
di massa
(«Vita e Pensiero» n. 2/11)
Darin L. Wolfe:
Il corpo sotto gli occhi
(«Le Scienze» n. 516/11)
Silvano Petrosino:
Da Lady Gaga a Steve Jobs. Idoli, idoletti e
oggetti affini
(«Vita e Pensiero» n. 6/11)
Marina D'Amato:
Telefantasie
(«Psicologia contemporanea» n. 225/11)
Alessandro Cerri:
I tristi diavoli del blues
(«Prometeo» n. 116/11)
Giuseppe Ivan Lantos:
A spasso con il commissario Maigret
(«Meridiani» n. 204/12)
Le nuove sfide della democrazia
- I problemi cruciali che l'Occidente si
trova oggi ad affrontare. Nel corso del primo decennio del nuovo
millennio ci si è resi conto di quanto fossero
infondate certe previsioni diffusesi,
all'indomani dell'Ottantanove, che davano per
scontato il tramonto, dopo quello avvenuto
nell'Est comunista, di altre dittature di
colore analogo o di matrici diverse. Così non
è stato. Anche se in alcuni punti le frontiere
della democrazia si sono ampliate, è rimasta
pur sempre consistente l'area dei regimi
totalitari, autoritari o militari, nonostante
alcuni di essi abbiano formalmente le parvenze
di governi democratici per quanto c'è scritto
nelle loro pandette costituzionali o per la
periodica chiamata alle urne dei loro
cittadini.
D'altra parte, se in alcuni casi come in
Iran (che è il più eclatante) la dittatura
degli ayatollah ha mostrato ancor più il suo
volto feroce e repressivo, non è che nel resto
dei paesi sotto il tallone di regimi
autocratici il pugno di ferro degli uomini,
delle caste o dei partiti unici al potere sia,
a seconda delle evenienze, meno pesante e
risoluto qualora ci si trovi alle prese con
qualche forma di opposizione che possa dar
ombra.
Sta di fatto che, al di là dell'area in cui
la democrazia aveva forti radici da molto
tempo o si è sviluppata nel corso del secondo
dopoguerra (che corrisponde sostanzialmente a
quella del mondo occidentale euroatlantico con
alcune propaggini in Asia, nell'America
centro-meridionale e in Australia), è ancora
vasto l'arcipelago dei paesi dove seguitano a
dominare tirannidi personali, monarchie
assolute, dittature o governi cosiddetti
«forti», di differente stampo politico e
ideologico. In pratica, a fare la conta dei
paesi soggetti in un modo o nell'altro a
regimi dove non esistono o vengono
sistematicamente conculcate libertà politiche
e individuali, diritti civili e garanzie
costituzionali, o ridotte al silenzio e
all'irrilevanza le minoranze, è dato
constatare come essi ammontino a quasi un
centinaio, sparsi dovunque, dall'Europa
all'Oceania. Oltretutto, si tratta di paesi
che per lo più spendono in media, rispetto
alla loro popolazione, più soldi in armamenti.
Se l'Africa sub-sahariana è quella che
annovera più dittature o regimi a un passo dal
divenirlo (per via di limitazioni al
multipartitismo, controlli del governo sul
sistema giudiziario, vincoli e discriminazioni
civili di vario genere a scapito dei diritti
umani), il Sud-est asiatico e l'area del
Pacifico non sono pressoché da meno, e così
pure quelle del Medio Oriente e del Nord
Africa. Ma pure in Europa e nelle contrade
contigue dell'Asia settentrionale sono almeno
una decina i paesi, appartenenti in passato
all'impero sovietico, dove esistono regimi
semidittatoriali o il cui assetto potrebbe
assumere connotazioni del genere. E se le
Americhe a sud del Messico sono le aree del
pianeta dove negli ultimi anni sono scomparsi
di più regimi autoritari o di marca militare,
Cuba seguita ad essere, a oltre mezzo secolo
di distanza dalla rivoluzione castrista (che
spodestò la dittatura di Fulgencio Batista),
un paese in cui Stato e partito coincidono, la
dissidenza è duramente contrastata, e il
passaggio di consegne nel 2008 dal «lìder
màximo» Fidel Castro al fratello Raúl non si è
tradotto per il momento in alcun concreto
mutamento di scenario. Nel frattempo s'è
inasprito il regime personale nazionalpopulista di Chàvez in Venezuela; e, se si è
assistito nel 2009 a un colpo di stato di
destra in Honduras, si è registrato un ritorno
di fiamma in Nicaragua del movimento
sandinista-marxista di Daniel Ortega e il
consolidamento al potere in Bolivia del
cosiddetto «Lenin indio», Evo Morales.
Che i paesi caduti sotto il tallone di
dittature o soggetti a regimi autoritari
possano affrancarsi da questo stato di cose,
appare oggi un'impresa più difficile di quanto
non si pensasse sino a qualche tempo addietro.
L'assunto sostenuto dai neoconservatori
americani, per cui la democrazia avrebbe
potuto o dovuto essere esportata anche con
l'uso della forza, è risultato un paradigma
dottrinario altrettanto incongruo che
disastroso alla luce di quanto è accaduto con
l'avventura anglo-americana in Iraq. Ma non ha
mostrato di reggere alla prova dei fatti
neppure la tesi secondo cui lo sviluppo
economico avrebbe contribuito, come una sorta
di campo magnetico, a una progressiva
transizione verso la democrazia. Se così
fosse, la Cina, che ha conosciuto negli ultimi
anni una crescita poderosa, non sarebbe
rimasta un «pianeta rosso». D'altro canto,
essa non è l'unico paese al mondo in cui il
passaggio dall'arretratezza economica
all'industrializzazione e alla diffusione dei
consumi, non ha dato luogo a sostanziali
cambiamenti nell'assetto politico in senso
democratico.
Non per questo, beninteso, si deve
considerare come permanente e inalterabile la
situazione dei paesi soggetti a un regime
autoritario. Si tratta di tener conto, assai
più di quanto in genere non si pensi,
dell'importanza che possono avere altri
elementi di carattere propulsivo, come quelli
di ordine culturale. Che, del resto, hanno
esercitato un ruolo preminente nell'evoluzione
politica e sociale dell'Occidente, come
attestano le sue vicende storiche. Grazie allo
sviluppo delle conoscenze e alla diffusione
del sapere, i paesi europei e l'America non
solo hanno conseguito il successo economico,
ma posto anche le fondamenta di ordinamenti
costituzionali segnati dall'affermazione delle
libertà e dei diritti politici e dal
consolidamento in progresso di tempo di
sistemi liberal-democratici con robuste
tendenze riformiste sul versante economico e
sociale.
Ma se per l'avvento di ordinamenti
democratici là dove oggi non esistono ancora o
appaiono troppo fragili e instabili per
consolidarsi, è essenziale che maturino
dall'interno nuovi fattori e stimoli di
carattere culturale, non per questo le
democrazie dell'Occidente sono esentate da
qualsiasi genere d'iniziativa. Esse devono
seguitare a denunciare recisamente qualsiasi
violazione dei diritti umani; impegnarsi per
la riduzione degli armamenti dandone per prime
l'esempio, assecondare la massima circolazione
di opinioni e informazioni, sollecitando
perciò il libero accesso ai mass media, e
solidarizzare con i movimenti d'opposizione ai
governi autoritari. D'altra parte, a giudicare
dalle vaste manifestazioni di piazza avvenute
in Iran contro il regime, non è detto che le
generazioni più giovani siano disposte, nei
paesi soggetti a regimi autocratici, ad
accettarli supinamente o a subirli sia pur
«obtorto collo».
Quanto è avvenuto dagli anni Novanta del
secolo scorso in poi ha segnato il tramonto di
quello che era stato definito, con riferimento
alle traiettorie dell'Occidente nel secondo
dopoguerra, come un «secolo
socialdemocratico». Non già perché avessero
assunto in questo periodo un ruolo da
protagonisti i partiti di marca socialista (la
cui presenza, del resto, non si estendeva agli
Stati Uniti e a vari altri paesi
extraeuropei). Ma perché il tratto distintivo
del processo di sviluppo manifestatosi in
Occidente consisteva, soprattutto, in una
serie di riforme che avevano aggiunto ai
diritti e alle libertà politiche tradizionali
i principi dell'uguaglianza sociale e
dell'equità distributiva. Tanto da dar luogo a
una sorta di «rivoluzione silenziosa»,
contrassegnata dagli sviluppi in senso
progressista della democrazia liberale,
dall'estensione dell'interventismo pubblico e
dalla diffusione del benessere economico, da
un miglioramento generalizzato del tenore di
vita delle masse popolari.
Ci si chiede oggi che il capitalismo
globale, la rivoluzione informatica e il
ridimensionamento dei poteri degli Stati
nazionali hanno modificato lo scenario in
termini sempre più tangibili, se possa
ricrearsi nell'ambito delle società
democratiche dell'Occidente quella sorta di
«circolo virtuoso» che in passato era
scaturito dall'intreccio fra democrazia
politica e ampliamento dei diritti civili, fra
crescita delle risorse e un più alto grado di
equità e coesione sociale.
Negli ultimi tempi si è assistito infatti a
una sempre più intensa finanziarizzazione
dell'economia, a una maggiore flessibilità del
mercato del lavoro, e quindi al declino di un
regime di piena occupazione e di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, nonché a un
restringimento delle prerogative e della sfera
d'intervento dei singoli Stati nazionali. Di
conseguenza, mentre l'industria non ha più
quel ruolo di assoluta centralità nel sistema
economico che rivestiva in passato, e così
pure la classe operaia, s'è indebolito il
potere contrattuale delle organizzazioni
sindacali; si sono dilatate le dimensioni e le
propaggini del settore terziario, è aumentata
sempre più la schiera dei lavoratori autonomi,
e sono comparse nuove sacche di povertà o di
precarietà e di emarginazione.
In questo nuovo contesto è evidente come sia
venuto riaffacciandosi il problema, tanto
dibattuto da sempre, se sia possibile
un'effettiva coesistenza fra capitalismo e
democrazia, fra le varianti e le dinamiche
dell'uno e le stimmate intrinseche e le
proiezioni dell'altra.
Sappiamo che il tasso d'innovazione è la
ragion d'essere e la forza propulsiva del
capitalismo, ma anche che la disoccupazione è
il maggior pericolo per la stabilità del
sistema. E sappiamo che la democrazia non può
considerarsi tale da corrispondere ai suoi
principi effettivi senza un'economia di
mercato competitiva ma orientata al
conseguimento di un maggior grado di benessere
collettivo, e perciò a un'equa ripartizione
della ricchezza prodotta e a fini di utilità
collettiva.
Negli ultimi tempi la crisi economica
provocata da un'overdose di finanza senza
adeguate regole ha riportato in auge
l'interventismo pubblico per salvare il
salvabile, per sottrarre una parte consistente
del sistema bancario dal pericolo di un
disastro, per cercare di sanare altri
sconquassi e riavviare il motore
dell'economia. Ma questi e altri provvedimenti
avrebbero effetti contingenti qualora non
venissero introdotte nell'ambito del mondo
finanziario severe regole etiche e norme
concrete in modo da ricondurlo a funzioni
complementari allo sviluppo degli investimenti
produttivi e, quindi, da impedire che certi
potentati si avventurino nuovamente in
operazioni puramente speculative e predatorie,
sganciate dall'economia reale. Inoltre, a poco
servirebbe l'esistenza di tante organizzazioni
internazionali attive da tempo se esse non
giungessero a coordinare le loro politiche per
garantire uno sviluppo omogeneo ed
equilibrato, senza cortocircuiti, senza derive
finanziarie e rigurgiti protezionistici, e
s'impegnassero anche in modo da assicurare il
progresso civile e la salvaguardia
dell'ambiente.
Non si tratta, con questo, di reinventare il
capitalismo, come da varie parti si tende a
dire, bensì di riportarlo su linee direttrici
che siano coerenti con un processo di sviluppo
sostenibile, in grado di accrescere
opportunità di lavoro, livelli d'istruzione e
qualità della vita. D'altronde, la proprietà
privata e l'economia di mercato sono
altrettanti requisiti e ingredienti della
democrazia. Il problema sta, quindi, in
politiche riformiste che valgano a ridurre le
diseguaglianze sociali e ad assicurare a tutti
i cittadini uguali capacità di influenza nella
gestione della cosa pubblica.
Se la crisi economica ha rivelato in pieno a
qual punto fosse giunta la forza e l'influenza
di alcuni dei principali gruppi e lobby della
finanza, nella distorsione non solo del
mercato ma anche nel condizionamento di vari
settori dell'amministrazione pubblica, non è
che unicamente loro siano arrivati ad avere un
ruolo così incisivo e rimarchevole.
Altre oligarchie, a livello nazionale e
internazionale, dalle grandi corporation, ai
titolari delle principali catene di massmedia, ai più autorevoli consessi del mondo
professionale continuano, sia pur in diversa
misura, a incidere nell'ambito delle
democrazie, sugli equilibri politici e
sociali. Perciò, non da oggi, si sono
moltiplicate le voci di quanti ritengono che
in Occidente la democrazia sia andata
corrodendosi o che comunque sia malata. Anche
perché si è indebolita o non conta più come
una volta quella sorta di intercapedine fra le
istituzioni politiche e la società civile
rappresentata dai grandi partiti di massa, con
la loro capacità di mobilitazione popolare, di
attivazione del dibattito e del confronto
delle idee, di sostegno alle cause di
interesse collettivo, con la loro dialettica e
alternanza nell'esercizio delle responsabilità
di governo.
Ma se tutto questo è avvenuto, è perché vi
hanno contribuito soprattutto due fenomeni
pressoché concomitanti: da un lato, le «onde
lunghe» prodotte dal crollo del comunismo, dei
regimi del «socialismo reale», per cui i paesi
occidentali non si trovano più sulla
difensiva, e, dall'altro, il progressivo
sfrangiamento del ceto medio, di quello che
era divenuto man mano il fulcro delle società
industriali avanzate.
L'esistenza di formazioni politiche
organizzate sulla base sia di determinate
concezioni ideologiche e culturali sia di
strutture capillari e articolate a livello
territoriale, erano in Europa il portato e
l'espressione di una stagione, come quella
prolungatasi dal secondo dopoguerra sino
all'Ottantanove, segnata da forti linee di
contrapposizione o di demarcazione fra due
differenti schieramenti. Pertanto, quando esse
sono venute meno, quel che era rimasto in vita
dei precedenti partiti di massa e dei loro
apparati s'è ridotto di peso e di statura, si
è frantumato in vari spezzoni più minuscoli o
si è trasformato in nuove entità e compagini
politiche. Non è con questo, ovviamente, che
siano scomparse la destra e la sinistra, ma
esse hanno assunto nuove insegne e comunque
delle connotazioni tali da non riprodurre le
stesse sembianze e le medesime istanze e
affiliazioni d'un tempo.
D'altra parte, s'è sdrucito negli ultimi
anni quella sorta di tessuto connettivo della
democrazia liberale composto dal ceto medio,
che aveva finito col divenire in progresso di
tempo il principale serbatoio elettorale dei
partiti di centro e di centro-sinistra, in
Germania e in Francia come in Gran Bretagna e
in Spagna. Ancora all'inizio del nuovo secolo
si parlava del ceto medio come di una classe
sociale destinata tanto a ispessirsi che ad
allargarsi al punto da costituire una «società
dei due terzi» con all'infuori un'élite a
reddito particolarmente elevato e una frangia
di gente alle soglie della povertà. Da allora,
invece, il ceto medio s'è andato
disarticolando e frammentando, in quanto è
cresciuta al suo interno la forbice fra alcuni
strati più abbienti o titolari di determinate
occupazioni più stabili, e gran parte delle
altre sue componenti, in quanto in condizioni
più disagiate o addette ad attività non
garantite.
Ma questo fenomeno e la crescente influenza
dei gruppi più eminenti dell'establishment non
comportano inevitabilmente il declino della
democrazia liberale o una sorta di «postdemocrazia», come è stata definita da alcuni
analisti. Le società occidentali hanno pur
sempre in sé gli anticorpi per contrastare il
pericolo di derive e regressioni oligarchiche,
di un sopravvento di consorterie corporative e
di ristretti clan e gruppi di interesse.
Purché la classe politica non si limiti a
declinare i principi e i valori del sistema
democratico secondo vecchi rituali e schemi
autoreferenziali.
C'è chi sostiene che si sarebbe ormai chiuso
un ciclo, che in Occidente la democrazia si
sia atrofizzata. La tradizionale divisione dei
poteri non sarebbe più in grado di regolare il
funzionamento delle istituzioni, le
rappresentanze parlamentari non avrebbero più
effettivi poteri di scelta e decisione, la
latitanza dalle urne e il disincanto di una
parte dell'elettorato sarebbero destinate a
crescere, la videodipendenza avrebbe preso il
posto della partecipazione alla vita pubblica
nella massa dei cittadini. Non da ultimo, si
chiama in causa, a riprova dell'esistenza di
un ulteriore fattore deformante e corrosivo
della democrazia, il populismo, quale forma di
legittimazione popolare passiva e strumento di
manipolazione del consenso dall'alto.
Ma se le cose stessero effettivamente a
questo modo, non rimarrebbe altro che
rassegnarsi a un desolante quanto sterile
pessimismo.
Non è, con questo, che si debbano chiudere
gli occhi sui rischi che corre altrimenti la
democrazia nei paesi che se ne fregiano, quale
loro conquista storica, e se ne proclamano
alfieri per eccellenza. Tuttavia non si può
pensare che ormai ci sia ben poco da fare,
come se una parabola declinante della
democrazia fosse qualcosa di ineludibile.
Governi e parlamenti, forze politiche e
sociali hanno pur sempre la possibilità di
stabilire determinate regole e gli strumenti
per far valere le proprie decisioni. Certo,
quelle che la democrazia occidentale deve
affrontare sono sfide ardue e complesse. Si
tratta infatti di bloccare l'invadenza di
lobby smodate e prevaricatrici, e ridare
vigore e fiducia al ceto medio, essenziale per
la stabilità delle istituzioni pubbliche,
definire nuove scale di priorità e promuovere
culture della ricerca e dell'innovazione per
competere nel mercato globale, modificare i
congegni del Welfare per serbarlo in vita e
renderlo più efficiente (e quindi alzare l'età
pensionabile e non solo tutelare chi ha perso
il lavoro ma anche aiutare chi non riesce a
trovarlo), rilanciare una partecipazione
attiva dei cittadini alla vita pubblica
attraverso nuove forme di aggregazione e
mobilitazione.
Tra i pericoli che incombono sulle
democrazie si è indicato, in particolare, dal
campo della sinistra, quello di una deriva
populista, consistente nella propagazione di
virus xenofobi e localistici. Va detto
tuttavia che il populismo di per sé non ha una
precisa colorazione politica né un corollario
unilateralista. In diverse circostanze il
populismo è stato declinato dai progressisti
in funzione di un coinvolgimento dei ceti
sociali più deboli e in nome del loro diritto
di cittadinanza; e oggi è stato uno degli
ingredienti del successo di Barack Obama negli
Stati Uniti. A ogni modo, se in vari paesi
europei il populismo sta assumendo colorazioni
politiche di estrema destra e scioviniste, lo
si deve soprattutto al fatto che le élite
politiche non hanno saputo prendere le misure
adeguate per gestire i mutamenti radicali di
scenario e di prospettiva avvenuti negli
ultimi anni finendo così per scaricare sulla
gente comune i problemi causati dalla
globalizzazione economica, dalla perdita
d'identità nazionale e dalle immigrazioni di
massa dal Sud del mondo.
Se la competizione sempre più serrata
imposta dal capitalismo globale e il
ridimensionamento del Welfare, dovuto alla
crisi fiscale dello Stato, hanno diffuso una
vasta ondata di apprensione e di malessere,
l'irruzione nei paesi euro-occidentali di una
fiumana di gente proveniente da varie parti
dell'universo, rischia di divenire una mina
vagante ad alto potenziale. Affinché non
finisca prima o poi per deflagrare, non basta
infatti che le autorità governative e le
amministrazioni locali assicurino a quanti
hanno le carte in regola, per stabilirsi nel
paese in cui intendono risiedere e svolgere il
proprio lavoro, la possibilità di usufruire
delle stesse condizioni e opportunità che
valgono per gli autoctoni. Né basta che
vengano posti freni efficaci all'immigrazione
clandestina, a quella avulsa da accordi
bilaterali con i paesi di provenienza o che
non ha a che fare con la ricerca di un rifugio
per motivi di persecuzione politica, come
sancito dal diritto internazionale.
È necessario che gli immigrati riconoscano a
tutti gli effetti i principi fondamentali e le
norme dei paesi d'arrivo e quindi vi diano
concreto riscontro nei loro comportamenti.
Ciò non significa, naturalmente, alcuna
rinuncia alla propria credenza religiosa e
alla propria identità, e tantomeno ai propri
orientamenti politici e sociali. Ma comporta
l'allineamento, senza ambiguità e ipocrisie,
ai principi istituzionali e alle leggi dello
Stato alla pari di tutti gli altri cittadini.
Solo così è possibile conciliare le diversità
e porre le basi di una reale convivenza in
un'incipiente società multietnica quale sta
profilandosi anche in Europa. Del resto, non è
che negli Stati Uniti il «melting pot» sia
avvenuto in modo diverso. Ciò che ha
contribuito a unire gli americani è infatti
l'adesione ai principi sanciti dalla
Costituzione, per quanto riguarda sia i
diritti e i doveri dei singoli cittadini, sia
la laicità delle istituzioni, e quindi la
rigorosa separazione fra autorità civili e
quelle religiose, nonché il riconoscimento
della piena sovranità dello Stato.
Il problema di un'effettiva integrazione di
quanti si sono stanziati nei paesi
dell'Occidente europeo, e seguitano a
giungervi, si è andato imponendo soprattutto
per gli immigrati musulmani, rispetto a quelli
di altre fedi religiose come l'induismo e il
buddismo. Sia perché essi sono divenuti negli
ultimi decenni la componente di gran lunga
maggioritaria degli extracomunitari
trapiantatisi in Europa, tra quelli che vi
risiedevano da tempo e quelli che vi sono
sbarcati di recente, fra quelli concentrati
nelle aree metropolitane e quelli disseminati
nei piccoli centri: tant'è che, secondo stime
attendibili, la popolazione musulmana nella
Ue, più che raddoppiata nell'ultimo
trentennio, raddoppierebbe di nuovo entro il
2020 se continuasse di questo passo, per poi
costituire entro il 2050 un quinto della
popolazione complessiva. Sia perché i
musulmani tendono, più di altri gruppi di
immigrati, a trapiantare tali e quali certe
ataviche prescrizioni religiose, nonché i
costumi e gli abiti mentali prevalenti nei
loro paesi d'appartenenza. Ed è questo il
fatto che desta più motivi di preoccupazione
tra gli europei.
S'è così diffuso il timore che l'Europa
finisca col trasformarsi in una sorta di
«Eurabia» (stando al termine coniato nel 2003,
prim'ancora che dai «neocon», dalla stampa
americana «liberal»). Che è quanto prevede
pure Bernard Lewis, uno dei massimi esperti
del mondo arabo, secondo il quale il Vecchio
Continente potrebbe tramutarsi, se non in un
prossimo futuro, entro la fine del secolo, in
una specie di «Euroislam».
Ciò non significa, beninteso, che l'Europa
debba chiudersi come in una fortezza, protetta
da una muraglia insormontabile, contro le
ondate migratorie provenienti dalle regioni
dove è dominante la religione islamica.
Rimane il fatto che l'integrazione degli
immigrati di fede musulmana costituisce una
questione quanto mai complessa, ben più
difficile rispetto a quella posta
dall'insediamento di altri nuclei
extraeuropei. E che quindi vada affrontata in
termini realistici e appropriati, tenendo in
debito conto due dati di fatto: il primo dei
quali è che numerosi immigrati islamici sono
originari di paesi dove sono cresciuti avendo
per precipuo riferimento le norme più rigide
della Shari'a; il secondo è che, per alcuni
imam delle moschee europee, quel che vale,
rispetto alle «leggi fatte dagli uomini», e a
maggior ragione nei riguardi di quelle degli
Stati secolari ospitanti, è pur sempre e deve
continuare a essere la «legge creata da
Allah».
Ci si domanda perciò, con riferimento a
queste due circostanze, se e fino a qual punto
determinate norme religiose e consuetudini di
matrice islamica siano compatibili con le
leggi e le istituzioni del mondo occidentale.
Se infatti uno Stato democratico deve
consentire a ciascuno di esprimere liberamente
le proprie convinzioni, dall'altro deve far
valere pur sempre determinati principi
fondamentali di rilevanza pubblica a cui tutti
sono tenuti a uniformarsi.
Senonché, nel caso degli immigrati di fede
musulmana, ci sono di mezzo diaframmi di non
poco conto, tradizioni e convenzioni sociali
che confliggono con le leggi dei paesi
occidentali: come la concezione della famiglia
e dei rapporti matrimoniali (per via tanto
della legittimazione della poligamia che della
giurisdizione assoluta del marito
sull'educazione dei figli e la gestione dei
beni famigliari); la posizione di globale
inferiorità civile della donna (soggetta a un
codice che sancisce il principio del tutore,
sia padre o fratello, a cui chiedere il
permesso se vuole sposarsi, oltre al divieto
di convolare a nozze con un non musulmano); la
pratica della mutilazione genitale femminile
che, ancorché non sia più seguita da molti,
non viene considerata per sé deplorevole; le
modalità dell'istruzione pubblica che si
vorrebbero basate sulla separazione fra maschi
e femmine nelle aule scolastiche, quando non
su un diverso grado di apprendimento.
È vero che non tutti gli immigrati musulmani
la pensano a questo modo o seguono in pratica
i precetti coranici più ortodossi e
totalizzanti. Ed è un fatto che molti di loro,
soprattutto quelli residenti da tempo in
Europa, hanno assunto laicamente le regole del
vivere comune.
Ma negli ultimi tempi, con la crescita degli
immigrati dai paesi islamici, è andata
ispessendosi anche la schiera degli imam e
degli ulema portati a ribadire anche fuori del
loro contesto originario il primato vincolante
della loro parola quale fondamento e fattore
di legittimazione sia del sistema giuridico e
sociale che delle istituzioni pubbliche. E
nell'ambito delle comunità musulmane si è
registrata negli ultimi anni, a cominciare
dalle leve più giovani, una tendenza non più
ad acquisire i valori etico-politici e i
modelli di riferimento laici occidentali bensì
a contrastarli recisamente, sino ad
abbracciare gli orientamenti più radicali
dell'islamismo come un'affermazione orgogliosa
della propria identità di fronte a sé e agli
altri.
È pur vero che, a detta di alcuni
osservatori, il multiculturalismo non
determina di per sé inevitabilmente una
«tribalizzazione» della società, e quindi la
diffusione di forme di separatezza e
segregazione tali da escludere categoricamente
qualsiasi reale rapporto di ibridazione e
interazione con il mondo circostante. Ma la
proliferazione di tante monadi monolitiche e
incomunicanti è quanto in pratica avviene
nella realtà. E quali pericoli, e conseguenze
negative, ciò finisce per innescare, lo hanno
sottolineato Giovanni Sartori e altri
osservatori abituati a valutare le cose senza
paraocchi fuorvianti. Il rifiuto pervicace, da
parte dei gruppi islamici più radicali, dei
principi dello Stato laico e liberale finisce
infatti per determinare tensioni laceranti e
destabilizzanti dell'ordinamento statuale.
Ha osservato perciò la scrittrice algerina
Assia Djebar: «Oggi la vera sfida, la vera
possibilità di avere un Islam nella modernità
e nella democrazia, si gioca in Europa». A suo
avviso, i musulmani europei dovrebbero
«prendere in mano la situazione», assumersi un
compito importante su due fronti: «discutere
tra di loro [...] e farsi interlocutori dei
loro Paesi d'origine». Esiste, d'altra parte,
tra gli immigrati islamici, una forte corrente
riformista, una sorta di «maggioranza
silenziosa», in grado di farsi valere se saprà
conciliare la propria fede religiosa con la
propria autonomia e libertà individuale. Del
resto, il filosofo iraniano Ramin Jahanglegoo
osserva come la cosa più importante in una
religione non è tanto quello che si crede, ma
quello che si fa con ciò che si crede.
Incontrarsi e discutere, per capire e farsi
capire. A questo riguardo si attribuisce un
ruolo importante ai leader delle istituzioni
ecclesiali. In effetti, la loro voce e la loro
opera risultano essenziali per promuovere un
clima favorevole allo sviluppo fra le varie
comunità di rapporti improntati a uno spirito
di reciproco rispetto e comprensione. Al di là
del versante teologico e dottrinale, esistono
infatti determinati valori etici condivisi in
linea di principio dalle diverse fedi
religiose, come il ripudio dei pregiudizi
razziali, il rifiuto dell'utilitarismo e
dell'egoismo individualistico, la compassione
e la solidarietà operosa verso gli umili e i
più deboli.
Ma se è dato sperare che il dialogo
interreligioso possa rivestire un ruolo
importante, nell'instaurare un clima di
reciproca fiducia e armonia fra comunità di
fede diversa, è un fatto tuttavia che in
Occidente spetti soprattutto alle istituzioni
pubbliche assolvere due precipui compiti. Il
primo dei quali è di neutralizzare le pulsioni
viscerali, fondamentaliste e teocratiche, di
alcune nomenclature islamiche più radicali. Il
secondo è di promuovere un'efficace azione
culturale, attraverso adeguate politiche
educative e scolastiche, che valga ad
accreditare e diffondere negli immigrati
islamici i principi basati sul primato
dell'individuo, sulla libertà di coscienza e
d'espressione, nonché sulla tolleranza e sulla
separazione fra religione e politica.
Sta di fatto che le democrazie occidentali
si trovano oggi ad affrontare quest'altra
impresa decisiva per la loro identità
collettiva e il loro futuro. Poiché è
essenziale a tal fine che quanti vengono a far
parte della loro società rispettino e facciano
proprie quelle norme fondamentali del regime
democratico e dell'ordinamento civile e
giuridico che costituiscono altrettante
architravi di un sistema aperto e pluralista.
Che è anche, nello stesso tempo, la leva più
efficace per scongiurare, al proprio interno,
la diffusione e la sedimentazione sia di
astiosi pregiudizi xenofobi sia di un clima
diffuso di smarrimento.
Valerio Castronovo
(«Prometeo» n. 111/10)
Internet e false credenze
- Quando cerchiamo informazioni in Internet
cadiamo spesso nell'errore di selezionare solo
quelle che confermano le nostre credenze. Come
accade? Internet, come tutte le grandi innovazioni
tecnologiche, suscita timori e speranze. In un
attimo ci permette di sapere qual è la
popolazione dell'Armenia o che tempo fa in
Australia; allo stesso tempo, però, molti sono
preoccupati dal fatto che in rete corra ogni
genere di informazioni sbagliate che ci
allontanano da una rappresentazione
ragionevole della realtà.
Data la diffusione planetaria del web, dato
che secondo stime attendibili dall'inizio del
nuovo millennio è entrata in circolazione una
quantità di informazioni cinque volte maggiore
di quelle diffuse da quando Gutenberg ha
inventato la stampa e data infine la nostra
tendenza a utilizzare sempre di più questo
strumento per cercare informazioni, è
legittimo chiedersi quale influenza esso possa
avere sulla diffusione di idee dubbie,
specialmente nel contesto delle società
democratiche.
Internet rappresenta anzitutto una
formidabile rivoluzione del mercato cognitivo,
cioè di quello spazio virtuale dove si
incontrano idee, conoscenze e credenze che
possono essere in concorrenza fra loro (si
veda Bronner, 2003). Ci potremmo aspettare
quindi che la diffusione generalizzata e a
basso prezzo dell'informazione favorisca la
diffusione del sapere e l'educazione delle
masse. Questa speranza di democratizzazione
della conoscenza è indubbiamente fondata,
almeno in parte, ma tradisce anche una certa
ingenuità nella rappresentazione del rapporto
che la nostra psiche normalmente intrattiene
con la ricerca di informazioni.
L'errore di conferma in azione
Abbastanza spesso succede, infatti, che la
nostra mente, nella ricerca di informazioni,
vada cercando dati che confermino la
rappresentazione che si è già costruita. Sotto
questo profilo Internet rappresenta lo
strumento perfetto: con un dispendio minimo di
tempo e di energia, ci propone una massa
enorme di informazioni, qualunque sia la
nostra inclinazione personale. La conseguenza
meno visibile, e tuttavia più decisiva, di
questo fatto è di predisporre le condizioni
ottimali perché l'errore di conferma
(confirmation bias) possa esercitare appieno
la sua efficacia nel distoglierci dalla
verità. Di tutte le tentazioni inferenziali
che affliggono la logica ordinaria, l'errore
di conferma è senza dubbio quello più
determinante al fine dei processi che
perpetuano le false credenze. Gli esperimenti
di Peter Cathcart Wason mettono in evidenza la
presa che questa distorsione esercita sulla
nostra mente. Ai soggetti viene presentato un
gioco apparentemente molto facile, con quattro
carte. Nell'esempio qui proposto sul retro
della carta contrassegnata con il numero 1 si
trova la lettera E; sul retro della carta
numero 2 si trova la lettera K; al numero 3 è
associato il 4; alla numero 4 è associato il
7.
Lo sperimentatore spiega che sul fronte si
possono trovare alternativamente due lettere,
E o K, e sul retro due cifre, 4 o 7. Il
problema è quali due carte si devono girare
per verificare l'affermazione seguente: «Se
una carta ha su un lato una vocale, sull'altro
ha una cifra pari».
La soluzione giusta è girare le carte 1 e 4,
ma la stragrande maggioranza dei soggetti
sceglie di girare le carte 1 e 3. Così
facendo, considerano il caso che conferma la
regola, anziché quello che la confuta. Sembra
infatti naturale andare a vedere se la terza
carta conferma l'enunciato, presentando sul
retro una vocale. In realtà, anche se sul
retro ci fosse una consonante la regola non
sarebbe contraddetta. La sola carta, a parte
la prima, che permette di verificarne la
validità è la quarta: se sul retro trovassimo
una vocale, sarebbe dimostrato che l'enunciato
è falso.
Questo meccanismo ci fornisce una
spiegazione semplice, ma molto efficace, per
capire la longevità delle credenze. È facile,
infatti, trovare dati che non sono
incompatibili con un enunciato dubbio, ma
questo tipo di dimostrazione non ha alcun
valore se non si tiene conto di quelli che lo
contraddicono.
Benché non esprima una razionalità
obiettiva, tuttavia, questo tropismo per le
conferme ci facilita in un certo senso
l'esistenza. Il processo di confutazione è
indubbiamente più efficace se lo scopo è la
ricerca della verità, riducendo la probabilità
di accettare come vere ipotesi false, ma esige
un investimento di tempo che può apparire
assurdo quando si tratta solo di prendere una
decisione soddisfacente. Come notano molti
autori, si sceglie spesso un'inferenza
soddisfacente anziché quella ottimale, cedendo
a quella che Fiske e Taylor (1984) chiamano
«avarizia cognitiva». Il fatto è che la
ricerca metodica di conoscenze fondate produce
un risultato cognitivo superiore, in confronto
a quelle proposizioni appena «soddisfacenti»
che sono le credenze condivise, ma implica un
dispendio di forze e di tempo molto maggiore.
La probabilità di adottare cognizioni ben
dimostrate risente della facilità con la quale
si incontrano credenze tutt'altro che
garantite.
Una volta accettata un'idea, si tende
generalmente a perseverare nella credenza,
tanto più facilmente quanto più la diffusione
ampia e non selettiva di informazioni rende
probabile la scoperta di «dati» che la
confermino. Personalmente non credo affatto
che Internet riprogrammi il nostro cervello,
come afferma Nicholas Carr nel suo saggio
Internet ci rende stupidi?, ma trovo del tutto
accettabile pensare che una persona a caccia
di informazioni in Internet dipenda in parte
dal modo in cui le organizza un motore di
ricerca. Quello rivelato dal web non è un modo
nuovo di pensare, ma al contrario un modo
arcaico, segnato dall'errore di conferma.
Qualcuno crede che gli attentati dell'11
settembre siano stati fomentati dalla CIA? In
pochi istanti, qualunque motore di ricerca gli
fornirà centinaia di pagine che gli permettono
di confermare quella sua credenza. Consultare
fonti d'informazione che non adottino quella
che è la sua rappresentazione del mondo può
sembrare una perdita di tempo.
Se teniamo conto di questo meccanismo di
ricerca selettiva dell'informazione, è chiaro
che la diffusione non selettiva di ogni sorta
di materiali sembra fatta apposta per
amplificare l'errore di conferma e quindi
perpetuare l'impero delle credenze, il che
rappresenta un notevole paradosso nella nostra
era informatica. Ma c'è un altro aspetto, che
finora i vari commentatori della cultura
Internet non sembrano aver colto fino in
fondo: abbiamo a che fare con un mercato
cognitivo ipersensibile alla strutturazione
dell'offerta e quindi alle motivazioni di chi
la produce. È questo uno dei fattori
principali che strutturano la concorrenza sul
mercato della conoscenza.
I «credenti» dominano il mercato cognitivo
Cosa rischia d'incontrare in rete, a
proposito di un tema vettore di credenze, un
internauta senza idee preconcette, se per
farsi un'opinione si affida a Google? Ho
cercato di simulare il modo in cui un utente
medio può accedere su Internet all'offerta
cognitiva relativa a vari soggetti:
l'astrologia, il mostro di Loch Ness, i crop
circles (agroglifi o cerchi nel grano), la
psicocinesi (qui mi limito a riassumere certi
risultati, ma per lo studio completo e il
metodo si veda Bronner, 2011). Mi è sembrato
interessante condurre la verifica su questi
temi, in quanto l'ortodossia scientifica
contesta la fondatezza delle credenze cui si
ispirano. Non è nemmeno il caso di porsi qui
la questione della verità o falsità degli
enunciati (chissà, un giorno si potrebbe
scoprire che esiste davvero un dinosauro in un
lago scozzese): ci basti osservare la
concorrenza fra risposte che si richiamano
all'ortodossia scientifica e altre che ne
divergono (indicate come «credenze» per
semplificare). Internet è un posto
d'osservazione interessante per valutare la
visibilità di tesi dubbie.
I risultati sono chiarissimi. Se si tiene
conto solo dei siti che sostengono tesi
favorevoli o sfavorevoli alle varie credenze,
fra le prime 30 voci proposte da Google si
trova in media oltre l'80% di siti che
sostengono la credenza in questione.
Come si spiega questa situazione?
Emerge chiaramente che Internet è, come già
accennato, un mercato cognitivo estremamente
sensibile all'offerta, e questa dipende dalla
motivazione di chi la produce. Altrettanto
chiaro è che i credenti sono generalmente più
motivati dei non credenti, quindi più disposti
a dedicare tempo alla difesa delle proprie
convinzioni. La credenza infatti è parte
integrante dell'identità personale del
credente: mentre questo si darà da fare per
trovare informazioni che gli forniscano pezze
d'appoggio, il non credente si accontenta di
rifiutare un enunciato, senza bisogno di altra
giustificazione che la sua palese fragilità.
Questo fatto si tocca con mano nei forum in
rete, dove talvolta credenti e non credenti si
contrappongono. Nell'insieme dei 23 forum che
ho esaminato (relativi alle quattro credenze
considerate), ho potuto contare 211
interventi, 83 a favore della credenza, 45
contrari e 83 neutri. Quello che colpisce
nella lettura di questi testi è che gli
scettici si limitano a messaggi ironici, senza
argomentare, mentre i sostenitori della
credenza portano argomenti, certo non
conclusivi (citazioni copia e incolla, link,
ecc.), ma comunque espongono per esteso il
loro punto di vista. Fra gli interventi a
favore, infatti, il 36% è corredato di un
link, un documento o un'argomentazione
articolata, contro il 10% degli interventi
scettici. Il mondo scientifico in generale non
ha molto interesse, né accademico né
personale, a intervenire in questo tipo di
dibattito, con la conseguenza paradossale che
i credenti, su ogni genere di argomento, hanno
finito per instaurare un monopolio nel mercato
cognitivo della rete, monopolio che non si
limita a Internet ma contagia anche i media
tradizionali, ormai estremamente sensibili
alle fonti d'informazione eterodosse.
Riassumendo, non credo si possa dire che
Internet ci renda più stupidi o più
intelligenti, ma il suo stesso funzionamento
facilita certe disposizioni rischiose della
nostra mente e organizza l'informazione in
maniera non sempre favorevole ad un sapere
rispettoso dei canoni scientifici. In altre
parole, la libera concorrenza delle idee non
sempre favorisce il pensiero più metodico e
razionale.
Gérald Bronner
(«Psicologia contemporanea» n. 230/12)
Sarà l'uomo a provocare la sesta estinzione di
massa?
- La scomparsa delle specie ha scandito
l'intera storia evolutiva. Oggi qualcosa del
genere accade ancora, ma non a causa di
meteoriti o grandi catastrofi, bensì per lo
più a seguito delle attività «antropiche». Il
dilemma del futuro che ci aspetta. Chi percorra le calli di Venezia o ne
navighi i rii si rende conto del degrado di
palazzi, ponti e monumenti, sui quali
l'inquinamento e le intemperie lasciano tracce
che con il tempo si trasformano in ingiurie e
ferite. Nel corso della storia sono nati e poi
morti imperi, nazioni e città: abbattuti dalle
invasioni, sommersi dalla sabbia, devastati
dai terremoti, allagati dagli oceani, arsi
dagli incendi. Ammiriamo le rovine di Machu
Picchu, le piramidi d'Egitto, le necropoli
etrusche, Pompei, i templi della Magna Grecia:
ma davanti alla lenta rovina di Venezia
avvertiamo un senso di ribellione e di
sconforto, perché si svolge sotto i nostri
occhi.
Da oltre quattro miliardi di anni la Terra
subisce sconvolgimenti e devastazioni. Appena
formate dalla spinta orogenetica, le montagne
cominciano a sfaldarsi, i continenti si
separano e tornano a riunirsi, le isole
emergono per poi scomparire di nuovo tra i
flutti degli oceani, i ghiacciai invadono le
pianure e poi si ritirano. Questa tormentata
storia geologica è inscritta sulla superficie
rugosa del nostro pianeta, sul fondo dei mari,
nei giacimenti stratificati di rocce e di
conchiglie e di ossa pietrificate. Di tutto
ciò siamo consapevoli: sappiamo bene che
montagne, laghi, coste e acrocori sono stati e
sono sottoposti a un continuo travaglio
costruttivo e distruttivo. Ma un conto è
sapere, un conto è vedere: quando l'indefesso
lavorio della natura si palesa davanti a noi,
ne siamo turbati e spaventati. Qualche anno fa
risonò un grido di allarme per lo sfaldarsi
delle nostre Dolomiti, uno dei più suggestivi
monumenti naturali del pianeta: ma le Dolomiti
hanno cominciato a sgretolarsi appena emerse
dai mari del Permiano, oltre 200 milioni di
anni fa. È la nostra visione ravvicinata che
c'impedisce di vedere le cose in prospettiva
geologica: fenomeni comunissimi, sempre
avvenuti nel lungo buio del tempo preumano,
oggi ci appaiono straordinari solo perché vi
assistiamo. Inoltre, lo sgomento che proviamo
di fronte alle inesorabili leggi
dell'entropia, del disordine e del degrado,
non deve farci dimenticare che spesso siamo
proprio noi a contribuire ai processi
degenerativi: le montagne sono solcate da
strade carrozzabili che consentono alle
automobili di inerpicarsi fino ad alta quota,
le foreste sono abbattute a ritmi forsennati
per sfruttarne il legno e ricavare spazio alle
coltivazioni, i mari sono solcati da pescatori
armati di una tecnologia che non lascia scampo
alle prede, cumuli di rifiuti più o meno
tossici e pericolosi invadono ogni angolo
dell'unico pianeta che abbiamo, e anche lo
spazio intorno alla Terra è gremito di
migliaia di oggetti piccoli e grandi che
abbiamo lanciato nel corso di mezzo secolo.
Questo discorso può essere declinato anche
in chiave biologica: la vita, comparsa
grossomodo tre miliardi di anni fa, si è
rapidamente diffusa ed è esplosa in una
varietà stupefacente di forme, ordini, specie.
Ma i periodi di grande fioritura sono stati
interrotti da calamitosi eventi recessivi, le
cosiddette estinzioni di massa. Se ne contano
cinque:
1. Nell'Ordoviciano superiore (circa 440
milioni di anni fa);
2. Nel tardo Devoniano (circa 370 milioni di
anni fa);
3. Nel passaggio dal Permiano al Triassico
(circa 250 milioni di anni fa), la più
disastrosa, in cui scomparvero il 96% delle
specie marine e il 50% di tutte le specie
animali esistenti;
4. Nel passaggio dal Triassico al Giurassico
(circa 180 milioni di anni fa);
5. Nel passaggio dal Cretaceo al Terziario
(circa 65 milioni di anni fa), nella quale
scomparvero, tra l'altro, i dinosauri.
Anche se le estinzioni di massa sono
impressionanti per le loro dimensioni, il
fenomeno della scomparsa delle specie si
riscontra lungo tutta la storia evolutiva,
tanto che più del 90% degli organismi mai
vissuti sono ora estinti. Se si esaminano
questi eventi adottando una visione oggettiva
e spassionata, non si può non convenire che
essi rientrano nell'avvicendamento naturale
tra la vita e la morte: la morte,
dell'individuo e della specie, è necessaria
alla comparsa di nuova vita, anzi allo stesso
mantenimento della vita. E in effetti dopo
ogni grande estinzione si è avuta una
straordinaria fioritura di nuove forme. I
dinosauri si affermarono dopo la terza
estinzione e i mammiferi conobbero il loro
trionfo dopo la quinta estinzione, che portò
alla scomparsa dei dinosauri.
Oggi assistiamo a quella che molti chiamano
la sesta estinzione di massa, segnata dalla
rapida scomparsa di un numero impressionante
di specie: ne siamo testimoni diretti, come
siamo testimoni del declino di Venezia. E,
come nel caso di Venezia, questa rapida
decadenza ci preoccupa e ci addolora. Ma oggi
il quadro è diverso: l'estinzione non è
causata come in passato da eruzioni vulcaniche
o dalla caduta di grandi meteoriti, bensì,
soprattutto, dalle attività antropiche.
Negli ultimi tempi, una crescente
consapevolezza della responsabilità umana
nell'ambito dei processi globali ha sostituito
la beata incoscienza di un passato non troppo
lontano. Ma quali sono i risultati di questa
consapevolezza? Il mese di aprile 2008 fu
proclamato «mese della Terra» e il pianeta fu
celebrato come un'arcaica divinità, riesumando
forme di venerazione tribali tipiche delle
popolazioni primitive. Tuttavia, questa acuita
sensibilità non è riuscita finora a tradursi
in azioni efficaci di contrasto alle attività
umane più invasive e inquinanti, che secondo
molti specialisti sono una delle cause
predominanti dell'estinzione di massa, del
riscaldamento globale e in genere degli
squilibri planetari. In assenza di
provvedimenti adeguati, la consapevolezza non
può che tradursi in angoscia.
Nei confronti di questi problemi, noi umani
tendiamo ad adottare un punto di vista
antropocentrico e a ricondurre alla nostra
specie e al momento attuale tutti gli eventi
che interessano il pianeta, dandone una
valutazione positiva o negativa con
riferimento solo a noi stessi. Ma il sistema
del quale facciamo parte è molto più vasto e
se gli equilibri planetari sono sconvolti
oltre misura, ciò può portare alla scomparsa
(non della vita ma) di molte specie viventi,
tra cui la nostra.
Si deve quindi operare una vera e propria
rivoluzione concettuale, che consiste nel
reinserire l'uomo nel grande quadro della
natura vivente. È una questione sistemica,
come ha sottolineato con forza, tra gli altri,
Gregory Bateson in tutte le sue opere e in
particolare in quelle dedicate all'ecologia
della mente. L'operazione auspicata di
reimmissione dell'uomo nel sistema complessivo
si è tradotta di recente nel cosiddetto
principio di precauzione, che consiste in
sostanza nell'astenersi da ogni intervento
umano che presenti una qualche probabilità di
danno significativo, anche se non accertata e
tantomeno quantificata.
Sorge tuttavia un problema: per quanto in
apparenza molto ragionevole, nella sua forma
più radicale il principio di precauzione è
paralizzante, perché ogni intervento umano,
anche il mancato intervento, presenta rischi
potenziali; e in generale è impossibile
dimostrare che una qualunque azione non
comporti rischi. In altre parole, se si
considera il sistema nel suo complesso, il
tentativo di salvaguardare un sottosistema può
ripercuotersi negativamente su un altro
sottosistema. Per esempio una riduzione rapida
e cospicua delle immissioni di gas serra
nell'atmosfera, di per sé benefica sotto il
profilo della qualità dell'aria e
presumibilmente anche del riscaldamento
globale, provocherebbe una vasta crisi
economica che avrebbe ripercussioni disastrose
sugli strati meno abbienti della popolazione
mondiale e in particolare sui Paesi in via di
sviluppo.
Il dilemma è evidentissimo nel caso della
Cina: l'aumento della produzione industriale
comporta costi altissimi in termini
ambientali, ma un suo ridimensionamento
porterebbe a una crisi economica di
proporzioni inimmaginabili. In sostanza è la
complessità insormontabile del sistema globale
a impedirci di applicare il principio di
precauzione nella sua forma estrema. Sono
invece accettabili forme attenuate del
principio, che predicano l'astensione da
quelle attività che presentano rischi
potenziali, anche se non accertati, purché la
rinuncia non comporti un aumento intollerabile
di rischi o di costi in altri settori del
sistema.
Si tratta di una sorta di conflitto di
interessi: coltivare un campo petrolifero al
largo di una costa incontaminata dove le
balene vengono a riprodursi, con il rischio di
inquinare il mare e sterminare pesci e
cetacei, oppure rinunciare al petrolio e
preservare lo stato integro del luogo?
L'interrogativo riguarda, per esempio, le
trivellazioni marine lungo le coste dell'isola
russa di Sakhalin, in Estremo Oriente, e si
traduce nel conflitto tra l'alimentazione
delle automobili da una parte e l'equilibrio
dell'ecosistema e il nutrimento della
popolazione locale dall'altra.
Certo, si può argomentare che siccome l'uomo
fa parte della natura, tutte le sue azioni
sono naturali, quindi anche quelle che portano
all'eliminazione di altre specie, eliminazione
che la natura, con la sua tipica «crudeltà»,
ha praticato per centinaia di milioni di anni
e continua a praticare senza nessuno scrupolo.
Tuttavia l'uomo è anche un essere razionale, e
non può limitarsi ad agire guardando solo il
profitto immediato e adottando la legge del
più forte.
Un atteggiamento più saggio consiste nel
considerare non solo gli interessi di questa
generazione, anzi dei suoi rappresentanti più
avanzati, ma nel tener conto delle componenti
più deboli della specie umana e delle
generazioni future. In effetti questa forma di
altruismo verrebbe a coincidere con una sorta
di «egoismo di specie», se con questa
locuzione s'intende un atteggiamento che
favorisca il mantenimento a lungo termine
dell'equilibrio dinamico del sistema Terra e
quindi della nostra sopravvivenza. La specie
che distrugge l'ambiente distrugge sé stessa
(è nota la metafora del boscaiolo incauto che
sega il ramo su cui sta seduto), anche se
nell'immediato questa distruzione, che si
traduce in uno sfruttamento intensivo delle
risorse, è fonte di prosperità e di benessere
materiale. Ma come decidere quali azioni sono
benefiche e quali negative per l'equilibrio
sistemico? Data l'insuperabile complessità del
reale, le nostre capacità di previsione sono
molto limitate: dobbiamo rassegnarci
all'incertezza e al rischio, ma non dobbiamo
rinunciare all'impegno etico.
Giuseppe O. Longo
(«Vita e Pensiero» n. 2/11)
Il corpo sotto gli occhi
- In passato, lo studio dei cadaveri era
parte integrante della formazione dei giovani
medici. E oggi? L'autopsia è ancora uno
strumento fondamentale o è ormai una reliquia
del leggendario passato della storia della
medicina? In un grigio mattino di novembre, durante il
mio internato in patologia, mi trovavo
nell'obitorio dell'Indiana University
Hospital, con la sola compagnia del piacevole
ronzio delle luci fluorescenti e del gocciolio
di un rubinetto. Una donna deceduta da poco
giaceva sul tavolo metallico. Indossava ancora
gli orecchini e la vera nuziale. Dal suo corpo
fuoriuscivano alcuni tubi di plastica, gli
ultimi dolorosi segni dell'intervento medico.
Con un senso di timore e di eccitazione mi
apprestai a compiere l'antico rituale
dell'autopsia. Sebbene da studente avessi già
avuto occasione di osservare il decesso di
alcuni pazienti, da quando avevo dissezionato
un cadavere durante il primo anno di medicina
non mi era più capitato di trovarmi da solo in
una sala settoria, in compagnia di un
cadavere. Divenni conscio del mio respiro,
degli sbuffi di aria calda che increspavano la
mascherina chirurgica e del martellare del mio
cuore mentre il ritmo aumentava. Sebbene il
corpo che avevo di fronte fosse privo di
emozioni e inerte come qualsiasi altro oggetto
inanimato nella stanza, percepivo la vita che
questa donna aveva vissuto, da giovane moglie,
figlia, forse sorella o madre. Mi sforzavo di
abbandonare la mia innata avversione per la
morte, accettandone il carattere definitivo e
separando la persona dal corpo che rimaneva.
Concentrandomi sul mio compito effettuai il
normale esame esterno, che per il patologo
equivale al tradizionale esame fisico eseguito
dal medico di famiglia, da un internista o da
un chirurgo. Mentre stavo preparando il
bisturi, scoprii una prominente protuberanza
delle dimensioni di un pompelmo nel punto in
cui la spalla si inserisce nella parte
superiore del torace. Tenendo ben ferma la
mano premetti la lama contro la pelle
incidendo l'epidermide e il tessuto molle
profondo fino a quando il bisturi toccò
l'osso. La pelle era rimasta sufficientemente
elastica per essere penetrata dalla mia lama,
e riuscii a completare velocemente la serie di
tagli necessari a creare un'incisione a Y sul
torace e sull'addome. Esaminai i tessuti della
cavità toracica, i quali rivelarono una massa
carnosa di tessuto bianco disorganizzato che
si estendeva dall'interno del seno fino ai
muscoli scheletrici sottostanti e alle costole
con una presa implacabile.
Questa era la natura del cancro, che
illustrava perfettamente l'etimologia della
parola, da karcinos, granchio. Il nome fu
coniato dal grande medico greco Ippocrate, e
si basava sulla tendenza dei tumori maligni
infiltranti a diffondersi in proiezioni
stellate, simili a dita, che ricordano le
zampe e le chele di un granchio. La parola
autopsia, che deriva dal greco e significa
«vedere con i propri occhi», ben esprimeva la
mia esperienza in quell'obitorio, mentre
imparavo a capire la natura dei tumori maligni
direttamente con i miei occhi, una capacità
che avrei coltivato per il resto della mia
carriera di patologo. Fu un episodio avvilente
osservare una così personale, palese e
avanzata manifestazione di malattia in una
donna che aveva la mia stessa età. Mi sentii
onorato di essere l'unico a posare gli occhi e
le mani sulla realtà della patologia che aveva
condotto alla morte questa donna. Provai anche
un legame spirituale con i medici del passato
che fecero un enorme balzo in avanti, passando
dalla semplice osservazione della superficie
di un corpo all'osservazione di ciò che era
racchiuso al suo interno.
Una simile scoperta rappresenta la forma più
pura della medicina, quando una condizione
clinica può essere direttamente collegata ai
sintomi fisici osservati. E sebbene le
caratteristiche grossolane e microscopiche del
cancro e di altre malattie abbiano avuto,
probabilmente, nel corso degli anni un aspetto
simile negli esseri umani, i modi in cui
scopriamo e interpretiamo le loro cause sono
cambiati drasticamente.
Una prognosi incerta
L'autopsia è stata e rimane lo strumento
migliore per giungere a una valutazione delle
malattie e dei traumi che comunemente
affliggono gli individui e le popolazioni.
Tuttavia questo esame sta progressivamente
perdendo il suo ruolo di procedura medica
principale. Osservando le onnipresenti
descrizioni di autopsie nelle serie
televisive, si potrebbe dedurre che gli
obitori straripano di casi in attesa di essere
risolti. Di fatto, mentre l'elevato numero di
omicidi, suicidi e incidenti tiene occupato
l'ufficio del coroner e del medico legale, il
patologo ospedaliero ha sperimentato negli
ultimi cinquant'anni un'enorme diminuzione
delle autopsie. Il tasso di autopsie negli
anni precedenti al 1950 si attestava su valori
costanti superiori al 50 per cento; negli anni
successivi, la percentuale di esami autoptici
per i decessi ospedalieri ha subito un brusco
calo fino a raggiungere attualmente valori
stimati intorno al 6 per cento. E questo
nonostante i risultati autoptici rivelino un
sorprendente tasso di errore nelle diagnosi
pre mortem e l'autopsia rappresenti, di fatto,
il principale strumento per determinare quel
tasso di errore.
Nel 40 per cento dei casi l'esame autoptico
rivela una diagnosi principale non scoperta in
precedenza, un valore che è rimasto costante
per i 60 anni in cui sono state registrate
queste correlazioni clinico-patologiche.
Questa statistica è in certa misura
fuorviante, in quanto i casi selezionati per
l'esame autoptico sono, in genere, quelli con
la maggiore incertezza diagnostica. Comunque,
analisi di regressione multipla su decenni di
dati disponibili presentati in numerose
pubblicazioni da parte di Kaveh Shojania
all'Università di Ottawa e da altri colleghi
hanno incluso periodi di studio, tassi di
autopsie, nazioni e diversi casi per
dimostrare che il tasso di errore diagnostico
continua a preoccupare i medici in modo
significativo. La probabilità che l'autopsia
evidenzi un errore di classe I, in cui
l'errata diagnosi può aver influenzato la
sopravvivenza del paziente, è del 10,2 per
cento. La probabilità di errori di maggiore
rilievo, diagnosi mancate che probabilmente
non hanno influito sul risultato, è risultata
del 25,6 per cento. Si stima che 35.000
pazienti che muoiono negli ospedali degli
Stati Uniti ogni anno potrebbero sopravvivere
se queste condizioni cliniche nascoste
venissero alla luce prima.
L'incompetenza diagnostica non è
necessariamente l'unico colpevole. Alcune
discrepanze fra le diagnosi cliniche e quelle
effettuate in sala settoria vanno attribuite
ai limiti della tecnologia diagnostica, e alle
inevitabili sfide costituite da pazienti
affetti da problemi medici multipli, da
sintomatologie atipiche della malattia o da
una patologia che può essere clinicamente
nascosta. Eppure, l'ampiezza delle statistiche
sugli errori suggerisce chiaramente quanto
l'esame autoptico sia importante ai fini del
monitoraggio e del miglioramento dei
risultati. Oltre a confermare e a correggere
le diagnosi cliniche, l'autopsia consente di
stabilire le cause del decesso, permette di
scoprire nuove e mutate patologie, consente di
valutare nuovi test diagnostici, tecniche
chirurgiche, dispositivi e farmaci. Inoltre dà
la possibilità di investigare su rischi
ambientali e occupazionali, consente di creare
precise statistiche vitali e permette di
valutare la qualità degli interventi medici.
Infine ha un valore fondamentale nella
formazione dei medici e, soprattutto, continua
ad ampliare i confini della conoscenza medica.
L'esame autoptico è un'arte antica. Ha un
futuro incerto, e un emozionante passato.
Gli inizi
La curiosità nei confronti dei fenomeni
naturali ha sempre alimentato gli sforzi
scientifici. A uno a uno, i grandi misteri
della vita sono stati illuminati da menti
avide di sapere, che spesso procedevano
controcorrente contestando i dogmi dell'epoca.
Le scienze mediche non hanno fatto eccezione,
come dimostrato dalla coesistenza di opposte
correnti di pensiero che ipotizzavano, per
esempio, l'attività di demoni e spiriti come
causa di malattia, proprio mentre stavano
emergendo spiegazioni più laiche e moderne.
La prima e predominante teoria sulle
malattie nell'antica Grecia, così come in
India e in Tibet, si basava sul concetto dei
quattro umori associati ai quattro elementi terra, aria, fuoco e acqua - che a loro volta
configurano la personalità umana. La teoria
degli umori postulava che tutti gli acciacchi
umani avessero origine da squilibri a carico
di questi elementi interni, che si manifestano
con apatia, perdite di sangue, bile gialla e
bile nera. Per esempio, a un individuo
sofferente di depressione veniva diagnosticato
un eccesso di bile nera (il termine melancolia
è formato dalle parole greche «nero» e
«bile»). Questa scuola di pensiero era
preminente all'epoca dei grandi medici greci
come Erofilo, il primo anatomista sistematico,
Ippocrate, il cui corpus medico rigettava le
spiegazioni soprannaturali della malattia, ed
Erasistrato, seguace di Erofilo e uno degli
ultimi di quell'epoca a dissezionare corpi
umani.
Il ruolo degli umori venne articolato in
modo assai eloquente da Galeno di Pergamo
(129-200 d.C.). La grande opera di Galeno
sulla cura, De methodo medendi, assieme agli
altri suoi trattati, fu il primo grande
scritto sulla medicina, e servì come guida
universale alle malattie umane per più di un
millennio. Durante l'epoca di Galeno e dei
discepoli che seguirono, la dissezione del
corpo umano non era approvata, e veniva
violentemente condannata. Di conseguenza,
Galeno formò la maggior parte delle sue
conoscenze di anatomia umana dissezionando
animali, incluse le bertucce, una specie di
scimmie presenti soprattutto in Nord Africa.
Galeno suppose - in modo ragionevole ma
pericolosamente imperfetto - che la struttura
interna di questi animali fosse abbastanza
simile a quella degli esseri umani, tanto da
essere sufficiente per capire l'anatomia
umana. Gli insegnamenti di Galeno rimasero in
auge in Europa e in Grecia fino al XVI secolo,
e alcune antiche scuole mediche, come quelle
ayurvedica e tibetana, esercitano ancora la
guarigione metafisica e la diagnostica basata
sugli umori che hanno avuto origine dalle
stesse radici, combinate con tecniche
terapeutiche e farmacologiche altamente
sofisticate. In effetti, quando i governanti
tibetani tennero due importanti conferenze
mediche nell'VIII e nell'XI secolo, riunendo
moltissimi medici - e traduttori - provenienti
da India, Persia, Nepal, Grecia, Cina e da
altri paesi per condividere le proprie
conoscenze, fu proprio la medicina di Galeno
quella che usarono come base per il loro
sistema medico integrato.
L'approccio galenico generalmente accettato
cambiò drasticamente nel 1530, quando Andrea
Vesalio, medico e anatomista italiano che
esercitava a Padova, ipotizzò che le
supposizioni di Galeno sulle somiglianze fra
l'anatomia animale e quella umana - senza
contare i suoi errori di osservazione stavano impedendo di capire più a fondo il
corpo umano. Vesalio giunse alla conclusione
che, per conoscere e caratterizzare le
malattie umane, fosse essenziale nient'altro
che l'accurata dissezione dei corpi umani.
Nel 1539 un giudice padovano che condivideva
un certo interesse per il lavoro svolto da
Vesalio concesse ai medici il diritto di
dissezionare i corpi dei criminali
giustiziati, fornendo in questo modo una fonte
fondamentale - sebbene discussa - di
conoscenza anatomica: un corpo umano appena
deceduto. Girava voce che un giudice
accomodante avrebbe organizzato le esecuzioni
per favorire l'anatomista padovano. Il lavoro
di Vesalio fu essenziale per espandere
l'ampiezza del sapere medico, e segnò la
nascita di una nuova era nella scienza
anatomica. Allo stesso modo in cui aumentò il
numero dei criminali giustiziati e delle loro
autopsie, crebbe anche la conoscenza anatomica
globale di Vesalio. Le sue indagini
culminarono nel 1543, con la pubblicazione del
De Humani Corporis Fabrica. Sulla struttura e
la funzione del corpo umano. Le sue scoperte
furono così complete e dettagliate che oggi
Vesalio è conosciuto come il padre
dell'anatomia umana.
Con la pubblicazione della sua opera si aprì
la via verso una reale comprensione della
struttura interna e delle funzioni del corpo
umano. Da raccolta sparsa di superstizioni e
rimedi fidati, la medicina occidentale si
trasformò in una disciplina basata sulla
logica e sull'osservazione, e un'altra area
della natura che in precedenza era rimasta
avvolta nel mistero venne liberata e
assimilata nella biblioteca collettiva della
conoscenza umana.
Il commercio dei corpi
Il patrimonio di informazioni provenienti
dalla dissezione dei corpi umani fu alimentato
e nutrito, e le scuole mediche finirono per
incoraggiare l'uso dei cadaveri a scopo
didattico. Il problema era dato semplicemente
dalla scarsità di corpi a disposizione: il
numero dei criminali giustiziati era di gran
lunga inferiore al numero dei cadaveri
necessari per i grossolani corsi di anatomia
delle scuole mediche. Di conseguenza, la
richiesta di corpi crebbe a dismisura e, come
spesso accade quando qualcosa scarseggia, il
prezzo salì ed ebbero inizio loschi affari.
Fra le novità introdotte dallo stesso Vesalio
va annoverato l'oscuro traffico di corpi
ignobilmente acquistati per un nobile scopo.
Come riporta Charles O'Malley nell'autorevole
biografia di Vesalio:
«Come un autentico studioso, Vesalio
raccomandò di fare ricorso alle fonti, in
questo caso i corpi umani, e se i corpi non
fossero stati facilmente accessibili lo
studente veniva incoraggiato a parole o, nella
Fabrica, attraverso insegnamenti aneddotici, a
procurarseli da sé. È significativo che,
dovunque Vesalio si recasse a tenere seminari,
ne conseguisse un'ondata di corpi scippati; i
vari aneddoti presenti nella Fabrica non danno
indicazioni sulla provenienza...»
Quando le pratiche e le conoscenze di
Vesalio si diffusero su larga scala, il
bisogno di cadaveri si tramutò nel cosiddetto
«commercio dei corpi», e trafugare salme dai
cimiteri divenne pratica comune. Per salme
decedute da poco e parti anatomiche varie
venivano offerti prezzi più alti di quelli
richiesti per cadaveri in diverso stato di
decomposizione. Tutto ciò indusse alcuni
imprenditori a partecipare a questo macabro
commercio. Famiglie preoccupate furono spinte
a prendere ulteriori precauzioni per
proteggere i loro cari dagli «uomini della
resurrezione», come venivano chiamati,
seppellendo i corpi in bare rinforzate che
venivano sigillate, e assumendo guardie per
impedire che le tombe venissero violate.
Numerose scuole mediche svilupparono una
politica del «non chiedere, non dire» quanto
all'acquisizione da parte degli studenti di
materiale umano per la dissezione. Se uno
studente si presentava in classe con un corpo,
questo veniva usato per la dissezione senza
che nessuno facesse domande. Questa abitudine
stimolò nuovamente la domanda di corpi come
pure la competizione fra i ladri di cadaveri.
Ma mentre molti pagavano ingenti somme di
denaro per acquisire corpi, arti e cervelli
dalle tombe, c'era chi accompagnava le persone
verso una morte prematura, in modo da poterne
vendere la salma. I due più famigerati ladri
di cadaveri, William Burke e William Hare,
fecero una breve carriera assassinando
numerosi cittadini e consegnando corpi ancora
caldi, evitandosi così il fastidio di esumare
i cadaveri dal terreno e fornendo materiale
fresco ai prezzi più elevati. Burke e Hare
entrarono in commercio quando un inquilino
della pensione di Hare morì per cause
naturali. I due portarono il corpo
all'università di Edimburgo, dove furono
ricompensati con 7 sterline e 10 scellini,
grosso modo un migliaio di euro al tasso di
inflazione attuale.
I due affrontarono allora il problema del
rifornimento, dando inizio a una mattanza che
fece 16 vittime in 12 mesi. Dopo la cattura, a
Hare venne concessa l'immunità per la sua
testimonianza contro Burke, con grande rabbia
del popolino che fu in certa misura ammansito
solo quando Burke venne impiccato e, in
seguito, dissezionato pubblicamente.
La protesta relativa alle pratiche di
sottrazione di cadaveri produsse, in
Inghilterra, l'Anatomy Act del 1832, che
affrontava, secondo la rivista «Lancet», «il
sistema di traffico fra resurrezionisti e
anatomisti, della cui esistenza l'esecutivo
aveva così a lungo sofferto». L'Anatomy Act
ampliava il pool di cadaveri legalmente
disponibili includendovi i senzatetto che
nessuno reclamava, molti dei quali furono
agevolmente recuperati da prigioni e ospizi.
Alla fine, con la comparsa dell'Anatomy Act e
una nuova detrazione per la donazione di corpi
da parte di privati cittadini, il mercato dei
rapitori di cadaveri giunse a termine.
La nascita dell'autopsia medica
Avevo appena ultimato la tradizionale
incisione a Y della mia prima autopsia quando
il patologo di turno entrò in sala,
apparentemente ignaro della mia mancanza di
esperienza. «Vai avanti e fai una Rokitansky»,
disse con tono monocorde. Dal momento che non
avevo la più pallida idea di che cosa fosse la
Rokitansky, immaginai che si stesse riferendo
alla rimozione e all'esame degli organi
interni. Il patologo scrutò attentamente ogni
mia incisione e guidò la mia mano con
suggerimenti esperti. Trascorsi più di un'ora
tagliando i tessuti molli, incidendo fra le
costole e manipolando organi in questo e
quell'altro modo, con tagli precisi e mirati.
Con le maniche completamente inzuppate di
sangue e la fronte imperlata di sudore,
completai la prima autopsia della mia
carriera. Avevo fatto la Rokitansky al mio
primo cadavere.
Il medico tedesco Karl von Rokitansky (18041878) fu uno dei primi a proporre l'uso
dell'anatomia patologica e degli studi
autoptici per l'apprendimento della medicina
clinica. In qualità di direttore dell'Istituto
di patologia del primo ospedale d'Europa,
l'Allgemeines Krankenhaus di Vienna, si dice
che Rokitansky abbia supervisionato più di
70.000 autopsie, facendone egli stesso più di
30.000, un'impresa lavorativa apparentemente
inverosimile che, tuttavia, sembra vera. Ai
suoi tempi era considerato di gran lunga il
più autorevole esperto in quest'arte. In
un'epoca in cui la velocità della dissezione
era cruciale per completare un'autopsia prima
che iniziasse la decomposizione, Rokitansky
inventò una procedura in cui gli organi
interni venivano dissezionati in situ e
rimossi in blocco, mantenendo in tal modo i
reciproci rapporti anatomici.
Molti patologi usano però il termine
«Rokitansky» riferendosi di fatto alla tecnica
«in massa», la procedura che io stesso usai
con la mia paziente deceduta di cancro. La
tecnica in massa rappresenta una procedura
straordinariamente efficiente per eviscerare
la salma con pochi tagli ben direzionati,
permettendo la rimozione degli organi da
collo, torace, addome e pelvi in un unico
grande blocco, mentre essi mantengono tutti i
rapporti anatomici originari. Il blocco con
gli organi rimosso dal corpo viene
dissezionato completamente su un tavolo
separato.
L'altro metodo autoptico eponimo comune è la
tecnica Virchow, chiamata così dal nome del
patologo tedesco Rudolf Virchow (1821-1902), i
cui contributi al settore della patologia sono
troppo estesi per essere riassunti in queste
pagine. In breve, Virchow è ritenuto da molti
il primo patologo, ed è senza dubbio assai
famoso per la sua teoria secondo la quale una
malattia inizia a livello cellulare, un
concetto assai moderno per quell'epoca. La
tecnica autoptica di cui Virchow fu pioniere
implica la rimozione sistematica degli organi
e la loro dissezione individuale sequenziale
via via che l'esame procede. Molti patologi
forensi preferiscono usare questa tecnica,
perché spesso accorcia il tempo necessario per
svolgere l'esame, cosa ideale per un patologo
che abbia più corpi in frigorifero in attesa
dell'esame post mortem. I rapporti anatomici
fra organi di solito non vengono mantenuti con
questa tecnica. Per questo motivo molti
patologi impiegano un ibrido di entrambe le
tecniche, scegliendo di rimuovere alcuni
organi a uno a uno, e altri in blocco, in
particolare cuore e polmoni per i quali le
connessioni anatomiche e vascolari possono
costituire il bersaglio dell'esame volto a
individuare problemi quali blocchi o rotture.
Lo stato dell'arte
Uno degli obiettivi della medicina moderna
consiste nell'usare nuove tecnologie per
diagnosticare con accuratezza una malattia,
minimizzando al contempo l'invasività delle
procedure diagnostiche. La potente macchina
della tecnologia ha coinvolto la medicina
quanto ogni altro settore, producendo
strumenti come gli endoscopi a fibre ottiche e
le apparecchiature radiologiche per immagini
ad alta risoluzione, e ponendo maggiore enfasi
su soluzioni di genetica molecolare per la
prevenzione e la cura delle malattie.
Nonostante quasi 200 anni di pratica autoptica
pressoché di routine, la procedura è cambiata
poco nel corso degli anni. L'esame sistematico
e diretto, sia visivo che tattile, è ancora la
cosa migliore. Di recente, tuttavia, sono
stati fatti tentativi per realizzare procedure
post mortem meno invasive, basate meno sulla
dissezione e più sulle immagini radiologiche.
Queste tecniche non sono solo più rapide e
pulite, ma lasciano la salma virtualmente
intatta prima che l'impresario delle pompe
funebri si metta al lavoro per la vestizione.
Questa scelta risulta vantaggiosa per le
famiglie che non gradiscono che il corpo
dell'estinto venga violato dall'autopsia, ma
anche per i medici, dal momento che i referti
autoptici vengono ottenuti più velocemente.
Un metodo noto come biopsia autoptica
prevede il recupero di un campione di tessuto
da ciascun organo mediante inserzione di un
ago e prelievo di un piccolo frammento di
tessuto, in modo simile alla biopsia a fini
diagnostici usata su pazienti vivi. Sebbene
questo metodo produca piccolissimi danni
corporali, richiede una notevole abilità e in
molti casi anche fortuna. Senza l'assistenza
delle immagini radiologiche come quelle
ecografiche o la tomografia computerizzata
(TAC), il campionamento di questi organi
sarebbe una biopsia alla cieca. Malattie che
non richiedono una grande precisione nella
fase di campionamento, come grossi tumori o
cirrosi epatiche croniche, si prestano bene a
questa tecnica. Viceversa, una malattia che si
sviluppi in un sito circoscritto come un
infarto miocardico acuto viene identificata
meglio sorreggendo il cuore nel palmo della
mano e incidendo ciascuna delle principali
arterie coronarie millimetro per millimetro,
come pure producendo sottili sezioni dello
stesso muscolo cardiaco, in modo da poter
osservare coaguli ostruttivi, rotture o
necrosi. Il risultato di una biopsia in questo
tipo di situazione clinica sarebbe
incongruente, e farebbe aumentare il numero di
falsi negativi.
Un metodo autoptico addirittura meno
invasivo è la risonanza magnetica per immagini
post mortem (MRI). Come accade nel caso delle
MRI tradizionali usate per esaminare tessuti
come quello cerebrale o le articolazioni del
ginocchio, le immagini ottenute con MRI post
mortem sono interpretate da un radiologo.
Questa metodica non danneggia la salma e
produce immagini di ottima qualità grazie
all'immobilità del corpo, tuttavia non riesce
a dare un risultato affidabile nel caso di
malattie con caratteristiche anatomiche più
sottili o assenti, come infezioni o scompensi
elettrolitici.
Più recentemente, ricercatori svizzeri hanno
applicato la risonanza magnetica e la
tomografia computerizzata per produrre
autopsie virtuali della salma ad alta
risoluzione e in tre dimensioni. Le hanno
chiamate «virtopsie», e le hanno usate
principalmente per scopi forensi. I patologi
possono esaminare queste ricostruzioni visive
e determinare il percorso seguito da un
proiettile, l'accumulo di liquidi, la frattura
e la frantumazione ossea e altre
caratteristiche probatorie, senza dover
sezionare la salma. Ulteriori informazioni,
come la natura chimica dei fluidi corporei e
notizie di natura tossicologica, possono
essere usate in abbinamento alle immagini per
giungere a una diagnosi. Questo approccio
presenta numerosi vantaggi, fra cui la
creazione permanente ed estremamente
dettagliata di dati digitali relativi alle
prove anatomiche di ogni caso.
Il principale ostacolo a un uso più diffuso
della virtopsia - e di altre forme di autopsia
basate sulle immagini - sono i costi
proibitivi. Senza includere la parcella del
medico, si stima che il costo delle
attrezzature per la virtopsia si aggiri sui 23 milioni di dollari, includendo lo scanner
per la risonanza magnetica e la TAC, oltre
all'hardware e al software per il computer.
Per di più, i pazienti deceduti per
avvelenamento o per una causa anatomica
naturale e poco evidente non sono buoni
candidati per questa procedura, il che
significa che bisogna mantenere la
funzionalità dell'autopsia tradizionale,
compresi i costi per l'attrezzatura, lo spazio
in laboratorio e i fondi per i patologi in
servizio.
Il futuro dell'autopsia
Come detto in precedenza, la frequenza delle
autopsie ha raggiunto il suo nadir: se appena
cinquant'anni fa una maggioranza dei decessi
ospedalieri finiva per essere sottoposta ad
autopsia, ora il tasso si aggira attorno al 6
per cento. Nonostante il declino, la
letteratura medica continua a pubblicare
regolarmente studi che documentano il valore
dell'autopsia come standard di accuratezza per
i certificati di morte - dai quali si ricavano
statistiche nazionali di rilevante importanza
- strumento didattico e molto altro.
È chiaro che si ricaverebbe un beneficio se
si invertisse il declino nel tasso di
autopsie. Le statistiche di sanità pubblica
sarebbero più accurate e l'acquisizione sempre
maggiore di competenze fra i medici
professionisti risulterebbe di grande valore
quando studi autoptici venissero chiamati in
causa per scopi vitali, come la
caratterizzazione di malattie emergenti o
precedentemente sconosciute, come è stato
durante le risposte iniziali all'HIV/AIDS, la
morte improvvisa in culla (SIDS) e molte apre
crisi sanitarie. I pazienti, così come i
medici, hanno interesse a che la procedura
venga ripristinata. I familiari chiudono un
triste capitolo e capiscono le cause della
morte del loro congiunto, e non è raro che
ricevano anche informazioni vitali su malattie
rimaste clinicamente nascoste ma ricorrenti
nella famiglia. Ciò può portare a cambiamenti
nello stile di vita prima che il male si
manifesti, un obiettivo basilare tanto della
medicina moderna quanto di quella antica.
È vero che, per gli anni a venire, una gran
quantità di informazioni rimarrà nascosta
persino alla migliore tecnica non invasiva di
cui disponiamo. Non c'è miglior esempio del
caso di quella mia giovane paziente con tumore
della mammella. Mentre stavo stilando il
referto finale, poco prima dell'autopsia, ho
riesaminato alcune sezioni degli organi
rimossi in sede autoptica. Sebbene la causa
presunta del decesso fosse un'insufficienza
d'organo dovuta allo stadio metastatico finale
di un tumore mammario, l'esame accurato dei
suoi tessuti al microscopio ottico rivelò
minuscole strutture ramificate che
interessavano quasi tutti i tessuti, la prova
di un'infezione fungina invasiva dovuta,
verosimilmente, allo stato di
immunosoppressione in cui versava la paziente
in seguito alla chemioterapia. Senza un esame
interno, i medici non avrebbero mai saputo la
diagnosi finale. E la stessa informazione non
sarebbe mai stata disponibile per migliorare
pratiche e procedure future.
Darin L. Wolfe
(«Le Scienze» n. 516/11)