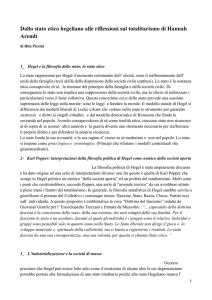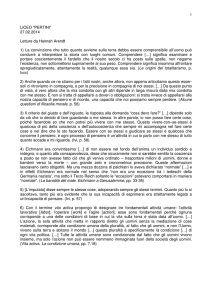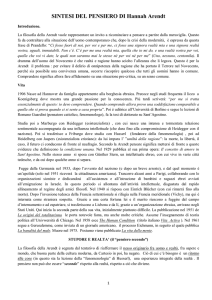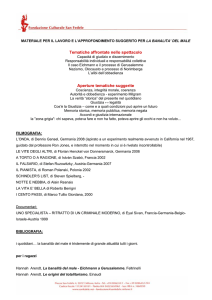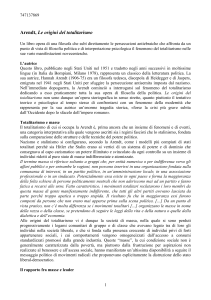Anno XXXIII, nov-dic. 2011, n.3/4
ra lii
c u lt u ral
fo n d im e n ti
a p p ro fon
LA RIVISTA DELLA SCUOLA
15
Quella che nei lager si compiva era una
forma di annichilimento dell’uomo
già Kant – in “La religione entro i
limiti della sola ragione” – definiva
il “male radicale”. Tuttavia Arendt
non indica quale sia la reale natura
di tale male, ma si limita a indicarne
i luoghi in cui esso è nato: i lager.
Ella è altresì convinta che, per capire il totalitarismo (e questo è l’obiettivo della sua opera del ’51), si
debbano innanzitutto capire i lager,
ossia quei luoghi in cui la logica del
male radicale si è sviluppata appieno. Ma usare i lager per capire il
totalitarismo equivale, naturalmente, a chiedersi quale fosse la funzione dei lager: a tal proposito, Arendt
esclude in blocco tutte le possibili
risposte utilitaristiche, secondo le
quali i lager sarebbero serviti a
qualcosa; al contrario – ella nota –
essi non sono fabbriche finalizzate
alla produzione di qualche cosa, né
volte a creare cadaveri. Certo, quella che nei lager si compiva era una
forma di annichilimento dell’uomo,
giacché egli era in primo luogo
annullato come individuo non
appena, nel lager, gli erano negate
una nazione e una giuridicità, e, in
secondo luogo, era azzerato sul
piano morale, nella misura in cui –
nel lager – i classici problemi morali perdevano ogni significato (tale è
il caso in cui alla madre è chiesto
quale dei suoi figli preferisce che
muoia per primo). Sicchè Arendt
addiviene in fine alla conclusione
che il vero scopo dei lager era la
trasformazione della natura umana,
la quale, così com’è, si oppone per
sua natura al totalitarismo: il lager
plasma un’umanità perversamente
nuova e diversa, e questo è il sogno
di tutti i pensatori moderni (dal
“Faust” di Goethe fino a Marx). Nei
lager quel sogno
Robert Krams -1956010 - II re e la regina
si è capovolto in incubo,
l’utopia si è fatta distopia (è l’immagine del “giardiniere” in altre
forme): dopo poche settimane di
reclusione, persone tra loro diversissime sotto ogni profilo diventano una sola persona che non ha
più umanità né diritti, ma a cui
restano esclusivamente le funzioni
primarie. Il passo successivo compiuto dalla Arendt è di chiedersi
quale sia il ruolo svolto dalla cultura nei lager intesi come laboratori
per cambiare la natura umana.A tal
proposito, ella confessa a Jaspers:
“ho il sospetto che la filosofia non
sia monda e priva di macchia in
tutto ciò”. Come disciplina, la filosofia ha innanzitutto responsabilità
di tipo politico/dirette: è questo il
caso in cui essa si mette al servizio
di una certa linea politica, con un
coinvolgimento diretto (è il caso di
Gentile e il fascismo italiano); ma
c’è anche una responsabilità di tipo
intellettuale/indiretta, quando –
come nel caso di Nietzsche e del
nazismo – si precorrono filosoficamente posizioni che altri percorreranno fraintendendole.
Abbiamo qui succintamente delineato le possibili responsabilità
della filosofia in generale, ma dobbiamo ora chiederci quando si
debba parlare di responsabilità riferita ai singoli filosofi: quand’è che
un filosofo può essere qualificato
a pugni. Lo slogan degli “ideologi”
è, in questo senso, il seguente: “ciò
che vale per la teoria, deve necessariamente valere anche per la prassi”; o anche quello latino: “fiat veritas ac pereat mundus”. É esattamente questo che si è verificato ad
Auschwitz, dove i nazisti hanno
tentato di concretare la loro perversa teoria: per mettere in evidenza ciò, Arendt si sente in dovere di
dimostrare come l’orrore nazista si
sia realizzato in virtù del fatto che il
mondo è svanito, ossia è caduta
quella pluralità che garantiva resistenza, giacché l’ideologia, per funzionare, non ha bisogno dell’io e
del mondo: essa è, piuttosto, un
parto della mente, un monologo
paranoico, un’evasione dal reale.
E tale rimozione della pluralità in
tutte le sue sfaccettatura – rimozione su cui, come abbiamo detto,
trova il suo terreno più fertile l’ideologia – affetta sempre più la
filosofia, che tende sempre più a
capovolgersi essa stessa in ideologia e a diventare preda di un folle
pensare l’unità, riducendo l’umanità ad un solo uomo (nei lager,
come abbiamo precedentemente
rilevato, le pluralità e le differenze
erano azzerate: si era una sorta di
unico uomo ridotto alle funzioni
primarie).
Tuttavia Arendt si accorge ben
presto che questo modello, se
applicato al nazismo, funziona
poco: e, per salvarlo, decide di
estenderne l’applicabilità anche
allo stalinismo, consapevole di
come sia stato, più di ogni altro,
Marx (che, nella lettura della
Arendt, dello stalinismo è, in certo
senso, l’antesignano)
a tentare di far
diventare prassi la
teoria (rendere “filosofico” il mondo,
com’egli amava
dire), teorizzando
la priorità della
vita activa su quella contemplativa.
Con Marx la filosofia diventa supporto politico del
totalitarismo,
anche se – come
Arendt stessa
rileva – “il filo
che lega Marx ad
Aristotele è assai
più robusto di
quello che lega
Marx a Stalin”.
Mostrata la validità della sua tesi
per cui si procede sempre più in
direzione di un’ideologia, cosicché
si perde la pluralità in nome dell’unità, Arendt estende il modello –
risultato valido nell’analisi dello stalinismo - anche al nazismo: la teoria
della razza è diventata prassi nei
lager (questa è l’ideologia). Come
antidoto a questa inquietante marcia verso l’ideologia, ella propone
di distinguere, all’interno della storia, una “tradizione principale”, che
rimuove la pluralità e le differenze,
e – ad essa contrapposta – una “tradizione alternativa” che, viceversa,
valorizza ed esalta il pluralismo in
ogni ambito, lottando contro ogni
totalitarismo: appuntare l’attenzione su questa tradizione minoritaria
è il compito che Arendt si assume a
partire dal suo scritto Vita activa. Si
tratta dunque di ripensare l’intera
tradizione storica e filosofica tentando di valorizzare quegli elementi pluralizzanti che la “tradizione
principale” ha eliminato o, nel
migliore dei casi, messo a tacere:
siamo pertanto di fronte a quello
che potremmo definire un “contravveleno anti-ideologico”. Tra la
fine degli anni ’50 e l’inizio degli
anni ’60 il pensiero di Arendt subisce una nuova svolta in concomitanza con l’arresto di Eichmann,
uno dei pezzi grossi della milizia
nazista, fuggito in Argentina – con
l’appoggio del Vaticano - dopo la
disfatta tedesca: si cattura e si pro-
cessa quello che, nell’immaginario
collettivo, è il mostro per antonomasia. Israele, diventato Stato, vuole
mostrare al mondo che, da quel
momento in poi, chi oserà attaccarlo non si salverà; e il fatto stesso
che lo Stato vada a prelevare Eichmann in Argentina è una prova lampante di ciò. Subito sorge un problema non da poco: chi ha il diritto
di processare Eichmann? Per la
prima volta si parla di crimini contro l’umanità: in tale occasione,
Jaspers sostiene che tutto il mondo
deve processare Eichmann (e
Arendt condivide tale posizione),
ma Israele si rivela sordo e decide
di processarlo a Gerusalemme,
anche quando molti (fra cui Arendt
stessa) fanno notare che i lager non
hanno riguardato esclusivamente
gli ebrei, ma anche i comunisti, gli
omosessuali, i minorati mentali e, in
fin dei conti, l’intera umanità. A
questo punto, Arendt decide di
seguire di persona il processo a
Gerusalemme e di vedere “in carne
e ossa” quello che a quei tempi
ancora definiva “il male radicale”:
sicché si fa mandare da un giornale
americano come inviata speciale e
da quest’esperienza esce un libro –
La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme – attraversato da
cima a fondo da un costante senso
di spaesamento che traspare fin da
quando Arendt scende dall’aereo.
Con la pubblicazione di quel libro,
inoltre, ella perderà tutti i suoi più
cari amici (tra cui Hans Jonas) e
sarà ripetutamente accusata di
“insensibilità”. Ciò può essere facilmente compreso fin dalle prime
pagine, dove ella scrive che, alla
vigilia del processo, Israele si stava
organizzando come la Germania
nazista: espressione, questa, che
suonò assai sgradita alle orecchie di
molti. Le prime domande che si sollevarono furono le seguenti: perché
Eichmann non è processato da una
corte universale? Perché non in
Germania, dove compì i suoi crimini? La risposta – destinata a suscitare grande scalpore - che Arendt,
sconcertata, forniva era che Israele
aveva bisogno di legittimarsi e il
processo ad Eichmann era un’eccellente occasione. Ancora più
sconcertata ella fu allorché vide in
persona Eichmann in tribunale;
appena due giorni dopo, essa riferì
a suo marito dell’incontro e così
descrisse icasticamente Eichmann:
“è un uomo grigio, piccolo, un
coglione”. Ma ciò che più la colpì
fu l’assoluta normalità di Eich-
mann: quello che, nell’immaginario
collettivo, era un mostro efferato, si
presentava ora come una persona
qualunque, del tutto sana, che non
uccise mai nessuno con le sue
mani e che addirittura svenne alla
vista del sangue; egli era, in altri termini, semplicemente un “funzionario delle fabbriche della morte” e,
di fronte a lui, la teoria del “male
radicale” girava a vuoto.
A questo punto,Arendt comincia
a mutare prospettiva e ad elaborare
una teoria simile a quella della
“zona grigia” di Levi. L’avvenuto
mutamento di prospettiva è da
Arendt comunicato a Scholem
(che, fino a quel momento, fu suo
amico) in una lettera del 1963: “ho
cambiato idea e non parlo più di
“male radicale”. […] Quel che ora
penso veramente è che il male non
è mai “radicale”, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca.
Esso può invadere e devastare il
mondo intero, perché si espande
sulla sua superficie come un fungo.
Esso “sfida” […] il pensiero, perché
il pensiero cerca di raggiungere la
profondità, di andare alle radici, e,
nel momento in cui cerca il male, è
frustrato perché non trova nulla.
Questa è la sua “banalità”. Solo il
bene è profondo e può essere radicale”.
La spaesante conclusione cui ella
perviene è che Eichmann non è un
mostro orripilante, un essere “non
umano” che uccide per il gusto di
uccidere: al contrario, egli né uccide
né odia gli ebrei, bensì si limita ad
organizzare il trasporto ferroviario
degli ebrei nei campi di sterminio,
ossia si preoccupa solamente che i
treni arrivino in orario, senza curarsi
minimamente del loro carico.
-------------------------------------------------
“
Eichmann non è un
mostro orripilante... egli né
uccide né odia gli ebrei,
bensì si limita ad organizzare il trasporto ferroviario
nei campi di sterminio, si
preoccupa che i treni arrivino in orario, senza curarsi minimamente del loro
carico
emerge, allora, la figura di un Ponzio Pilato che non giudica mai e
che è sconvolto quando i nazisti
optano per la “soluzione finale”: da
tutto ciò,Arendt sostiene che “Eichmann non pensa” ed è perciò un
uomo malvagio, quasi l’incarnazione del totalitarismo e dell’ideologia, pensa e agisce in modo meccanico, è “obbediente come un cadavere”. Chiamato a difendersi, egli
arriva a dire di aver agito “kantianamente” e di aver seguito la volontà
di Hitler: non sa ergersi a giudicare
quel che fa, si limita ad obbedire ai
comandi che gli sono impartiti; così
rileva Arendt e, di seguito, si
domanda se quello di Eichmann
fosse un comportamento obbligato. A questa domanda risponde
negativamente: non è assolutamente vero che in ogni uomo si nasconde e latita un potenziale mostro
come Eichmann; al contrario, basta
saper pensare ed essere giudici del
proprio agire perché ciò non si
verifichi. Per chiarire questo punto,
Arendt adduce l’esempio della
Danimarca, l’unico Paese che si era
fermamente opposto all’invasione
della Germania e delle sue idee
aberranti. In fin dei conti, Arendt
rileva che Eichmann ha compiuto
un male immenso e incommensurabile ma credendo di fare del bene
(in ciò risiede quella che ella chiama la “banalità del male”), non ha
saputo opporsi poiché non è stato
in grado di pensare e giudicare:
perciò deve essere punito dalle
leggi. Sicché la pena che gli fu
inflitta a Gerusalemme (l’impiccagione) fu giusta secondo Arendt,
benché ella non condividesse affatto la sentenza per cui Eichmann
era un criminale contro gli ebrei: in
realtà – ella nota – Eichmann fu un
criminale contro l’umanità e perciò
deve morire. Il concetto di obbedienza va bene solo quando si ha a
che fare coi bambini o coi credenti, ma mai in politica, dove obbedire
equivale ad appoggiare. Certo, non
tutti possono essere eroi e intraprendere una resistenza attiva, poiché – come giustamente notava
don Abbondio – il coraggio non ce
lo possiamo auto-infondere, e tuttavia, ciò non di meno, tutti possono
rifiutarsi di obbedire, intraprendendo per questa via una resistenza
passiva.
☎
------------------------------------------------Addirittura, si scopre che il suo
progetto era di invadere il Madagascar e di mandare lì in esilio tutti
gli ebrei: il loro sterminio esulava
del tutto dalla sua volontà. Ne
F
ilo diretto
per abbonarsi
se avete una carta di credito
è sufficiente una telefonata
al 02/669.2195
oppure un fax al 02/6698.3333