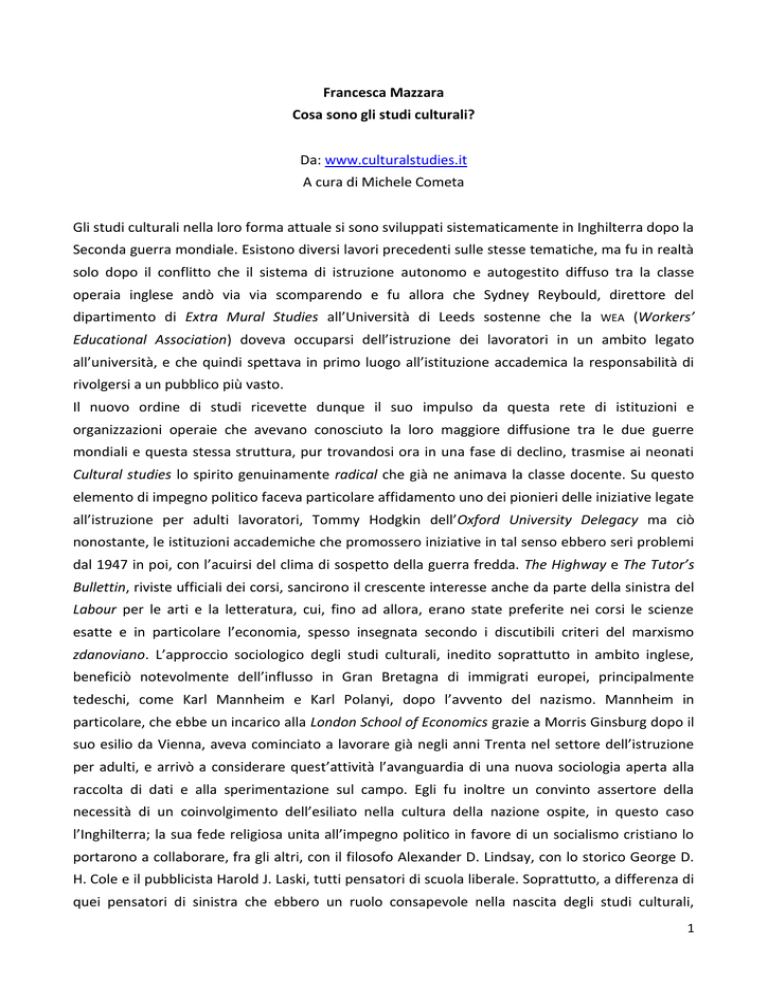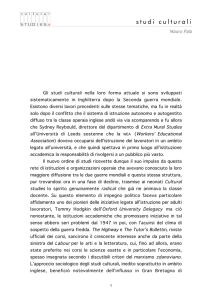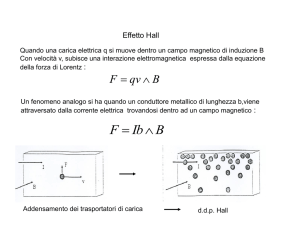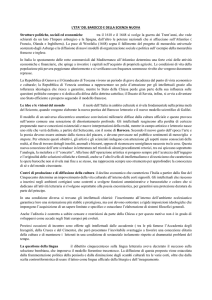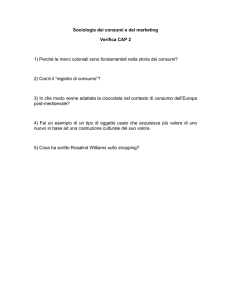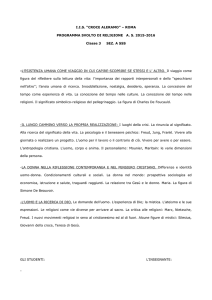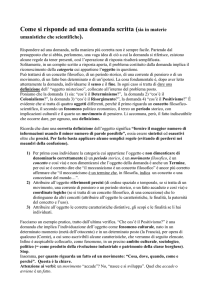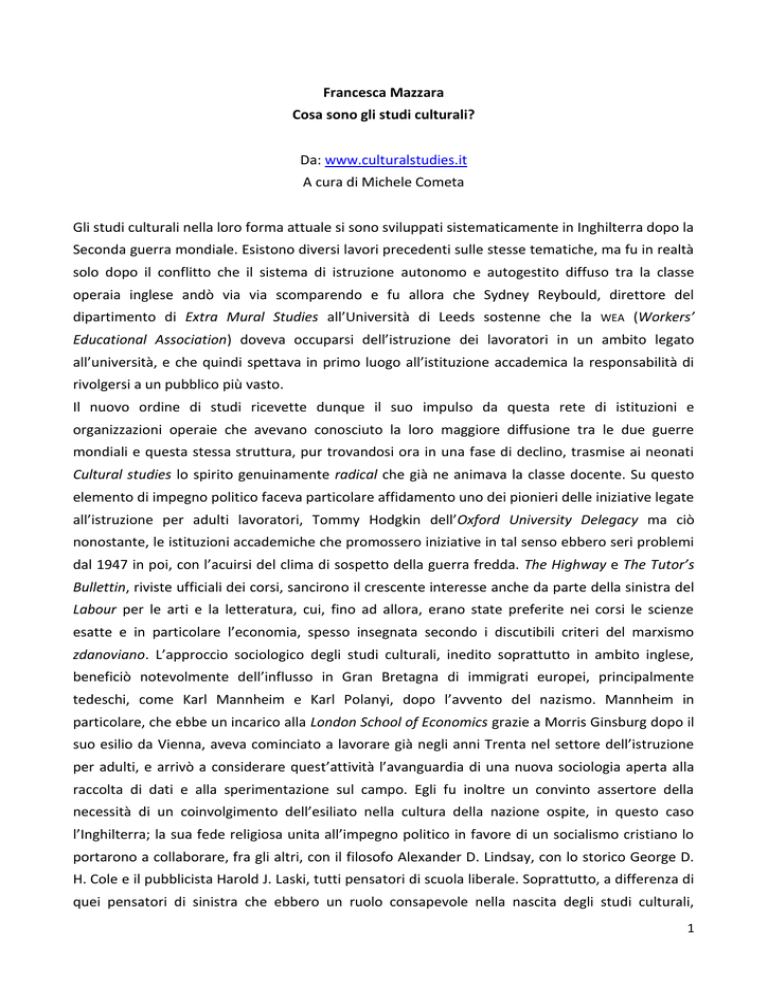
Francesca Mazzara
Cosa sono gli studi culturali?
Da: www.culturalstudies.it
A cura di Michele Cometa
Gli studi culturali nella loro forma attuale si sono sviluppati sistematicamente in Inghilterra dopo la
Seconda guerra mondiale. Esistono diversi lavori precedenti sulle stesse tematiche, ma fu in realtà
solo dopo il conflitto che il sistema di istruzione autonomo e autogestito diffuso tra la classe
operaia inglese andò via via scomparendo e fu allora che Sydney Reybould, direttore del
dipartimento di Extra Mural Studies all’Università di Leeds sostenne che la
WEA
(Workers’
Educational Association) doveva occuparsi dell’istruzione dei lavoratori in un ambito legato
all’università, e che quindi spettava in primo luogo all’istituzione accademica la responsabilità di
rivolgersi a un pubblico più vasto.
Il nuovo ordine di studi ricevette dunque il suo impulso da questa rete di istituzioni e
organizzazioni operaie che avevano conosciuto la loro maggiore diffusione tra le due guerre
mondiali e questa stessa struttura, pur trovandosi ora in una fase di declino, trasmise ai neonati
Cultural studies lo spirito genuinamente radical che già ne animava la classe docente. Su questo
elemento di impegno politico faceva particolare affidamento uno dei pionieri delle iniziative legate
all’istruzione per adulti lavoratori, Tommy Hodgkin dell’Oxford University Delegacy ma ciò
nonostante, le istituzioni accademiche che promossero iniziative in tal senso ebbero seri problemi
dal 1947 in poi, con l’acuirsi del clima di sospetto della guerra fredda. The Highway e The Tutor’s
Bullettin, riviste ufficiali dei corsi, sancirono il crescente interesse anche da parte della sinistra del
Labour per le arti e la letteratura, cui, fino ad allora, erano state preferite nei corsi le scienze
esatte e in particolare l’economia, spesso insegnata secondo i discutibili criteri del marxismo
zdanoviano. L’approccio sociologico degli studi culturali, inedito soprattutto in ambito inglese,
beneficiò notevolmente dell’influsso in Gran Bretagna di immigrati europei, principalmente
tedeschi, come Karl Mannheim e Karl Polanyi, dopo l’avvento del nazismo. Mannheim in
particolare, che ebbe un incarico alla London School of Economics grazie a Morris Ginsburg dopo il
suo esilio da Vienna, aveva cominciato a lavorare già negli anni Trenta nel settore dell’istruzione
per adulti, e arrivò a considerare quest’attività l’avanguardia di una nuova sociologia aperta alla
raccolta di dati e alla sperimentazione sul campo. Egli fu inoltre un convinto assertore della
necessità di un coinvolgimento dell’esiliato nella cultura della nazione ospite, in questo caso
l’Inghilterra; la sua fede religiosa unita all’impegno politico in favore di un socialismo cristiano lo
portarono a collaborare, fra gli altri, con il filosofo Alexander D. Lindsay, con lo storico George D.
H. Cole e il pubblicista Harold J. Laski, tutti pensatori di scuola liberale. Soprattutto, a differenza di
quei pensatori di sinistra che ebbero un ruolo consapevole nella nascita degli studi culturali,
1
Mannheim intrattenne rapporti di studio con Thomas Stearns Eliot, con il quale condivise una
concezione della funzione dell’intellettuale come custode dei valori di un’intera società senza
cedere però alla tentazione elitaria che anima l’intervento eliotiano nel ’48 delle Notes towards
the Definition of Culture. Lo stesso termine intellectual ebbe una vasta circolazione in Gran
Bretagna solo dopo la traduzione, nel 1936, di Ideologie und Utopie di Karl Mannheim del 1929.
Contemporaneamente Paul Tillich e Adolph Löwe e altri francofortesi di orientamento weberiano,
svolsero un compito sostanziale nell’introduzione nell’accademia inglese di una metodologia di
matrice tedesca. Sia per Mannheim che per Polanyi, entrambi convinti assertori di un impegno
dichiarato, il compito genuino dell’intellettuale consisteva nel sapere discriminare tra le forze
oggettive e naturali da cui l’intera società beneficia sotto forma di spinte al progresso materiale e
spirituale e quelle tendenze, di natura ideologica, di cui invece può trarre vantaggio temporaneo
una sola classe e che, come tali, vanno smascherate e respinte. Mannheim sostenne inoltre la
necessità di un imperativo o un’utopia, elemento molto presente anche in Bloch, Buber e
Benjamin, che costituisse il fulcro di questo progresso collettivo e interclassista. In tale anelito la
visione di Mannheim trovò adesioni in Gran Bretagna anche tra molti marxisti, che gli
contestarono però la mancanza di un’analisi di classe del gruppo degli intellettuali e di un progetto
politico esplicito e totalizzante. Il consenso riunito intorno a Mannheim portò nel 1940 alla
pubblicazione di una versione ampliata di Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus del
1935, Man and Society, oltre che della raccolta di saggi Diagnosis of Our Time. Furono
principalmente due i punti di questo sforzo collettivo che suscitarono vivaci dibattiti tra pensatori
laici e socialisti e stimolarono così la nascita di una disciplina progressivamente autonoma: la
concezione dell’intellettuale, in parte mutuata da Benda, come chierico capace di attuare un
mutamento dall’alto, e l’idea di un progressivo degrado della società in quanto società di massa.
Sulla massificazione della società nata dalla rivoluzione industriale si erano pronunciati a più
riprese Eliot con la sua Idea of a Christian Society (1939) base delle Notes (1948), nonché Frank R.
Leavis e Ivor A. Richards e fu su queste problematiche che si sviluppò l’attività di Raymond
Williams, Richard Hoggart e Edward Palmer Thompson. Tutti furono impegnati pressoché nello
stesso periodo in corsi di adult education: Hoggart, di origini proletarie, formatosi alla scuola
liberale di Bonamy Dobrée, fu influenzato da Lionel Trilling con Middle of the Journey (1947) e The
Liberal Imagination (1950) nonché da A Study of History (1951) di Toynbee e dai Four Quartets
(1935-1942) eliotiani. Il suo interesse si incentrò prevalentemente sulla progressiva scomparsa di
una genuina cultura popolare e sulle modalità di funzionamento della società urbana,
caratterizzata da forme di aggregazione sempre più complesse. Il suo The Uses of Literacy del 1957
analizza come il sistema educativo interagisca con le forme di produzione culturale su larga scala,
dal cinema alla letteratura popolare, e finisca col determinare l’appartenenza a una certa classe
sociale, soppiantando, fra l’altro, la trasmissione tradizionale del sapere, prevalentemente orale,
all’interno di una comunità. Hoggart, pur sostenendo di non essere animato da un intento politico
2
quanto dalla preoccupazione del declino in Inghilterra delle istituzioni di famiglia, comunità e
classe utilizza una serie di strumenti e indicazioni mutuate dall’antropologia nell’analisi del folklore
che assumono un carattere inequivocabilmente politico. L’idea di esperienza come convalida
empirica di un processo storico caratterizza anche The Making of the English Working Class (1963)
di Thompson dove la ricerca sulle origini della classe sociale divenuta formazione storica
omogenea tra il 1780 e il 1832 è vista come un processo cui contribuiscono dinamicamente più
fattori. Tra questi la sfera sovrastrutturale, ovvero culturale, nell’impostazione marxista adottata
da Thompson assume un’importanza preponderante, smentendo sia la concezione meccanicisitica
del marxismo volgare – anzi, secondo Thompson recuperando alla lettera l’originale marxiano dei
Grundrisse e della Deutsche Ideologie – che la visione delle classi sociali come raggruppamenti
statici e rigidamente separati tipica dei sociologi liberali come Dahrendorf. Anche il
contemporaneo Culture and Society (1958) di Williams tratta delle trasformazioni della società
inglese tra il 1780 e il 1950 esaminando l’evoluzione semantica di termini chiave come arte,
industria, democrazia, e, appunto, cultura in un corpus di testi che abbraccia autori canonici della
letteratura inglese e figure prevalentemente ottocentesche rilevanti nel pensiero politico, come
Carlyle, Morris e Marx. Con quest’opera Williams unì l’impegno etico propugnato da Leavis
all’indagine sociologica applicata alla letteratura, un approccio metodologico che il suo maestro
Leavis e il gruppo della rivista Scrutiny non avevano mai voluto accettare. Consapevole delle
tradizioni socialiste nella famiglia d’origine nel Galles, Williams nel corso di tutta la sua attività di
studioso si sarebbe poi concentrato sulla formazione e lo sviluppo di concetti come cultura,
canone, nazione e identità, rilevando lo scarto esistente tra ciò che veniva insegnato nella scuola e
nelle università britanniche e il portato dell’esperienza nella comunità da cui proveniva. Con
Williams iniziò l’analisi e la revisione delle idee alla base dei cosiddetti English studies, così come
trasparivano dal cosiddetto Newbolt Report, dove si attribuiva all’insegnamento della letteratura
notevole importanza nella formazione del cittadino inglese. I risultati di questo tipo di ricerca
avrebbero poi dato luogo a una serie di suggestioni per un’azione politica incentrata sulla sfera
culturale in circostanze storiche ben precise. Fra queste spicca il concetto di Englishness, insieme
di valori legati ad un modello ideale di suddito e frutto dell’impostazione arnoldiana dello studio
della letteratura. La Englishness costituisce tra l’altro il nesso teorico di tutta una serie di studi nel
campo della comparatistica, delle ricerche postcoloniali e degli studi culturali. Contro una nozione
unitaria e immutabile di Englishness a sostegno del canone si pronunciò Williams nei suoi studi tesi
a rivalutare una nozione di cultura aperta alle suggestioni di Volosinov, a loro volta debitrici nei
confronti di Bachtin e della scuola di Lotman. In The Country and the City (1973) Williams individuò
anche il discrimine tra una tradizione nata e sviluppatasi dal centro metropolitano – come fulcro
anche di espansione imperiale – e le testimonianze antagoniste, da Blake a Dickens in poi, che
rappresentano e danno voce alla periferia, intesa anche come sfera regionale e minoritaria, e a
gruppi subalterni. Sulla reazione sistematica al sistema di valori normalmente associato alla
3
Englishness si definisce anche la prassi degli studi (post-)coloniali, che sapranno valorizzare queste
aperture nel campo degli English studies arricchendolo degli spunti teorici nati dalla
contemporanea ricerca nel campo dei media.
Anche i cosiddetti Culturalist studies o Culturalism nascono da una branca degli studi culturali
come reazione al ruolo secondario assegnato dai teorici marxisti alla cultura rispetto alla sfera
economica e, in particolare, alla priorità data da questi nello studio dei fenomeni sociali ai mezzi di
produzione. Stuart Hall e Tony Bennett, fra gli altri, tradussero e utilizzarono negli anni Sessanta gli
studi dei francofortesi contro una concezione, dominante in campo anglosassone, fortemente
condizionata dalla sociologia americana (Paul Lazarsfeld, Bemald Berelson, Hazle Gaudet). Negli
Stati Uniti l’orientamento prevalente nell’accademia, di matrice positivista, vedeva una società di
massa indifferenziata, passiva e affatto condizionabile dai nuovi sistemi di comunicazione. Hall
formula una critica serrata di quella concezione liberal pluralista legata all’orientamento
comportamentista delle scienze sociali. In America alla fine degli anni Cinquanta la visione
acquiescente dei media nasceva dalla soddisfatta constatazione del pluralismo politico come
garanzia di una democrazia realizzata. Servendosi dello strutturalismo di Lévi-Strauss e Barthes
fino alla teoria degli apparati di Althusser, Hall smentisce l’idea che i media forniscano una riflesso
immediato della realtà e che soprattutto offrano a chiunque un analogo accesso ai canali di
comunicazione e, attraverso questi, al dibattito politico. L’intera concezione liberale della
democrazia ne risulta fortemente inficiata. Il cosiddetto paradigma critico cui approda la critica di
Hall rivaluta e mette in primo piano la funzione dell’ideologia. Gli studi culturali vengono concepiti
in opposizione al ruolo affatto secondario assegnato alla cultura nella sociologia di Parson e anche
al modello base-sovrastruttura del marxismo volgare, soprattutto per ciò che concerne la
distinzione operata all’interno di questo dualismo, tra forze ideali e materiali. La cultura indica la
dialettica tra l’essere e la coscienza sociale; abbraccia come tale i valori che emergono e si
affermano nell’ambito di una certa comunità dove la comunità in esame può corrispondere anche
a un’intera classe sociale, visto che viene giudicata empiricamente: in altri termini, la cultura di un
gruppo corrisponde a tutte le manifestazioni del gruppo stesso, considerate in una rete di relazioni
e soprattutto non come dati fissi, ma all’interno di un’evoluzione storica. Nella considerazione dei
media si sono affermate due concezioni che hanno condizionato l’evolversi degli studi del
Culturalism: da un lato lo strutturalismo anglosassone ha sottolineato, sulla scia di quello francese,
la crescente autonomia degli apparati fino al punto in cui essi sfuggono anche al controllo
dell’autorità politica preposta al loro funzionamento. Rientrano in questo orientamento fra gli
altri, gli studi Sande Cohen, Graham Murdock e Peter Golding. In un ambito non legato soltanto
alla ricerca sui media gli studi sull’ideologia di Terry Eagleton possono anche essere riferiti al
Culturalism.
Dall’altra parte invece si pone il gruppo di studiosi, tra cui rientra lo stesso Hall, che concepisce
l’agone politico come fondamentalmente aperto, pur non trascurando il ruolo dell’ideologia,
4
ricondotta però dall’idea althusseriana di fattore determinante ed esclusivo a una forza che tende
a mascherare, servendosi dei canali della comunicazione, gli interessi prevalentemente economici
di una classe o di un gruppo di potere (Th. Bennet). Hall e la frazione di studiosi cosiddetti
culturalist si servono del concetto gramsciano di egemonia per individuare le aree dove si ottiene
consenso attraverso un’azione congiunta condotta attraverso più canali di comunicazione.
La mancanza in Italia di un termine specifico per gli studi culturali non significa che non vi sia nel
nostro Paese un interesse per le tematiche che normalmente vengono studiate in ambito
anglosassone. L’area di questi studi corrisponde in Italia a quella coperta da discipline come la
sociologia, l’antropologia culturale o l’etnologia, spesso insegnate congiuntamente nelle facoltà di
scienze della comunicazione. Il temine cultura designa sia una serie di attività di appannaggio quasi
esclusivo degli intellettuali che, in un’altra accezione molto più ampia di uso corrente in
antropologia, un gruppo di attività caratteristiche e qualificanti di una certa società, dai sistemi di
produzione materiale alle convenzioni nell’abbigliamento ai riti religiosi o, infine, anche al modo di
trascorrere il tempo libero. Tutti questi fenomeni devono essere studiati non già in termini
intrinseci, in base cioè a criteri estetici, intellettuali, formali preordinati, ma piuttosto come parte
essenziale delle norme di comportamento collettive, e dunque secondo le convenzioni che
generano i giudizi di valore e l’idea di considerazione sociale. Ne consegue che la prassi in ambito
culturale risulta fortemente condizionata dalla classe, dal sesso e dall’appartenenza a un
particolare gruppo etnico. Tali differenze sono state in gran parte erose dal sistema di
comunicazioni tipico delle società industriali che ha avuto anche in Italia l’effetto di rendere
difficile oggi una chiara distinzione tra la sfera delle arti, dello svago e dello spettacolo e quella dei
costumi tradizionali. Storicamente in Italia l’identificazione delle arti con l’istruzione e le arti alte è
stata molto più duratura che altrove, per un retaggio umanistico legato a Croce e Gentile che
identificavano la cultura prevalentemente o esclusivamente con una classe di intellettuali. Un
differente concetto di cultura cominciò a emergere solo dopo gli studi di Cirese e De Martino che
valorizzarono le suggestioni di Gramsci: le note sul folklore contenute nei Quaderni del carcere
(1975) fornirono infatti la base teorica per una rivalutazione delle comunità agrarie localizzate
prevalentemente nel Mezzogiorno. Questo interesse degli antropologi risultò allora storicamente
motivato anche dalla marginalizzazione attuata nei confronti del Sud d’Italia da parte del fascismo.
Rapidamente queste ricerche si estesero però a insediamenti urbani come testimoniano le prime
ricerche sistematiche da parte dell’istituto De Martino di Giovanni Bosio. Ne è un esempio recente
lo studio di Alessandro Portelli sulla città industriale di Terni, mentre un altro campo di ricerca
venne aperto da Roberto Leydi nell’etnomusicologia. Questi lavori finiscono per assumere un
marcato significato politico perché, nelle parole di Luigi Lombardi Satriani, studiare il folklore
significava parteggiare per i diseredati, le classi subalterne in contrasto con quella cultura
commerciale in piena ascesa in Italia negli stessi anni in cui Pasolini la poneva sotto accusa.
Pasolini, Fortini e altri intellettuali videro la televisione come strumento di questa
5
commercializzazione
e,
come
tale,
intrinsecamente
nociva
per
una
società
sana.
Quest’opposizione fece seguito per certi versi a una radicata avversione degli intellettuali italiani
nei confronti del cinema. Dopo le ricerche a carattere etnologico si aprì comunque negli anni
Sessanta un altro filone degli studi culturali incentrato sui media di cui Ivano Cipriani e Umberto
Eco furono tra i pionieri, trattando diffusamente di sistemi di comunicazione di massa nella rivista
Ikon. Di recente, stimolato anche dalla particolarità della situazione politica italiana, si è sviluppato
un interesse sulle modalità di influsso reciproco tra media diversi come televisione e stampa o
sulla nascita e lo sviluppo di grosse concentrazioni industriali nel campo dei media.
6