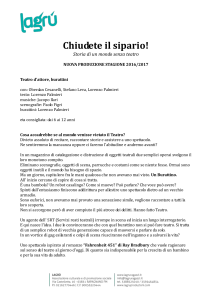Quaderno n.2
Nero su Bianco edizioni
Luglio 2011
a cura di
Graziano Graziani
Matteo Vallorani
con Bernardo Brogi
Hanno collaborato
Matteo Boscarol
Alessandra Cava
Manuela De Leonardis
Luca Scarlini
Serena Terranova
Cinzia Toscano
Disegni di
Brochendors Brothers
Anna Deflorian
Impaginazione
Brochendors Brothers
Anna Deflorian
In collaborazione con
il Coordinamento critico-organizzativo di
Santarcangelo 2009/2011
Si ringrazia
Keiko Shiraishi
www.santarcangelofestival.com
www.altrevelocita.it
COME NON DETTO
Parlare di Seinendan vuol dire parlare di Giappone. Non solo
perché questa compagnia, tra gli ospiti di punta di Santarcangelo 41, è
una delle più importanti della scena del Sol levante. Ma anche perché
dietro all’interesse per il suo lavoro si nasconde la curiosità per un
paese che ha fortemente contaminato il nostro immaginario ma di cui,
in fondo, conosciamo ben poco, soprattutto a livello teatrale. Per questo
il quaderno dedicato a Oriza Hirata e alla sua compagnia si apre con
il tentativo di tracciare un panorama del contesto artistico nipponico,
dove inquadrare la ricerca e il metodo del regista giapponese.
Si parte con delle breve considerazioni sul teatro giapponese
passato per le piazze italiane, utilizzando il festival di Santarcangelo
come visuale privilegiata, che traccia la silhouette di una scena aperta a
innumerevoli stili e contaminazioni, in dialogo con altri campi dell’arte.
Da qui si diramano gli approfondimenti che tre critici e studiosi tracciano
nei rispettivi settori: la scena teatrale, l’arte visiva, il cinema.
La seconda parte del quaderno è dedicata all’incontro con
Oriza Hirata, il suo teatro e il suo metodo. Partiamo da una lunga
conversazione con lui, sulle origini della compagnia e della teoria che
ha elaborato durante i primi anni di lavoro; mentre le recensioni degli
spettacoli ci danno conto della sua estetica e della sua particolare
ricerca drammaturgica. Infine, attraverso un doppio report, raccontiamo
quanto accaduto nel laboratorio per attori professionisti che il regista
giapponese ha tenuto nell’ambito del festival: da un lato gli esercizi
compiuti, presentati come una sorta di “metodo Hirata”; dall’altro la
raccolta delle impressioni degli attori italiani, che si sono confrontati
con un approccio formativo molto diverso da quelli diffusi qui da noi.
La visione d’insieme è una sorta di mappa di un teatro di parola
che parla, più che tramite il testo, attraverso ciò che la parola non dice.
Graziano Graziani
3
INDICE
Big in Japan
pag.5
Così lontano, così vicino
pag.7
Conversazione con Hirata
pag.17
Cos’è Seinendan
pag.23
Tokyo Notes — recensione
pag.25
The Yalta Conference — recensione
pag.27
Lasciar cadere le parole — il metodo Hirata
pag.29
Da oriente a occidente
pag.35
Bibliografia essenziale
pag.39
4
GRAZIANO GRAZIANI
BIG IN JAPAN
Una breve riflessione sul teatro giapponese in Italia, attraverso il prisma
del festival di Santarcangelo. Ritratto di una scena ricca, estremamente
variegata e per molti aspetti ancora misconosciuta.
L’idea di teatro giapponese che abbiamo in Italia è generalmente
legata alle grandi tradizioni di quel paese, il Nō e il Kabuki, con qualche
curioso che si spinge fino al Rakugo, un genere comico tradizionale. In
epoca più recente il Butō, la “danza delle tenebre” nata come reazione
all’olocausto nucleare, si è conquistato una sua nicchia di visibilità. A ben
vedere un panorama piuttosto parziale per un paese che abitualmente
inonda il nostro immaginario a più livelli, dalla tecnologia al cinema,
dai fumetti all’arte visiva. L’idea di un paese incastonato nel contrasto
irriducibile tra una modernità strabordante e un passato ipercodificato
è, a quanto pare, l’unica griglia estetica in cui riusciamo a incasellare il
Giappone. Certo, a differenza del cinema e dell’animazione, che possono
contare anche sulla diffusione via web a costo zero, il teatro è un oggetto
artistico con cui è più difficile entrare in contatto: i costi sono elevati e
la barriera culturale della lingua è più difficile da superare che in altri
settori dell’arte. Eppure la curiosità verso il paese del Sol Levate cresce,
e le programmazioni dei festival la seguono di pari passo, proponendo
al pubblico italiano alcuni dei protagonisti di una scena contemporanea
ancora praticamente ignota al grande pubblico.
Anche il festival di Santarcangelo è stato un link di questa rete
di curiosità. Se guardiamo anche solo all’ultima triennalità, che si
5
Graziano Graziani
conclude quest’anno, troviamo in programma almeno una compagnia
giapponese per edizione. Una coincidenza – ma nessuna coincidenza
è davvero tale –, vista la grande distanza tra i progetti che hanno
dato corpo agli ultimi tre festival: il suono per Chiara Guidi nel 2009, il
rapporto tra realtà e finzione per Enrico Casagrande nel 2010, il ruolo
dell’attore per Ermanna Montanari nel 2011.
Due anni fa, con White lives on speaker, il duo composto da
Yoshimasa Kato e Yuichi Ito dava vita a delle figure antropomorfe con
l’amido di riso, che grazie alle vibrazioni di un subwoofer si modellavano
e si muovevano per poi ricomparire al cessare delle onde sonore. Una
ricerca sonora ed estetica che sconfina nell’arte visiva, più vicina a
un’istallazione che a una rappresentazione, eppure intimamente
teatrale nel tentativo di attingere alla sfera emozionale, persino
sentimentale, degli spettatori. L’anno scorso i Fai Fai hanno messo in
scena uno spettacolo corrosivo per il ricorso estremo al pop e a un
gusto surreale tutto interno alle derive kitsch e trash dell’immaginario
nipponico contemporaneo. My name is I love you, un lavoro che non
ha mancato di dividere il pubblico, ruotava attorno allo stereotipo
romantico di cui l’industria culturale del Sol levante si nutre con
ingordigia, che puntualmente si rovescia nel suo opposto soft-porn.
Nel mezzo una serie di simboli – il fedele cane Hachiko, i manga, i
robot – che siamo abituati ad attribuire più al cinema giapponese che
al teatro. Infine quest’anno Oriza Hirata presenta due lavori – Tokyo
notes e The Yalta Conference – dove il fulcro è la drammaturgia. Ma una
drammaturgia costruita come reagente agli stereotipi della scrittura
teatrale del Novecento europeo, che cerca il significato più tra i silenzi
e nelle interruzioni delle frasi che non nella parole stessa e nel suo
significato. Una ricerca che si rapporta allo stile colloquiale giapponese
e che dunque è estremamente connaturato a quella cultura, ma
allo stesso tempo non si può fare a meno di notare di come essa sia
consonante con l’idea di teatro post-drammatico che si è delineato
nell’ultimo decennio nel vecchio continente.
Questi spettacoli rappresentano tre discorsi autonomi che
aprono l’arte scenica verso orizzonti estremamente differenti tra loro:
l’arte istallativa, il pop, la ricerca drammaturgica e il quotidiano. Ma
proprio nella loro estrema diversità essi ci danno testimonianza di
una scena ricca ed estremamente reattiva, aperta a forme di ricerca e
contaminazione radicale che vanno ben al di là di qualunque stereotipo.
Che poi è il compito del teatro, o almeno del teatro che produce senso.
6
LUCA SCARLINI / MANUELA DE LEONARDIS / MATTEO BOSCAROL
COSÌ LONTANO, COSÌ VICINO
Immagini, sogni e ossessioni del paese del Sol levante sono entrate ormai
stabilmente nel nostro immaginario, ma nonostante ciò il Giappone resta
un grande sconosciuto. Abbiamo chiesto a tre critici e studiosi di ambiti
diversi di tracciare una panoramica delle estetiche che animano il dibattito
artistico nel Giappone contemporaneo, tra cinema, teatro e arti visive.
TEATRO
Hirata e gli altri
Dal Giappone sono arrivati nei decenni postbellici vari segnali che
hanno interagito con il mondo dello spettacolo occidentale. Se molti
sono stati quelli che hanno sentito il fascino delle codificazioni del Nō
e del Kabuki, nelle loro strutture altamente formalizzate, altrettanto
importante è stato l’impatto che il Butō ha avuto sull’immaginario euroamericano, con infiniti (e spesso assai noiosi) imitatori. Poco o niente
fino ad ora si sapeva invece del repertorio di drammaturgia del paese,
ricco, variato e per molti aspetti sorprendente, con il solo Mishima Yukio
che compariva qualche volta nei repertori con pièces come Madame
de Sade (di cui resta memorabile la versione passata anche in Italia
diretta da Ingmar Bergman, con un manipolo di indimenticabili attrici).
Mancano da noi anche i classici del nuovo dramma novecentesco, ad
esempio è stato pubblicato solo un testo di Tanizaki Jun’ichirō e oggi,
dopo tanto cinema, tanta narrativa in forma di libro e di manga, è il
7
Luca Scarlini, Manuela De Leonardis, Matteo Boscarol
momento di osservare quello che è il filo di maggiore interesse nei
teatri di Tokyo, spesso definiti come palcoscenici-studio, nella tradizione
della celeberrima sala Bungakuza, dove Mishima si divertiva ad andare
in scena nel Britannicus di Racine e dove si susseguono ancora oggi
stagioni fitte di proposte.
Hirata Oriza, notissimo nel suo paese anche come giornalista,
con moltissimi fans per le sue rubriche dai titoli curiosi (Di nuovo a
casa, Stavo per farlo) da quando iniziò la sua attività. L’autore è ormai
popolarissimo in Francia, dove non si contano più le versioni dei suoi
numerosi lavori, che spesso giocano con l’autobiografia, come è tipico
di uno scrittore che ha inaugurato giovanissimo la propria produzione,
con un lavoro intitolato Oriza e il test di ingresso all’università. Fino
dall’inizio la sua attività si riferisce alla compagnia da lui fondata,
Seinendan, in cui svolge anche attività registica, ma anche didattica,
facendo da trait d’union tra le varie generazioni. Non si contano ormai
i premi, i riconoscimenti, le segnalazioni, le critiche positive che hanno
accolto i suoi titoli più noti, come la magnifica opera corale Gente di
Seoul (1989), in cui una melanconica trama di affetti, dall’impatto
quasi cechoviano, è ambientata nella capitale coreana nel 1909, poco
prima dell’occupazione nipponica o Tokyo Notes (1995) che narra la
contemporaneità del suo paese attraverso la visione di frammenti. Al
centro del suo lavoro c’è una riflessione sulla lingua, di cui ha dato
conto anche in un manifesto come La teoria dello stile parlato nel
teatro contemporaneo, in cui spiega la sua attrazione per il racconto
in scena dei momenti di quiete, delle pause che svelano molto
più delle parole. La conferenza di Yalta (2002) è un detour verso la
commedia nera, indagata nei suoi aspetti più estremi. Il modello è il
“rakugo”, una forma di intrattenimento comico popolarissima nel Sol
Levante, in cui un interprete virtuoso (se ne ricordano moltissimi del
Periodo Edo, che suscitavano un vero e proprio delirio di folla e molti
sono quelli apprezzati oggi, tra cui Kaytsura Shijaku, noto per le sue
rappresentazioni in inglese) sale in scena e racconta una storia buffa,
potendosi servire solo di un ventaglio come unico accessorio. Il termine
ha come significato “lasciar cadere le parole” ed è esattamente quello
che fanno i tre comici presidenti, impegnati a decidere del destino del
mondo, tra bizze, capricci, infantilismi e incontinenze uriche. Il potere
viene quindi raccontato come un mockumentary, finto documentario
irridente e perfido, oppure come uno scalcinato spettacolino di periferia,
pieno di volgarità e di doppi sensi, nel momento in cui, con un grande
8
Così lontano, così vicino
trauma nazionale, per la prima volta l’esercito del suo paese torna in
guerra, nei bruciati paesaggi iracheni. Un lavoro che gioca con diversi
piani di scrittura, ma che spesso si confronta anche con la danza e
con installazioni site specific, come l’affascinante progetto Community
Cafè, a Osaka, un vero e proprio luogo di ristoro, dove ogni giorno per
due ore intellettuali e artisti parlano dei temi più diversi in forma di
performance.
La vita metropolitana in tutti i suoi aspetti è anche il filo rosso
del lavoro di Okada Toshiki, anch’egli segnalato nel vivaio del teatro
Seinendan. Dopo gli studi di economia, ha scelto come nome per la
propria attivissima compagnia Chelfitsch, una storpiatura infantile
dell’aggettivo inglese che definisce “egoista”, termine che a suo parere
ben rappresenta il Giappone di oggi rispecchiato nei suoi più segreti
moventi. Nella notte illuminatissima di Roppongi è infatti il notissimo
locale Super De Luxe a accogliere una recente performance, Free time,
che reca sul poster immagini disegnate con un tratto bambinesco, per
descrivere un tempo libero che diviene una sofisticata trappola per
individui e collettività, nel dialogo muto tra una donna seduta in un
ristorante a riempire un quaderno di disegni privi di senso e una cameriera
che si sforza di intuire il loro significato. Il physical theatre è un punto di
riferimento costante per questa scrittura, messa in scena da attori che
sono anche danzatori. Nel breve spazio di un decennio la sua attività
è venuta prepotentemente alla ribalta nel suo paese, come all’estero,
con ottimi risultati anche in Europa, tra il KunstenFestivalDesArts di
Bruxelles e Uovo a Milano. I suoi lavori principali hanno titoli ironici, come
On the harmful Effects of Marihuana (2003), Five Days in March (2004),
Air-Conditioner (2004), The End of Toil (2005). In Air Conditioner due
performer abbigliati con pantaloni neri e camicia bianca, con identici
occhiali, mettono in discussione lo statuto del testo e dello spettacolo,
suddividendone la scansione in un minimalismo spietato, portato alle
estreme conseguenze, come un match di rara violenza che è sempre e
solo alluso, in cui argomento del contendere è un condizionatore d’aria
che è tenuto troppo alto. Altrettanto forte è l’impatto di Cinque giorni
a marzo, che rimane il suo titolo più noto. Sullo sfondo di un love hotel
a Shibuya, si incrociano e disperdono i destini di personaggi spesso
alla sbando, che hanno l’età dei loro interpreti, mentre fuori scoppia
su tutti i megaschermi la cronaca televisiva dell’inizio della guerra
in Iraq, il 21 marzo 2003, un evento che, come già detto, riportando
all’attenzione l’esercito nipponico, mette radicalmente in discussione
9
Luca Scarlini, Manuela De Leonardis, Matteo Boscarol
abitudini, ritmi, modi di vita. Come in un grande affresco corale, scena
dopo scena si compone il ritratto di un paese in crisi di identità, che
rivede davanti a sé il temuto spettro della guerra. Uno straordinario
lavoro iperrealista, quindi, che mette in azione una precisa vocazione
alla mimesi del quotidiano, con i comportamenti fotografati con una
nitidezza cruda, che a tratti diventa geniale coreografia della banalità
verbale e gestuale.
Luca Scarlini
(storico dello spettacolo, studioso di drammaturgia contemporanea)
Adattamento ad opera dell’autore dell’introduzione
a Teatro Giapponese Contemporaneo [Roma, Editoria & Spettacolo, 2009]
∗∗∗
ARTE CONTEMPORANEA
Foto, manga e arte condite con salsa di soia
Rumoroso e alienante il pachinko quanto fluttuante l’ukiyo-e.
Mondi a confronto, confini che si intercettano e si perdono gli uni negli
altri, come i fiori di pesco e le rocce di un giardino zen in mezzo alle luci
artificiali del quartiere di Shinjuku a Tokyo. Luoghi comuni come i semi
di sesamo sui fagiolini conditi con miso e mirin.
Nel Giappone contemporaneo anche le arti visive ascoltano i ritmi
delle contraddizioni, proiettandosi nel futuro – che sia delirante e pop
come per Takashi Murakami (1962), tra i più quotati artisti della scena
(non a caso è entrato da tempo a far parte della “scuderia” di Gagosian)
– ma rimanendo legati a quel filo sottile che si chiama passato.
Del resto il manga stesso, considerato fuori dai confini nazionali un
prodotto di serie B, nel Sol Levante è un’arte dalle varie sfaccettature,
riconosciuta anche dalla presenza a Kyoto dell’International Manga
Museum che, oltre ad ospitare centinaia di volumi ordinatissimi e
colorati, destinati ad un pubblico di tutte le età, organizza workshop,
seminari e mostre invitando artisti di ogni dove. La Tokyo Art Fair, dal
2005 l’appuntamento fieristico dedicato all’arte contemporanea più
importante del paese, quest’anno è slittata alla fine di luglio, a causa del
10
Così lontano, così vicino
terremoto di cui tutti sappiamo. In attesa di quello che verrà presentato,
possiamo dare comunque uno sguardo rapido alle tendenze.
Da una parte ci sono i grandi dissacratori, artisti che hanno
scardinato il concetto di equilibrio caro all’estetica giapponese,
sperimentando ognuno il proprio linguaggio significativo. Artisti come
Shozo Shimamoto (1928), proveniente dal Gutai, e fotografi come
Shomei Tomatsu (1930), Eikoh Hosoe (1933), Daido Moriyama (1938),
Nobuyoshi Araki (1940), hanno in comune il dramma della guerra, gli
echi di Sartre e dell’Esistenzialismo.
Se Shimamoto, ad esempio, nelle sue pitture e performance degli
anni Sessanta rompeva gli schemi del quadro tradizionale, bucando,
spruzzando colori – ispirato dalla gestualità dell’Action Painting – allo
stesso modo fotografi come Hosoe, la cui poetica è stata attraversata
nel tempo dalla presenza di Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno – fondatori
della danza Butoh e Yukio Mishima –, usa tonalità estreme del bianco
e nero, arrivando ad un minimalismo che annulla dettagli superflui per
filtrare la descrizione del reale. Il perché lo spiega lui stesso: «Gli anni
Sessanta non erano certo anni tranquilli, come al tempo dei paesaggi
di Ansel Adams. Era un periodo politicamente agitato che urlava.
Anch’io sentivo che dovevo urlare. Non potevo trovare mezze misure,
sfumature: dovevo insistere sui contrasti. Da quest’idea nasce Man
and Woman, il lavoro più importante di quegli anni. Avevo ventisei anni
quando l’ho realizzato. Ero giovane e vigoroso. Il sesso era, all’epoca,
l’argomento affrontato dalla cultura in generale».
Di sesso parlano anche le immagini di Moriyama e Tomatsu, ma
certamente è Araki che ne ha fatto il proprio stilema: non solo Bondage,
anche Love Stories e Tokyo Diary sono vicini all’immaginario dei peep
show e lingerie bar di cui parla Ryu Murakami nei suoi romanzi.
Intorno al mito individuale e collettivo si concentrano, invece,
Orimoto Tatsumi (1946) e Yasumasa Morimura (1951). Il primo utilizza
la maschera di pane (baguette, pagnotte, rosette, filoni, legati con lo
spago) con cui, annullata la propria individualità, attraversa i luoghi del
sociale creando un cortocircuito sotto gli sguardi indifferenti o beffardi di
un pubblico immerso nella quotidianità.
Al mito collettivo, invece, guarda – ribaltandolo – Morimura,
vestendo egli stesso i panni degli eroi del XX secolo, da Mao a Hitler,
Charlie Chaplin, Che Guevara, Einstein…
Decisamente agguerrite le artiste Mako Idemitsu (1940), Miyako
Ishiuchi (1947), Miwa Yanagi (1967): non è casuale che facciano tutte
11
Luca Scarlini, Manuela De Leonardis, Matteo Boscarol
parte della collettiva Global Feminisms. New directions in Contemporary
Art, organizzata nel 2007 dal Brooklyn Museum di New York.
Per molte di loro, soprattutto quelle meno giovani, si è trattato
di portare avanti istanze che andavano a cozzare contro tradizioni
secolari di devozione, ossequio e sudditanza nei confronti del maschio.
Pur rifiutando spesso la definizione “femminismo”, il pensiero espresso
in modo più o meno consapevole all’interno delle loro opere, che non
sono specificamente legate a questa ideologia, crea un’ambiguità
tipicamente giapponese.
Torniamo, infine, a citare l’haiku (ed implicitamente il mondo
fluttuante) con Masao Yamamoto (1957) e Rinko Kawauchi (1972),
interpeti di una visione intima e sospesa nella quale prendono forma le
emozioni. Un tipo di narrazione fotografica che focalizza la poesia delle
piccole cose, il soffio della vita (ibuki in giapponese), ovvero tutti quei
momenti prevedibili che diventano unici.
Fotografare, per la Kawauchi, è come cucinare: «Amo cucinare. Mi
piace molto sia la cucina italiana che quella giapponese. In particolare,
adoro un tipo di pasta italiana da brodo, i semi di melone. Quanto alla
cucina giapponese c’è un piatto per cui vengo lodata da tutti, si chiama
‘Chikuzenni’. È un bollito di vari tipi di verdura, tra cui funghi giapponesi,
carote, bardana, germogli di bambù, radice di loto… L’importante è che
non manchi la salsa di soia».
Manuela De Leonardis
(Critica e storica dell’arte)
∗∗∗
CINEMA
Cinematografia d’autore ibrida e pop
Anni di passaggio, periodo di trasformazione. Sembrano
espressioni trite, ma mai come in questo caso sono le parole più adatte
a descrivere la situazione cinematografica, ed audiovisiva in generale,
del Giappone contemporaneo. Da una parte il cinema giapponese che
è esploso durante la metà degli anni Novanta si assesta o trova una
12
Così lontano, così vicino
definitiva celebrazione internazionale con le opere dei registi emersi
allora, dall’altra autori più giovani e nuove leve cominciano a farsi
notare dal pubblico degli appassionati anche grazie alla rivoluzione
digitale ed al fondamentale apporto di internet come nuovo canale
di distribuzione e di fruizione. Se aggiungiamo la triplice catastrofe
terremoto-tsunami-nucleare che ha recentemente colpito l’arcipelago
nipponico sarà chiaro come il passaggio non sia relativo solo al cinema
ma che la trasformazione, dolorosa ma inevitabile, sarà necessaria alla
società giapponese nel suo complesso.
Naturalmente in questi ultimi anni continua a svilupparsi, in alcuni
casi con grandi risultati, il cinema della cosiddetta nuova onda, quella
nata negli anni Novanta con nomi che oggi sono ormai parte della
cinematografia internazionale come Takeshi Kitano, Shinya Tsukamoto,
Shinji Aoyama, Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa o Hirokazu Kore’eda,
solo per citare i nomi più noti. Tsukamoto intensifica e stilizza la sua
poetica che diviene più essenziale, perde un po’ della freschezza degli
inizi ma è un processo inevitabile ed è meglio così, anzi con gli anni il
regista di Tokyo va a comporre una filmografia tra le più interessanti
degli ultimi decenni. La progressiva disintegrazione del nucleo familiare
tradizionale, almeno così come è stato concepito fino a qualche decennio
fa, e la crisi economica che continua a destabilizzare e in alcuni casi
a cambiare radicalmente alcuni pilastri su cui si fondano la società e
l’animo nipponico, offrono un terreno fertilissimo su cui Tsukamoto può
far germinare le sue fobie e ossessioni. Il regista continua così la discesa
nell’animo e nell’inconscio dell’uomo, della metropoli e della società con
una lucidità che ha pochi eguali: A snake of June (Rokugatsu no hebi,
2002) e Vital (2004) sono due esempi di come sempre di più il corpo sia
il crocevia e il crogiolo attraverso cui passano tutte le problematiche, le
tensioni sociali e politiche che animano la contemporaneità.
In questo senso un altro autore importante è Mamoru Oshii,
definitivamente consacrato a livello internazionale nel 2004 quando il
suo film d’animazione Innocence (Innocensu, 2004) viene invitato al
Festival di Cannes. È una data storica non solo per Oshii ma anche
per l’animazione, che nello stesso periodo vede la celebrazione
internazionale di almeno altri due autori: Hayao Miyazaki, vincitore nel
2002 dell’Orso d’oro a Berlino e dell’Oscar 2003 con La città incantata
(Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001) e Satoshi Kon – scomparso lo
scorso anno a soli 46 anni – con Paprika (Papurika, 2006).
13
Luca Scarlini, Manuela De Leonardis, Matteo Boscarol
Uno dei temi che attraversano trasversalmente tutti i generi
cinematografici e televisivi è senza dubbio quello della famiglia
tradizionale che implode e che si apre mostrando l’inadeguatezza e la
debolezza delle strutture sociali e politiche giapponesi che la attraversano.
Quasi tutti gli autori più importanti ci sono passati, ma l’opera che forse
sintetizza il tutto nel modo migliore è Tokyo Sonata (2008) di Kiyoshi
Kurosawa.
Un regista che i temi e gli stili li ha toccati praticamente tutti,
con una filmografia fluviale di ben 85 titoli in vent’anni, è Takashi Miike.
Si fa conoscere al pubblico internazionale con l’eccessivo Audition
(Odishon, 2000) che apre simbolicamente il terzo millennio. Se agli
inizi è un regista selvaggio e quasi sperimentale, negli ultimi anni si
sta specializzando in remake di “jidai-geki” peraltro ottenendo risultati
sorprendenti: 13 Assassins (2010) è stato a Venezia e sarà distribuito
nelle nostre sale questa estate; Harakiri: Death of a Samurai (2011) è
in competizione quest’anno a Cannes.
Discorso a parte va fatto per Kitano, il regista giapponese più
noto all’estero: va preso atto di come il suo cinema si sia parzialmente
involuto, o meglio, le sue opere della seconda metà del decennio a
partire da Takeshi’s (2005), pur rimanendo delle interessanti puntate
in territori più personali, non hanno offerto niente di nuovo rispetto
all’opus sviluppato nei Novanta (Hana Bi, Sonatine). Chi invece è
andato crescendo è Hirokazu Kore’eda, autore nato e cresciuto nel
mondo del documentario, retroterra che stilisticamente rimane sempre
ben presente in quasi tutti i suoi lavori, essenziali e scarni nella messa
in scena ma sempre di forte impatto emotivo. Vuoi quando trattano
temi legati alle sette religiose come in Distance (Disutansu, 2001), vuoi
quando riesce a descrivere la vita di quattro bambini abbandonati dalla
madre in Nobody Knows (Daremo shiranai, 2004). O ancora quando con
un tocco lieve e dichiaratamente alla Ozu si cimenta, in Still Walking
(Aruitemo aruitemo, 2008), nel racconto e descrizione di una riunione
familiare, delle piccole cose e del passaggio del tempo.
Tutti i film e gli autori che abbiamo fin qui trattato sono spesso
presenti nei festival internazionali, ma in patria succede, come spesso
per il cinema cosiddetto d’autore, che non godano di una popolarità
massiccia.
Quali sono allora i film che attirano il grande pubblico al
botteghino? Una costante è sicuramente l’animazione dello Studio Ghibli
ed in particolare le opere di Hayao Miyazaki; il decennio è costellato di
14
Così lontano, così vicino
suoi successi, dal clamoroso Spirited Away (titolo internazionale de La
città incantata) del 2001 a Ponyo del 2008. Un’innegabile tendenza è
quella che vede premiati prodotti nati dalla televisione e poi trasferiti
sul grande schermo – drammoni sentimentali, polizieschi o quant’altro
– oppure, in un processo ancora più totalizzante e dannoso perché di
fatto blocca nuove idee e attori emergenti, la continua produzione di
film che fungono solo da contenitore per mostrare l’idol del momento. Il
problema non è tanto, o non solo, l’impiego di questi volti televisivi, ma
la standardizzazione dei prodotti che trasformano il grande schermo in
una succursale della televisione.
La sorpresa degli ultimi anni ha però proprio un’origine
“televisiva”: l’esordio alla regia del famosissimo comico del piccolo
schermo Hitoshi Matsumoto. Matsumoto prima sorprende tutti con
una personalissima rivisitazione del tema del supereroe triste in Big
Man Japan (Dai-nipponjin, 2007), per poi spingersi ancora più in là con
l’astratto Symbol (Shinboru, 2009) ed infine firmare il suo capolavoro
con Scabbard Samurai (Saya samurai, 2011). Unica ed originale è
anche l’opera di Shion Sono, talento capace di incarnare nelle sue opere
stilemi del cinema di genere (horror, b-movie) e una visione del mondo
poetica e perversa al di là di ogni convenzione sociale. Regista, poeta
ma anche attore, dopo lavori molto discussi come Strange Circus (Kimyô
na sâkasu, 2005) e soprattutto Suicide Circle (Jisatsu sâkuru, 2001),
realizza il suo capolavoro con Love Exposure (Ai no mukidashi, 2008),
una galoppata di quattro ore dove riesce a mescolare perversione,
sette religiose e amor fou in un film generazionale sui generis. Il suo è
un cinema d’autore ma ibrido, “sporco”, che si nutre di b-movie, soft
porno, pop ma anche sperimentazione, che mescola l’alto e il basso con
grande visionarietà e vitalità, sempre insofferente verso le costrizioni
e gli apparati di cattura delle società contemporanee. In questo senso
è forse l’autore che meglio rappresenta la cinematografia giapponese
contemporanea, tanto che il Festival di Torino gli dedicherà quest’anno
una retrospettiva.
Matteo Boscarol
(Critico cinematografico – Alias, Il manifesto)
15
16
BERNARDO BROGI, CINZIA TOSCANO, MATTEO VALLORANI
CONVERSAZIONE CON HIRATA
Classe 1962, Oriza Hirata ha iniziato a lavorare giovanissimo come
drammaturgo, e oggi la sua compagnia, Seneindan, è tra i nomi di
punta della scena contemporanea giapponese. L’arte di Hirata e la sua
scrittura sono conosciuti ben oltre gli steccati del mondo teatrale, e la sua
compagnia è ormai una presenza fissa in Europa, soprattutto in Francia. In
una lunga conversazione con l’osservatorio critico, Hirata ha raccontato
le origini della sua carriera e le coordinate del suo metodo che cerca di
inventare, attraverso la colloquialità, delle forme che restituiscano la lingua
giapponese reale al di là degli stereotipi linguistici dei drammi europei.
Come si è avvicinato al teatro? E come nasce la compagnia Seneindan?
Sono nato in una famiglia di artisti, mio padre faceva teatro, vivevo
in quell’ambiente già prima di diventare famoso. Quando mi chiedono
di raccontare la mia vita mi piace cominciare dal viaggio in bici intorno
al mondo che ho fatto a sedici anni, perché il mio debutto da scrittore, a
diciotto anni, è stato proprio il diario di quel viaggio. Dopo quella prima
pubblicazione ho sentito di non essere portato per le cose così legate
alla realtà e mi sono avvicinato al mondo del teatro. All’università
non ho scelto ambiti artistici, ma ho formato una compagnia teatrale.
All’epoca non pensavo che potesse durare così tanto: era l’hobby di un
gruppo di studenti… Ma sono passati più di trent’anni!
17
Bernardo Brogi, Cinzia Toscano, Matteo Vallorani
Il mio sogno, in realtà, era fare lo scrittore. Sapevo che non ero
molto adatto a fare il regista, così per lo più scrivevo i testi. Ogni tanto
mi cimentavo nella regia ma i miei spettacoli venivano troppo seri,
enigmatici e spesso troppo drammatici: non erano apprezzati dai miei
amici che mi hanno consigliato di restare drammaturgo.
Un’altra esperienza molto importante per la mia formazione
di scrittore è stato il soggiorno in Corea. Io sono nato in uno stato
democratico, in una città cosmopolita come Tokyo, quindi andare in
Corea significava immettersi in una situazione completamente diversa.
Quel soggiorno mi ha aiutato a scrivere in maniera più umana: prima
scrivevo cose ideologiche o utopiche, invece lì mi sono avvicinato alla
vita vera. Oltretutto vivere in Corea e studiare la lingua coreana mi hanno
aiutato a comprendere meglio la lingua giapponese: ho cominciato a
vedere la lingua giapponese e ad analizzarla come un oggetto esterno.
Dopo questo soggiorno sono tornato in Giappone e più o meno dopo
due anni ho ripreso a occuparmi della regia teatrale. La teoria attuale
l’ho formata in circa tre anni di lavoro. Il periodo più faticoso non è stato
quello in cui ho stabilito la teoria, ma quello in cui ho dovuto applicarla.
Quali difficoltà pratiche ha trovato nell’applicare le sue teorie?
Sentivo di aver fatto una teoria giusta, ma non ne capivo l’utilità.
Nell’89 ho scritto un testo, Cittadini di Seoul, ambientato nell’epoca
coloniale, quando la Corea era una colonia giapponese; lo spettacolo
racconta una giornata qualsiasi di una famiglia giapponese che viveva
in Corea. Non vediamo nessun elemento aggressivo, come la presenza
militare o la corruzione politica, e ci sono poche battute che mostrano
quanto i giapponesi considerassero inferiori i coreani. Ma è proprio
in questo contesto di assoluto realismo che emerge l’aggressività di
quella situazione. Questo spettacolo per me è stato la dimostrazione
che la mia teoria del super-realismo poteva essere applicata.
Il suo metodo ha lo scopo di superare gli stereotipi teatrali importati
dall’occidente. Che rapporto ha questa impostazione con la lingua?
In Giappone la musica e l’arte sono materie scolastiche. Quando
abbiamo iniziato ad importare musica dall’occidente, quindi, lo abbiamo
fatto con una certa cautela ed è stato possibile creare una nuova forma
di musica e di arte giapponese basate sullo stile occidentale. All’inizio
18
Conversazione con Hirata
c’è stato anche un processo di imitazione, ma già nell’atto di copiare
sceglievamo sonorità più simili alle nostre: per esempio la musica
giapponese tradizionale ha più o meno la stessa scala delle musiche
popolari scozzesi o irlandesi. Per il teatro non è stato così. L’importazione
di spettacoli occidentali è avvenuta dal 1920 in poi tramite i privati, non
era quindi un’importazione organizzata. Gli studenti andavano a vedere
gli spettacoli al teatro Odeon, l’unico teatro che faceva spettacoli
occidentali tradotti in giapponese, e copiavano le battute e i dialoghi
per poi andare a riprodurli in maniera identica. La cosa buffa è che per
apparire occidentali mettevano agli attori parrucche di capelli biondi
e nasi finti: cercavano di copiare persino le sembianze fisiche. Come
sapete noi giapponesi siamo bravissimi a copiare. Ne è un esempio Yukio
Mishima: lui è riuscito a copiare gli scrittori occidentali ma scrivendo in
lingua giapponese. I testi di Mishima sono dei capolavori perfetti, ma
nessun giapponese parlerebbe mai nel modo da lui descritto.
Io ho cercato una tensione verso la lingua giapponese parlata,
cercando di rispettare anche l’ordine delle parole, la costruzione della
frase così come suona quando è detta. Una volta lessi su un manuale
di recitazione che per porre l’attenzione su una parola della frase
bisogna enfatizzarla. Se dicendo “questo è un bicchiere” vuoi portare
l’attenzione sul fatto che il bicchiere è questo e non un altro devi dire
“questo è un bicchiere”; se invece vuoi dare più attenzione al fatto che
è un bicchiere e non un’altra cosa dici “questo è un bicchiere”. Quindi
la tecnica è porre l’accento sulla cosa che più interessa. In giapponese
non funziona così: si può anche ripetere tante volte una parola se la
vuoi accentuare (“questo è un bicchiere bicchiere bicchiere”). La lingua
giapponese è abbastanza piatta nelle intonazioni o negli accenti, mentre
le lingue occidentali sono più “movimentate”. Quando hanno importato
il teatro occidentale in Giappone, oltre ad aver tradotto mantenendo lo
stile parlato occidentale, hanno anche applicato le metodologie della
recitazione e della scrittura ad esso legate: il risultato è così innaturale
da non essere credibile. Per fare uno spettacolo realistico, per raccontare
la vita vera dei giapponesi, non potevamo utilizzare quel linguaggio.
In che rapporto è il suo lavoro con i generi tradizionali del teatro giapponese come il Nō e il Kabuki?
Sono forme di teatro molto diverse dalla mia, ma soprattutto
usano linguaggi molto lontani, linguaggi medievali, antichi. Quindi se
19
Bernardo Brogi, Cinzia Toscano, Matteo Vallorani
mi chiedi cosa ho introdotto di quella tradizione nel mio teatro devo
dirti “niente”. Sicuramente però ho preso spunto dai testi tradizionali:
nel teatro tradizionale è importantissimo come finisce la battuta
precedente per l’attacco della battuta successiva; oppure nel teatro
del Nō, c’è sempre una presenza, un osservatore sul palcoscenico, oltre
all’attore che recita. In Tokyo notes si nota molto bene come anche per
me debba esserci sempre una presenza in più, un osservatore, rispetto
a chi è impegnato nella conversazione: questo deriva dal teatro Nō.
Lei ha realizzato, con l’università di Osaka, il progetto Robot-Human
Theatre: laboratorio e spettacolo per attori robot. Che fine fa l’attore?
Se devo dire la verità, sono sicuro che sostituire al cento per cento
gli attori vivi con dei robot non sarà fattibile, almeno prima di cento
anni. Non è una cosa impossibile, ma già il solo fatto che sia una cosa
teoricamente possibile ci fa riflettere su cosa sia il teatro e su cosa sia il
lavoro dell’attore. Quest’elemento diverso può aiutare la comprensione
del teatro, offrendo un confronto. Nel progetto Robot-Human Theatre,
che porterò a Palermo il prossimo settembre, uso dei robot non molto
raffinati. Eppure questi robot, abbastanza semplici, vengono percepiti
dalla maggior parte del pubblico come “vivi”, pieni di sentimenti, come
se avessero un cuore.
Non penso sia una cosa così strana: succede anche che il pubblico
immagini cattivo un attore che semplicemente interpreta il ruolo di un
uomo malvagio. Quindi una parte della mia ricerca è proprio indirizzata
a questo: che la regia possa essere così precisa e ben strutturata da far
credere che anche dei robot abbiano un’anima.
Allora quanto il lavoro dell’attore è attivo e quanto invece è meccanico?
Ovviamente preferisco un attore bravo, capace ed espressivo. Un
attore bravo ha una capacità che non si può sostituire con niente, né
con la tecnologia, né con la regia. In Tokio notes c’è un personaggio
molto importante, la moglie tradita che rimane spesso con la cognata:
quel ruolo lì è stato scritto per un’attrice specifica, che poi ha portato
avanti il ruolo per quindici anni e nessuno ha mai pensato che si potesse
sostituire con un’altra attrice. Quando a quarantacinque anni rimase
incinta, e non poté più andare in scena, è stata sostituita con la ragazza
che avete visto in scena a Santarcangelo. All’inizio cambiare l’attrice ha
20
Conversazione con Hirata
creato uno scompiglio totale: dalle difficoltà create a causa della sua
diversità si capisce quanto la presenza di un attore sia fondamentale.
Però dopo un anno la sua presenza è diventata normale e oggi nessuno
potrebbe immaginare un’attrice diversa per quel ruolo. In qualche modo
il lavoro dell’attore è anche un po’ triste: per quanto sia bravo, per
quanto si creda indispensabile, in realtà è sostituibile, qualsiasi attore
è sostituibile alla fine.
Parliamo del suo metodo. Come nascono i giochi e gli esercizi che propone nei suoi workshop? Cambiano da paese a paese?
Prendo spunti da diverse cose, com’è ovvio, ma fondamentalmente
sono tutti giochi o metodi creati da me. Originariamente questo tipo
di giochi di società è stato sviluppato nei paesi anglosassoni. Io ho
fatto una lunga ricerca, ho studiato a fondo questi giochi inglesi, e ne
conosco parecchi; però davvero pochi si possono adattare e utilizzare
in Giappone perché hanno comunque un’impostazione occidentale.
Quando devo organizzare un laboratorio all’estero, la metodologia
rimane la stessa, ma applico piccole variazioni di contenuto. Perché
alcuni esempi funzionano bene in Giappone e non in altri luoghi. Quindi
cerco di stare attento negli esempi, nei doppi sensi, nelle ironie e nelle
semplificazioni: quando sono all’estero cerco di semplificare il più
possibile.
Per quanto riguarda la risposta dei partecipanti a questo metodo
le differenze non dipendono dalla nazionalità dei partecipanti, ma dal
loro grado di formazione.
Nel suo metodo lei si riferisce ad ambientazioni particolari: quello che
definisce un semi-pubblic place, un posto dove non c’è una totale intimità ma neanche la codificazione del comportamento in pubblico. Perché?
Per capire l’importanza di questi aspetti bisogna tenere presente
le peculiarità della cultura giapponese e la differenza tra dialogo e
conversazione. La conversazione è un libero scambio di parole, delle
chiacchere diciamo; il dialogo, invece, è una discussione, uno scambio
di opinioni attraverso il confronto. Il popolo giapponese non è abituato
a relazionarsi attraverso il dialogo, a confrontarsi. Spesso quando un
giapponese capisce che l’altra persona ha un’altra opinione rispetto
alla sua, non si mette a discutere, evita sempre di parlarne, piuttosto
21
Bernardo Brogi, Cinzia Toscano, Matteo Vallorani
cambia l’argomento. Solo che il teatro contemporaneo è basato sulle
discussioni, non è una narrazione, ma una discussione pubblica.
Un’altra caratteristica della comunicazione dei giapponesi di oggi
è che non si discute a lungo su uno stesso argomento: le persone si
incontrano, scambiano due parole e poi si separano. Questo è molto
chiaro in Tokyo notes dove lo spettacolo viene costruito proprio sulle
sovrapposizioni di tanti scambi, di tante conversazioni. Il dialogo, lo
scambio di opinioni, è una cosa fondamentale per il mondo democratico:
sin dall’antica Grecia il teatro, la democrazia e il dialogo erano un’unica
cosa. Il Giappone non è ancora un paese democratico al cento per
cento: è stato governato per sessant’anni dalla destra, e ora serve un
grande sforzo educativo, una formazione che parta dall’infanzia, che
insegni ai bambini e ai ragazzi a esprimersi. Per questo, ad esempio,
porto avanti anche un lavoro con i bambini.
Il suo teatro ha anche una dimensione pedagogica?
La pedagogia è pedagogia. La creazione di uno spettacolo
teatrale è tutta un’altra cosa. Io considero l’arte e l’educazione due
cose diverse, ben distinte, delle volte addirittura opposte. L’arte non fa
parte dell’educazione, ma fa parte della società, di un certo ambiente
per un certo periodo di tempo.
Ma l’arte può influire sulla realtà?
Io considero l’arte assolutamente superiore alla politica e
all’economia: l’arte è una cosa immensa, perché può essere utile alla
società. Può servire alla sua stessa epoca, ma potrebbe essere utile
anche per un’altra epoca, in un altro luogo. In Giappone a marzo
c’è stato un terremoto e lo tsunami. Ci sono stati eventi o iniziative
artistiche per risollevare il morale dei terremotati. Al contrario a Tokyo,
che è una città meno colpita, hanno annullato spettacoli e concerti per
essere solidali alla sofferenza della parte settentrionale del Giappone.
Ma se noi smettiamo di creare adesso, le persone sofferenti come
potranno ricevere supporto, oggi o fra cento anni? Io credo che l’opera
di un artista sia dedicata alle persone che vivono esattamente dall’altra
parte del mondo tra cento anni. Però quando la mia arte sarà utile alla
società io non ci sarò più, quindi il compenso devo riceverlo adesso:
ecco perché non si possono diminuire i fondi per la cultura.
22
COS’È SEINENDAN*
*adattamento dal testo di presentazione della compagnia dal sito www.seinendan.org
Seinendan è una compagnia teatrale fondata da Oriza Hirata a
Tokyo. Dal 1983 ricerca un nuovo stile teatrale attraverso l’applicazione
della “Teoria del teatro colloquiale contemporaneo”. Questo stile ha
esercitato una notevole influenza tanto sul teatro giapponese sin dagli
anni Novanta, quanto su altri ambiti come la letteratura e gli studi
linguistici.
Tra gli obiettivi c’è quello di stabilire una nuova forma espressiva
che arrivi ad alterare la struttura del teatro stesso grazie a una
particolare unione di teoria e pratica.
Hirata crede che siano state regolarmente praticate modalità di
scrittura e strutture logiche estranee al linguaggio giapponese, così
da portare gli attori a distorcere il loro stile recitativo. Il cuore della
critica che Hirata muove al teatro giapponese convenzionale è il rifiuto
dell’importazione di modelli del teatro occidentale e delle sue logiche.
Questi i caratteri fondamentali del suo teatro:
- conversazioni multiple che progrediscono simultaneamente;
- battute a volte pronunciate con un tono di voce così basso da non
essere percepite;
- possibilità di parlare/recitare con le spalle rivolte al pubblico.
Questi aspetti sono il frutto di una ricerca indirizzata
verso l’alterazione dell’intera struttura del teatro, attraverso la
23
Cos’è Seinendan
riconsiderazione critica delle teorie teatrali e la ricostruzione di uno
spazio d’azione fragile e drammatico. Seinendan cerca di creare un
simile spazio basando il proprio teatro sullo stile di vita giapponese,
creando allo stesso tempo un nuovo linguaggio teatrale che sia una
commistione di scritto e parlato.
«La vita non è un flusso continuo di eventi significativi come
l’amore e la morte. La maggior parte del tempo è costituito da momenti
ordinari o di quiete. La nostra esistenza stessa è drammatica e
divertente: può essere entusiasmante, appagante, divertente e stupida
in ogni momento. Noi astraiamo e poi ricostruiamo questi elementi
complessi, trasferendo sulla scena i momenti di quiete della vita».
Ciò che rende Seinendan diversa dalle altre compagnie teatrali
della stessa generazione è il fatto che abbia sempre condiviso la propria
esperienza attraverso l’organizzazione di workshop e la diffusione dei
saggi di Hirata – tra cui Gendai Kogo Engeki no tameni (Per un teatro
colloquiale contemporaneo), Toshini Shukusaiwa Iranai (Le città non
hanno bisogno di festività), Engeki Nyumon (Introduzione al dramma),
Geijutsu Rikkoku-ron (Le arti come base di una nazione).
Il percorso che Hirata e Seinendan hanno intrapreso verso questo
teatro è stato lento ma continuo. Il lavoro prosegue nella convinzione
che il teatro colloquiale contemporaneo sarà completo quando segnerà
la nascita di un vero teatro contemporaneo che rifletta la mentalità
complessa della società giapponese.
Oltre a presentare opere scritte e dirette da Oriza Hirata, nel
2002 Seinendan ha creato Seinendan Links, una nuova struttura per gli
attori e registi della compagnia. Per le produzioni di Seinendan Links,
un regista sceglie i propri attori e collaboratori attingendo alle risorse
di Seinendan e del teatro Komaba Agora, di cui Hirata è il direttore
artistico. L’obiettivo è diventare una vera e propria compagnia teatrale
come ce ne sono poche in Giappone: un gruppo formato da vari registi,
drammaturghi e attori, capace di affrontare produzioni di ogni genere.
La teoria di Hirata, nata per aderire alle caratteristiche del
linguaggio giapponese, sta diventando popolare e ha ricevuto consensi
entusiastici. Hirata ha condotto workshop in varie nazioni, tra cui la
Francia, la Corea, il Canada e alcuni stati del Sud-est asiatico.
24
SERENA TERRANOVA
TOKYO NOTES
Questo lavoro di Oriza Hirata è uno dei più rappresentativi della sua idea
di teatro colloquiale. Sovrapposizioni di discorsi, frasi interrotte, silenzi
e pause che dicono più delle parole stesse, costruiscono una partitura
dove il senso nasce sì da ciò che si dice, ma non necessariamente dal
suo significato. Lo spettacolo ha debuttato in Giappone nel 1995; a
Santarcangelo è stato presentato l’8 e il 9 luglio 2011. Una recensione.
Quando è iniziato l’andirivieni nella sala non si sa. Non sappiamo
nemmeno se, dopo che le luci si sono spente, quel procedere di passi
nel museo di Tokyo sia finito davvero. Il tempo del racconto è una linea
senza termini, e lo spazio che abbiamo di fronte è una scatola che
ne cattura un segmento. Uno dopo l’altro, i personaggi di Tokyo Notes
prendono posto nel bookshop, ognuno con la sua guida illustrata alla
mostra di Vermeer o con un bicchiere di caffè tra le mani.
Qualcuno sembra sia venuto da solo, in realtà si nasconde in
quell’atrio per riposare dalla compagnia invadente di un’amica; altri
arrivano insieme, e si scattano reciprocamente rapide fotografie. Alcuni
visitano la mostra, e sanno i colori dei quadri e i nomi dei soggetti,
altri la attraversano senza vederla, e ascoltano muti il racconto di chi
hanno accompagnato. Nell’arco di quasi due ore di spettacolo, le frasi
spezzate compongono il nocciolo di più racconti. I dialoghi sono il vero
luogo dell’accadimento, e nelle parole dette dai numerosi attori di
Oriza Hirata precipitano vite intere, traumi familiari a cui chi ascolta
25
Serena Terranova
non sa come rispondere. Non c’è conforto, non c’è accoglienza, non
c’è compassione. Ogni attore è un personaggio verticale, sottile e
inafferrabile. La comunicazione tra loro esiste nella superficie del
racconto, e si compone per tutta la durata dello spettacolo nella mente
di chi guarda, che ricompone pezzo per pezzo il mosaico affrescato di
fronte a sé.
La profondità di Tokyo Notes è nella cornice della rappresentazione,
un quadro spaziale animato con ritmo formicolante da esempi di semplice
umanità, illuminati per il tempo che è necessario allo spettacolo, e
nella scelta di parole pronunciate nel terrore dello spreco, a comporre
frasi con il peso specifico di un’arma che ferisce o di un muro che
respinge. Chi sta dentro è lo spettatore, attorno al quale vorticano vite
e sguardi, sorrisi e strette di mano, saluti di convenienza e imbarazzi
che investono all’improvviso tutta l’aria della scena. Hirata compie un
lavoro sulle emozioni che sfugge ai ricatti, e chi guarda è coinvolto
senza morbosità, ma si ritrova con incanto dentro un’opera registica
che contempla sempre un nuovo ingresso, l’ennesima intrusione,
l’ennesimo personaggio che costruisce, con quegli attori, una nuova
storia intima, personale, singolare e irripetibile.
Credits:
Scritto e diretto da Oriza Hirata
Con Kenji Yamauchi, Miyuki Moriuchi, Hiroko Matsuda, Koji Ogawara, Mizuho Nojima,
Mami Goto, Masayuki Yamamoto, Kumi Hyodo, Minako Inoue, Natsuko Hori, Tadashi
Otake, Hiroshi Otsuka, Satoshi Kobayashi, Makiko Murata, Kenichi Akiyama, Mizuho
Tamura, Tatsuya Kawamura, Chikako Suzuki, Yuri Ogino, Umi Nagano
Scenografia Itaru Sugiyama
Luci Tamotsu Iwaki
Sottotitoli Aya Nishimoto
Direzione tecnica Aiko Harima, Takao Nakanishi
Produzione Yoko Nishiyama con il supporto di Agency for Cultural Affairs
In collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia
Traduzione del testo Chiara Botta
Interprete Maria Tiziana Bacco
26
BERNARDO BROGI
THE YALTA CONFERENCE
Pièce di taglio ironico, dove i grandi della terra – Churchill, Roosevelt e
Stalin – sono intenti a prendere il tè come signore dell’alta borghesia. Ma
dietro l’apparente affabilità dell’incontro c’è la tragedia umana della guerra
e l’appetito insaziabile delle grandi potenze nella spartizione del mondo.
Lo spettacolo ha debuttato in Giappone nel 2002; a Santarcangelo è stato
presentato l’8, 9 e 10 luglio 2011. Una recensione.
L’Internazionale dei golosi, cover ironica dell’inno dei lavoratori,
introduce due donne, nel ruolo di Stalin e Roosevelt, e un uomo, nel
ruolo di Churchill. I tre giapponesi, con un evidente problema di linea,
conversano nella sala consiliare del Comune di Santarcangelo, seduti a
un tavolo. Tra sigari di biscuit e praline di cioccolato, i bulimici fanno a
fette il mondo come fosse una torta, per poi distribuirle tra loro.
Siamo a Yalta, all’interno di The Yalta Conference di Oriza Hirata.
Dimenticate le ideologie, perché quello che emerge sono gli stereotipi
che ogni leader incarna. I costumi indossati e i colori rimano con i
rispettivi cliché: Roosevelt è uno yankee in blue-jeans, Churchill indossa
un abito bianco coloniale, mentre il tipico cappotto dell’Armata rossa
rende Stalin una parodia della propria icona. Questi personaggi, incapaci
di un pensiero politicamente strutturato, scherzano aspettando che uno
dei tre si assenti per poterlo calunniare. L’arroganza ingenua della loro
carne si risolve in un’utopia malata dai modi grotteschi. Perché corpi di
massa tanto grande, e di altrettanto grande potere, possono attirare
27
Bernardo Brogi
nella propria orbita tanti oggetti e molto cibo, ma non saranno in
grado di abbracciare qualcosa di diverso dalla circonferenza dei propri
stomaci.
In loro manca la percezione dell’altro; la conferenza potrà dirsi
conclusa quando il cibo sarà terminato e non rimarrà più niente di cui
cibarsi. Solo allora i leader potranno tornare al consueto solipsismo che
quell’incontro aveva forzatamente interrotto.
L’ilarità e il sarcasmo suggeriscono una svolta interpretativa
ambigua: difficile capire se Hirata condanni i vizi di un Occidente
opulento, o se sottolinei le pessime debolezze del Giappone, una
nazione, dal dopoguerra a oggi, ormai troppo edulcorata e resa melliflua
dai modelli americani ed europei. Un paese desideroso di recuperare
una dignità ieratica e non ancora corrotta da influenze straniere: forse
l’unico modo per raccontare questo desiderio è nasconderlo dietro le
maschere dei fantasmi dell’Occidente.
Credits:
Scritto e diretto da Oriza Hirata
Con Hiroko Matsuda, Yukari Takahashi, Yozo Shimada
Scenografia Itaru Sugiyama
Luci Tamotsu Iwaki
Sottotitoli Aya Nishimoto
Direzione tecnica Aiko Harima, Takao Nakanishi
Produzione Yoko Nishiyama con il supporto di Agency for Cultural Affairs
In collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia
Traduzione del testo Alessandro Clementi
Interprete Maria Tiziana Bacco
28
BERNARDO BROGI (a cura di)
LASCIAR CADERE LE PAROLE
Nell’ambito di Santarcangelo 41, il regista giapponese Oriza Hirata ha
condotto un laboratorio per attori professionisti. Dal 9 all’11 luglio 2011,
durante quattro incontri tenuti presso la Cappella Zampeschi, quattrordici
attori si sono confrontato col suo metodo. Quello che segue è un report
dell’esperienza, proposto come una sorta di “metodo Hirata”.
LA SCENEGGIATURA
1. Elementi per una sceneggiatura
L’obiettivo del corso è realizzare un breve spettacolo della durata
di 5-10 minuti; per fare questo i partecipanti dovranno rispettare la
metodologia adottata da Oriza Hirata (da adesso OH).
Ogni sceneggiatura rispetterà i seguenti principi:
– La scelta di un luogo fisso dove ambientare la narrazione. Non
sono ammessi cambi di scena.
– Il luogo perfetto è un semi-public space (esempio: sale di attesa,
corsia di un ospedale, sauna, etc…). Un ambiente che permette
l’accesso a personaggi eterogenei con livelli di relazione tra loro,
dal familiare, all’amico, all’estraneo.
29
Bernardo Brogi
– Adottare la sincronia tra tempo fisico e tempo della narrazione.
– Individuare un problema da risolvere (interno alla narrazione).
– Il problema, o la sua soluzione, è introdotto da un estraneo.
Nota: OH offre due esempi di ambientazioni errate: l’eccessiva intimità di
una cena in famiglia nega un discorso ricco di informazioni; una grande
stazione con la sua folla di estranei preclude il dialogo.
2. Costruzione della sceneggiatura
Per costruire una sceneggiatura occorrono personaggi ben
identificati, e una precisa caratterizzazione degli stessi. La metodologia
seguita da OH identifica tre punti:
a) La caratterizzazione del personaggio deve precedere lo sviluppo
della trama.
b) L’intreccio narrativo si otterrà dalle relazioni tra i personaggi.
c) Le relazioni tra i personaggi si determinano in base alle���������
informazioni che possiedono.
Esempio:
Ambientazione:
Cerimonia funebre in una casa dal nucleo familiare allargato.
Personaggi:
Nonno defunto, nonna, padre, madre, nipote, zio (fratello del nonno).
Informazioni depositate:
– lo zio: fratello del nonno, conosce quindi il defunto sin dall’infanzia;
– la nonna: conosce il marito da quando questi aveva venti anni;
– il nipote: ha conosciuto il nonno nei suoi ultimi anni di vita.
30
Lasciar cadere le parole
Azione:
Il nipote chiede allo zio informazioni sconosciute agli altri familiari
sull’infanzia del nonno.
Problema:
Tra i personaggi presenti al funerale ci sono gli amici del nonno,
estranei a tutti gli altri familiari.
Nota: OH precisa che gli sceneggiatori inesperti di solito impiegano la
nonna per raccontare la vita del marito, che è la scelta più facile e stereotipata. Quasi sempre ciò avviene in forma di monologo, che secondo
OH è una forma da non utilizzare.
3. Gestione delle informazioni
Gestire il numero dei personaggi in scena, ovvero le entrate e le
uscite, corrisponde a stabilire le informazioni disponibili per il pubblico,
in un dato momento. Al variare del numero dei personaggi, si modificano
le relazioni tra quelli rimasti in scena. Nessuno può rimanere da solo sul
palco, perché secondo OH l’unità minima è binaria.
Affinché il sistema informativo, basato sulle relazioni, resti
sempre attivo, non può verificarsi neppure lo scambio, ovvero un attore
che entra mentre ne esce un altro. Il successo di una sceneggiatura è
parallelo al corretto sviluppo di ogni personaggio; la trama emerge in
funzione dei rapporti tra gli attori.
∗∗∗
L’ATTORE
1. L’attore e le azioni
Un’ottima sceneggiatura include anche la descrizione di azioni
minime che gli attori eseguiranno sulla scena. Ogni elemento dovrà
essere previsto.
La memoria dell’attore è fondamentale per facilitare il ricordo
di una routine non verbale dettagliata. Nel testo, a ogni movimento
31
Bernardo Brogi
sarà associato uno stimolo (esempi: l’improvvisa entrata in scena di un
personaggio, la posizione di un oggetto su un tavolo, un gesto durante
un dialogo). Si crea così un meccanismo di input-output che stimola la
reazione corretta nel soggetto.
2. L’attore e la parola
«Parlare, spiegare, serve sempre a nascondere una debolezza»
(Oriza Hirata)
Secondo OH, la conversazione tra i personaggi va costruite
seguendo i seguenti principi:
– i dialoghi devono essere economici;
– la funzione informativa dei dialoghi deve essere ridotta al minimo
– deve rimanere fuori dalla conversazione tutto ciò che può essere
espresso in altro modo;
– i turni di parola devono essere costruiti in funzione del quotidiano
per aumentare la coesione con la realtà (sovrapporre le voci; non
stabilire turni di parola fissi; etc.);
– importanza del silenzio: la pausa, anche prolungata, tra due battute, permette la creazione di un’attesa, fattore che aiuta a sviluppare il senso del ritmo.
Esempio:
Durante il corso sono state interpretate alcune conversazioni, a più
voci, tratte dalle sceneggiature di OH. È stato chiesto di eseguire la loro
lettura e le battute si succedevano rispettando i turni. Successivamente
OH ha spiegato la simbologia che accompagna le battute e che definisce
i momenti nei quali gli attori possono prendere parola, di modo che
più piani del discorso possano sovrapporsi. Con questo metodo il ritmo
offre un maggiore effetto di realtà e dinamizza il discorso.
Queste prove hanno visto un grado crescente di complessità:
sono state arricchite con elementi di disturbo, come personaggi che
attraversando la sala avrebbero interrotto i parlanti, in funzione di una
visione ecologica della scena.
∗∗∗
32
Lasciar cadere le parole
PROVE PRATICHE
Durante l’ultima lezione di laboratorio sono stati presentati, presso
il Teatrino della Collegiata, due spettacoli realizzati dai quattordici
partecipanti.
1. Spettacolo A
Il primo spettacolo è ambientato in una galleria d’arte (semipublic space). Al suo interno i visitatori (diversi gradi di relazione tra
i personaggi) attendono l’arrivo dell’artista che espone; nessuno lo ha
mai visto, persino la gallerista non conosce il suo volto (problema).
Chiunque entri nella sala può essere il personaggio atteso. Prima la figlia
(estraneo 1) poi la moglie (estraneo 2) sono scambiate per l’autore, ma
quest’ultimo non arriverà mai.
2. Spettacolo B
Il nuovo assistente (estraneo) di un’estetista fa coincidere
l’appuntamento di una donna con quello dell’amante del marito
(problema). Nel salone di bellezza (semi-public space) le due donne
si confrontano, ignorando l’equivoco (diversi gradi di relazione tra i
personaggi). Entra in scena la figlia della donna tradita e rivela a tutti
che anche la madre conduce una relazione extraconiugale; pochi istanti
dopo arriva l’amante di quest’ultima minacciando il suicidio. I due
escono dal salone di bellezza affermando il loro amore.
33
34
MATTEO VALLORANI (a cura di)
DA ORIENTE A OCCIDENTE
Al termine del laboratorio «Il metodo del teatro colloquiale contemporaneo»,
condotto da Oriza Hirata, gli attori che vi hanno preso parte hanno raccontato
all’osservatorio critico la loro esperienza. Di seguito riportiamo alcune
delle loro testimonianze, che danno conto dell’incontro non scontato tra la
formazione occidentale e il metodo del regista giapponese.
Il confronto con il metodo di Hirata ha significato per gli attori
inserirsi in una struttura molto definita. Una partitura scritta nei suoi
particolari, dove l’attore deve entrare come parte di un meccanismo.
Qualcosa di molto distante dal tipo di formazione dell’attore a cui
siamo abituati in Italia. Nel nostro paese si privilegia un lavoro che va a
pescare nell’intimo dell’attore, per poi dare forma a questo materiale.
Al contrario Hirata chiede ai suoi attori di inserirsi in un meccanismo
che li sovrasta, in cui devono trovare il modo di sentirsi parte. Tra i
partecipanti al laboratorio, qualcuno ha dichiarato di sentirsi più
libero all’interno di una struttura così ben definita: la griglia, anziché
ingabbiare, darebbe maggiore libertà.
Altri hanno rilevato che una griglia stretta rende tutto più semplice,
ma non è detto che questa semplicità renda il lavoro automaticamente
“creativo”, secondo quelli che sono i nostri standard.
C’è anche chi vede il metodo di Hirata come una “limitazione
individuale” che però mette l’attore a servizio di qualcosa di più grande.
Quelle che seguono sono sei testimonianze dirette di questo
incontro-scontro con il metodo del maestro giapponese.
35
Matteo Vallorani
∗∗∗
La prima puntualizzazione da fare è che Hirata non ha lavorato con
noi come lavora di solito con gli attori della sua compagnia. Il Maestro
muove gli attori secondo schemi precisi, ma noi abbiamo abitato questi
schemi da un punto di vista pedagogico, non artistico. A differenza dei
laboratori ai quali ho partecipato in precedenza, questo ha più a che fare
con la scrittura, meno con l’attore. Gli altri laboratori erano di ricerca
personale, una ricerca interna. In questo invece facevamo tutti parte
di un disegno globale, bisognava stabilire e partecipare al sistema di
relazioni che si era creato. Il Maestro critica il teatro occidentale, perché
secondo lui noi applichiamo uno studio sull’attore troppo introspettivo:
come se fosse un qualcosa dentro di noi che deve uscire fuori; invece
lui ritiene che l’interpretazione naturale si ottenga attraverso l’aiuto di
stimoli esterni, che non dipendono dal nostro controllo. Ci ha insegnato
a rispondere agli input: l’attore europeo agisce sulla scena, quello
orientale reagisce alla scena.
Livia Antonelli
∗∗∗
La cosa che subito mi ha colpito è il suo modo di fare teatro in
maniera essenziale. Il nostro teatro si basa molto sull’esagerazione:
dell’espressione, del movimento. Al contrario, in questo laboratorio
tutto è stato spinto verso il grado zero: mentre per la nostra cultura
è un punto di partenza, per lui lo zero è un punto di arrivo, un
raggiungimento del nulla. Chiede sempre a ciascuno di rimanere se
stesso senza usare tecniche particolari. Sicuramente anche la sua è
una costruzione, una struttura, ma è lì per semplificare, per togliere.
Indirizzando la recitazione verso questa naturalezza usa certamente
degli esercizi teatrali occidentali, vicini al teatro anglosassone o
all’ultimo Stanislavskij: dopo aver imparato le battute ci ha chiesto
di recitare passandoci una pallina da ping pong per dimenticare
l’interpretazione, distrarsi dalle battute. Per quanto questo aspetto sia
vicino all’Occidente, l’essenzialità di cui parlavo si sviluppa attraverso
caratteristiche che non avevo mai sperimentato, come gli stimoli
multipli, le conversazioni in contemporanea e le pause.
Stefania Canini
36
Da oriente a occidente
∗∗∗
Sicuramente è sempre molto complesso liberarsi dei
condizionamenti, anche involontari, che ciascuno porta con sé, con la
propria formazione; ma nel laboratorio con Oriza Hirata questo processo
è stato immediato: non solo perché è riuscito a portarci al grado zero di
apprendimento, ma anche perché è stato da subito molto chiaro nello
spiegare gli strumenti utili e quelli inutili all’apprendimento del suo
metodo. Molto interessante è stata l’attenzione agli stimoli esterni sulla
scena, che aiutano l’attore a creare altri segnali: come nell’aikido l’attore
utilizza la forza dell’altro e la trasforma in energia per la sua azione o
reazione. Hirata mette a disposizione tutta una struttura con riferimenti
specifici, scientifici, e se sei in grado di rispettarli non ti perderai: come
il sassolino della favola occidentale, per ritrovarti puoi anche avere
bisogno delle cose che opportunamente vengono posizionate intorno
a te. Ti dà la sicurezza che studiando comunque riuscirai a cavartela
all’interno di quella rete, non potrà esserci un imprevisto.
Gianni Iasimone
∗∗∗
La ricerca della naturalezza è una cosa che sin dal primo giorno
mi è piaciuta molto. In realtà lo fanno spesso i maestri, tentano di
lavorare su di te eliminando ogni ridondanza. Quello che mi ha colpito
in questo caso è il modo in cui ce l’ha spiegato. Lui ha sottolineato
come per noi togliere l’enfasi, positiva o negativa, equivale a togliere
l’energia, la voce. Ha così cercato di farci raggiungere spontaneamente
questa naturalezza aumentando le distrazioni: in un dialogo a due
anche l’ingresso in scena di un terzo può creare quella distrazione tale
da indurti a essere più naturale. In lui la naturalezza coincide con la
semplicità anche nell’insegnamento: da un regista del suo calibro ti
aspetteresti una certa rigidità di valutazione, al contrario Hirata ha una
sottigliezza, una capacità e una visione talmente ampia che riesce a
lavorare su di te proprio a partire dagli errori. Proprio grazie alla fluidità
con cui riesce a maneggiare il suo metodo riesce ad alleggerire la scena
e la tua stessa recitazione.
Marouane Zotti
37
Matteo Vallorani
∗∗∗
Ho trovato molto interessante la lezione di Hirata sulla pausa. Per
noi occidentali il silenzio è spesso una provocazione, quasi uno strappo,
perché non siamo abituati alle pause lunghe. Durante il laboratorio è
stato spiegato che in realtà è necessario alternare all’azione dei momenti
di quiete, con un ruolo ben definito: durante una pausa lo spettatore
ha tutto il tempo di riflettere su cosa è avvenuto e su cosa accadrà; il
silenzio serve per dare al pubblico il tempo di pensare. Quando l’azione
riparte si può avere la conferma delle proprie aspettative, o la loro
smentita. Gli spettacoli di Broadway e la televisione riducono al minimo
l’immaginazione del pubblico, perché hanno ritmi incalzanti, al lato
opposto il teatro di ricerca lascia ampio margine all’immaginazione,
forse troppo. Hirata vuole trovare un equilibrio matematico tra l’azione
e la pausa, attraverso simili strategie si può gestire con facilità
l’attenzione del pubblico e offrire una sensazione di realtà più naturale.
Paola Pieri
∗∗∗
Già il testo crea un effetto di realtà disegnando una situazione molto
precisa, con dialoghi fissi e movimenti prestabiliti. Ma il suo obiettivo è
rendere molto chiara la situazione naturale a livello psicologico: quando
nella vita parli con qualcuno, ad esempio su un treno, nel momento in
cui nella stessa cabina entra un’altra persona il dialogo continua, ma
entrambi gli interlocutori non possono far altro che pensare a questa
intromissione. Con queste semplicissime spiegazioni riusciva davvero a
farti immedesimare nella situazione, a farti capire come dovevi sentirti.
L’attore ha un ruolo psicologico molto chiaro, sa ogni volta chi è e
cosa sta facendo. Insiste molto sulla chiarezza, perché il pubblico deve
capire molto bene quello che sta succedendo. A lui interessava che la
scena fosse chiara: potevi interpretarla in maniere diverse, ma se era
molto chiaro quello che accadeva andava comunque bene. In questo
senso, nonostante la scrittura rigida, restava uno spazio di manovra
interpretativa.
Enrico Bossi
38
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Teatro
Oriza Hirata, Yoji Sakaye, Toshiki Okada, Teatro
Contemporaneo, Roma, Editoria & Spettacolo, 2009.
Giapponese
Luca Scarlini, Hirata e gli altri, prefazione a «Teatro Giapponese
Contemporaneo» (vedi sopra).
Maria Pia D’Orazi, Buto. La nuova danza giapponese, Roma, E&A Editori
Associati, 1997.
Cinema
Andrea Chimento, Paolo Parachini, Shinya Tsukamoto. Dal Cyberpunk al
mistero dell’anima, Alessandria, Falsopiano, 2009.
Anna Antonini, L’incanto del mondo. Il cinema di Miyazaki Hayao, Milano,
Il principe Costante, 2005.
Luciano Barcaroli, Carlo Hintermann, Daniele Villa (a cura di), Il cinema
nero di Takeshi Kitano (con tre sceneggiature: Sonatine, Hana-Bi,
Brother), Milano, Ubulibri, 2001.
Arte, Fumetto, Fotografia
Fabriano Fabbri, Lo zen e il manga. Arte contemporanea giapponese,
Milano, Mondadori, 2009.
F. Maggia (a cura di), Daido Doriyama. Visioni del mondo, Milano, Skira
2010.
Manuela De Leonardis, A tu per tu con i grandi fotografi, Roma, Postcart,
2011.
39
Nero su Bianco edizioni
Luglio 2011