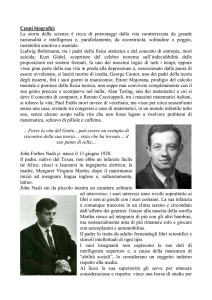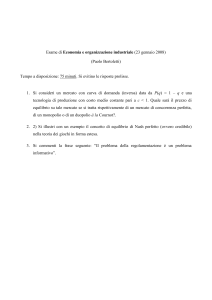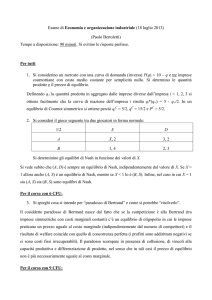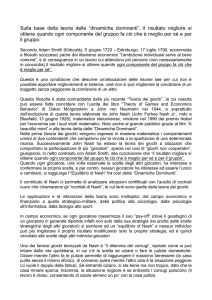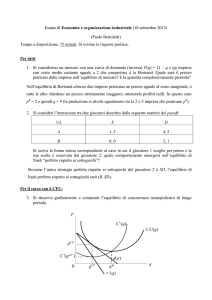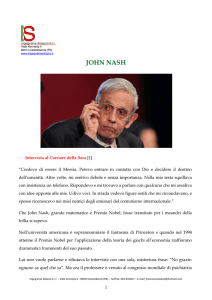Primo premio Concorso “Scrivi la tua recensione”
Cineforum pomeridiano A.S. 2015/’16
“Immaginazione e matematica nel cinema”
Film: “A beautiful mind” di Ron Howard (2002)
Molti dicono che questo non è un film sulla matematica. Ritengono che essa vi abbia un ruolo
marginale, sullo sfondo; e che ciò che conti sia, in realtà, la
psicologia dei personaggi; i loro sogni e i loro incubi; le loro
visioni.
Ma la matematica è visione. Si necessita di fantasia e
profonda immaginazione per individuare soluzioni innovative
a un problema proposto.
Questo ci porta a ribaltare la tesi iniziale: “A beautiful mind” è
un film sulla matematica. John Nash è matematica allo stato
puro. E nella matematica razionalizza la sua vita. “È questo
che faccio” dice il protagonista alla fine del film :“Risolvo problemi”. Usa la matematica come
mezzo di risoluzione, anche in campi dove questo non è permesso. Nella vita reale. Ha un
problema: la solitudine. “Alle persone non piaccio molto” confida a Charles all’inizio del film. È
questo Nash: genio a livello mentale, ominide a livello sociale ed empatico.
È isolato dal mondo; per ricollegarsi ad esso prova e riesce a creare un ponte matematico. Lo
tormenta la competitività. Immagina, fin dall’inizio del film, se sia possibile un equilibrio “dove
nessuno vince”. È un problema, anche a livello personale, per Nash. Vuole e deve riscattarsi. Non
possiamo vedere nella sua “teoria dei giochi” l’ennesimo utilizzo della matematica per ergere
barriere contro la vita?
Nash pare non vivere un’esistenza propria. Scrive sulle
finestre; guarda il mondo all’esterno; ma è come se non ne
facesse parte. Da quel mondo si auto respinge; e da esso
viene rigettato come organo non proprio. Nel mondo della
matematica questo non avviene; e Nash vi si rifugia. È
inevitabile però che il genio si trovi ad affrontare un minimo di
vita. Ecco Charles, ecco Marcee, ecco Parcher. Sono tutti, se
vogliamo chiamarli tali, “anti-Nash”. Rispondono alle sue
aspirazioni più profonde, sono parti di sé che Nash non vuole riconoscere, scisse, incapaci di
emergere, sommerse nel mare dell’inconscio ma vive e reali nella luminosa realtà.
Questo non è solo un film sulla matematica: è un film sull’illuminazione.
Prima di tutto, a livello tecnico. La differente illuminazione sottolinea e accentua i passaggi
psicologici, la drammaticità o la leggerezza delle diverse scene. È l’uso cinematografico del
chiaroscuro. E proprio l’illuminazione – mero mezzo scenico - diventa proiezione delle tensioni
emotive all’esterno: l’ennesima proiezione di sé. La luce, come un filo conduttore, permea tutto il
film. La ritroviamo negli arabeschi disegnati dal bicchiere nella scena iniziale, nei numeri e nelle
lettere evidenziate dal genio di Nash, sul volto della bionda contesa che gli darà l’ispirazione.
Nash è un uomo che vive di illuminazioni. “Vede” ciò che gli altri non vedono: nuove soluzioni ma
altrettante visioni. L’eccesso del genio porta alla follia; e John, per quanto geniale, si ritrova a
precipitare in una spirale buia. Necessita di una luce nuova, diversa
da quelle false o pseudo false che lo circondano. E la luce non è
altro che sua moglie. Alicia svolge un ruolo di “luce rivelatrice”
all’interno della vita di Nash: rappresenta il vero confine tra ciò che è
reale e ciò che non lo è. Lo dichiara quasi esplicitamente alla fine del
film, quando, prendendo la mano al marito, gli dice: “Vuoi sapere
cos’è reale? Questo”. È la guida, l’aiuto, il sostegno. Non è un caso
che Nash le dedichi il discorso finale, alla consegna del Nobel.
L’amore – ci dice il film – è la reale illuminazione.
Tuttavia, nonostante Alicia, le visioni permangono. Nash non le ha sconfitte: ha deciso di ignorarle.
Crede in ciò che ha detto a Hansen, e cioè che “è lo stesso con i nostri sogni e i nostri incubi.
Dobbiamo alimentarli per mantenerli in vita”. Nash decide di dosare adeguatamente il peso, e di
non eccedere in immaginazione là dove non ve ne è bisogno. È l’ultima, geniale applicazione
dell’equilibrio della teoria dei giochi.
Sono possibili, certo, anche altre considerazioni. La prima, a livello tecnico, merita di essere citata.
Oltre alla luce, grande attenzione è stata posta nei colori. Nelle varie scene, i colori degli abiti e
dell’ambiente corrispondono alla psicologia dei personaggi. Durante la cena in cui chiede ad Alicia
di sposarlo, l’abito della ragazza è rosso (colore della passione). Dopo il ritorno dall’ospedale
psichiatrico, la casa di Nash ha toni verde acido, colore triste di una speranza quasi spenta.
Nell’inseguimento con Parcher, dominano il nero e il blu cupo, quasi elettrico, a sottolineare la
tensione. Quei colori nel prisma donato ad Alicia paiono distribuirsi uniformemente lungo tutto il
film, conferendogli l’ennesimo e spettacolare equilibrio.
Altra menzione merita la musica; mai violenta, sottolinea con improvvise variazioni le increspature
nell’animo dei protagonisti. Considero degno di nota anche l’utilizzo di un canto quasi religioso ogni
volta che Nash riceve una nuova “illuminazione” (ad esempio con il dottor Rosen, quando viene
rivelata l’inesistenza delle sue visioni).
Infine, la regia: accentuano la tensione in maniera impercettibile le inquadrature che mettono in
evidenza prima l’oggetto, poi il soggetto; prima le conseguenze, poi la causa (quasi un dilemma
matematico).
Un esempio è quando, nell’ospedale psichiatrico, Nash
tenta di estirpare il diodo radioattivo, non trovando però
nulla e procurandosi solo una ferita sul braccio. Vediamo
prima le conseguenze (la sirena, l’infermiera che
richiede aiuto urgente, il volto e il muoversi concitato del
dottor Rosen); poi ciò che lo ha provocato.
Come quando Alicia si fa strada nella capanna dove
Nash ha dato nuovo sfogo al suo delirio: vediamo prima
il suo volto sconvolto, poi i muri invasi di giornali.
Interessante anche il passaggio da una scena all’altra, effettuato spesso con lo sfumato, quasi a
voler conferire, alle diverse scene, l’alone evanescente del sogno.
Infine, trovo necessario concludere con una riflessione personale scaturita dalla visione del film. E
cioè: chi garantisce che noi stessi non siamo schizofrenici? Che la realtà attorno a noi non sia altro
che un distorto delirio collettivo? Chi garantisce che la nostra sia la “vera” realtà, e non quella dei
poeti, dei pazzi, dei folli? Chi dice che non vi siano segreti occultati dalla luce, che l’oscurità rivela?
Noi non abbiamo risposta.
Borges dice che “l’uomo che conosce l’universo giunge a follia”. Allora lascio racchiuso nella
pagina un interrogativo: chi dice che non sia questo che è davvero successo a Nash?
Agnese Galeazzi
Classe 2^ I