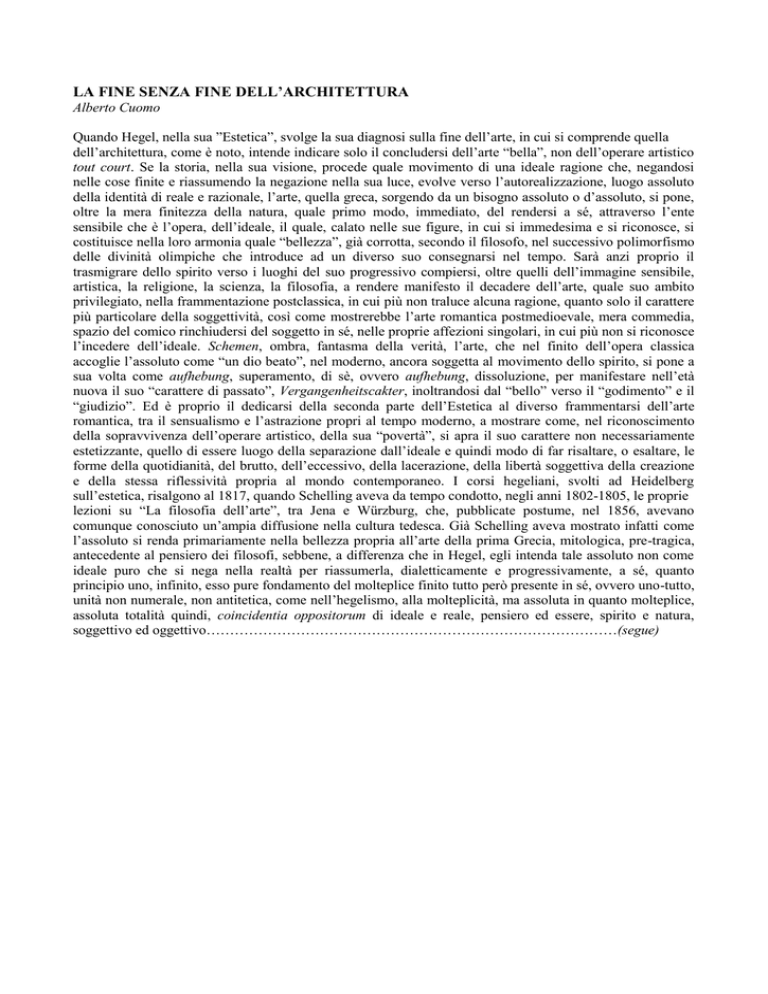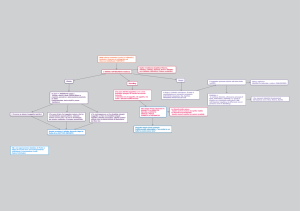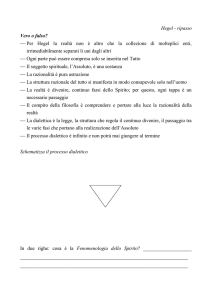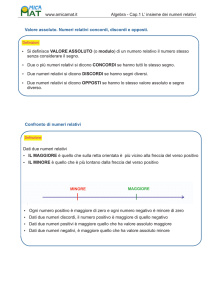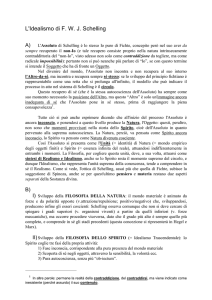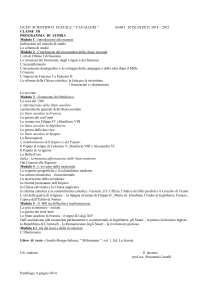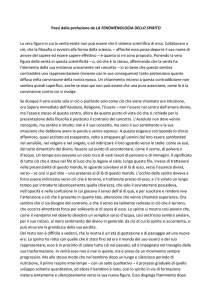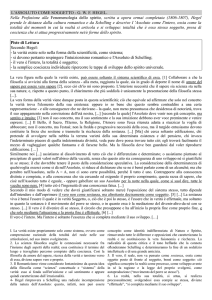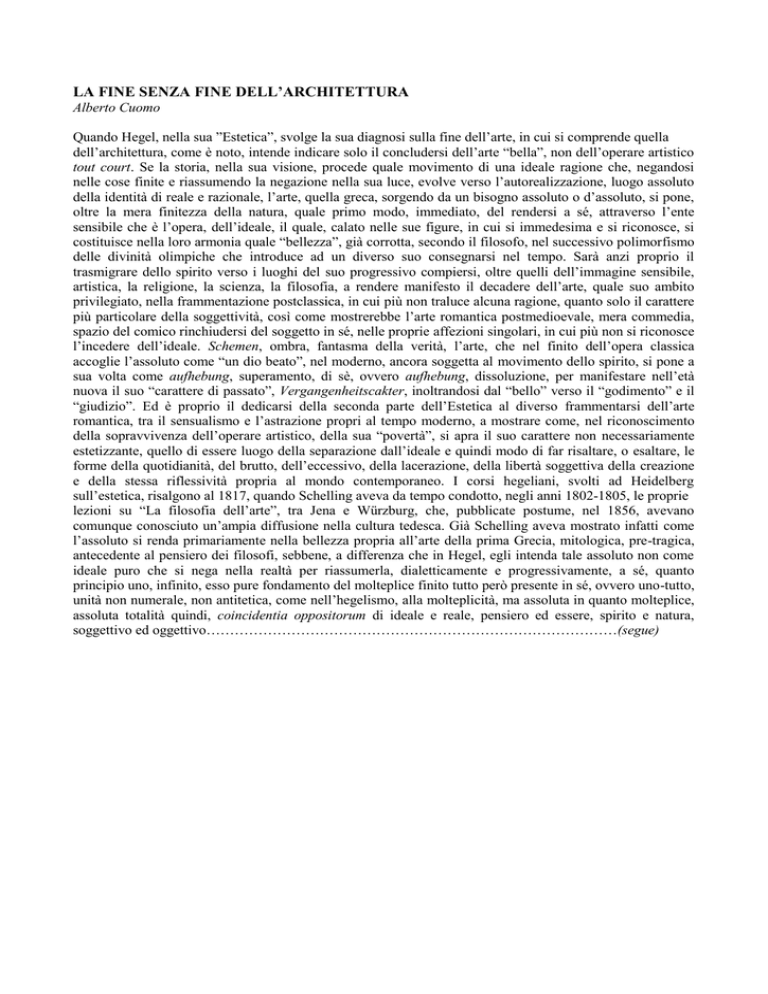
LA FINE SENZA FINE DELL’ARCHITETTURA
Alberto Cuomo
Quando Hegel, nella sua ”Estetica”, svolge la sua diagnosi sulla fine dell’arte, in cui si comprende quella
dell’architettura, come è noto, intende indicare solo il concludersi dell’arte “bella”, non dell’operare artistico
tout court. Se la storia, nella sua visione, procede quale movimento di una ideale ragione che, negandosi
nelle cose finite e riassumendo la negazione nella sua luce, evolve verso l’autorealizzazione, luogo assoluto
della identità di reale e razionale, l’arte, quella greca, sorgendo da un bisogno assoluto o d’assoluto, si pone,
oltre la mera finitezza della natura, quale primo modo, immediato, del rendersi a sé, attraverso l’ente
sensibile che è l’opera, dell’ideale, il quale, calato nelle sue figure, in cui si immedesima e si riconosce, si
costituisce nella loro armonia quale “bellezza”, già corrotta, secondo il filosofo, nel successivo polimorfismo
delle divinità olimpiche che introduce ad un diverso suo consegnarsi nel tempo. Sarà anzi proprio il
trasmigrare dello spirito verso i luoghi del suo progressivo compiersi, oltre quelli dell’immagine sensibile,
artistica, la religione, la scienza, la filosofia, a rendere manifesto il decadere dell’arte, quale suo ambito
privilegiato, nella frammentazione postclassica, in cui più non traluce alcuna ragione, quanto solo il carattere
più particolare della soggettività, così come mostrerebbe l’arte romantica postmedioevale, mera commedia,
spazio del comico rinchiudersi del soggetto in sé, nelle proprie affezioni singolari, in cui più non si riconosce
l’incedere dell’ideale. Schemen, ombra, fantasma della verità, l’arte, che nel finito dell’opera classica
accoglie l’assoluto come “un dio beato”, nel moderno, ancora soggetta al movimento dello spirito, si pone a
sua volta come aufhebung, superamento, di sè, ovvero aufhebung, dissoluzione, per manifestare nell’età
nuova il suo “carattere di passato”, Vergangenheitscakter, inoltrandosi dal “bello” verso il “godimento” e il
“giudizio”. Ed è proprio il dedicarsi della seconda parte dell’Estetica al diverso frammentarsi dell’arte
romantica, tra il sensualismo e l’astrazione propri al tempo moderno, a mostrare come, nel riconoscimento
della sopravvivenza dell’operare artistico, della sua “povertà”, si apra il suo carattere non necessariamente
estetizzante, quello di essere luogo della separazione dall’ideale e quindi modo di far risaltare, o esaltare, le
forme della quotidianità, del brutto, dell’eccessivo, della lacerazione, della libertà soggettiva della creazione
e della stessa riflessività propria al mondo contemporaneo. I corsi hegeliani, svolti ad Heidelberg
sull’estetica, risalgono al 1817, quando Schelling aveva da tempo condotto, negli anni 1802-1805, le proprie
lezioni su “La filosofia dell’arte”, tra Jena e Würzburg, che, pubblicate postume, nel 1856, avevano
comunque conosciuto un’ampia diffusione nella cultura tedesca. Già Schelling aveva mostrato infatti come
l’assoluto si renda primariamente nella bellezza propria all’arte della prima Grecia, mitologica, pre-tragica,
antecedente al pensiero dei filosofi, sebbene, a differenza che in Hegel, egli intenda tale assoluto non come
ideale puro che si nega nella realtà per riassumerla, dialetticamente e progressivamente, a sé, quanto
principio uno, infinito, esso pure fondamento del molteplice finito tutto però presente in sé, ovvero uno-tutto,
unità non numerale, non antitetica, come nell’hegelismo, alla molteplicità, ma assoluta in quanto molteplice,
assoluta totalità quindi, coincidentia oppositorum di ideale e reale, pensiero ed essere, spirito e natura,
soggettivo ed oggettivo……………………………………………………………………………(segue)