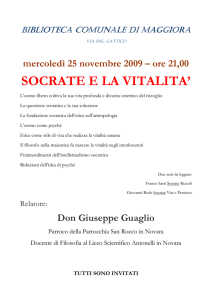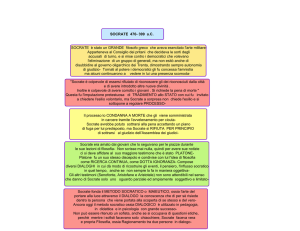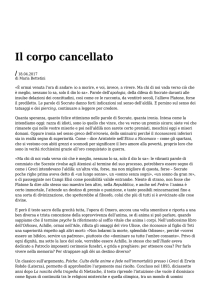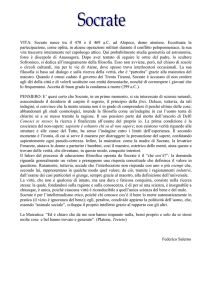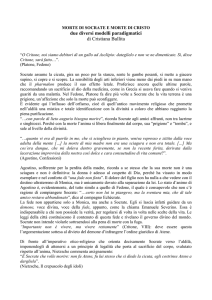Cos’è la Filosofia?
a cura di Enzo Galbiati
Seconda parte
[email protected]
filosofiacapriate.Enzogalbiati
Socrate: vita (1)
La vita di Socrate (Atene, 470 a.C./469 a.C.– Atene, 399 a.C.) si svolge
nel periodo della maggiore potenza ateniese (vittoria sui Persiani ed età
di Pericle), ma anche del suo declino (Guerra del Peloponneso, Trenta
Tiranni e restaurazione della democrazia).
Il padre di Socrate, Sofronisco, fu uno scultore del demo di Alopece e
della tribù di Antiochide ed è possibile che trasmettesse tale mestiere al
giovane figlio: in tal senso, secondo Diogene Laerzio, sarebbero state
opera di Socrate le Cariti velate (ovvero le Grazie che secondo
tradizione sono tre: Aglaia lo splendore, Eufrosine la gioia e la letizia,
Talia la prosperità e portatrice di fiori) sull'Acropoli di Atene.
Sua madre, Fenarete, sarebbe stata una levatrice. Probabilmente
Socrate era di famiglia benestante: nei dialoghi platonici non risulta che
egli esercitasse un qualsiasi lavoro e del resto sappiamo che egli
combatté come oplita fino all’età di 46 anni (quindi doveva avere una
qualche rendita o mercede).
Fu educato come i giovani ateniesi del suo tempo e della sua classe:
musica, ginnastica e poesia (nelle testimonianze si fa riferimento ad un
suo peana ad Apollo oltre ad un suo coinvolgimento nelle attività di
Euripide).
[segue]
Socrate: vita (2)
Nulla si sa di certo sulla sua formazione culturale (dal 455 al 433 a C.
circa). Ebbe probabilmente contatti con Parmenide e Zenone di Elea,
con Anassagora, con i Fisici di scuola ionica Diogene di Apollonia ed
Archelao, oltre a conoscere la nuova scienza medica. Conobbe
ovviamente la Sofistica e i suoi maggiori esponenti (Protagora nel 432,
Gorgia nel 427, Prodico di Ceo nel primo ventennio del V secolo a. C.).
Fra il 433 e il 422 combatté nelle battaglie di Potidea (432 a.C.) contro
Corinto e in quelle di Delio (424 a.C.) contro i Beoti e di Anfipoli (422
a.C.) contro Sparta. È riportato nel dialogo Simposio di Platone che
Socrate si comportò in modo coraggioso: si racconta che rimase al fianco
di Alcibiade ferito salvandogli probabilmente la vita.
Durante queste campagne di guerra dimostrò di essere
straordinariamente resistente, marciando in inverno senza scarpe né
mantello. Nel 421 tornò ad Atene dove rimase fino alla morte.
Fra il 420 e il 415 si collocherebbe il suo matrimonio. Socrate fu sposato
con Santippe, che gli diede tre figli: Lampsaco, Sofronisco e Menesseno
(tuttavia, secondo Aristotele e Plutarco, due di questi li avrebbe avuti da
una concubina di nome Mirto; altri parlano di bigamia).
[segue]
Socrate: vita (3)
Santippe ebbe fama di donna insopportabile e bisbetica. Socrate stesso
attestò che, avendo imparato a vivere con lei, era divenuto ormai capace
di adattarsi a qualsiasi altro essere umano. D'altra parte Socrate era
talmente preso dalle proprie ricerche filosofiche al punto da trascurare
ogni altro aspetto pratico della vita, tra cui anche l'affetto della moglie, la
quale più volte, nei dialoghi di Platone, si meraviglia di un marito sempre
preso a parlare con amici e sconosciuti di questioni inessenziali.
Nel 406 come membro del Consiglio dei Cinquecento Socrate fece parte
della Pritania quando i generali della battaglia navale delle Arginuse
furono accusati di non aver soccorso i feriti in mare e di non aver
seppellito i morti per inseguire le navi spartane. Socrate fu l’unico
nell'assemblea che si oppose alla richiesta illegale di un capo di
accusa collettivo contro i generali. Nonostante pressioni e minacce,
bloccò il procedimento fino alla conclusione del suo mandato, quando i
sei generali furono condannati a morte.
Nel 404 i Trenta Tiranni (ed in particolare Crizia) ordinarono a Socrate e
ad altri quattro cittadini di arrestare il democratico Leonzio di Salamina.
Socrate si oppose all'ordine e la sua morte fu evitata solo dalla
successiva caduta dei Tiranni e dal ritorno della democrazia.
[segue]
Socrate: vita (4)
Socrate è descritto da Platone come un uomo di corporatura robusta e
con il naso camuso. Fisicamente era quindi simile a un satiro, anche se
era sorprendentemente buono nell'animo per chi si soffermava a
discutere con lui.
Nel 399 ebbe luogo il processo contro Socrate voluto dalla restaurata
democrazia. Il capo d’accusa contro Socrate presentato da Meleto era il
seguente:
« […] questo ha sottoscritto e giurato Meleto di Meleto, Pitteo,
contro Socrate di Sofronisco, Alopecense. Socrate è colpevole di
non riconoscere come Dei quelli tradizionali della città, ma di
introdurre divinità nuove; ed è anche colpevole di corrompere i
giovani. Pena: la morte» (Diogene Laerzio, Vita e dottrine dei filosofi,
II, 5, 40).
Il continuo dialogare di Socrate, attorniato da giovani affascinati dalla sua
dottrina e da importanti personaggi, nelle strade e piazze della città di
Atene, fece sì che egli venisse scambiato per un sofista dedito ad
attaccare imprudentemente e direttamente i politici.
[segue]
Socrate: vita (5)
Il filosofo, infatti, dialogando con loro dimostrò come la loro vantata
sapienza in realtà non esistesse. Socrate venne quindi ritenuto un
pericoloso nemico politico che contestava i tradizionali valori cittadini. Per
questo Socrate, che aveva attraversato indenne i regimi politici
precedenti, che era rimasto sempre ad Atene e che non aveva mai
accettato incarichi politici, fu accusato e messo sotto processo.
I suoi accusatori al processo furono due esponenti di rilievo del regime
democratico, Anito e Licone, i quali, servendosi di un prestanome,
Meleto (un giovane ambizioso e letterato fallito), accusarono il filosofo di:
1. corrompere i giovani insegnando dottrine che propugnavano il
disordine sociale;
2. non credere negli dei della città e tentare di introdurne di nuovi.
L'accusa di "ateismo", condannato da un decreto del 430, fu
evidentemente un pretesto giuridico per un processo politico. Poiché
l'ateismo era sì ufficialmente riprovato e condannato, ma tollerato se
affermato privatamente e poiché la religione e la cittadinanza erano
ritenute un tutt'uno, accusando Socrate di ateismo lo si incolpò di avere
cospirato contro le istituzioni e l'ordine pubblico.
[segue]
Socrate: vita (6)
D'altra parte Socrate non aveva mai negato l'esistenza degli dei della
città ed eluse facilmente l'accusa sostenendo di credere in un demone.
Un avvocato suo discepolo, Lisia, si offrì di difenderlo in tribunale, ma
Socrate rifiutò preferendo difendersi da solo.
Descritto da Platone nell’Apologia di Socrate, il processo evidenziò due
elementi:
1) per chi non lo conosceva direttamente, Socrate veniva confuso con i
sofisti, considerati corruttori morali dei giovani;
2) vista la provenienza politica dei suoi discepoli, Socrate era odiato dai
politici democratici.
Riguardo al secondo punto occorre ricordare che Socrate era stato
maestro di Crizia e di Alcibiade, due personaggi che nell'Atene della
restaurata democrazia godevano di pessima fama.
Da questo punto di vista il processo e la morte di Socrate non furono un
avvenimento incomprensibile rivolto contro un uomo, apparentemente
trascurabile e non pericoloso per il regime democratico, che voleva
ricostruire un'unità politica e spirituale all'interno della città.
[segue]
Socrate: vita (7)
Fu la diffidenza suscitata dai rapporti di Socrate con i "traditori" che
spinse i capi della restaurata democrazia a sottoporlo a processo;
Alcibiade e Crizia erano morti entrambi, ma i democratici non si sentivano
al sicuro finché l'uomo, che s'immaginava avesse ispirato i loro
tradimenti, esercitava ancora influenza sulla vita pubblica (al riguardo
Apologia di Socrate, 24 b).
Il processo si tenne dinanzi a una giuria di 501 cittadini di Atene e fu
atipico: Socrate si difese contestando le basi del processo, anziché
lanciarsi in una lunga e pregevole difesa (apologia) o portando in
tribunale la sua famiglia per impietosire i giudici, come di solito si faceva.
Fu riconosciuto colpevole per uno stretto margine di voti - appena 30.
Dopodiché, come previsto dalle leggi, sia Socrate che Meleto dovettero
proporre una pena per i reati di cui l'imputato era stato accusato.
Socrate sfidò i giudici proponendo loro di essere mantenuto a spese della
città, poiché riteneva che anche a lui dovesse essere riconosciuto l'onore
dei benefattori della città, avendo insegnato ai giovani la scienza del
bene e del male.
[segue]
Socrate: vita (8)
Poi consentì di farsi multare - seppur di una somma ridicola. Meleto
chiese invece la morte.
Furono messe ai voti le proposte: con ampia maggioranza - 360 voti a
favore contro 140 contrari - gli ateniesi, più per l'impossibilità di punire
Socrate, multandolo di una somma così ridicola, che per effettiva volontà
di condannarlo a morte, accolsero la proposta di Meleto e lo
condannarono a morire mediante l'assunzione di cicuta.
Era pratica diffusa autoesiliarsi dalla città per sfuggire alla sentenza di
morte ed era probabilmente su questo che contavano gli stessi
accusatori. Socrate dunque intenzionalmente irritò i giudici, che non
erano in realtà mal disposti verso di lui. Ma perché lo fece? Socrate, in
effetti, aveva già deciso di non andare in esilio, in quanto anche fuori di
Atene avrebbe persistito nella sua attività: dialogare con i giovani e
mettere in discussione tutto quello che si vuol far credere verità certa. Del
resto egli non temeva la morte (che nessuno sa se sia o no un male)
preferendola addirittura all'esilio.
La sentenza venne eseguita un mese dopo a causa delle feste Deliee e
nonostante questo Socrate non fuggì ma attese in cella il compiersi del
suo destino.
Il giovane Socrate (1)
Il problema Socrate: Socrate non ha scritto nulla. Difficile quindi ricostruire il
suo pensiero autentico (e non quello che emerge dai dialoghi di Platone di
cui, come noto, Socrate è quasi sempre il protagonista).
Su Socrate abbiamo per fortuna alcune testimonianze di Aristofane,
Platone, dei socratici minori, Senofonte e Aristotele. Le più attendibili da
un punto di vista storico sono le prime tre: quella di Aristofane è l’unica
testimonianza che ci mostra Socrate “giovane”, mentre quelle di Platone (i
primi dialoghi e soprattutto l’Apologia di Socrate) e dei socratici ci parlano del
Socrate della maturità.
Il giovane Socrate è alle prese con la nuova cultura filosofica e scientifica
giunta ad Atene nell’età periclea. Nell’Apologia Socrate cita almeno tre
aspetti della sua “formazione”:
19 b – c: riferimento alla commedia di Le Nuvole di Aristofane;
26 c – d: riferimento esplicito ad Anassagora e ai fisici;
19 e – 20 c: riferimento ai Sofisti attivi ad Atene.
La testimonianza di Aristofane è contenuta principalmente nella
commedia intitolata Le nuvole, andata in scena per la prima volta ad
Atene alle Grandi Dionisie del 423 a.C.
[segue]
Il giovane Socrate (2)
Trama delle «Nuvole»: il contadino Lesina è perseguitato dai creditori a
causa dei soldi che suo figlio Fidippide ha dilapidato alle corse dei cavalli;
pensa allora di mandare il figlio alla scuola di Socrate, filosofo che,
aggrappandosi ad ogni sofisma, insegna come prevalere negli scontri
dialettici, anche se in posizione di evidente torto. In questo modo, pensa
Lesina, il figlio sarà in grado di vincere qualsiasi causa che i creditori gli
intenteranno.
In un primo momento Fidippide non vuole andare al Pensatoio del filosofo e
così il padre, disperato e perseguitato dagli strozzini, decide di recarvisi lui
stesso. Appena giunto, incontra un discepolo che gli dà un assaggio delle
cose su cui si ragiona in quel luogo: il modo migliore di misurare il salto di
una pulce e da dove provenga il ronzio emesso dalle zanzare. Dopodiché
finalmente Lesina vede Socrate che, appeso in una cesta, contempla il cielo
(vv. 225 – 233): «LESINA: Ehi, Socrate! Ehi, Socratuccio! / SOCRATE
(Riscuotendosi dalla profonda meditazione): A che, mortal, m'appelli? / LESINA:
Dimmi prima che fai, fammi il piacere! / SOCRATE: Per l'ètere movo, e il sol dall'alto
io guardo! / LESINA: E stando in terra, i Numi non li puoi guardar dall'alto? /
SOCRATE: I celesti fenomeni scrutare giammai potrei dirittamente: se dalla terra
investigassi, di giú le cose di lassú, non mai le scoprirei; poiché la terra a forza attira
a sé l'umore dell'idea»
[segue]
Il giovane Socrate (3)
Il filosofo, dopo un breve dialogo, decide di impegnarsi ad istruirlo: gli mette
indosso un mantello e una corona ed invoca l'arrivo delle Nuvole, le divinità
da lui adorate, che si presentano puntuali sulla scena (vv. 250 – 262 e
soprattutto vv. 316 e sgg.):
«Affatto, perdio! Non ti figuri quanti sofisti nutrono [le Nuvole]! Indovini di Turi,
guaritori, sfaccendati con zazzera unghie ed anelli, tornitori di canti in
girotondo, astronomici imbroglioni. Nutrono le Nuvole fannulloni sfaticati, che
poi le cantano in musica».
Lesina però non riesce a capire nulla dei discorsi pseudo-filosofici che gli
vengono fatti (parodia della filosofia socratica e sofistica) e viene quindi
cacciato. Fidippide, incuriosito dai racconti del padre, decide infine di andare
a visitare il pensatoio e quando arriva assiste al dibattito tra il Discorso
Migliore e il Discorso Peggiore.
Nonostante i buoni propositi e i sani valori proposti dal Discorso Migliore
(personificazione delle virtù della tradizione), alla fine prevale il Discorso
Peggiore (personificazione delle nuove filosofie) attraverso ragionamenti
cavillosi. Fidippide impara la lezione ed insieme a Lesina riesce a mandare
via due creditori; il padre è contento, ma la situazione gli sfugge subito di
mano: Fidippide comincia infatti a picchiarlo, e di fronte alle sue proteste il
figlio gli dimostra di avere tutto il diritto di farlo.
[segue]
Il giovane Socrate (4)
Esasperato e furioso, Lesina dà allora alle fiamme il Pensatoio di
Socrate, tra le grida spaventate dei discepoli.
Per Aristofane mettere al centro della commedia, rappresentata in Atene
e per ateniesi, Socrate ateniese significava:
1. Socrate nel 423 era già un personaggio conosciuto, con un
atteggiamento un po’ balzano e strano;
2. Socrate era uno dei pochi ateniesi ad aver compreso l’importanza
delle nuove scienze mediche e fisiche (Anassagora, Zenone,
Pitagora, Ionici) e della Sofistica (Protagora, Gorgia, Prodico,
Ippia) portate in città da stranieri: con il suo atteggiamento Socrate
voleva in realtà trasmettere ai suoi concittadini il messaggio che
ciascun uomo, attraverso gli altri, ha da essere consapevole di sé e
dei propri limiti, componendo dialetticamente le varie ragioni senza
necessariamente conformarsi ai costumi e alle idee della tradizione e
della maggioranza.
Prima di illustrare le caratteristiche salienti del Socrate della maturità,
occorre andare indietro nel tempo per conoscere quelli che hanno
investigato la Natura e gli uomini prima di lui.
[segue]
I Presocratici: i Milesi
La ricerca dell’archè (= principio di tute le cose). Secondo
l’interpretazione aristotelica Talete (circa 630 a.C. – 560 a.C.),
Anassimandro (discepolo di Talete, circa 611 a.C. – 545 a.C.) e
Anassimene (discepolo di Anassimandro, circa 598 a.C. – 527 a.C.),
tutti di Mileto (colonia greca in Asia Minore), furono i primi tre filosofi ad
aver individuato un principio per spiegare la realtà: il primo nell’acqua, il
secondo nell’àpeiron (= indefinito, illimitato), il terzo nell’aria.
La ricerca dell’archè, come sostiene ancora Aristotele, rappresenta un
ragionamento tipicamente “filosofico”, che è alla base del futuro
sviluppo della filosofia e della scienza occidentali: significa pensare
che la molteplicità e la complessità della realtà sono riconducibili
a un principio unitario che ha valore fondativo.
Frammento B1 di Anassimandro: «… principio degli esseri è l’infinito…
da dove infatti le cose traggono la loro nascita, ivi si compie la loro
dissoluzione secondo necessità: poiché pagano l’un l’altro la pena e la
colpa dell’ingiustizia, secondo l’ordine del tempo» (per i Presocratici si
citerà sempre da: I Presocratici: testimonianze e frammenti, 2 volumi,
Laterza, 1990, pagg. 106 e 107).
I Presocratici: i Pitagorici (1)
Le comunità pitagoriche erano associazioni religiose e spesso anche politiche
(sviluppatesi nella Magna Grecia - Crotone e Taranto – a partire dal 570 a. C.)
che si basavano sull’idea che la dedizione alla ricerca della verità si
coniugasse con la condivisione di uno stile di vita “comunitario” fra gli
adepti.
Oggetto privilegiato del sapere era la matematica, insegnata non tanto alla
stregua di una sistematica disciplina scientifica, quanto piuttosto come tappa di
un cammino di iniziazione verso misteri progressivamente più elevati. Secondo
la tradizione, gli adepti si dividevano in due gruppi distinti: i matematici (“coloro
che apprendono”), e gli acusmatici (“coloro che ascoltano”).
Certa è l’indiscussa verità attribuita alla parola di Pitagora, come pure l’obbligo
degli iniziati di mantenere segrete le loro conoscenze con i profani. Il modo di
“fare filosofia” delle comunità pitagoriche fungerà da modello nei secoli
successivi, soprattutto nell’era pagana.
Anche nella dottrina pitagorica troviamo il medesimo tentativo dei milesii di
individuare un principio generale per spiegare la realtà. Per Pitagora tale
principio si identifica con i numeri. La numerabilità, infatti, può essere
applicata a tutte le cose, in accordo con il criterio dell’universalità del principio
che caratterizza la ricerca filosofica. In qualità di principio “semi-astratto”, i
numeri sono, da un lato, gli elementi di cui sono costituite le cose; dall’altro, i
mezzi per rappresentare simbolicamente la realtà non materiale.
[segue]
I Presocratici: i Pitagorici (2)
La tradizione attribuisce a Pitagora l’elaborazione di due serie di opposti,
in cima alle quali vi è l’opposizione tra Limite e Illimitato (connotati anche
in senso morale, rispettivamente come bene e male), seguiti da altre coppie
come dispari/pari, uno/molteplice, destra/sinistra, maschio/femmina,
retta/curva, luce/oscurità, ecc.
Non è chiaro se i numeri per Pitagora fossero i principi primi, o andassero
subordinati anch’essi alla coppia Limite/Illimitato. È lecito, comunque,
pensare che i Pitagorici ritenessero che tutte le cose, e in primo luogo i
numeri, si generassero dall’unione di Limite e Illimitato, secondo il pensiero
tipico della mentalità greca antica, in base a cui è possibile pensare ogni
cosa come il prodotto di una delimitazione su uno sfondo illimitato.
Un’altra caratteristica della filosofia pitagorica è la credenza in un universo
ordinato, armonico, buono, retto da una proporzione equilibrata tra i suoi
elementi, cioè i numeri (armonia cosmica); ne è prova il fatto che esistano
rapporti matematici esatti tra le cose, riscontrabili sia nell’astronomia sia
nella musica, dove la gradevolezza di un suono si lega al rispetto di
proporzioni precise tra le note. Corollario di questa idea è il nesso, tipico
della mentalità greca, tra il buono e il bello (buono è ciò che è anche
bello), nel quale sussistono rapporti armonici tra gli elementi che lo
compongono.
I Presocratici: Eraclito (1)
I concetti di νοῦς (= nous = intelletto, comprensione) e λόγος (= lògos =
parola, discorso) furono introdotti per la prima volta nel lessico filosofico da
Eraclito di Efeso (circa 530 a. C. – 450 a.C.).
Mentre il lògos si identifica con la ragione, con il discorso razionale, il nous
l’intelletto, l’intelligenza, che è patrimonio comune di tutti gli uomini ma che,
tuttavia, di norma i mortali, appellati come “dormienti”, usano di rado.
Per Eraclito la vera conoscenza deriva dal ricercare nelle cose l’elemento
comune, universale, e può essere raggiunta solo tramite l’intelletto, che
permette alla verità, sotto forma di lògos, di rivelarsi e manifestarsi. Ciò che è
vero, infatti, per Eraclito si impone anche come un discorso razionale
dimostrabile e corente (fr. 1 e 2).
Eraclito è il primo filosofo, nella storia del pensiero occidentale, ad aver
operato la distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale,
sostenendo la superiorità di quest’ultima.
I principi universali possono essere colti solo dall’intelletto, e non dai sensi,
che forniscono all’uomo conoscenze particolari, frammentarie, mutevoli che
possono dare erudizione ma non conoscenza vera (fr. 40): al massimo, la
sensibilità può rappresentare un primo livello di conoscenza, utile per la
raccolta di informazioni, ma appartiene solo all’intelletto la capacità di
individuare le leggi generali della realtà.
[segue]
I Presocratici: Eraclito (2)
L’unica cosa che importa conoscere è il rapporto fra la realtà nella sua unità
e l’opposizione che distacca i contrari l’uno dall’altro dando luogo alla
molteplicità (fr. 30, 50, 51, 54).
Eraclito rileva (diversamente dai contrari simili di Anassimandro) che ciò che
risulta da due opposti è una unità e l’unità è unita dei due opposti: la realtà è
sempre unità ed opposizione, unità armonica di tensioni opposte (fr. 8).
L’opposizione non intacca l’unità ma la realizza; e l’unità non toglie rilievo
alla molteplicità degli opposti / contrari, ma la esprime e la spiega (fr. 10, 53,
80, 88, 103, 111). Lo stesso concetto viene espresso dal filosofo di Efeso
con la metafora dell’arco: questo oggetto può svolgere la sua funzione se, e
soltanto se, la corda e il legno ricurvo permangono in uno stato di tensione,
mentre cessa di essere ciò che è e di funzionare se la tensione di una delle
due parti si allenta.
Il conflitto «padre di tutte le cose» (in greco pòlemos, che significa anche
“guerra”). Se la realtà è unità di contrari occorre che il passaggio dall’uno
all’altro dei contrati sia necessario. Il divenire nella dottrina di Eraclito è
infatti la necessaria conseguenza dell’identità fra unità e opposizione: πάντα
ῥεῖ (= panta rei = tutto scorre, Platone A 6). Si vedano i frammenti del fiume
(fr. 12, 49, 91) e quelli sulla realtà fisica (fr. 126).
[segue]
I Presocratici: Eraclito (3)
Altri termini usati da Eraclito per indicare il “divenire di tutte le cose” sono:
giorno / notte, guerra / pace, abbondanza / carestia, giustizia / ingiustizia,
morte / vita, giovinezza / maturità.
Ispirandosi ai principii della filosofia ionica, Eraclito ha ritenuto di
riscontrare nel fuoco i caratteri essenziali della realtà (fr. 30, 31, 32, 64,
66, 67, 90). Il fuoco, infatti, da un lato ha la caratteristica di poter
trasformare tutte le cose (tutte le cose possono prendere fuoco) in modo
continuo; dall’altro muta in ogni istante, pur rimanendo la medesima cosa.
L’Efesino spiega la dinamica del divenire attraverso due procedimenti (fr.
60): il cammino in basso muove dal fuoco che condensandosi diviene
umido e, quando venga compresso, si trasforma in acqua, l’acqua poi
congelandosi si trasforma in terra; il cammino verso l’alto muove invece
dal liquefarsi della terra da cui nasce l’acqua e dall’acqua tutto il resto per
evaporazione.
Lo stesso vale per l’anima dell’uomo (fr. 45, 77, 117, 118 e anche 85) e
nel rapporto fra gli Dei e gli uomini. Ogni mutamento in una direzione
viene insomma compensato da un mutamento nella direzione contraria.
Una misura / logos governa il divenire; nemmeno il fuoco può sottrarsi
alla misura dentro la quale il mondo viene regolato dalla necessità
(chiamata da Eraclito anche «giustizia»).
Parmenide (1)
Parmenide di Elea (circa seconda metà del VI secolo – prima metà del
V secolo), nel proemio della sua opera Sulla natura (un poema scritto
in esametri di cui si sono conservati solo 19 frammenti per complessivi
150 versi), fa tracciare per bocca della dea Giustizia le uniche tre vie di
ricerca della verità che possono essere pensate: la via della verità
assoluta, la via dell’errore ed infine la via dell’opinione plausibile dei
fenomeni e del movimento (fr. 1, vv. 28-32).
1. La via della verità: l’essere è, il non essere non è (fr. 2, vv. 1-8;
fr. 6, vv. 1-9; fr. 8, vv. 1-2); è la stessa cosa l’essere e il pensiero (fr. 3,
vv. 1): “lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero,
perché senza l’essere nel quale è espresso, non troverai il pensare” (fr.
8, vv. 34-37). Caratteristiche dell’essere: ingenerato e incorruttibile,
senza passato né futuro ma solo eterno presente senza inizio e
fine (fr. 8, vv. 1-21), immobile ed immutabile nelle catene del limite
(limitato= definito = perfetto; riferimento a Pitagora) e della necessità
(fr. 8, vv. 26-33), indivisibile, continuo e tutto eguale perché ogni
differenza implicherebbe il non essere (fr. 8, vv. 22-25 e 46-49),
sferiforme (fr. 8, vv. 42-44) ed uno (fr. 8, v. 6).
[segue]
Parmenide (2)
2. La via dell’errore: “anche da quella su cui i mortali che nulla sanno /
vanno errando, uomini a due teste: infatti, è l’incertezza / che nei loro
petti guida una dissennata mente. Costoro sono trascinati, / sordi e ciechi
ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio, / dai quali essere
e non-essere sono considerati la medesima cosa / e non la medesima
cosa, e perciò di tutte le cose c’è un cammino che è reversibile” (fr. 6, vv.
1-9; ma anche il fr. 7, vv. 1-6): prestando fede ai sensi sembra che la
realtà sia diversa da quella attestata dalla verità: morire, nascere,
movimento, quiete, cioè proprio il non essere. Il vero fatale errore
dell’uomo è proprio ammettere essere e non essere allo stesso tempo. Il
non essere, infatti, per Parmenide non può essere né pensato né detto, e
il regno della verità coincide con quello di ciò che esiste. Chi vuole
conoscere la verità e cogliere l’essere, quindi, non può percorrere la via
della negazione.
3. La via della spiegazione plausibile dei fenomeni / secondo
opinione (fr. 1, vv. 30-31 e fr. 8, vv. 60-61): l’errore è concepire la luce e
la notte come contrari, mentre in realtà sono inclusi in un essere
superiore (fr. 8, vv. 53-54 e soprattutto fr. 9, vv. 1-4 e per via indiretta
Teofrasto, A 46).
[segue]
Parmenide (3)
La via della verità è quella nella quale si adopera soltanto l‘
«essere», l’«è», e si esclude rigorosamente il «non essere» e il
«non è». Affermare che «il non essere è» è infatti immediatamente
contraddittorio e costituisce la prima e principale via dell'errore; ma da
evitare è anche la seconda via dell'errore, costituita dalla contestuale
affermazione di essere e non essere.
Per intendere tutto ciò è necessario capire esattamente il significato di
essere e non essere nel poema di Parmenide. L‘«essere» è l‘ «ente» i
cui predicati ontologici (ontologia: la dottrina dell’essere e delle
sue forme; a volte è usata come sinonimo di metafisica) vengono
elencati nel fr. 8. E’ così evidente l’esistenza dell’essere che non si
capisce l’esigenza parmenidea di evitare accuratamente il pericolo di
negarlo. Nessun Greco a lui contemporaneo o precedente lo aveva
fatto (e tuttavia lo farà in seguito proprio Gorgia).
L’insistenza di Parmenide sul valore assoluto di questo «essere» si
chiarisce però quando si tenga presente la determinazione che ne dà lo
stesso fr. 8, designando ai vv. 35-36 il «νοεῖν» (=noein» = «pensare»)
come inseparabile «da quell'essere nel quale è espresso»:
[segue]
Parmenide (4)
l’essere di Parmenide non è altro, nel suo motivo originario, che l’
«essere» astraibile come forma comune di tutti gli "è" costituenti
le singole affermazioni empiriche.
Detto altrimenti: il pensiero di Parmenide parte dal rilievo della
molteplicità delle singole designazioni delle cose rispetto all'unità
dell'essere con cui esse si predicano e s'affermano.
Ma le singole cose non sono soltanto particolari di fronte all'unità
dell'essere: sono anche contraddittorie, perché ciascuna di esse
«è» in un modo in quanto «non è» in un altro (per esempio: una
donna è alta e non bassa, nello stesso tempo), quindi mescola
insieme contraddittoriamente l'essere e il non essere.
Vero in senso proprio, e quindi reale e quindi pensabile, è soltanto
«ciò che è», l‘ «ente», l’ «essere», senz’altra determinazione.
Ecco compresa la genesi dell’essere parmenideo e insieme quella delle
"vie dell'errore" come metodi in cui, pensata la verità nelle sue
determinazioni empiriche, si giunge alla contraddittoria asserzione del
«non-essere».
[segue]
Parmenide (5)
Compiuta in forma estrema e universale, l'asserzione del «non essere»
costituisce la prima via dell'errore.
Affiancata all'asserzione dell'essere, essa dà luogo alla seconda e più
comune via dell'errore, percorsa da ogni "opinione" umana che
asserisce ed afferma il particolare e quindi somma insieme essere e
non essere, e tipicamente rappresentata da Eraclito (se contro questo
suo grande contemporaneo, è particolarmente diretta da Parmenide la
seconda parte del fr. 6, vv. 6-9).
L’ «ente», di cui Parmenide scopre la natura in base a un'analisi
della natura logico-verbale del pensiero, non è per lui un «essere»
ideale o logico che perciò si distingue dall‘ «essere» reale, ma è
anzi, in virtù dell'originaria indistinzione delle sfere ontologica,
logica e linguistica propria della mentalità greca arcaica, la stessa
realtà nella sua più vera e solida forma.
E così l’ «essere» viene definito nel fr. 8 come non nato né perituro, non
appartenente al passato e al futuro, ma solo all'eterno presente
(giacché, se se ne afferma l'è, deve negarsene il fu e il sarà); [segue]
Parmenide (6)
non interiormente diverso o diviso, e perciò tutto compatto e pieno; non
mobile; e, infine, neppure infinito, perché l'infinità è imperfezione, e
quindi definito nella più perfetta forma geometrica, quella della sfera
(attributo, quest'ultimo, tipico per la singolare tendenza del pensiero
greco verso il finito, ma insieme problematico per il carattere di
assolutezza dell'ente parmenideo, che doveva escludere da sé ogni non
essere, cioè ogni negazione e determinazione).
Tutti questi attributi sono dedotti da Parmenide in base a quella
che egli chiama (fr. 8, vv. 15-16) «distinzione dell'è dal non è»:
l'esclusione, cioè, di ogni predicazione di "non essere", che venga
a contraddire la purezza della predicazione dell‘ «essere».
Che i predicati che risultano da tale analisi logico-verbale abbiano poi
per Parmenide immediato valore ontologico, non deve sorprendere
quando si pensi, come già detto, al carattere primitivo di questo
pensiero non ancora giunto alla distinzione dell'ontologia dalla logicagnoseologia (gnoseologia: la teoria dei metodi di conoscenza o in
alcuni casi, come questo di Parmenide, la teoria della conoscenza
stessa) e quindi portato a considerare il vero come reale e il reale
come vero.
[segue]
Parmenide (7)
Questo è proprio il solo significato legittimo della cosiddetta identità
parmenidea di essere e pensiero: identità che non esiste nel senso di
un'adeguazione e dissoluzione del pensiero nell'essere (né avrebbe
potuto, perché per tale riflessa identificazione sarebbe stata necessaria
una precedente distinzione), bensì esiste nel senso della primitiva e
irriflessa unità, onde ciò che si trova "vero" nel pensiero e nella parola
viene sentito come senz'altro "reale".
La stessa indistinzione tra sfera logico-verbale e sfera
ontologica si ripete a proposito di quel mondo «secondo
opinione» in cui l'uomo incorre quando, obbedendo alla
conoscenza sensibile, crede alle forme particolari delle cose e
deve quindi, per spiegarle, mescolare il non-essere all'essere.
Eppure anche l'errore logico-verbale «secondo opinione» assume, nella
sua possibilità e nella sua attuazione, un aspetto di realtà: altrimenti non
si giustificherebbero quegli aspetti d'indiscussa oggettività, che pur
presenta questa parmenidea dottrina dell'empirico, e nel cui rilievo è il
motivo di verità delle altre interpretazioni.
[segue]
Parmenide (8)
Anche la teoria dell'errore viene quindi ad essere in un certo
modo «reale».
E le molteplici forme del mondo dell’opinione sono per
Parmenide gli stessi «nomi» (fr. 8, vv. 38 segg. e fr. 19) che
sommandosi, come predicati particolari, alla pura asserzione
dell‘ «è» producono la determinazione, e quindi la
contraddittoria sintesi dell'essere e del non essere.
In questa concreta determinazione, essere e non essere
assumono l'aspetto di elementi fisici (luce e tenebre, o caldo e
freddo, ecc.), la cui sintesi dà origine ai singoli aspetti sensibili del
reale.
Così anche l'interpretazione della dottrina dell'opinione conferma
la genesi logico-verbale del pensiero parmenideo, e insieme
l'originaria e primitiva connessione onde quel carattere logicoverbale è in esso ancora connaturato col carattere propriamente
reale di ciò che è.
Zenone di Elea (1)
A Zenone di Elea (discepolo di Parmenide vissuto fra il 489 e 431 a. C.) gli
autori antichi attribuiscono l’invenzione della “dialettica”, intesa come quel
metodo argomentativo che, invece di partire dalla descrizione della natura
reale, parte dalle asserzioni che su di essa si possono formulare.
In realtà, ciò che a Zenone può essere legittimamente attribuito è la
scoperta di quella parte della dialettica che nel linguaggio matematico si
definisce ragionamento per assurdo o paradosso: esso consiste nel
negare che una certa proposizione x sia vera, per poi mettere in luce gli
esiti assurdi e contraddittori che ne conseguono e giungere, infine, ad
ammettere la necessità della verità dell’asserzione x.
L’originale metodologia inventata da Zenone ha come scopo principale la
difesa degli insegnamenti del suo maestro Parmenide dagli attacchi dei
suoi detrattori, soprattutto in relazione alla negazione parmenidea del
movimento e del pluralismo.
1. Paradossi contro il pluralismo
Il primo paradosso contro la pluralità delle cose sostiene che se le cose
sono molte, esse sono allo stesso tempo un numero finito e un numero
infinito: sono finite in quanto esse sono né più né meno di quante sono, e
infinite poiché tra la prima e la seconda ce n'è una terza e così via. [segue]
Zenone di Elea (2)
Il secondo paradosso contro il pluralismo sostiene che se queste unità
non hanno grandezza, le cose da esse composte non avranno
grandezza, mentre se le unità hanno una certa grandezza, le cose
composte da infinite unità avranno una grandezza infinita.
2. Paradossi contro il movimento
Primo paradosso (lo stadio): afferma che non si può giungere
all'estremità di uno stadio senza prima aver raggiunto la metà di esso,
ma prima di raggiungerla si dovrà raggiungere la metà della metà e così
via senza quindi mai riuscire nemmeno ad iniziare la corsa. Secondo il
filologo Giorgio Colli delle due versioni tramandate del paradosso
andrebbe preferita la seguente: «non si può giungere all'estremità di uno
stadio senza prima aver raggiunto la metà di esso, ma una volta
raggiunta la metà si dovrà raggiungere la metà della metà rimanente e
così via, senza quindi mai riuscire a raggiungere l'estremità dello
stadio».
Secondo paradosso (è il celeberrimo paradosso di Achille e la
tartaruga): ideato per dimostrare l’infondatezza delle tesi che negano
l’immobilità dell’essere sostenuta da Parmenide.
[segue]
Zenone di Elea (3)
Esso afferma che se Achille piè veloce fosse sfidato da una tartaruga
nella corsa e concedesse alla tartaruga un piede di vantaggio, egli non
riuscirebbe mai a raggiungerla, dal momento che Achille dovrebbe
prima raggiungere la posizione occupata in precedenza dalla tartaruga
che, nel frattempo, si sarebbe spostata di un certo intervallo di spazio;
così la distanza tra Achille e la tartaruga non potrebbe mai arrivare ad
essere pari a zero.
La descrizione del paradosso dello scrittore argentino Jorge Luis
Borges (Altre inquisizioni, Adelphi, 2004) forse è più chiara: «Achille,
simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di lentezza.
Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci
metri di vantaggio. Achille corre quei dieci metri e la tartaruga percorre
un metro; Achille percorre quel metro, la tartaruga percorre un
decimetro; Achille percorre quel decimetro, la tartaruga percorre un
centimetro; Achille percorre quel centimetro, la tartaruga percorre un
millimetro; Achille percorre quel millimetro, la tartaruga percorre un
decimo di millimetro, e così via all’infinito; di modo che Achille può
correre per sempre senza raggiungerla».
[segue]
Zenone di Elea (4)
Terzo paradosso (la freccia): la freccia appare in movimento ma, in
realtà, è immobile. In ogni istante difatti essa occuperà solo uno spazio
che è pari a quello della sua lunghezza; e poiché il tempo in cui la freccia
si muove è fatto di singoli istanti, essa sarà immobile in ognuno di essi. Il
concetto di questo terzo paradosso è in fondo opposto a quello del
secondo: l'esistenza di punti e istanti indivisibili. Ma anche in questo
caso il movimento risulta impossibile, in quanto dalla somma di istanti
immobili non può risultare un movimento.
Ciò su cui si fondano tutti i paradossi di Zenone è la differenza tra
estensione in senso fisico ed estensione in senso matematico:
mentre una linea tracciata su un piano fisico ha una certa dimensione, e
quindi contiene un numero finito di punti, un segmento matematicogeometrico è invece composto da infiniti punti. Quindi, tornando per
esempio al paradosso di Achille e la tartaruga, se Achille corresse su un
piano concreto, e non lungo una linea matematica, raggiungerebbe con
facilità la lenta tartaruga. Il senso implicito dei paradossi è quindi
mostrare l’essenziale differenza tra il piano della razionalità, espressa
dalle discipline matematiche e della filosofia, e quello del reale.
I pluralisti: Empedocle (1)
Fedele alle posizioni parmenidee e al principio secondo cui nulla si genera
dal nulla né si distrugge nel nulla, Empedocle (Agrigento 490 - 430 a. C.)
cerca di spiegare il divenire che si manifesta nella realtà: sostituendo i
termini parmenidei di «essere» e «non essere» con quelli di
«composizione» e «scomposizione» di elementi che rimangono
ingenerati e incorruttibili, Empedocle rende ragione del divenire della
realtà che si mostra agli occhi di tutti, senza contravvenire al contempo ai
principi dell’eleatismo. Nulla si origina e nulla si distrugge, dunque, ma
tutto è una trasformazione dei quattro elementi fisici che compongono la
Natura. Probabilmente trova qui una spiegazione la credenza nella
metempsicosi, sostenuta in qualche frammento.
I quattro elementi ingenerati e incorruttibili – chiamati da Empedocle
«radici» – che si compongono e scompongono tra loro, dando origine al
divenire delle cose, sono: aria, acqua, terra e fuoco. Essi corrispondono
ai diversi stati in cui si presenta la materia: solido (terra), liquido (acqua),
gassoso (aria); il fuoco è invece inteso sia come calore sia come luce, e
considerato una sorta di materia. Tale concezione dei quattro elementi
godrà di ampia fortuna nell’Antichità e nel Medioevo e costituirà la chimica
di base fino all’avvento della scienza nel XVIII secolo.
[segue]
I pluralisti: Empedocle (2)
Per spiegare il divenire, Empedocle introduce i due principi di Amore e
Odio, intesi come le due forze cosmiche che presiedono rispettivamente al
moto che spinge le cose a unirsi e a quello che le spinge a separarsi.
Combinando le due forze cosmiche con i quattro elementi, egli arriva a
ipotizzare un ciclo universale, eternamente reversibile, che oscilla tra lo
stadio estremo in cui vi è il dominio massimo dell’Amore (principio a cui
Empedocle concede la superiorità) e quello in cui vi è il dominio massimo
dell’Odio, e viceversa. Essendo tale ciclo di lunghissima durata, gli uomini
non sanno in quale momento del ciclo cosmico vivono, né in quale direzione
esso si sta muovendo.
In merito alla questione di come sia possibile la conoscenza, Empedocle
sostiene la tesi che «il simile conosce il simile»: essendo ogni cosa
costituita dalle quattro radici, noi riconosciamo nelle altre cose gli stessi
elementi di cui anche noi siamo composti; in altre parole, è l’acqua che è in
noi che ci fa conoscere l’acqua che c’è nelle cose, e così per tutte le altre
radici. È lecito supporre che Empedocle, sulla scia della sua teoria dei
quattro elementi, non ammettesse distinzione alcuna tra piano sensibile e
intelligibile, materiale e spirituale, fisico e psichico. Da qui le definizioni di un
pensiero “che è sangue”, o della ragione come una “cosa” capace di
“dividersi”.
I pluralisti: Anassagora
Anche Anassagora di Clazomene (500 – 428 a.C.) fu fedele ai principi
di Parmenide secondo cui nulla nasce e nulla perisce. Egli spiega il
divenire concependolo, al pari di Empedocle, come mescolanza e
disgregazione di elementi, ma, a differenza di Empedocle, chiama questi
elementi «semi»: di numero infinito, identici tra di loro e divisibili
all’infinito, i semi corrispondono alle qualità percepibili.
In ogni cosa sono presenti i semi di tutte le altre (da qui la celebre
espressione: la natura è «tutte le cose insieme») e, se una cosa è tale,
lo è perché vi prevale un certo seme in quantità. Aristotele chiamerà i
semi di Anassagora «omeomerie» (= parti uguali), per il loro essere
divisibili all’infinito, mantenendo inalterato le proprie qualità.
Anassagora postula una forza che fa muovere e ordina i semi,
imprimendo loro l’energia necessaria alla trasformazione. Questa forza è
chiamata «nous» (= intelletto), definito «la cosa più pura e sottile» che
governa i semi senza mescolarsi a essi.
Secondo la cosmologia ideata da Anassagora, il nous dispone un
cosmo ordinato, imprimendovi un movimento turbinoso che porta le
sostanze a dividersi o aggregarsi tra loro secondo il criterio del più raro e
del più denso, dando così origine al mondo come lo conosciamo.
I Sofisti (1)
Lo sviluppo politico, sociale e culturale che caratterizza la Grecia del V
secolo a.C. favorisce la comparsa di una nuova tipologia di intellettuale:
il sofista (dal greco sophòs: “sapiente”). Vengono così chiamati quegli
intellettuali che iniziano a dare, dietro compenso, lezioni di filosofia,
retorica, cosmologia, fisica, grammatica, trasformandole in professioni.
Proprio per questa loro caratteristica, i sofisti furono aspramente criticati
dai loro contemporanei, che li accusarono di mercificare il sapere,
voltando le spalle al tradizionale atteggiamento di ricerca
disinteressata della verità e della conoscenza.
Socrate, Platone e Aristotele, in particolare, contribuirono a dare al
termine un’accezione dispregiativa, etichettando il sofista come colui
che predilige gli argomenti capziosi e ingannevoli e che finisce col
barattare la ricerca della verità con una tecnica di persuasione.
Due sono le possibili conclusioni abbracciate dai maggiori esponenti del
movimento sofistico: la conoscenza umana è irrimediabilmente
soggettiva (Protagora, Abdera 486 - 411), oppure la conoscenza umana
non può uscire dalle maglie del pensiero e del linguaggio e non può mai
incontrare l’essere (Gorgia, Lentini 485 – Larissa 375 a. C.).
[segue]
I Sofisti (2)
L’insegnamento dei Sofisti si concentra soprattutto su:
1. l’arte di usare la parola, che diventa tecnica, e sull’abilità di
formulare discorsi persuasivi, capaci di suscitare nell’ascoltatore reazioni
emotive e finalizzati al raggiungimento di un certo scopo, come il
consenso e l’approvazione dei propri concittadini. In un’epoca in cui le
riforme in senso democratico di Clistene e Pericle avevano ad Atene
esteso l’accesso alle cariche politiche e pubbliche anche a chi non era
aristocratico, l’educazione politica e la capacità di persuadere i cittadini
diventano beni fondamentali.
2. Il relativismo sofistico: i sofisti mettono in dubbio i cardini del
pensiero filosofico che li ha preceduti e le certezze raggiunte dalla
scuola eleatica, soprattutto l’identità fra pensiero, parola ed essere,
affermata con vigore da Parmenide e difesa dai suoi discepoli e
successori. Comincia così a delinearsi un divario tra pensiero ed essere:
la fiducia nella capacità dell’uomo di cogliere in modo definitivo la verità
del reale si incrina, così come la garanzia nella corrispondenza tra ciò
che si pensa e ciò che è.
Sulla sofistica si è seguito: M. Untersteiner: I Sofisti, B. Mondadori Editore, 1996.
I Sofisti: Protagora
Il relativismo di Protagora si traduce nella celebre espressione, contenuta in
uno dei pochi frammenti giunti fino a noi, «l’uomo è misura di tutte le cose».
L’intento di Protagora è quello di delineare la reale situazione in cui l’uomo vive:
poiché manca un criterio divino per valutare la verità o la falsità dei propri
giudizi, l’uomo non può che arrendersi di fronte alla loro relatività, al fatto che
essi cambiano a seconda delle circostanze, delle esperienze personali, delle
prospettive e del tempo in cui vengono formulati. Perciò Protagora può dire che,
in merito a ogni oggetto, esistono due ragionamenti contrapposti (le cosiddette
antilogie). Dal momento che tutti i giudizi godono di una legittima pretesa di
verità, Protagora risolve le inevitabili difficoltà sostituendo il criterio di verità
con quello dell’utilità. Al posto delle variabili vero/falso troviamo quindi quelle
utile/dannoso, sulle quali esiste un certo accordo intersoggettivo. Il lavoro del
filosofo si concentrerà di conseguenza, secondo Protagora, nell’individuare i
mezzi più efficaci per raggiungere un certo scopo, primo fra tutti quello di
produrre le migliori condizioni di vita per l’uomo e la società nel suo complesso.
Per questa ragione il compito più importante del sofista è insegnare la virtù
politica, intesa come capacità pratica, e non solo morale, di produrre determinati
effetti positivi sulla vita comunitaria. La virtù è per Protagora accessibile a tutti
gli uomini, anche se in misura differente: compito di chi la insegna, del sofista, è
di stimolare il massimo sviluppo delle potenzialità e capacità di ciascun
individuo.
I Sofisti: Gorgia (1)
In netta polemica con Parmenide e Zenone, Gorgia, nella sua opera Sul
non essere, elabora la sua celebre tesi tripartita:
1) nulla esiste;
2) se anche esistesse, non sarebbe afferrabile con il pensiero;
3) se anche fosse afferrabile con il pensiero, non sarebbe esprimibile con
le parole.
Con la prima tesi, Gorgia intende smontare il concetto di “essere” di
Parmenide, che è passibile di determinazioni contraddittorie (per
Parmenide, infatti, esso è finito, mentre Melisso lo concepisce infinito).
Con la seconda tesi, che si può accettare come vera solo una volta
ammessa la falsità della prima, ritroviamo le posizioni relativistiche di
Protagora e la mancata identità di essere e pensiero, cui fa da appendice la
sfiducia nelle possibilità del pensiero umano di cogliere la verità (Gorgia fa
notare come l’uomo può pensare cose che non esistono, come i carri che
volano). Con la terza tesi, che è vera se si ritengono false la prima e la
seconda, Gorgia sottolinea la differenza qualitativa tra linguaggio e realtà,
tra le parole e le cose. Ne deriva una concezione dell’uomo rinchiuso nel
suo universo mentale e linguistico, che sarà oggetto di un confronto serrato
nell’ambito della riflessione filosofica dei secoli successivi.
[segue]
I Sofisti: Gorgia (2)
Una volta negato il valore della parola nell’esprimere la verità delle cose,
il linguaggio si libera dell’uso tradizionalmente attribuitogli e finisce con
l’assumere ben altre funzioni.
Per Gorgia il linguaggio ha lo scopo di persuadere, di “ingannare”, nel
senso di creare mondi fittizi capaci di suscitare forti reazioni emotive
nell’interlocutore.
La parola è intesa come farmaco (che in greco significa sia “medicina”,
sia “veleno”), una sorta di narcotico che non agisce sul piano razionale
ma a livello di desiderio/istinto/passione, determinando meccanicamente
certe reazioni e inducendo corrispondenti comportamenti.
Ne consegue che, nel pensiero di Gorgia, la razionalità umana e le sue
possibilità conoscitive sono relegate a un ruolo assolutamente
secondario. E’ quanto emerge dall’ «Encomio di Elena», in cui Gorgia
tenta di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver
provocato, abbandonando il marito per seguire Paride a Troia, la
sanguinosa guerra di Troia. L'argomento non era nuovo: Gorgia
prendeva spunto infatti da un filone preesistente che sosteneva che la
donna in realtà non andò mai a Troia e che al suo posto, con Paride,
partì un fantasma e non Elena in carne e ossa.
[segue]
I Sofisti: Gorgia (3)
Questo fatto scagionava la regina di Sparta come causa del decennale
conflitto. Gorgia per discolparla presenta una serie di implicazioni logiche
secondo le quali Elena non è realmente rea del conflitto tra i greci e i
troiani: si riferisce infatti alla τύχη (= destino), all'eros, alla persuasione
della parola e alla forza fisica.
L'encomio è una dimostrazione della forza della parola che è capace,
mediante un opportuno utilizzo, di ribaltare il convincimento popolare,
risultato di secoli di tradizioni, a proprio piacimento. Elena è innocente,
poiché il movente del suo gesto è esterno alla sua responsabilità perché
dovuto ad uno di questi motivi:
1.per decreto degli dèi: non si era potuta opporre al fato;
2.era stata rapita con la forza;
3.era stata persuasa dalle parole di Paride;
4.era stata vinta dalla passione amorosa.
Nel primo caso Elena non ha colpa, in quanto nemmeno gli dèi stessi
potevano opporsi al Fato. Se rapita, Elena è una vittima, e la colpa è da
assegnare a Paride.
[segue]
I Sofisti: Gorgia (4)
Di nuovo, se persuasa dalle parole, ancora una volta è da ritenersi
innocente, dal momento che, insita nelle parole, è presente una
fortissima carica persuasiva, se queste sono pronunciate da un abile
oratore. Infine, se innamorata, Elena è una vittima, poiché fu Afrodite a
farla innamorare, come ricompensa a Paride per averla giudicata
vincitrice della sfida della Mela d'Oro.
La forza della parola è intesa come "gran dominatrice". Infatti, secondo il
sofista, la parola riesce a dominare le emozioni; la poesia, ad esempio,
riesce a suscitare nell'ascoltatore le stesse emozioni del poeta.
Sempre per far percepire la potenza della parola, il potere d'ingannare
che esse celano, Gorgia conclude ad effetto dicendo che la sua opera
vale sì a difesa di Elena, ma per lui solo come gioco dialettico. Se nulla
è, le parole non significano la verità; anche Elena, che dalla tradizione
antica greca è criticata assai aspramente, può essere innocente, e anzi
degna di compassione. L’importanza del concetto καιρός (= kairòs =
momento giusto o opportuno o anche il tempo di Dio).
L’Encomio certamente riscosse un enorme successo, dato che
successivamente molti altri oratori greci scrissero opere omonime con il
medesimo intento.
Il Socrate della maturità (1)
Per rintracciare il Socrate della maturità dobbiamo rifarci alle
testimonianze dei cosiddetti socratici minori (che sottolineano
l’atteggiamento di Socrate verso una riforma morale dei valori della
grecità) e soprattutto di Platone.
Platone intrepreta Socrate alla luce degli aspetti dell’ironia, del
demone, della «brachilogia» (= discorso breve) basata sulla
domanda socratica per eccellenza τί ἐστί (= ti esti = che cosa è?)
quale rintraccio attraverso la «dialettica» (dal greco διά-λέγειν = dià legein = «parlare attraverso») di quelle che sono le premesse
adialettiche e perciò universali - non più storiche o basate sulle
opinioni come per i sofisti – da cui dedurre un discorso scientificamente
valido sul piano morale e politico (la scienza del bene o della virtù).
Dai dialoghi di Platone emerge sempre più che una dottrina ben definita,
un uomo vivo, impegnato nel discorso umano di una ben precisa città
(Atene), al fine di comprendere sé e gli altri attraverso la ricerca così che
ciascuna volta, indipendentemente da fondamenti morali già dati (dalla
tradizione, dalla circostanza storica, ecc.), ognuno sappia i propri limiti e
perciò le sue stesse possibilità, ogni volta ricominciando da capo perché
ogni situazione è sempre diversa dall’altra.
[segue]
Il Socrate della maturità (2)
Si vedano perciò l’Apologia di Socrate (19 b – d) e il Fedone (96 a – 99
d), in cui si spiega il passaggio dalle ricerche di fisici e dal metodo di
Zenone (destinate allo scacco perché sul piano logico e scientifico ogni
passaggio da un sapere specifico ad un sapere assoluto è illecito:
sapere di non sapere) alla ricerca sugli uomini.
Posto che razionalmente non si può uscire da un orizzonte umano, la
scoperta del Socrate maturo riguardo alle scienze della natura è che i
fenomeni fisici non possono essere interpretati che meccanicisticamente
(Fedone, 95 b), mentre l’uomo non ha una «natura» data: in quanto
azione, in quanto tensione verso l’altro l’uomo costituisce i fini e i valori
secondo ragioni che si vengono delineando attraverso la stessa ragione,
intesa come dialogo continuo fra gli uomini.
Così Socrate decide per sé che, non essendo competente in fisica,
medicina o altre scienze e posto comunque che nulla è possibile
sapere di ciò che è in quanto è, si dedicherà allo studio di come
l’uomo è uomo: non meccanicità, ma costruzione di sé e del
mondo, nel conoscere se stesso attraverso gli altri (Fedone, 99 de). Si guardi anche l’interesse di Socrate per il mondo degli uomini
(Apologia, 40 c – 41 c) ragionando della morte.
L’insegnamento di Socrate (1)
Sapere di non sapere (Apologia, 20 c– 23 c): Socrate precisa che il
suo sapere, il suo più preciso rapporto con i fisici, il suo accordo con i
sofisti nel volgersi su piano umano, nel suo disaccordo con i sofisti stessi
relativamente alla questione di come si costituiscono i rapporti umani, in
una ricerca che è scienza del bene e dell’uomo e nel suo disaccordo
con chi, entro l’ambito di una o altra scienza, pur competente in uno o
altro campo, ritiene che tutto si esaurisca in quella particolare scienza,
che sia quindi possibile un sapere umano assoluto ed unico.
Il paradossale fondamento del pensiero socratico è quindi il "sapere di
non sapere", un'ignoranza intesa come consapevolezza di non
conoscenza definitiva. Questo il senso del detto dell’Oracolo di Apollo
a Delfi (non una conversione quindi, ma una conseguenza invitabile del
suo percorso filosofico).
Egli quindi "investigando e ricercando" conferma l'oracolo del Dio,
mostrando così l'insufficienza dei saperi particolari, compresi quelli della
classe politica dirigente. Da qui le accuse dei suoi avversari: egli
avrebbe suscitato la contestazione giovanile insegnando con l'uso critico
della ragione a rifiutare tutto ciò che si vuole imporre in forza della
tradizione o della religione.
[segue]
L’insegnamento di Socrate (2)
Socrate in realtà non intende affatto contestare la religione tradizionale,
né corrompere i giovani incitandoli alla sovversione.
Socrate, abbandonate le singole ricerche scientifiche a chi in esse è
competente, si è volto in particolare nel richiamare ciascuno alla
propria competenza di sé (all’anima direbbe Platone), nel risvegliare gli
altri uomini ad essere uomini, secondo il motto delfico Γνῶθι σεαυτόν (=
Gnòthi seautòn = conosci te stesso nel senso di: nulla di troppo,
ottima è la misura, non desiderare l'impossibile, o meglio ancora:
conosci chi sei e i tuoi limiti e non presumere di essere di più).
Il dubbio e la maieutica: nel suo procedere Socrate sottolinea che egli
stesso in partenza non sa nulla, anzi è il più dubbioso degli uomini su se
stesso e sul sapere presunto degli altri.
Occorre spogliare i sapienti delle loro verità mediante le domande
tramite quella tecnica di cui Socrate si dichiara esperto: la maieutica (=
arte della levatrice) intesa come l’arte di aiutare a partorire quegli
uomini fecondi, ovvero dubbiosi, ovvero non più presi dalle
impressioni e passioni immediate (Teeteto, 148 e – 151 d). La maieutica
si basa essenzialmente sulla cosiddetta brachilogia.
[segue]
L’insegnamento di Socrate (3)
Al contrario dei sofisti che usano il grande e lungo discorso che non
dava spazio alle obiezioni, Socrate dialoga con brevi domande e risposte
- la cosiddetta brachilogia (= «un breve dialogare») - proprio per dare la
possibilità di intervenire ad un interlocutore che egli rispetta per le sue
opinioni e che fosse «gravido».
Ironia: il continuo ed instancabile domandare di Socrate sulle
affermazioni dell'interlocutore, ponendo ossessivamente la domanda
sulla precisa definizione dell'oggetto del dialogo (il famoso «ti esti» =
che cos'è quello di cui parli?; vedi Sofista, 229 e – 230 d), è stato
chiamato «ironia socratica» da intendersi come gioco di parole che
mette in discussione ogni certezza. Socrate finge di non sapere quale
sarà la conclusione del dialogo, accetta le tesi dell'interlocutore e le
prende in considerazione, portandole poi ai limiti dell'assurdo in modo
che l'interlocutore stesso si renda conto che la propria tesi non è
corretta. Chi dialoga con Socrate tenterà varie volte di dare una
risposta precisa, ma alla fine sarà costretto a confessare la sua
ignoranza. Proprio questo sin da principio vuole Socrate: la sua non è
fastidiosa pedanteria, ma il voler dimostrare che la presunta sapienza
dell'interlocutore è in realtà ignoranza (Apologia, 37 c -38 a).
[segue]
L’insegnamento di Socrate (4)
Il demone socratico: Socrate afferma di credere, oltre agli dèi riconosciuti
dalla polis, anche in una particolare divinità minore, appartenente alla
mitologia tradizionale, che egli indicava con il nome di demone (un essere
divino inferiore agli dèi ma superiore agli uomini: insomma un semidio).
Socrate si dice tormentato da questa voce interiore che si faceva sentire non
tanto per indicargli come pensare e agire, ma piuttosto per dissuaderlo
dal compiere una certa azione. Socrate stesso dice di esser continuamente
spinto da questa entità a discutere, confrontarsi e ricercare la verità morale
(Apologia, 31 c – d).
Etica socratica: è tradizionalmente connotata come «intellettualistica» (in
quanto basata sull’idea che nessun uomo compia il male volontariamente, ma
che questo derivi da un’ignoranza dell’intelletto che non conosce il vero bene)
ed «eudemonistica» (in quanto rivolta alla ricerca della felicità). Tutti gli
uomini possiedono per natura la stessa inclinazione alla felicità, ma spesso
sbagliano nell’individuare in che cosa questa consista: solo chi si comporta in
modo virtuoso, buono e giusto, può essere felice. Ne deriva una nuova
concezione dell’uomo come essere spirituale che rivolge al suo interno
la propria attenzione, e della felicità, intesa non come qualcosa che
dipende da fattori esterni, come la gloria o i beni materiali, ma come una
qualità dell’anima orientata alla virtù e al bene (Apologia, 28 b - 31 b).
Platone: Il Fedone (1)
Il Fedone (in greco: Φαίδων, sottotitolo: Sull'anima) è uno dei più celebri
dialoghi di Platone che lo ha composto probabilmente fra il 386 e il 385
a.C. Argomento centrale del dialogo è l'immortalità dell'anima.
I personaggi principali del dialogo diretto sono due:
Fedone di Elide, allievo di Socrate e voce narrante del dialogo; fondò ad
Elide una scuola socratica che, alla sua dissoluzione, fu trasferita a
Eretria. Ci racconta di lui Diogene Laerzio: «Fedone di Elide, degli
Eupatridi, fu catturato insieme con la caduta della sua patria e fu
costretto a stare in una casa di malaffare (o in un bordello). Ma
schiudendo la porta riuscì a prendere contatto con Socrate e alla fine,
per incitamento di Socrate, Alcibiade, Critone e i loro amici lo
riscattarono. Da allora divenne libero e si dedicava alla filosofia». In
realtà, secondo le notizie pervenutaci attraverso altre fonti, Fedone
venne fatto prigioniero durante la battaglia tra Elide e Sparta e poi
acquistato da un ateniese mercante di schiavi. Servendo il pasto nella
dimora del suo nuovo padrone, rispose al posto di questi a una domanda
di un illustre invitato di nome Socrate. Stupito per lo spirito e per la
bellezza di Fedone, Socrate acquistò il giovane dal suo amico e ne fece
un suo discepolo;
[segue]
Platone: Il Fedone (2)
Echecrate di Fliunte, filosofo pitagorico e interlocutore di Fedone nel dialogo
diretto.
I personaggi principali del dialogo narrato sono:
Socrate, filosofo e maestro di Platone;
Simmia di Tebe, filosofo allievo, in un primo momento, del filosofo pitagorico
Filolao, in seguito "convertitosi" alla dottrina di Socrate;
Cebète di Tebe, altro ex-allievo di Filolao, amico di Simmia;
Critone, facoltoso cittadino ateniese, amico e allievo di Socrate nonché
protagonista del dialogo platonico omonimo.
Molti altri personaggi erano presenti al momento della morte di Socrate.
Platone è invece stranamente assente, forse malato (59 b): in realtà,
nessun'altra fonte antica parla per quell'epoca di una malattia del filosofo
tanto grave da impedirgli di assistere il maestro nelle ultime ore.
Con la sua assenza Platone forse vuole affermare che il dialogo non sarà
una cronaca puntuale della morte di Socrate, quanto piuttosto una sua
ricostruzione letteraria in linea con lo spirito dialogico del maestro.
L’espediente del dialogo narrato consente la descrizione di
un’atmosfera che è del tutto particolare e di fondamentale importanza
per gli eventi ed i ragionamenti che vi si svolgono in un modo che
nessun dialogo diretto renderebbe possibile.
[segue]
Platone: Il Fedone (3)
In collegamento con gli eventi descritti con gli stati psicologici degli astanti
e degli interlocutori di Socrate, vanno visti i vari argomenti che vengono
presentati e discussi e se ne potrà capire la natura ed il significato,
rifiutando un’analisi di tipo esclusivamente logico che non tenga
conto di componenti extralogiche importanti: in particolare, del tipo di
interlocutore e della reazione che l’argomento suscita in lui.
Forse nessun dialogo come il Fedone offre tanto materiale di riflessione in
proposito.
La struttura generale dell’opera appare legata dal principio alla fine ad una
serie di motivi che vengono ripresi via via con successivi approfondimenti e
che ascendono dal livello di dati esterni, apparentemente occasionali e
quasi trascurabili, ad elementi dotati di intrinseca necessità che
conferiscono significato anche a quanto precede.
Occorre infine ricordare che l’evento narrato – cioè la morte di
Socrate - è della massima importanza; esso rappresenta in un certo
senso per Platone il farsi stesso della Filosofia: il punto in cui la
Filosofia (come «amore della sapienza», come «aspirazione e
desiderio della sapienza»), tocca il suo temine (la conquista della
sapienza), anche se essa risulta, come totalità, umanamente
irraggiungibile.
[segue]
Platone: Il Fedone (4)
La vita e morte di Socrate, nella descrizione platonica, appaiono da un
lato come espressione del giusto rapporto tra mondo sensibile e mondo
intelligibile, dall’altro come suprema conferma che la verità, condizione
della ricerca filosofica, esiste realmente e che la vita dell’uomo
assume significato soltanto nella misura in cui egli la cerca e crede
in essa.
La vita umana assume significato soltanto attraverso la
conoscenza: l’ascetismo che Socrate propone, la conquista della
massima purezza dell’anima, non sono una forma di macerazione
per una colpa, un’espiazione religiosa e mistica ante litteram, ma la
condizione necessaria per l’esercizio non offuscato della ragione;
l’aldilà promesso è la vita dell’Essere vero, la piena attuazione
della conoscenza.
La vita come «esercizio di morte» è dunque da intendersi come
esercizio di conoscenza, come ricerca del sapere, come filosofia.
Ed il fatto che si attui appieno solo nell’aldilà vale ad indicare che la
filosofia avrà fine solo con la fine della storia dell’uomo.
[segue]
Platone: Il Fedone (5)
Cornice del dialogo (57 a – 58 a)
Echecrate chiede a Fedone di narrare a lui e ai suoi allievi le ultime ore di
Socrate, poiché le notizie giunte da Atene al riguardo sono poche e vaghe.
Fedone, presente al momento dell'esecuzione, accetta di buon grado, e inizia a
narrare ciò che accadde quel giorno, riportando i discorsi intrattenuti da
Socrate con i due filosofi tebani Simmia e Cebète. Il dialogo diretto (quello fra
Fedone ed Echecrate) si svolge, per l'appunto, a Fliunte.
Dopo un mese di prigionia, è infine giunto per Socrate il giorno dell'esecuzione,
momento per lungo tempo rimandato, poiché dovevano far ritorno le navi che
ogni anno venivano mandate a Delo in onore di Apollo, per ringraziarlo di aver
aiutato Teseo a liberare Atene dal pericolo del Minotauro (58 b).
Appresa la notizia dal messo degli Undici (collegio di magistrati ateniesi
preposti alle prigioni, scelti a sorte uno per ciascuna delle 10 tribù, con in più un
segretario; erano assistiti, specialmente nell’esecuzione della condanna, da
aiutanti), gli allievi si riuniscono attorno al maestro per passare insieme a lui le
ultime ore.
In carcere Socrate è tranquillo e, dietro l’invito di Apollo apparsogli in sogno, ha
iniziato a comporre poesie, mettendo in musica i propri insegnamenti (60 d - 61
c). In questo senso, Platone ci informa che il Fedone può essere inteso come il
«canto del cigno» di Socrate (85 a).
[segue]
Platone: Il Fedone (6)
Socrate inizia a discutere della propria condizione di condannato a morte
con quelli che saranno i suoi interlocutori nel dialogo: i tebani Simmia e
Cebète, già allievi del pitagorico Filolao (61 d). Non è casuale il richiamo a
Pitagora la cui dottrina poneva grande attenzione ai concetti di anima,
armonia, metempsicosi e purificazione.
Socrate afferma infatti che la sua condizione non è affatto da compiangere,
poiché qualsiasi filosofo, in quanto tale, desidera morire; ciò non significa,
però, che la morte debba essere ricercata o anticipata attraverso il
suicidio che è un atto considerato empio, cioè contro il volere degli
Dei.
L'apparente contraddizione che si viene a creare si scioglie nel momento in
cui Socrate prende in esame il fatto che, come affermano certi Misteri
(presso gli antichi greci e romani, erano chiamati così i riti di iniziazione e
culti segreti quali i misteri eleusini, dionisiaci, orfici, ecc.; i misteri si
configuravano come particolari sistemi religiosi segreti, differenziati dalla
religione pubblica della collettività e circoscritti a una cerchia di iniziati), il
corpo è come un carcere, da cui non possiamo liberarci di nostra
iniziativa: gli uomini sono infatti proprietà degli Dei, e sarebbe un
gesto oltremodo blasfemo togliersi la vita senza che essi lo abbiano
ordinato apertamente (62 a-c).
[segue]
Platone: Il Fedone (7)
Cebète tuttavia obietta a Socrate che, se gli uomini si trovano veramente nelle
mani di padroni così buoni e savi come sono gli Dei, non vi sarebbe alcun
motivo di desiderare la morte.
A tali parole, Socrate risponde enunciando quello che sarà il fine del dialogo: la
vita del filosofo è preparazione alla morte (63 b - 69 e). In altre parole: Socrate
tenterà di dimostrare che nulla di male può accadere all'uomo buono né in
vita né in morte, e che anzi, anche dopo la morte l'anima continuerà ad
esistere (63 b-c).
Continuando nella risoluzione del precedente paradosso, la morte è intesa
come separazione dell'anima dal corpo. Il filosofo non si cura del corpo e dei
suoi piaceri, ma ambisce al perfetto sapere (il giusto in sé), che appartiene
solo all'anima. La morte, dunque, in quanto liberazione dal corpo, è una
purificazione per l'anima. La vita del filosofo sarà allora un continuo esercizio di
preparazione alla morte, purificando sempre più l’anima (64 a-68 b).
In questo senso solo i filosofi sono coraggiosi e temperanti, mentre gli
altri uomini, paradossalmente, lo sono per paura e intemperanza: la virtù
infatti è vera conoscenza e la purificazione da ogni altra passione, il che è
prerogativa del filosofo, non dell'uomo comune (68 b-69 e).
Con questa prima dimostrazione generale si conclude quella che è la prima
parte del dialogo.
[segue]
Platone: Il Fedone (8)
La prima dimostrazione è portata avanti con molta attenzione dal filosofo, così da
persuadere completamente i suoi due interlocutori. Il discorso di Socrate sulla
morte come distacco dell'anima dal corpo viene accettato di buon grado dai due
tebani. Tuttavia, ciò che ancora non li convince è l'effettiva immortalità dell'anima
una volta uscita dal corpo. Come afferma infatti Cebète, gli uomini «temono che,
nell'atto medesimo in cui ella si distacca dal corpo e ne esce, subito come
soffio o fumo si dissipi e voli via». Inoltre, la persistenza dell'anima dopo la
morte non basta per affermare che essa sia immortale: essa deve conservare
anche «potere e intelligenza», cioè mantenere la propria coscienza individuale
(70 b). Socrate risponde a queste obiezioni con tre diversi argomenti:
Prima prova dell’immortalità dell’anima: argomento dei contrari (70 c-72 e).
Anzitutto, Socrate mostra come ogni cosa tragga origine dal proprio contrario.
Dal forte si genera il debole, dal grande il piccolo, dal veloce il lento, e, perché
ciò avvenga, tra i due contrari vi deve essere un processo che permetta di
passare dall'uno all'altro (per esempio: il crescere e il decrescere, il raffreddarsi e
il riscaldarsi…). La stessa cosa accade per il vivere e il morire: dal vivo si genera
il morto, e allo stesso modo, con il processo contrario del rivivere, dal morto si
genera il vivo. E se è possibile rivivere, è necessario che le anime non
scompaiano, ma continuino ad esistere anche fuori dal corpo. D'altra parte, se si
esclude che dal morto nasca il vivo, si dovrebbe ammettere che una legge di
natura («i contrari si generano dai contrari») non abbia valore universale, il che è
impossibile.
[segue]
Platone: Il Fedone (9)
Seconda prova dell’immortalità
reminiscenza (72 e-78 b).
dell’anima:
argomento
della
Cebète richiama allora la dottrina della reminiscenza socratica, secondo
cui ogni nostro apprendimento è in realtà un ricordo di qualcosa conosciuto
in precedenza, prima della nostra nascita. Ma, obietta Simmia, come può
Socrate dimostrarlo, quali prove dà di questa teoria?
Il filosofo richiama anzitutto l'attenzione su alcune basi condivise: se
qualcuno ricorda qualcosa deve averla vista in precedenza; inoltre il
ricordo di una cosa può smuoverne un altro (un oggetto, per esempio,
ricorda l'innamorato) e tale associazione può avvenire anche di fronte alle
semplici immagini dipinte di tali oggetti.
Ora, noi diciamo che queste associazioni sono possibili in base alla
somiglianza o alla dissomiglianza tra gli oggetti: ma il concetto di "simile",
ovvero l'uguale in sé, da dove proviene? Poiché noi infatti lo conosciamo, è
necessario che da qualche parte lo abbiamo visto e conosciuto, e siccome
in questa vita abbiamo esperienza di oggetti uguali, ma non dell'uguale in
sé, è necessario che sia successo in una vita precedente. A questo punto,
Socrate può ricollegarsi al precedente argomento e riaffermare che le
anime sono immortali e posseggono conoscenza.
[segue]
Platone: Il Fedone (10)
Terza prova dell’immortalità dell’anima: argomento dei composti (78
b - 80 b), ovvero ciò che è composto può decomporsi.
Nonostante tutto, Simmia e Cebète non sono ancora persuasi dalle parole
di Socrate, e riportano la credenza di molte persone, secondo la quale
l'anima, dopo la morte del corpo, si dissolve nell'aria. Socrate però
allontana subito tali timori: solo ciò che composto può decomporsi e,
dissolvendosi nelle sue parti, perire. L'anima invece è simile alle idee le
quali - e qui Socrate fornisce l'unica definizione delle idee presente
nell'intero corpus dell’opera platonica - sono quelle cose che
«permangono sempre costanti e invariabili», le uniche che si possano
pertanto dire «non composte». Essendo dunque congenere alle idee, e
quindi di natura elementare e invisibile, l'anima non può modificarsi né
tanto meno perire. Dimostrazione di questa superiorità dell'anima sul
corpo è anche il fatto che è la prima a governare sul secondo, e non
viceversa.
Dopo queste tre prime dimostrazioni Socrate passa a descrivere il destino
che le anime avranno dopo la morte (81 d e sgg.).
La seconda parte del dialogo termina poi con un ulteriore discorso di
Socrate circa la virtù dell'anima e l'importanza della filosofia.
[segue]
Platone: Il Fedone (11)
La dottrina dell'anima-armonia
La terza parte del dialogo inizia con un momento di stallo. Socrate e gli
allievi rimangono in silenzio a riflettere su quanto appena detto, mentre
Simmia e Cebète restano discosti a parlare tra di loro. Interrogati da
Socrate, i due tebani affermano di non essere ancora del tutto persuasi e
di avere altri dubbi circa l'effettiva immortalità delle anime.
Per tale motivo, propongono a Socrate altre due obiezioni.
Simmia afferma che il ragionamento proposto in precedenza si adatta
anche all'idea che l'anima sia simile a un accordo musicale: come
l'accordo è prodotto da uno strumento e non gli sopravvive una volta
che lo strumento è rotto, allo stesso modo l'anima potrebbe essere
un prodotto del corpo e dissolversi con esso.
Cebète invece propone un'analogia con un tessitore di mantelli il quale,
dopo aver fabbricato e usurato vari mantelli nel corso della propria vita, alla
fine muore prima di aver consumato anche l'ultimo: non può essere allora
che anche l'anima, dopo aver vissuto varie vite, alla fine si dissolva e
muoia come il tessitore?
Socrate accetta queste due ultime obiezioni, ribadendo che dovrà
rispondervi subito, poiché in futuro non ne avrà più l'opportunità. [segue]
Platone: Il Fedone (12)
Il timore di Socrate, il vero lutto da scongiurare, non è infatti la propria
morte, bensì la «morte del logos»: come afferma parlando con il giovane
Fedone accarezzandogli i capelli, bisogna impegnarsi con tutte le forze per
giungere, attraverso la maieutica, a un risultato positivo per la propria
indagine. In caso contrario, il rischio è quello che il ragionamento muoia e,
di conseguenza, si cada nella misologia - ovvero si inizi a diffidare del
logos come strumento di indagine (89 b-c).
Socrate si sofferma quindi su quanto detto da Simmia. Il filosofo tebano ha
riproposto una teoria di origine pitagorica, la dottrina dell’anima-armonia:
poiché infatti il corpo è l'unione ben temperata di caldo e freddo, umido e
secco, e via dicendo, è possibile pensare che l'anima sia l'accordo che
armonizza questi elementi - e che quindi, come qualsiasi armonia, essa
scompaia con la scomparsa del corpo (85 e - 86 d).
Dopo aver richiamato l'attenzione su alcuni punti condivisi delle precedenti
dimostrazioni, Socrate obbietta a Simmia che l'anima non può essere
paragonata ad un accordo poiché, mentre l'anima governa il corpo e ne
regola le passioni, l'armonia di uno strumento non può governare lo
strumento stesso; al contrario, subisce delle modificazioni a seconda di
quelle cui va incontro lo strumento (92 e – 93 a).
[segue]
Platone: Il Fedone (13)
Simmia, accettando allora la dottrina della reminiscenza, deve rifiutare
quella dell’anima-armonia (94 b - e). Inoltre, se tutte le anime fossero
armonie, dovrebbero essere tutte uguali - mentre sono diverse - e
dovrebbero sottostare ai desideri dei corpi, in quanto loro prodotti - mentre
si è detto che avviene l'esatto contrario (93 a – 95 a).
La «seconda navigazione» e la ricerca delle cause prime (95 a – 99 d)
Persuaso Simmia, Socrate deve ora rispondere a Cebète la cui obiezione,
tutt'altro che ingenua, richiede di cercare «la causa della generazione e
della corruzione delle cose» (96 a).
Pertanto, prima di rispondervi, il filosofo decide di richiamare l'attenzione
sul metodo che si deve adoperare nelle indagini filosofiche e che in realtà
costituisce un’autobiografia intellettuale di Socrate.
Socrate racconta di essersi dedicato in gioventù allo studio della natura e
di aver indagato le cause di tutte le cose senza però riuscire a rintracciare
una causa prima.
Sconfortato da risultati così deludenti, che per di più lo avevano confuso su
quanto già sapeva, Socrate racconta di aver pensato di abbandonare quel
genere di studi, finché un giorno non sentì leggere «da un tale» (forse da
Archelao, suo maestro) alcuni passi del libro di Anassagora.
[segue]
Platone: Il Fedone (14)
Nel libro di Anassagora veniva addotta come causa di tutte le cose una
mente ordinatrice (νοῦς = nous). Entusiasta, il giovane Socrate si era
affrettato a leggere l'opera di Anassagora, ma la delusione fu grande
quando si accorse che il filosofo riduceva tutto a cause materiali, come
l'aria, l'etere, l'acqua (98 c).
Secondo simili tesi, commenta Socrate, sarebbe come cercare di spiegare
la sua presenza in carcere adducendo a cause i suoi nervi e la
conformazione dei suoi muscoli, invece che la sua scelta di accettare la
decisione del tribunale.
Fu così che, non trovando né maestri né soluzioni, Socrate decise di
mutare «modo di navigazione», ricorrendo qui alla nota metafora della
«seconda navigazione» (99 c – 101 e).
Non vi è tra gli studiosi un'interpretazione condivisa di questa metafora, ma
sembra comunque chiaro che Socrate abbia deciso di abbandonare lo
studio degli enti (gli oggetti sensibili) per dedicarsi a quello delle cause
prime, ben più difficoltoso.
Come appare infatti dalla metafora dell'acqua (99 d 5-6), non è possibile
guardare direttamente le cose senza finire accecati: è dunque necessario
ricorrere ad un filtro, ovvero ai discorsi (λόγοι = logoi). Rivolgendosi ai
λόγοι è però facile perdersi.
[segue]
Platone: Il Fedone (15)
Per porre rimedio a questo pericolo, afferma Socrate, è necessario
procedere con cautela: partendo da una regola generale, riconosciuta ben
solida, se ne trarranno le conseguenze, le quali andranno messe in
relazione con l'ipotesi di partenza, così da valutare se sono d'accordo
oppure no, e quindi se sono accettabili o meno.
Nel caso, poi, si dovesse dar ragione dell'ipotesi di partenza, bisognerà
procedere allo stesso modo, ponendo via via altre ipotesi di valore sempre
più universale, fino a raggiungere l'universalità massima (101 c - e).
In questo modo è possibile scoprire le cause prime (cioè le cose in sé, le
idee, le forme) e quindi, per esempio, affermare che, se di due uomini uno
è più alto dell'altro, il primo supera il secondo non tanto e non solo per la
testa, ma perché partecipano dell'idea della grandezza in sé che consente
di fare tale paragone.
L'ultimo argomento sull’immortalità dell’anima (100 a – 106 e): l’anima
è immortale ed indistruttibile.
Fatte queste premesse, Socrate può ora occuparsi dell'obiezione di Cebète.
Nel precedente ragionamento si è detto che le cause prime sono le idee, di
cui partecipano gli oggetti sensibili (100 a).
[segue]
Platone: Il Fedone (16)
Ora, le realtà in sé hanno la caratteristica di non accettare in sé il
proprio contrario - senza con ciò negare la legge secondo cui il contrario
nasce dal contrario, poiché se il piccolo nasce dal grande, non per questo
partecipa dell'idea del grande.
Anche tra le cose, accade lo stesso: alcuni oggetti partecipano di uno
solo dei contrari (per esempio, la neve del freddo, il due del pari) e
quando ad essi si avvicina qualcosa che partecipa dell'idea contraria,
essi o periscono o vanno via. Per esempio, la neve, che per essenza è
fredda, se avvicinata al caldo si scioglie, e lo stesso i numeri pari, se
sommati a quelli dispari diventano dispari (103 c – 105 b).
Questo ragionamento viene applicato all'obiezione in campo: anche
l'anima infatti partecipa essenzialmente di un'idea, quella della vita, e
per questo motivo essa non potrà morire, poiché altrimenti l'idea
della vita non sarebbe più vita; perciò, quando l'anima entra in
contatto con la morte, non potendo accogliere su se stessa tale idea,
essa se ne andrà via salva e incorrotta (106 e).
Socrate ha così dimostrato una volta per tutte che l'anima è per essenza
immortale e incorruttibile. A Simmia e Cebète non resta che concordare
con lui che bisogna prendersi cura della propria anima e mantenerla sana
attraverso l'esercizio della virtù.
[segue]
Platone: Il Fedone (17)
Il mito escatologico conclusivo (107 c – 114 c)
Ma Cebète, nonostante non possa confutare gli argomenti di Socrate, non
riesce ancora ad essere completamente persuaso.
Socrate allora racconta, come conclusione del dialogo, un mito.
Spiegazione: μῦϑος = parola, discorso, racconto, favola, leggenda:
narrazione fantastica tramandata oralmente o in forma scritta, con valore
spesso religioso e comunque simbolico, di gesta compiute da figure
divine o da antenati - esseri mitici - che per un popolo, una cultura o una
civiltà costituisce una spiegazione sia di fenomeni naturali sia
dell’esperienza trascendentale, il fondamento del sistema sociale o la
giustificazione del significato sacrale che si attribuisce a fatti o a
personaggi storici; con lo stesso termine si intende anche ciascuno dei
temi della narrazione mitica in quanto trattati ed eventualmente rielaborati
in opere letterarie o filosofiche (per Platone, rappresentazione verosimile,
in forma di allegoria, di realtà inattingibili da parte della ragione): i m. della
genesi del mondo e dell’uomo; il crearsi, il diffondersi di un m.; i m. greci,
romani, orientali; il m. di Prometeo, di Teseo e Arianna; il m. della
spedizione degli Argonauti può essere interpretato come allegoria delle
antiche navigazioni; il m. della reincarnazione in Platone.
[segue]
Platone: Il Fedone (18)
Socrate conclude il Fedone raccontando un mito escatologico (escatologia =
dottrina che riguarda i destini ultimi dell’umanità e del singolo; è una parte
delle credenze coessenziale all’idea stessa della religione sia tra quelle
cosiddette «primitive» sia presso le religioni «superiori»), che ha la funzione di
descrivere quello che - ragionevolmente - dovrebbe essere il destino delle
anime dopo la morte.
La Terra è una sfera posta al centro dell'universo, ma quella che noi uomini
conosciamo e abitiamo non è che una sua parte. Essa è infatti come una
grotta sovrastata dall'aria, di cui noi abitiamo la parte interna - situazione
paragonabile a quella degli organismi marini, i quali, vivendo sott'acqua,
pensano che il limite del mondo sia il cielo.
Inoltre sulla terra, a sua volta, esistono altre cavità e altre voragini, la
principale delle quali è quella che Omero e i poeti chiamano Tartaro, in cui
confluiscono tutte le acque dei fiumi e dei mari e da cui poi escono di nuovo. In
questo luogo, inoltre, vi sono vari fiumi che non mescolano mai le proprie
acque, tra i quali i quattro principali sono: l'Oceano, l'Acheronte (che,
attraversando luoghi deserti, alla fine giunge all'Acherusiade, dove sono
convogliate le anime dei morti prima della loro palingenesi, ovvero il processo
di progressiva purificazione e liberazione dell’anima attraverso successive
incarnazioni), il Piriflegetonte (in cui scorrono i lapilli e la lava che poi eruttano
dai vulcani) e lo Stige (che nasce dalla palude Stigia).
[segue]
Platone: Il Fedone (19)
Per quanto riguarda il destino delle anime nell'Oltretomba, esse dovranno
dapprima essere sottoposte a giudizio, in modo da distinguere quelle buone
da quelle cattive: le buone ricevono un premio, le cattive vengono relegate
per sempre nel Tartaro - o in altro luogo, secondo la colpa -, mentre quelle la
cui vita non è stata né buona né cattiva vengono raccolte nella palude
dell'Acherusia, dove dovranno purificarsi in vista dei premi futuri.
La morte di Socrate (115 b – 118)
Dopo tanti discorsi, viene però il momento per Socrate di abbandonare
questa vita. La scena descritta da Platone, tuttavia, non è tragica: l'intero
dialogo ha infatti dimostrato che all'uomo buono, che ha esercitato la
filosofia per tutta la vita, non può succedere nulla di male né in vita né in
punto di morte.
Si viene così delineando l'immagine di Socrate come anti-eroe tragico, e il
Fedone risulta in questo modo l'anti-tragedia per eccellenza. Socrate, con la
propria morte, dimostra nella pratica ciò che era andato spiegando durante
la propria vita: non può succedere che il saggio soffra senza colpa a
causa del proprio destino, ma anzi, gli Dèi non gli imputeranno dolore
e sofferenza.
[segue]
Platone: Il Fedone (20)
Questo è il più puro insegnamento che il logos socratico ci ha lasciato, la
certezza, secondo ragione, che chi vive una vita morigerata, dedita alla
filosofia e alla cura della propria anima, non deve temere alcun male.
Giunta l'ora, Socrate abbandona i propri allievi per congedarsi dai parenti,
quindi si lava e, date le ultime raccomandazioni ai suoi cari, ribadisce a
Critone di non preoccuparsi per la propria sepoltura, poiché la sua anima
verrà liberata dal carcere in cui è stata rinchiusa per tanto tempo.
Celeberrimo è il finale, dove Socrate, morente per avere ingerito un
pharmakon (secondo una discussa tradizione la cicuta) e circondato dai
suoi allievi piangenti, chiede al suo fidato amico Critone di ricordarsi di
offrire un gallo ad Asclepio (Dio della medicina), in segno di ringraziamento
per la liberazione dell’anima dal corpo.
Due parole sul programma del 2015.
Una parola sul futuro.
Siete stati proprio bravi!!
Opere consultate per il corso (in rosso quelle difficili)
Testi e opere dei filosofi trattati:
Platone: Simposio, Apologia di Socrate, Critone e Fedone, Mondadori Editore, 2005.
G. Giannantoni (a cura): I Presocratici: Testimonianze e frammenti, 2 volumi, Laterza Editore, 1990.
G. Colli: La sapienza greca, 3 Volumi, Adelphi Editore, 1990, 1992 e 1993
Introduzione alla filosofia:
T. Nagel: Una brevissima introduzione alla Filosofia, Il Saggiatore, 1997.
A. Massarenti: Il filosofo tascabile: dai presocratici a Wittgenstein, 44 ritratti per una storia del pensiero in miniatura, Guanda
Editore, 2009
R. Casati: Prima lezione di filosofia, Laterza Editore, 2011
R. Fisher: L' arte del negoziato, Mondadori Editore, 1995
K. Jaspers: Introduzione alla filosofia, Cortina Editore, 2010
Storia e Letteratura:
M. Finley: Il mondo dei Greci, Einaudi Editore, 1987.
L. Canfora: Il mondo di Atene, Laterza Editore, 2011.
Omero: Iliade, Einaudi Editore, 2005
Omero: Odissea, Einaudi Editore, 2004.
Sofocle: Edipo re, in Tragici Greci, Mondadori Editore, 2008
Manuali e opere di storia della filosofia antica:
M. Dal Pra: Sommario di storia della filosofia, Volume I, La Nuova Italia Editrice, 1986.
G. Reale: Storia della filosofi antica, Volume I, Vita e Pensiero, 1984.
F. Adorno: La filosofia antica, Volume I, Feltrinelli Editore, 1984.
P. Hadot: Che cos' è la filosofia antica?, Einaudi Editore, 1998
G. Colli: La natura ama nascondersi, Adelphi Editore, 1988
Opere specifiche su alcuni filosofi:
R. Laurenti: Eraclito, Laterza Editore, 1974.
A. Capizzi: Introduzione a Parmenide, Laterza Editore, 2000.
G. Colli: Gorgia e Parmenide, Adelphi Editore, 2003
F. Adorno: Introduzione a Socrate, Laterza Editore, 2008.
G. Reale: Socrate: alla scoperta della sapienza umana, Rizzoli, 2000
S. A. Kierkegaard: Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, Rizzoli, 1995.
P. Hadot: Elogio di Socrate, Il melangolo, 1999