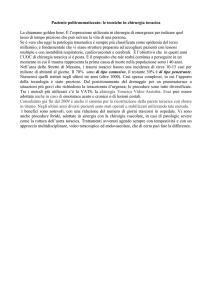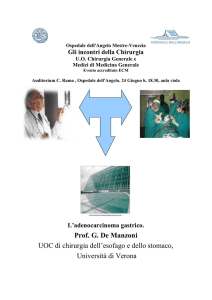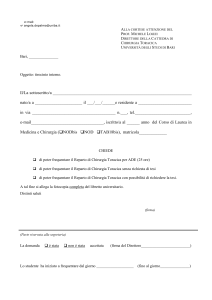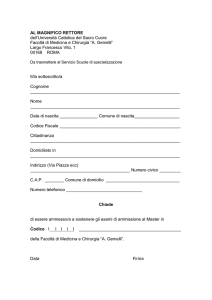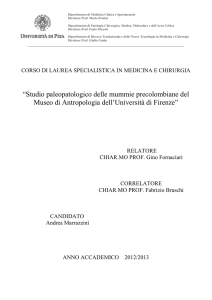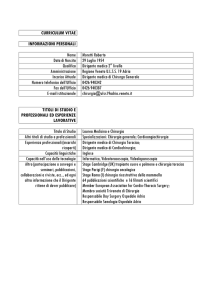“Porto avanti il bioscreening, un test di diagnosi precoce,
che individua i tumori a uno stadio molto iniziale”
Il cognome è di quelli ingombranti, soprattutto per chi, come lei, ha deciso di seguire in qualche modo le orme paterne. Ma Giulia Veronesi,
classe 1969, quinta figlia dell’oncologo scomparso lo scorso novembre,
non pare per niente intimidita da tanta eredità: ha studiato alla Statale
di Milano, si è specializzata in Chirurgia generale e poi in Chirurgia
toracica e ha portato i robot in sala operatoria.
Amore «antico» il suo, iniziato già ai tempi della tesi di laurea e attivo dal 2006, cioè
dal suo incontro con i primi robot sofisticati tra cui il macchinario Da Vinci che è in
uso all’Humanitas, dove Giulia Veronesi è passata dopo 15 anni trascorsi allo IEO,
fondato da padre Umberto, e dove ha anche avviato uno screening del tumore polmonare per la diagnosi precoce e l’individuazione dei fattori di rischio.
Ci racconta in che cosa consiste il suo impegno?
«Nell’ambito della chirurgia robotica applicata ai tumori del polmone, mi occupo
dello sviluppo di questa tecnica nell’ambito dell’équipe di Chirurgia Toracica, coordinata dal dottor Marco Alloisio. È una chirurgia nuova, che prevede step precisi per la
formazione per questo esiste un gruppo di lavoro europeo che porrà le basi delle linee
guida sul training che devono seguire i chirurghi. Contemporaneamente porto avanti
il bioscreening, un test di diagnosi precoce del tumore polmonare validato con una
Tac spirale a basso dosaggio, un esame che dura 6 secondi, e che individua i tumori a
uno stadio molto iniziale».
Come funziona?
«La ricerca ha lo scopo di individuare particolari marcatori molecolari (microRNA
o mutazioni nel DNA), nel siero di persone a rischio, come i fumatori o gli ex-fumatori, soggetti con familiarità o esposizione ad agenti cancerogeni, messo a punto con
l’obiettivo di favorire strategie di prevenzione o di cura personalizzate. Qui in Humanitas abbiamo una nuova macchina che è in grado di analizzare le cellule tumorali nel
sangue e dare già delle indicazioni sulla diagnosi e i fattori di rischio. Dallo sviluppo
di questo studio, che portiamo avanti insieme all’Università di Parigi, vogliamo trarre
una strategia non invasiva per la prevenzione. Il nostro impegno è anche promuovere
sul territorio, con il supporto delle Istituzioni, la diffusione della tac torace di screening».
Quanto è importante lo screening nella prevenzione?
«Importantissimo. La tac a bassa dose di radiazioni ha il ruolo di identificare il tumore, quando c’è, in fase molto iniziale e asintomatica (il 70/80 per cento dei tumori si
trova in stadio iniziale), mentre ora chi arriva alla diagnosi troppo spesso è gia in stadio avanzato. Altri screening oncologici sono già routine in Italia. Il nostro obiettivo è
che anche questo lo diventi. Importante sarà anche identificare meglio la popolazione
a rischio».
Che cosa direbbe a una ragazza che volesse intraprendere gli studi di medicina?
«Che come per tutto deve essere disposta a dedicare molto tempo al lavoro: per la
qualità di ciò che si fa l’impegno è necessario. Il che non vuol dire sacrificare la sfera
privata (Giulia Veronesi ha tre figli di 7, 11 e 14 anni, n.d.r.), ma trovare spazi per
l’una e per l’altra cosa. La determinazione è fondamentale, non bisogna fermarsi di
fronte alle difficoltà. E poi non bisogna avere paura di entrare in un ambiente troppo
maschilista: non è più così. Perfino la chirurgia sta diventando sempre più femminile,
anche grazie alle nuove tecnologie che permettono un approccio più soft a specialità
dove fino a ieri era banalmente necessaria la forza fisica. Penso ai robot con cui lavoro:
seduta davanti a un monitor, una donna chirurgo può stare in sala operatoria anche
durante la fase finale della gravidanza».
C’è una «via femminile» alla medicina?
«Credo che esista una predisposizione del genere
femminile alla medicina. Tantissime qualità delle
donne si adattano perfettamente al lavoro di cura.
Non ultima la naturale tendenza ad accogliere le
emozioni e la minore competitività. Il rispetto
degli altri, la scarsa aggressività, favoriscono il
lavoro di gruppo che dà risultati migliori rispetto
alle performance solitarie»
Lei ha lavorato A Parigi, a New York, e tuttora fa parte di un board di chirurghi
internazionali. Quanto è importante per un giovane un’esperienza all’estero?
«È fondamentale per imparare a confrontarsi anche con altre realtà. La formazione in
Italia è eccellente ma in medicina, nella fase del training chirurgico, c’è ancora la tendenza a non far operare i giovani. Ma la pratica in sala operatoria è la base. All’estero
questa barriera è molto più fluida ed esiste un sistema meritocratico che da noi stenta
a decollare, a meno che sulla nostra strada non incontriamo un mentore illuminato.
Detto questo, il ritorno in Italia è auspicabile perché anche qui si lavora bene, e ci sono
strutture efficienti».
Come, per esempio, lo Ieo, dove lei ha lavorato per 15 anni, e l’Humanitas. Per
quale motivo ha lasciato l’ospedale fondato da suo padre?
«I motivi erano legati all’opportunità di avere un maggiore spazio per la chirurgia e
la ricerca per il futuro. I fondi sono un problema che riguarda tutti, qui ho trovato
supporto nello sviluppare progetti finalizzati a ottenere i finanziamenti necessari a
portare avanti la ricerca. In più l’Humanitas è anche un ambiente stimolante per la sua
università internazionale che inoltre cercava profili di clinici nell’ambito della chirurgia toracica (la mia specialità) per espandersi. Qui abbiamo creato un team trasversale
e aperto di ricercatori che include tra gli altri chirurghi, radiologi, medici nucleari,
biologi e bioinformatici: posso proprio dire che la ricerca è il nostro “stile” quotidiano».