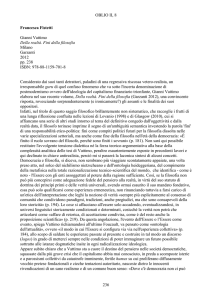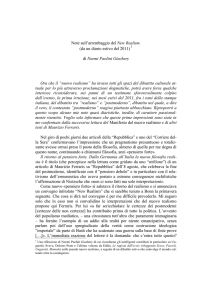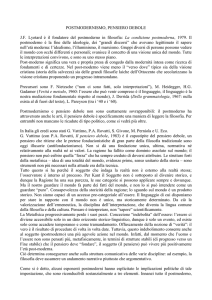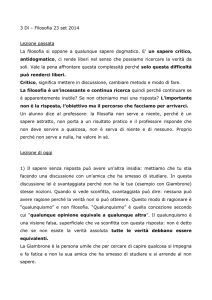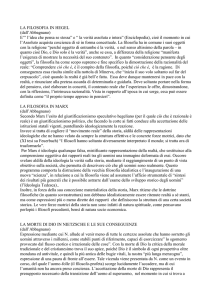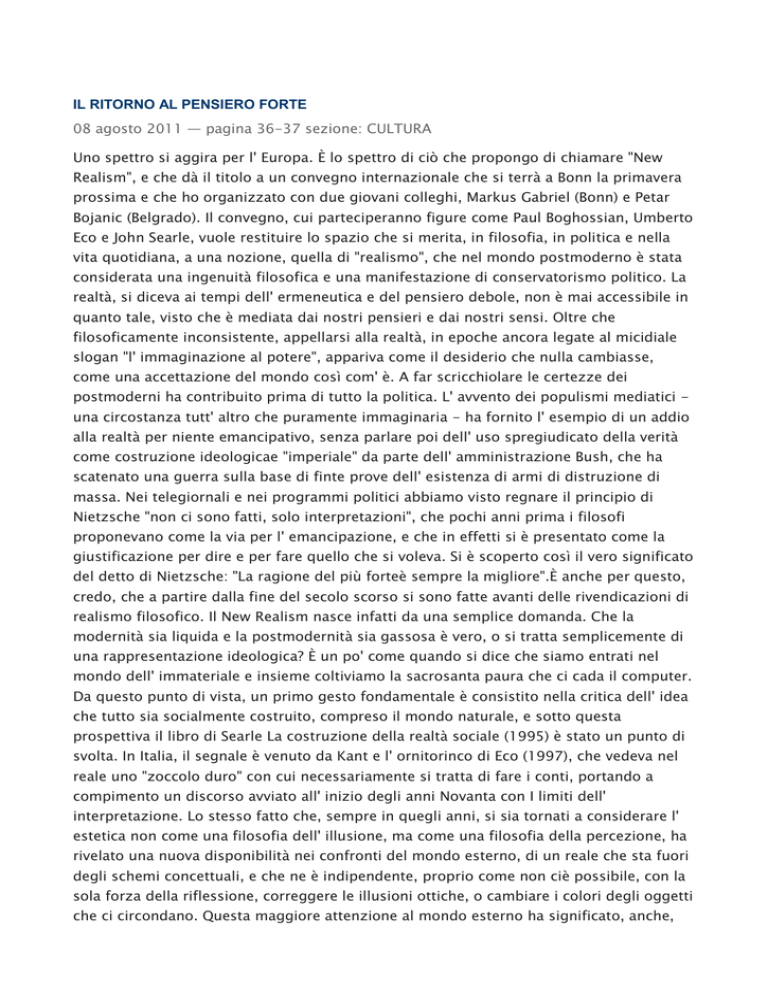
IL RITORNO AL PENSIERO FORTE
08 agosto 2011 — pagina 36-37 sezione: CULTURA
Uno spettro si aggira per l' Europa. È lo spettro di ciò che propongo di chiamare "New
Realism", e che dà il titolo a un convegno internazionale che si terrà a Bonn la primavera
prossima e che ho organizzato con due giovani colleghi, Markus Gabriel (Bonn) e Petar
Bojanic (Belgrado). Il convegno, cui parteciperanno figure come Paul Boghossian, Umberto
Eco e John Searle, vuole restituire lo spazio che si merita, in filosofia, in politica e nella
vita quotidiana, a una nozione, quella di "realismo", che nel mondo postmoderno è stata
considerata una ingenuità filosofica e una manifestazione di conservatorismo politico. La
realtà, si diceva ai tempi dell' ermeneutica e del pensiero debole, non è mai accessibile in
quanto tale, visto che è mediata dai nostri pensieri e dai nostri sensi. Oltre che
filosoficamente inconsistente, appellarsi alla realtà, in epoche ancora legate al micidiale
slogan "l' immaginazione al potere", appariva come il desiderio che nulla cambiasse,
come una accettazione del mondo così com' è. A far scricchiolare le certezze dei
postmoderni ha contribuito prima di tutto la politica. L' avvento dei populismi mediatici una circostanza tutt' altro che puramente immaginaria - ha fornito l' esempio di un addio
alla realtà per niente emancipativo, senza parlare poi dell' uso spregiudicato della verità
come costruzione ideologicae "imperiale" da parte dell' amministrazione Bush, che ha
scatenato una guerra sulla base di finte prove dell' esistenza di armi di distruzione di
massa. Nei telegiornali e nei programmi politici abbiamo visto regnare il principio di
Nietzsche "non ci sono fatti, solo interpretazioni", che pochi anni prima i filosofi
proponevano come la via per l' emancipazione, e che in effetti si è presentato come la
giustificazione per dire e per fare quello che si voleva. Si è scoperto così il vero significato
del detto di Nietzsche: "La ragione del più forteè sempre la migliore".È anche per questo,
credo, che a partire dalla fine del secolo scorso si sono fatte avanti delle rivendicazioni di
realismo filosofico. Il New Realism nasce infatti da una semplice domanda. Che la
modernità sia liquida e la postmodernità sia gassosa è vero, o si tratta semplicemente di
una rappresentazione ideologica? È un po' come quando si dice che siamo entrati nel
mondo dell' immateriale e insieme coltiviamo la sacrosanta paura che ci cada il computer.
Da questo punto di vista, un primo gesto fondamentale è consistito nella critica dell' idea
che tutto sia socialmente costruito, compreso il mondo naturale, e sotto questa
prospettiva il libro di Searle La costruzione della realtà sociale (1995) è stato un punto di
svolta. In Italia, il segnale è venuto da Kant e l' ornitorinco di Eco (1997), che vedeva nel
reale uno "zoccolo duro" con cui necessariamente si tratta di fare i conti, portando a
compimento un discorso avviato all' inizio degli anni Novanta con I limiti dell'
interpretazione. Lo stesso fatto che, sempre in quegli anni, si sia tornati a considerare l'
estetica non come una filosofia dell' illusione, ma come una filosofia della percezione, ha
rivelato una nuova disponibilità nei confronti del mondo esterno, di un reale che sta fuori
degli schemi concettuali, e che ne è indipendente, proprio come non ciè possibile, con la
sola forza della riflessione, correggere le illusioni ottiche, o cambiare i colori degli oggetti
che ci circondano. Questa maggiore attenzione al mondo esterno ha significato, anche,
una riabilitazione della nozione di "verità", che i postmoderni ritenevano esaurita e meno
importante, per esempio, della solidarietà. Non considerando quanto importante sia la
verità nelle nostre pratiche quotidiane, e quanto la verità sia intimamente connessa con la
realtà. Se uno va dal medico, sarebbe certo felice di avere solidarietà, ma ciò di cui
soprattutto ha bisogno sono risposte vere sul suo stato di salute. E quelle risposte non
possono limitarsi a interpretazioni più o meno creative: devono essere corrispondenti a
una qualche realtà che si trova nel mondo esterno, cioè, nella fattispecie, nel suo corpo. È
per questo che in opere come Paura di conoscere (2005) di Paul Boghossian e Per la verità
(2007) di Diego Marconi si è proceduto a argomentare contro la tesi secondo cui la verità
è una nozione relativa, e del tutto dipendente dagli schemi concettuali con cui ci
accostiamo al mondo. È in questo quadro che si definiscono le parole-chiave del New
Realism: Ontologia, Critica, Illuminismo. Ontologia significa semplicemente: il mondo ha
le sue leggi, e le fa rispettare. L' errore dei postmoderni poggiava su una semplice
confusione tra ontologia ed epistemologia, tra quello che c' è e quello che sappiamo a
proposito di quello che c' è. È chiaro che per sapere che l' acqua è H O ho bisogno di
linguaggio, di schemi e di categorie. Ma l' acqua bagna e il fuoco scotta sia che io lo
sappia sia che io non lo sappia, indipendentemente da linguaggi e da categorie. A un
certo punto c' è qualcosa che ci resiste. È quello che chiamo "inemendabilità", il carattere
saliente del reale. Che può essere certo una limitazione ma che, al tempo stesso, ci
fornisce proprio quel punto d' appoggio che permette di distinguere il sogno dalla realtà
e la scienza dalla magia. Critica, poi, significa questo. L' argomento dei postmoderni era
che l' irrealismo e il cuore oltre l' ostacolo sono emancipatori. Ma chiaramente non è così,
perché mentre il realismo è immediatamente critico ("le cose stanno così", l' accertamento
nonè accettazione!), l' irrealismo pone un problema. Se pensi che non ci sono fatti, solo
interpretazioni, come fai a sapere che stai trasformando il mondo e non, invece, stai
semplicemente immaginando di trasformarlo, sognando di trasformarlo? Nel realismo è
incorporata la critica, all' irrealismo è connaturata l' acquiescenza, la favola che si
racconta ai bambini perché prendano sonno. Veniamo, infine, all' Illuminismo. La storia
recente ha confermato la diagnosi di Habermas che trent' anni fa vedeva nel
postmodernismo un' ondata anti-illuminista. L' Illuminismo, come diceva Kant, è osare
sapere ed è l' uscita dell' uomo dalla sua infanzia. Da questo punto di vista, l' Illuminismo
richiede ancora oggi una scelta di campo, e una fiducia nell' umanità, nel sapere e nel
progresso. L' umanità deve salvarsi, e certo mai e poi mai potrà farlo un Dio. Occorrono il
sapere, la veritàe la realtà. Non accettarli, come hanno fatto il postmoderno filosofico e il
populismo politico, significa seguire l' alternativa, sempre possibile, che propone il
Grande Inquisitore: seguire la via del miracolo, del mistero e dell' autorità. - MAURIZIO
FERRARIS
L'addio al pensiero debole che divide i filosofi
FERRARIS E VATTIMO DISCUTONO IL MANIFESTO DEL "NEW REALISM" CHE PROPONE DI
RIPORTARE I FATTI CONCRETI AL CENTRO DELLA RIFLESSIONE
Maurizio Ferraris, La Repubblica, 19 agosto 2011
Siamo ancora postmoderni o stiamo per diventare "neo realisti", ritornando al pensiero forte? Il
dibattito filosofico è aperto. Grazie anche al convegno che si terrà a Bonn il prossimo anno sul
"New Realism" a cui parteciperanno, fra gli altri, Umberto Eco e John Searle. Il dialogo con
Vattimo (che lanciò in Italia il pensiero debole con un´antologia curata con Pier Aldo Rovatti e
uscita nel 1983 dove si guardava al postmoderno come ad una chiave per la democratizzazione
della società, diffondendo pluralismo e tolleranza) cerca di affrontare i punti principali della
questione.
FERRARIS Gli ultimi anni hanno insegnato, mi pare, una amara verità. E cioè che il primato delle
interpretazioni sopra i fatti, il superamento del mito della oggettività, non ha avuto gli esiti di
emancipazione che si immaginavano illustri filosofi postmoderni come Richard Rorty o tu stesso.
Non è successo, cioè, quello che annunciavi trentacinque anni fa nelle tue bellissime lezioni su
Nietzsche e il "divenir favola" del "mondo vero": la liberazione dai vincoli di una realtà troppo
monolitica, compatta, perentoria, una moltiplicazione e decostruzione delle prospettive che
sembrava riprodurre, nel mondo sociale, la moltiplicazione e la radicale liberalizzazione
(credevamo allora) dei canali televisivi. Il mondo vero certo è diventato una favola, anzi è diventato
un reality, ma il risultato è il populismo mediatico, dove (purché se ne abbia il potere) si può
pretendere di far credere qualsiasi cosa. Questo, purtroppo, è un fatto, anche se entrambi
vorremmo che fosse una interpretazione. O sbaglio?
VATTIMO Che cos’è la "realtà" che smentisce le illusioni post-moderniste? Undici anni fa il mio
aureo libretto su La società trasparente ha avuto una seconda edizione con un capitolo aggiuntivo
scritto dopo la vittoria di Berlusconi alle elezioni. Prendevo già atto della "delusione" di cui tu parli;
e riconoscevo che se non si verificava quel venir meno della perentorietà del reale che era promessa
dal mondo della comunicazione e dei mass media contro la rigidità della società tradizionale, era
per l’appunto a causa di una permanente resistenza della "realtà", però appunto nella forma del
dominio di poteri forti – economici, mediatici, ecc. Dunque, tutta la faccenda della "smentita" delle
illusioni post-moderniste è solo un affare di potere. La trasformazione post-moderna
realisticamente attesa da chi guardava alle nuove possibilità tecniche non è riuscita. Da questo
"fatto", pare a me, non devo imparare che il post-modernismo è una balla; ma che siamo in balia di
poteri che non vogliono la trasformazione possibile. Come sperare nella trasformazione, però, se i
poteri che vi si oppongono sono così forti?
FERRARIS Per come la metti tu il potere, anzi la prepotenza, è la sola cosa reale al mondo, e tutto
il resto è illusione. Ti proporrei una visione meno disperata: se il potere è menzogna e sortilegio
("un milione di posti di lavoro", "mai le mani nelle tasche degli italiani" ecc.), il realismo è
contropotere: "il milione di posti di lavoro non si è visto", "le mani nelle tasche degli italiani sono
state messe eccome". È per questo che, vent’anni fa, quando il postmoderno celebrava i suoi fasti, e
il populismo si scaldava i muscoli ai bordi del campo, ho maturato la mia svolta verso il realismo
(quello che adesso chiamo "New Realism"), posizione all’epoca totalmente minoritaria. Ti
ricorderai che mi hai detto: "Chi te lo fa fare?". Bene, semplicemente la presa d’atto di un fatto
vero.
VATTIMO Se si può parlare di un nuovo realismo questo, almeno nella mia esperienza di
(pseudo)filosofo e (pseudo)politico, consiste nel prender atto che la cosiddetta verità è un affare di
potere. Per questo ho osato dire che chi parla della verità oggettiva è un servo del capitale. Devo
sempre domandare "chi lo dice", e non fidarmi della "informazione" sia essa giornalistico-televisiva
o anche "clandestina", sia essa "scientifica" (non c’è mai La scienza, ci sono Le scienze, e gli
scienziati, che alle volte hanno interessi in gioco). Ma allora, di chi mi fiderò? Per poter vivere
decentemente al mondo devo cercare di costruire una rete di "compagni" – sì, lo dico senza pudore
– con cui condivido progetti e ideali. Cercandoli dove? Là dove c’è resistenza: i no-Tav, la flottiglia
per Gaza, i sindacati anti-Marchionne. So che non è un verosimile programma politico, e nemmeno
una posizione filosofica "presentabile" in congressi e convegni. Ma ormai sono "emerito".
FERRARIS Per essere un resistente, sia pure emerito, la tua tesi secondo cui "la verità è una
questione di potere", mi sembra una affermazione molto rassegnata: "la ragione del più forte è
sempre la migliore". Personalmente sono convinto che proprio la realtà, per esempio il fatto che è
vero che il lupo sta a monte e l’agnello sta a valle, dunque non può intorbidargli l´acqua, sia la base
per ristabilire la giustizia.
VATTIMO Io direi piuttosto: prendiamo atto del fallimento, pratico, delle speranze postmoderniste. Ma certo non nel senso di tornare "realisti" pensando che la verità accertata (da chi?
mai che un realista se lo domandi) ci salverà, dopo la sbornia ideal-ermeneutica-nichilista.
FERRARIS Non si tratta di tornare realisti, ma di diventarlo una buona volta. In Italia il
mainstream filosofico è sempre stato idealista, come sai bene. Quanto all’accertamento della
verità, oggi c’è un sole leggermente velato dalle nuvole, e questo lo accerto con i miei occhi. È il 15
agosto 2011, e questo me lo dice il calendario del computer. E il 15 agosto del 1977 Herbert Kappler,
responsabile della strage delle fosse Ardeatine, è fuggito dal Celio, questo me lo dice Wikipedia.
Ora, poniamo che incominciassi a chiedermi "sarà poi vero? chi me lo prova?". Darei avvio a un
processo che dalla negazione della fuga arriverebbe alla negazione della strage, e poi di tutto
quanto, sino alla Shoah. Milioni di esseri umani uccisi, e io garrulamente a chiedermi "chi lo
accerta?".
VATTIMO È ovvio (vero? Bah) che per smentire una bugia devo avere un riferimento altro. Ma tu
ti sei mai domandato dove stia questo riferimento? In ciò che "vedi con i tuoi occhi"? Sì, andrà bene
per capire se piove; ma per dire in che direzione vogliamo guidare la nostra esistenza individuale o
sociale?
FERRARIS Ovviamente no. Ma nemmeno dire che "la cosiddetta verità è un affare di potere" mi
dice niente in questa direzione, al massimo mi suggerisce di non aprire più un libro. Ci vuole un
doppio movimento. Il primo, appunto, è lo smascheramento, "il re è nudo"; ed è vero che il re è
nudo, altrimenti sono parole al vento. Il secondo è l’uscita dell’uomo dall’infanzia, l’emancipazione
attraverso la critica e il sapere (caratteristicamente il populismo è a dir poco insofferente nei
confronti dell’università).
VATTIMO Chi dice che "c’è" la verità deve sempre indicare una autorità che la sancisce. Non
credo che tu ti accontenti ormai del tribunale della Ragione, con cui i potenti di tutti i tempi ci
hanno abbindolato. E che talvolta, lo ammetto, è servito anche ai deboli per ribellarsi, solo in
attesa, però, di instaurare un nuovo ordine dove la Ragione è ridiventata strumento di oppressione.
Insomma, se "c’è" qualcosa come ciò che tu chiami verità è solo o decisione di una auctoritas, o, nei
casi migliori, risultato di un negoziato. Io non pretendo di avere la verità vera; so che devo render
conto delle mie interpretazioni a coloro che stanno "dalla mia parte" (che non sono un gruppo
necessariamente chiuso e fanatico; solo non sono mai il "noi" del fantasma metafisico). Sul piovere
o non piovere, e anche sul funzionamento del motore dell’aereo su cui viaggio, posso anche essere
d´accordo con Bush; sul verso dove cercare di dirigere le trasformazioni che la post-modernità
rende possibili non saremo d’accordo, e nessuna constatazione dei "fatti" ci darà una risposta
esauriente.
FERRARIS Se l’ideologia del postmoderno e del populismo è la confusione tra fatti e
interpretazioni, non c´è dubbio che nel confronto tra un postmoderno e un populista sarà ben
difficile constatare dei fatti. Ma c'è da sperare, molti segni lo lasciano presagire, che questa stagione
volga al termine. Anche l’esperienza delle guerre perse, e poi di questa crisi economica, credo che
possa costituire una severa lezione. E con quella che affermo apertamente essere una
interpretazione, mi auguro che l’umanità abbia sempre meno bisogno di sottomettersi alle
"autorità", appunto perché è uscita dall’infanzia. Se non è in base a questa speranza, che cosa
stiamo a fare qui? Se diciamo che "la cosiddetta verità è un affare di potere" perché abbiamo fatto i
filosofi invece che i maghi?
VATTIMO Dici assai poco su dove cavare le norme dell’agire, essendo il modello della verità
sempre quello del dato obiettivo. Non hai nessun dubbio su "chi lo dice", sempre l’idea che
magicamente i fatti si presentino da sé. La questione della auctoritas che sancisce la veritas
dovresti prenderla più sul serio; forse io ho torto a parlare di compagni, ma tu credi davvero di
parlare from nowhere?
Baruffe torinesi su favole e verità
di Pierfranco Pellizzetti
Neo-Realismo vs. Postmoderno Debole? Insomma, Cesare Zavattini o Wim Wenders?
Il dibattito ferragostano tra Gianni Vattimo e Maurizio Ferraris, apparecchiato sulle pagine de La
Repubblica il 19 agosto, potrebbe essere letto come una disputa interna alla famiglia accademica
torinese, in cui il più giovane tra i due contendenti (Ferraris, già cucciolo della redazione che nel
1983 assiemò in volume la raccolta di saggi eponima del debolismo o, come lo chiama Carlo
Augusto Viano, flebilismo) elabora ancora una volta il lutto dell'uccisione simbolica del padre
accademico (appunto, Vattimo), tradito per i più up to date lidi del post-post-modernismo.
Chi scrive, d'istinto parteggerebbe per l'agonista under, certo più spiritoso dell'over e
probabilmente – lui sì – ancora studioso, quando il suo antico maestro ormai campa di rendita;
come risultò ancora una volta l'aprile scorso, nella performance vattimiana al Festival della Laicità
di Reggio: la sua giustificazione dell'essere credente (in dio o Chavez?) era solo la deliberata
volontà di prendersi gioco dell'uditorio o che altro?
Quale l'oggetto dell’attuale contendere? Presto detto (si fa per dire): se, in campo ontologico,
dunque riguardo ai modi di esistenza della realtà, valga solo l'interpretazione oppure si mantenga
un nocciolo duro di fattualità. Discussione che entra almeno nel suo secondo secolo di vita, come
ricerca di una via altra tra idealismo e positivismo. D'altro canto lo snobismo torinese ama il
remake. Anche filosofico. Operazione in cui uno come lo scrivente, che bazzica marciapiedi
infinitamente sottostanti al ciel dei cieli del pensiero che riflette su se stesso, evita accuratamente
di addentrarsi; lascia senza troppi rimpianti o frustrazioni a tipi come John Searle le questioni sul
misterico del "come può esserci un insieme epistemicamente oggettivo di affermazioni relative a
una realtà che è ontologicamente soggettiva" (Creare il mondo sociale, Cortina, Milano 2010 pag.
21).
Eppure anche il rozzo frequentatore del fatto sociale bruto intuisce che la filosofia sarà pure un
genere letterario, quanto l’economia, la sociologia o la teologia; ciò nonostante l’assunto
dell’ermeneutica quale teoria della verità-storicità, che interpreta il Moderno producendo favole e
miti, incontra qualche difficoltà a non evaporare davanti all’obiezione di Flores d’Arcais: “una
favola può smentire un’altra favola?” (Almanacco di filosofia, MicroMega 2011).
Difatti, dopo l’overdose decostruttiva, dopo tanto accatastare nuvole postmoderniste, dopo i tanti
appelli narcisistici alla condizione del nomadismo senza scopo, in cui il bla-bla benaltristico finiva
per produrre lische di pesce consistenti quanto il fumo di una papier mais da intellettuale di Rive
Gauche, l'estensore di queste note aveva apprezzato il tentativo di ritrovare un ancoraggio di
senso/significati.
Ben venga – dunque – chi dice che "senza ontologia non ci possono essere né epistemologia né
etica, perché la realtà (l'ontologia) è il fondamento della verità (l'epistemologia) e la verità è il
fondamento della Giustizia (l'etica)”. (M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione, Bompiani, Milano
2010 pag. 89).
Possiamo spingere – però – la nostra ricostruzione post decostruzione fino al punto di rinunciare a
quella fondamentale ermeneutica del sospetto che chiamiamo "critica"? Ferraris lo nega. Però,
quanto è conseguente laddove contesta l'affermazione che la realtà viene ricostruita
comunicativamente e presentata sotto forma di illusione, forgiata – appunto – dal Potere come
arma al servizio della propria autoperpetuazione? Può negare la grande mistificazione come gioco
degli specchi (deformanti) linguistici, in nome di una irriducibile verità della realtà, quando tale
verità-realtà viene condivisa linguisticamente? Può farlo dopo "le armi di distruzione di massa
irachene" o il "ghe pensi mì" berlusconiano?
Il mondo (per qualcuno) sarà pure una favola, ma (per tutti noi) è anche il campo di battaglia dove
eserciti d’occupazione combattono per la conquista di una legittimità gabellata quale naturalità,
corrispondenza all’ordine naturale delle cose. E questo, prima dei filosofi decostruttori e
affabulatori, ce lo prospetta proprio un uomo di guerra; il generale dei generali David H. Petraeus:
“quello che i decisori politici pensano sia accaduto è ciò che conta, più di quanto sia effettivamente
accaduto”.
Difatti nella sua (molto blasé, dunque torinese) querelle con l'ex maestro Vattimo, l’allievo le spara
davvero grosse: "se diciamo che la cosiddetta verità è un affare di potere, perché abbiamo fatto i
filosofi invece che i maghi?".
Non so Ferraris, ma altri continuano a ragionare sospettosamente sulla realtà sociale, proprio
perché su di essa sono al lavoro tanti spudorati maghi illusionisti. Magari – per dirla alla Pierre
Bourdieu – per "rendere problematico quello che appare scontato" e mostrare come l'evidente sia
sempre costruito, a partire da poste in palio e rapporti di forza. La Forza, un punto da cui ripartire
nelle faccende umane dopo tanta indefinitezza debolistica. Non un'inesitente forza dei fatti "veri",
quanto l'intrinseca cogenza del dominio e della sottomissione. In tutta la loro materialità.
Atteggiamento laico e critico, cui faceva appello una altro torinese (lui – però – ben poco snob;
semmai severo come gli antichi maestri alla Gaetano Salvemini) – il buon Viano – quando
bastonava in un libello einaudiano, dell'Einaudi del bel tempo che fu (Va' pensiero, 1985), la
combriccola dei "flebili". Appunto, dal Vattimo al Ferraris.
(25 agosto 2011)
L’idolatria dei fatti
di Pier Aldo Rovatti, da Repubblica, 26 agosto 2011
Il pensiero debole, nato 30 anni fa grazie a un reading curato da Gianni Vattimo e da me, ha avuto
una imprevedibile diffusione internazionale. Certo, anche le sciocchezze possono andare in giro per
il mondo e trovare ascolto. Non so se questo sia il caso, e comunque non mi affretterei a darlo per
morto.
In autonomia dallo stesso Vattimo, con il quale tuttora condivido lo stile, la funzione e il senso di
questo modo di pensare, e soprattutto la sua potenzialità emancipatoria, ci ho lavorato sopra da
allora, puntando sui temi del gioco e del paradosso, senza di cui credo che si possa capire poco della
difficile realtà in cui viviamo (e spesso ci dibattiamo).
L'amico Ferraris lavorava gomito a gomito con me e con Vattimo, poi ha ritenuto opportuno andare
per la sua strada che oggi chiama "nuovo realismo". Ho letto con molta attenzione il suo dialogo
con Vattimo e sono rimasto – come molti – alquanto perplesso. Vi ho trovato un'eccessiva
semplificazione. Come accade quando si vuole tirare troppo la coperta dalla propria parte, si rischia
di deformare un poco le cose.
Innanzi tutto, pensiero debole e postmodernità non possono essere sovrapposti. Forse la
postmodernità ha fatto il suo tempo, mentre il pensiero debole era e rimane una maniera di leggere
l'intera filosofia, mettendovi decisamente al centro la questione del potere. Nasceva infatti come
uno strumento di lotta contro ogni violenza metafisica e di conseguenza sospettava di ogni
fissazione oggettivistica della Verità (con la iniziale maiuscola). Non si presentava come un
semplice discorso teorico, aveva una valenza esplicitamente "politica", e il carattere di una mossa
etica che Vattimo chiamava pietas (cioè, sostanzialmente, un ascolto del diverso) e che per me era
un contrasto tra pudore e prepotenza per guadagnare uno spazio di gioco nelle maglie strette
dell'uso dominante della teoria.
Quando, oggi, si riduce tutto ciò a una querelle semplificata tra fatti e interpretazioni, si corre il
pericolo di evacuare proprio questa sostanza etico-politica e di ridurre il pensiero debole a una
specie di barzelletta. Non esistono fatti nudi e crudi che non abbiano a che fare con qualche
interpretazione, questo è un fatto, così come sono fatti (duri e provvisti di effetti) le singole
interpretazioni. Che oggi ci sia il sole o piova non mi dice niente sulla realtà in cui stiamo vivendo e
nella quale temiamo di soccombere. Anzi, c'è da chiedersi perché qualcuno abbia bisogno di
costruirsi questo paraocchi lasciando fuori dalla vista le cose più importanti. Il pensiero debole
nasceva, poi, in una particolare consonanza con il pensiero critico di Michel Foucault e con le sue
analisi del potere microfisico e della società disciplinare. Ora, che abbiamo potuto conoscere
meglio le sue ultime ricerche, il debito si è allargato, e non è un caso che Foucault non trovi
nessuna cittadinanza nel cosiddetto new realism di Ferraris.
Un punto fa da spartiacque, e riguarda la verità. Foucault ci ha insegnato, con un gesto
nietzschiano, che la storia (sì, la storia!) è un susseguirsi di giochi di verità, il che significa che i
valori del vero e del falso si trasformano, sono la posta in gioco di un pesante e determinato
conflitto, vengono di volta in volta innalzati sulle bandiere dentro una lotta di posizioni e per
ottenere vantaggi. Dal dispositivo di potere (reale) non si evade con un semplice colpo di filosofia, e
quando si eternizzano le categorie, cercando di fissare cosa è veramente reale, non si fa altro che
assumere una posizione dentro il dispositivo, che lo sappiamo oppure no. Mi chiedo cosa abbia da
dire il nuovo realismo a questo riguardo, una volta che si sia sgombrato il campo da
contrapposizioni un po' di scuola e un po' artificiose, dato che nessuno dubita che la realtà abbia
una consistenza e produca effetti. Sicuramente non lo dubitano coloro che hanno trovato nel
pensiero debole molti attrezzi per la loro cassetta.
(26 agosto 2011)
Per farla finita con il postmoderno
Il testo qui riportato è stato pubblicato in versione rimaneggiata da Repubblica il 26 agosto.
di Paolo Flores d'Arcais
La querelle di venerdì 19 agosto su “la Repubblica” tra l’ermeneutica nichilista di Gianni Vattimo
(“non ci sono fatti, solo interpretazioni”) e il suo più brillante allievo, Maurizio Ferraris, marrano
del post moderno convertito ormai al “New Realism”, potrebbe rivelarsi un gioco di specchi, dove
ciascuno dei contendenti ha ragione nel criticare l’altro ma entrambi hanno torto proprio nel
nucleo filosofico che continuano a condividere. Situazione del resto frequente nei conflitti
intellettuali. Ma andiamo con ordine.
Vattimo ammette che “sul piovere o non piovere, e anche sul funzionamento del motore dell’aereo
su cui viaggio” potrebbe perfino convenire con Bush, accettare cioè che i fatti sono sovrani e perciò
cogenti per entrambi, ma sulla direzione in cui battersi per cambiare il mondo i fatti non
forniranno mai una guida “oggettiva”, “vera”: sarà sempre questione di lotta e di potere.
Ineccepibile (un esistenzialista-scientista come me sottoscriverebbe senza problemi), ma
ragioniamo i due assunti fino in fondo. Se l’evidenza empirica è in grado di dirci che qui e ora sta
piovendo (oppure no), e se il funzionamento di un aereo è materia “neutrale” e non opinabile, è
l’intera scienza della natura galileiana, l’intera impresa scientifica moderna ad essere sottratta al
nichilismo interpretativo e ad essere riconosciuta universalmente come intersoggettivamente
cogente (se la parola “vera” disturba, benché funzionalmente equivalente). Infatti, nessuna autorità
impone a Vattimo (e a tutti noi) di credere alle infinite leggi della natura imbozzolate nel
funzionamento del motore con cui stiamo realizzando il sogno di Icaro, ma le procedure con cui
ciascuna di esse è stata messa alla prova (tentando di smentirla in esperimenti ripetibili e ripetuti,
da parte di ricercatori di ogni latitudine e di ogni fede o miscredenza) e la corrispondenza tra i fatti
che esse ipotizzano (la capacità di levarsi in volo per un ciclope di miriadi di tonnellate) e quanto
quotidianamente qualsiasi membro di “homo sapiens” può constatare, costituiscono l’unica fonte
del nostro riconoscimento, l’unica “maestà” di una “oggettività” assolutamente critica e
strutturalmente esposta al dubbio. La “auctoritas” del “chi lo dice?” qui non ha alcuno spazio.
Non si capisce perciò perché Vattimo, contraddicendosi con le sue stesse ammissioni (neutralità
ideologica e cogenza di verità per “piove” e “motore”), rifiuti alle scienze della natura il loro status
di oggettività e ne faccia una questione di fiducia personale, interessi, lotta di classe. Curiosamente,
il sospetto verso le scienze della natura è condiviso da Ferraris, malgrado l’abiura del post-moderno
e la via di Damasco del “New Realism” (su “Repubblica” non lo sottolinea, ma lo ha fatto nei suoi
più importanti lavori, anche recenti). Questa idiosincrasia per l’oggettività della scienza (della
natura) non è cosa nuova, domina purtroppo il pensiero progressista già dal sessantotto (a mio
parere è una delle concause del fallimento di quel grande moto libertario) e anzi prima. Temo abbia
molto a che fare con una sinistra impotente a rovesciare o squilibrare gli assetti di potere e che si
consola (tramite i suoi intellettuali più eretici) lanciando strali contro l’inerme “violenza”
dell’illuminismo anziché contro l’agguerrita oppressione di classe degli establishment.
Comunque sia, è evidente che Vattimo vuole mettere in discussione ogni verità di fatto per timore
di riconoscere status scientifico anche alle cosiddette scienze dello spirito, o scienze umane. Che
scienze però non sono affatto, sature come sono, esse sì, di interpretazione, di ideologia, di valori,
dunque di preferenze soggettive e di interessi conflittuali, anche se utilizzano (dovrebbero, almeno)
in alcuni settori delle relative discipline strumenti e criteri di accertamento scientifico. Prendiamo
il sapere storico: qui l’accertamento dei fatti segue (almeno dovrebbe) il rigore che caratterizza ad
esempio una scienza come la biologia evoluzionista nella datazione, descrizione e classificazione dei
suoi reperti. Che un giorno di novembre dell’anno 1956 i carri armati sovietici abbiano invaso
l’Ungheria per schiacciare il governo Nagy che si appoggiava sui consigli operai, è una realtà
accertabile e anzi accertata, dunque oggettiva (perfino che Gesù non si proclamò mai messia è un
fatto accertabile e accertato).
Che la rivoluzione ungherese nella sua ultima fase finisse per fare suo malgrado il gioco
dell’imperialismo è l’interpretazione (a mio parere aberrante) con cui Jean-Paul Sartre finì per
giustificare il secondo intervento sovietico. Ma un’interpretazione, anche aberrante, non sarà mai
liquidabile nei termini di vero/falso. Si può sostenere Stalin contro Trockij (e ambedue contro gli
insorti di Kronstandt), perché purtroppo i gusti morali di homo sapiens hanno santificato di tutto
(se ne lamentava il cristianissimo Pascal, riconoscendo come la morale “naturale” fosse una fola),
mentre è verità incontrovertibile che in una foto famosa della rivoluzione d’ottobre, appoggiato al
palco da cui Lenin sta parlando, c’è Lev Trockij, numero due dei bolscevichi, anche se nei decenni
staliniani la sua figura in quella foto verrà miracolosamente riassorbita nelle assi di legno dello
sfondo (con un procedimento chimico in sé neutrale: solo il suo uso sarà stalinista). In questo
senso aveva perfettamente ragione Hannah Arendt a ricordare che le “modeste verità di fatto” sono
i nemici più intrattabili di ogni dispotismo, e a vedere nell’equiparazione tra verità di fatto e
opinione il prodromo della vocazione totalitaria.
Quello che vale per la storia vale in modo esponenziale per l’economia, dove l’ideologia la fa da
padrona. Se davvero i comportamenti economici fossero prevedibili, gli economisti sarebbero tutti
dei Creso poiché in borsa non sbaglierebbero un colpo. Ma soprattutto: qualsiasi “ricetta” per
affrontare una crisi (e la nozione stessa di crisi) dipende dalle variabili che vengono privilegiate
come valori: che sia il Pil, o il tasso di disoccupazione, o le tutele sindacali, o la forbice massima dei
redditi, o la redistribuzione tramite tassazione e pensioni, o l’orario di lavoro (dodici o quattordici
ore anche per i minori, così è decollato il capitalismo in Inghilterra, così è di nuovo in aree crescenti
di Gaia, compreso il suo civilissimo Occidente), o l’eguaglianza di fronte a casa, salute, istruzione (il
welfare, insomma), tutto ciò non riguarda l’incontrovertibile mondo dei fatti, ma la libera scelta dei
valori che si vogliono affermare, quasi sempre a danno (almeno parziale) di altri valori. E degli
interessi che spesso vi si accompagnano.
E’ paradossale, però, che Vattimo, per tenere aperta la prospettiva dell’emancipazione e
dell’eguaglianza (più che legittima, a mio modo di vedere anzi sacrosanta e cui aderisco “toto
corde”), anziché scegliere la via maestra e diretta della separazione quasi manichea tra fatti e valori,
dunque tra scienze della natura e ideologie dello spirito (le componenti scientifiche delle discipline
socio-storiche rientrano nel primo ambito), o per dirla col venerabile Hume tra essere e doveressere, compia un doppio salto mortale: dapprima unifica verità di fatto (in effetti accertabili) e
“verità” di valore (introvabili in natura e sempre soggettive) nell’unico spauracchio della “scienza”,
della “ragione”, attribuendo così all’eredità dei lumi le pretese dispotiche di Wall Street (o dei
gerarchi cinesi che le sostituiranno): elevate a “verità oggettiva” come l’equazione di Einstein o la
scoperta di Darwin. Di fronte all’insopportabile cogenza di “verità” che i poteri degli establishment
ricevono così in dono per i loro soggettivissimi (e iniqui) interessi, Vattimo è allora costretto ad
attribuire l’arroganza del potere a tutti i “saperi”, non solo ai Bush e Murdoch (Berlusconi e
Marchionne) ma ai figli legittimi di Galileo che continuano ad accertare la verità del
comportamento della natura.
In tal modo però, Vattimo resta disarmato di fronte ad ogni menzogna del potere, che non potrà
più essere tacciata neppure di manipolazione, visto che non ci sono fatti ma solo interpretazioni. Il
valore “verità” viene regalato all’arroganza del potere, con buona pace di Gramsci che aveva intuito
come essa fosse invece strutturalmente rivoluzionaria. Bastava attenersi alla classica distinzione di
Hume, riconoscere alle scienze della natura l’indagine sull’essere e all’esistenza individuale e
collettiva la sovranità sul dover-essere. Ma con un esistenzialismo così sobrio, naturalistascientista, sarebbero state liquidati tutti i barocchismi iper-metafisici intorno all’invio dell’essere e i
culti esoterici sulla differenza ontologica tra essere ed ente.
Perciò resta assai problematico che un “New Realism” possa davvero affrontare le antinomie
filosofiche (e politiche) di un nichilismo ermeneutico che si rivela – ahimè – realizzato da
Berlusconi e dalla dismisura del trend internazionale di menzogna di ogni potere (l’esatto opposto,
non a caso, della democrazia come trasparenza), senza andare a fondo nella critica alle
giustificazioni che di quell’ondata filosofica (effettivamente egemone per lunghissimi anni, e non
solo sul continente) ancor oggi Ferraris ripropone. E’ storicamente falso, infatti, che agli inizi degli
anni sessanta in Italia fosse ancora dominante in ambito filosofico la tradizione idealista.
Nell’immediato dopoguerra Abbagnano, Bobbio e Geymonat, tre maestri molto lontani sotto
importanti aspetti, e che coprivano il versante positivista come quello esistenzialista, avevano
lanciato insieme (e con crescente successo) l’appello anti-idealista per un nuovo illuminismo.
Aggiungiamo che il marxismo eretico di Della Volpe e della sua scuola aveva valorizzato la critica
antihegeliana del giovane Marx. Insomma, esattamente mezzo secolo fa circolavano nella filosofia
italiana tutti gli elementi per dar luogo a quel “New Realism” – capace di andare oltre la povertà
etico-politica del positivismo logico egemone nel mondo anglosassone – che ha ora conquistato
Ferraris.
Se si è perso mezzo secolo è solo perché, anziché lavorare sulle tradizioni che ho richiamato, per
superarne limiti e contraddizioni, in Italia negli anni sessanta ha preso piede un’inaspettata
rivincita di spiritualismo, cattolico e non, che ha declinato Heidegger in tutti i modi possibili, ma
sempre contro quelle promettenti istanze neo-illuministe. Pareyson e Severino hanno cresciuto le
punte di diamante di questa screziata “vague” heideggeriana, Vattimo e Cacciari, che ha vinto e
dilagato nella sinistra, esattamente come in Francia altri irrazionalismi trionfavano con Foucault e
Derrida (quando erano a disposizione, per il “New Realism” ora tardivamente invocato, i mattoni
filosofici predisposti da due grandi pensatori con Camus e Monod, trascurati invece come
“dilettanti”, oltretutto politicamente sostenitori, ad anni di distanza, dell’unico vero riformatore di
sinistra che l’Europa del dopoguerra abbia avuto, Pierre Mendes-France).
Naturalmente, meglio tardi che mai. Purché il “New Realism” non rimuova una volta di più le due
pietre d’inciampo che troppa filosofia “emancipatoria” ha paura di affrontare: il radicale addio ad
ogni metafisica o post-metafisica (in realtà l’heideggerismo costituisce una iper-metafisica),
riconoscendo che “essere” può valere esclusivamente come stenogramma per la totalità degli enti,
per il resto è solo una cattiva ipostasi, la personificazione (animismo!) del predicato generico (e
dunque insignificante) dei reali oggetti discreti. E che si tratta di tener ferma senza titubanza
alcuna la barra della separazione gnoseologica tra fatti e valori, oggetto di accertamento
intersoggetivamente cogente i primi, di libera decisione (dunque di lotta) i secondi.
La visione che ci restituisce il mondo
di Paolo Legrenzi, da Repubblica, 26 agosto 2011
Nella psicologia è circolata per molto tempo l'idea che quel che conta sono le interpretazioni, e non
i fatti. Anzi, sono le interpretazioni stesse a creare i fatti. In una variante di psichiatria sociale, il
matto era, semplificando (ma non tanto), il risultato di chi lo classificava come tale. Cambiata la
società, eliminata l'etichetta, trattati i matti da persone normali, il problema si sarebbe ridotto, se
non dissolto. In forme meno grossolane, questa stessa idea permeava altre scienze umane.
Oggi il vento è cambiato. Due grandi tradizioni di ricerca, l'evoluzionismo e lo studio del cervello,
anche grazie a nuove tecniche di osservazione, stanno occupando la scena. L'uomo è un pezzo della
natura biologica, e non è poi così speciale. L'idea che sia lui a costruire il mondo, con le sue
categorie di osservazione e d'interpretazione, è al tramonto. Si celebra così la fine del presunto
primato dell'interpretazione sui fatti. Non ci si era mai spinti ad affermare che leggi scientifiche –
come, poniamo, la legge dei gas –, fossero interpretazioni del comportamento dei gas. E tuttavia
per le scelte individuali e le società era così. Circola poi, ancor oggi, una variante politica, nel senso
che chi detiene il potere politico e i media può "costruire" la realtà. Era questo cui alludeva Donald
Rumsfeld, il segretario alla difesa del secondo Bush, quando affermava, dopo la caduta del
comunismo: «Ora il mondo lo facciamo noi».
Questa versione "forte" del credo "interpretativo" è fallita miseramente. I fatti si vendicano nella
politica estera americana. I fatti presentano il conto. Il potere politico può, anche per molto tempo,
far sì che l'opinione pubblica riconosca un fenomeno "da un certo punto di vista", ma non può fare
di più.
Quando s'insegna psicologia, al primo anno di studi, si deve contrastare lo spontaneo "realismo
ingenuo" degli studenti. Esso consiste nel pensare che noi vediamo il mondo così com'è,
semplicemente perché è fatto così. In realtà il nostro sistema percettivo è un intreccio di
meccanismi inconsapevoli che ci "restituisce" il mondo in seguito a una complessa elaborazione di
ipotesi su quello che c'è là fuori. E anche il pensiero umano funziona così. Questo però non implica
sposare la tesi che la mente crea il mondo. Al contrario, la mente dell'uomo e degli altri animali fa
ipotesi su come funziona il mondo e le aggiorna continuamente perché l'azione umana cambia il
mondo. Questa è la tensione che sbrigativamente si etichetta con il binomio natura/cultura.
Agli psicologi cognitivi piace che in filosofia stia emergendo una posizione chiamata "nuovo
realismo". Non possono concordare né con il realismo ingenuo, né con la rozza idea che siamo noi a
creare i fatti con le nostre interpretazioni. Per quanto concerne la versione politica, questa tesi si è
sconfitta da sola.
Perché serve una prospettiva diversa
di Petar Bojanic, da Repubblica, 26 agosto 2011
Nel gennaio scorso Ferraris e io eravamo a Parigi, e al termine di una sua conferenza sul futuro
della decostruzione qualcuno gli ha chiesto: «Ma perché senti tutta questa necessità di richiamarti
al realismo e ai fatti? In fondo, le interpretazioni possono dare libertà». Ferraris ha risposto: «È
vero. Ma possono anche negare tutto, comprese le peggiori tragedie della storia». Ripensandoci, è lì
che è nata l'idea di un convegno sul "New Realism".
Il realismo è la grande novità filosofica dopo trent'anni di postmoderno, ed è un punto a cui sono
arrivato, per parte mia, lavorando su una "fenomenologia dell'istituzionale" che, rispetto a Ferraris,
è più aperta alle proposte di Foucault. Sull'essenziale però siamo d'accordo. Derrida, il nostro
comune maestro, ci ha resi attenti alla necessità di decostruire, di smontare, di non fermarsi alle
apparenze (perché ovviamente non tutto quello che appare è reale, ci sono anche le allucinazioni, lo
sappiamo bene). Ma di farlo con una prospettiva di speranza, la speranza, appunto, che la
decostruzione potesse portare emancipazione e verità. Se trascuriamo questa circostanza, si finisce
nel nichilismo, una posizione che costituisce un problema non solo dal punto di vista teorico
(perché è una negazione del sapere) ma anche, e soprattutto, dal punto di vista morale, perché se si
sostiene che tutto è fluido e tutto è interpretabile anche il passato può essere riscritto.
C'è un altro segnale importante che, secondo me, viene dal "Nuovo Realismo", e che è
particolarmente significativo per chi, come me, si è trovato a vivere e a lavorare in situazioni
culturali molto diverse e a volte contrapposte (dall'Inghilterra alla Francia alla Serbia). Il
postmodernismo, malgrado la sua pretesa di cosmopolitismo filosofico, era in effetti una teoria che
si limitava alla cosiddetta "filosofia continentale". Con la svolta realistica si sta facendo esperienza
di un dialogo tra scompartimenti un tempo non comunicanti, per esempio fra temi che vengono da
filosofi analitici, come Searle, e temi che vengono da filosofi continentali, come Derrida.
Questo aspetto non mi sembra puramente formale, e tocca la sostanza del lavoro filosofico. Perché
"Nuovo Realismo" significa confrontarsi sulle cose, senza limitarsi a chiedersi l'un l'altro "da dove
parli?", il gioco postmoderno che spesso riduceva i confronti filosofici alla deferenza nei confronti
dei rituali della propria tribù di appartenenza.
Goodbye postmoderno
La sua fine su “Prospect”
Corrado Ocone - Il riformista, 30 agosto 2011
Il postmodernismo è morto. Con questo titolo icastico il prestigioso mensile britannico “Prospect”,
nel numero di agosto, presenta un lungo articolo dedicato ad una fase storica della cultura, della
società e della politica che giudica ormai definitivamente finita. Essa abbraccia gli ultimi trenta o
quarant’anni ed è caratterizzata da alcune idee guida, modi di pensare, icone e mitologie facilmente
identificabili. L’occasione dell’articolo è data dall’inaugurazione, il 24 settembre prossimo, al
Victoria and Albert Museum di Londra, della “prima retrospettiva complessiva sul fenomeno”:
Postmodernism. Style and subversion. La mostra, secondo lo scrittore Edward Docx, autore
dell’articolo, storicizzando il fenomeno lo mostrerebbe nella sua compiutezza e, alla fine, nella sua
distanza dai nuovi problemi che ci assillano e dalle nuove modalità di senso con cui ci rapportiamo
ad essi.
Ma cosa è stato propriamente il postmoderno? Da un punto di vista filosofico, possiamo dire che si
è trattato di una reazione alla fine di quelle “grandi narrazioni” che secondo Lyotard, autore nel
1979 del fortunato pamphlet su La condizione postmoderna avrebbero caratterizzato la modernità
(in pratica, tutte le grandi ideologie, dal marxismo al progressismo borghese, dal liberalismo
classico al cristianesimo politico). In verità, si è trattato di una imponente operazione di messa in
scacco dei classici concetti di verità e realtà su cui si è costruito il pensiero occidentale. Ciò è
avvenuto mediante un processo di “decostruzione”, una parola chiave del lessico postmoderno (al
centro del pensiero di un filosofo solo parzialmente assimilabile alla temperie quale Derrida):
grazie cioè alla messa in luce degli elementi “impuri” che sono alla base dei concetti giudicati “alti”
o “nobili” dalla nostra tradizione (Nietzsche, sicuramente un progenitore di questo modo di
pensare, aveva parlato di “genealogia della morale”). Si è perciò parlato addirittura della “violenza”
del concetto di verità, dei meccanismi di potere che ne sarebbero alla base e che avrebbero dato una
giustificazione morale, ad esempio, alla nostra arroganza verso i popoli non occidentali. Da questo
punto di vista la stessa realtà è un meccanismo di dominio con la cui falsa cogenza si sono tarpate
le ali alla fantasia, alla creatività, alla capacità di ricrearci il mondo secondo i nostri desideri (per i
postmodernisti, l’uomo è soprattutto un essere desiderante). La strategia di risposta
postmodernista è stata la spettacolarizzazione o virtualizzazione del reale, e quindi l’indistinzione
sempre piu marcata fra il vero e il falso, fra l’essere e l’apparire (un processo favorito in qualche
modo dall’avanzare di Internet o da spettacoli televisivi tipo “Il grande fratello”, tipicamente
postmoderni); la fine delle sintesi unitarie e una spiccata propensione alla frammentazione sia
nella costruzione del sapere sia delle identità personali (le quali possono essere continuamente
cambiate quasi fossero degli abiti); la fine di ogni gerarchizzazione, anche e soprattutto nell’ambito
culturale, ove la pop culture, mettiamo Madonna, un’altra icona postmoderna, ha la stessa dignità
di Dante o Shakespeare. Strategia tipicamente postmoderna è stata poi l’ironia, teorizzata dal
filosofo americano Rorty: una sorta di presa in giro dei valori attraverso il sarcarsmo, ma
sostanzialmente un comportamento di vita deresponsabilizzante che non prende sul serio niente e
nessuno.
Milton Friedman
Ma il postmoderno è veramente alle nostre spalle? E quali sono i segni del suo trapasso? C’è
veramente in giro una nuova voglia di fare sul serio, di “pesantezza”? Qui il discorso, probailmente,
si fa politico. L’articolo di “Prospect” non lo dice, ma gli anni del postmoderno hanno coinciso con
l’affermazione di una ideologia non solo onnipervasiva, ma anche subdola perchè si è presentata
come il suo contrario, come la risposta alla fine di ogni ideologia o “narrazione” più o meno grande.
In sostanza, la politica, seguendo i dettami di questa ideologia, ha abdicato ai propri compiti e ha
decretato la supremazia dei mercati, nel frattempo sempre più globali. Non solo non si sono
costruiti solidi organismi di governance politica democratica globale, ma gli stessi stati nazionali
sono stati visti, almeno fino alla grande crisi del 2008, per dirla con Reagan, come il problema e
non come una soluzione. Il Mercato come divinità spontaneamente autoregolantesi è diventato il
nuovo Dio, un feticcio indiscutibile a cui prostrarsi acriticamente. Questa ideologia, ormai nota
come neoliberalismo (per distinguerla dal liberalismo classico di un Tocqueville o di un Mill,
sempre attento alla “parità delle condizioni di partenza” e alle “eguali libertà”), ma che a ragione
può essere considerata una sorta di darwinismo sociale, si è sviluppata proprio negli anni Settanta
del secolo scorso dapprima in alcune università e centri di ricerca americani (si pensi alla “Scuola
di Chicago” e ad economisti fortemente liberisti e antikeynesiani come Friedman) e poi a livello
politico con la Thatcher e la deregulation reaganiana. Come mostra un breve ma efficace libro
uscito recentemente presso la Oxford, Neoliberalism di Steger e Roy, la stessa “terza via” di Blair o
la politica di Clinton non hanno in sostanza sconfessato i suoi assunti di base. E Obama, che ha
tentato di farlo, ha potuto realizzare gli obiettivi che si era proposto in maniera a dir poco molto
parziale.
Visto da questo angolo prospettico, il postmodernismo culturale sembrerebbe avallare la vecchia
tesi marxiana della ideologia come sovrastruttura. Quale più funzionale alleato del mercatismo
aggressivo di un pensiero in disarmo che predica la fine della verità e della realtà, e in sostanza
dello spirito critico?
Ancòra sul postmoderno
Il dibattito sul postmoderno in filosofia (che, in parte, mi riguarda) sta continuando. Qui sotto,
l'articolo di Emanuele Severino, uscito ieri sul Corriere della Sera. Sul sito di Micromega, alcuni
altri interventi interessanti: firmati da Franca D'Agostini, Adriano Ardovino e Mauro Barberis.
Nuovo realismo, vecchio dibattito
Fatti e interpretazioni: Eco, Ferraris e Vattimo rischiano la leggerezza
Emanuele Severino - Corriere della Sera, 31 agosto 2011
Questa estate, dopo un incontro alla Milanesiana, mi son trovato a cenare con Umberto Eco e
Maurizio Ferraris. A un certo punto il discorso è caduto sul modo di intendere i «fatti». Molto
difesi da Eco e Ferraris. E anche il «senso comune» era molto difeso da Eco. Ho avuto l'
impressione che per lui e, credo, anche per Ferraris, la «verità» fosse il cosiddetto «senso
comune». Il loro primo bersaglio era l'affermazione di Nietzsche, che «non esistono fatti ma solo
interpretazioni». Nietzsche non è un «realista». Ma implicitamente il bersaglio si allargava a
Heidegger e a Gadamer e anche a chi, come Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, ha lavorato sulla
scia di questi pensatori, a partire appunto da Nietzsche.
Poi, su «la Repubblica» Ferraris ha scritto che è ora di far rivivere su scala mondiale i «fatti», la
«verità», il «realismo» e ha discusso la cosa con Vattimo che però non è d'accordo. Sul «nuovo
realismo» si annunciano già convegni in varie parti del mondo a cui auguro di evitare una certa
leggerezza purtroppo occhieggiante. Anche Benedetto XVI, a Madrid, ha invitato i giovani a
«cercare la verità» (si capisce, per poterla trovare) e lo ha fatto citando il Parmenide di Platone. Se
mi è lecito annotarlo, c' è anche chi, da più di mezzo secolo, va dicendo che il senso autentico della
verità non è investito dalla crisi inevitabile a cui è andata incontro la «verità», quale è intesa lungo
la storia dell' Occidente.
Ma Ferraris, che peraltro stimo, vuol far rivivere «fatti», «verità» e «realismo» dando come cosa
per sé evidente (almeno così mi è sembrato) che la realtà esista indipendentemente dalla coscienza
umana, la quale sarebbe però capace di conoscerla con verità, scorgendo appunto i «fatti» ed
essendo quindi una certezza che ha come contenuto la verità. Con fatica, si potrebbe far rientrare
questo modo di pensare in ciò che Hegel chiamava appunto «identità di certezza e verità». Non
dubito che Ferraris e Eco l'abbiano presente. Con fatica, dico, perché - lo comunicavo a Eco anche
quella sera - il senso comune non è la conferma filosofica del senso comune.
Anche per le scienze della natura la realtà esiste indipendentemente dall' uomo. Da qualche
millennio questo è anche il comune modo di pensare dei popoli, il loro «senso comune». Ma ben
prima della scienza è la filosofia, sin dai suoi inizi, a riflettere sul rapporto tra l'essere umano e la
realtà - e sul significato di queste due dimensioni. Prevale, con la grande filosofia classica (Platone,
Aristotele) la conferma del senso comune. E più tardi tale conferma sarà chiamata «realismo». La
prospettiva espressa dal principio di Protagora che «l'uomo è la misura di tutte le cose» (e che
quindi la realtà dipende dal modo in cui l'individuo pensa e vuole) resta a lungo emarginata.
Ma, proprio perché conferma il senso comune, il «realismo» filosofico non è il senso comune. La
filosofia, infatti, viene alla luce evocando un senso prima sconosciuto della parola «verità» - il
senso che domina l'intera tradizione dell'Occidente dai Greci a Hegel, ad Einstein; cioè la verità
come «scienza» ( epistéme ) incontrovertibile, fondata su principi primi innegabili e per sé evidenti
-; e il realismo filosofico ritiene che il senso comune abbia verità. Ma è la filosofia a conoscere la
verità del senso comune, non il senso comune.
Per avere un esempio della potenza e complessità concettuale del realismo filosofico si tenga
sott'occhio questo passo dell' Etica nicomachea di Aristotele: «Ciò di cui abbiamo scienza non può
essere diversamente da come è; le cose che possono essere diversamente, invece, quando siano
fuori della nostra osservazione, ci rimane nascosto se esistano o no». (La parola «osservazione»
traduce la parola theoréin, che significa la manifestazione del mondo, che accade con l' esistenza
dell' uomo). Si può dire che in questo passo sia addirittura anticipato quell' importante
atteggiamento del pensiero contemporaneo che è la «fenomenologia» fondata da Edmund Husserl,
per la quale è verità tutto, ma anche solo ciò che è osservabile (manifesto, immediatamente
presente, sperimentabile); e quindi non è possibile che, con verità, venga affermato qualcosa
intorno a ciò che non è osservato. Proprio per questo la «fenomenologia» non è una conferma del
nostro senso comune. Aristotele non riconoscerebbe ciò che pure si è sviluppato dal proprio seme;
eppure la sua è una critica radicale del senso comune in quanto sussistente al di fuori della
conferma che l'epistéme gli dà: tutto ciò che esso dice non è scienza (epistéme). Inoltre, per
Aristotele, la realtà di cui c'è scienza e che quindi esiste indipendentemente dall'uomo è più ampia
della realtà di cui, secondo la «fenomenologia», c'è scienza (e anche Husserl intende la filosofia
come «scienza rigorosa»). La scienza è infatti per Aristotele (come per l' intera tradizione
occidentale) anche scienza di Dio, «metafisica».
Il «realismo» filosofico greco si è sviluppato nella filosofia patristica e scolastica (Agostino,
Tommaso, ecc.), e quindi nella dottrina della Chiesa cattolica e delle altre Chiese cristiane, e poi nel
Rinascimento e nella stessa filosofia moderna prekantiana, che però procede a una forma più
elaborata di conferma del senso comune. E il «realismo» è stato messo in questione da Kant e
dall'idealismo, per poi riaffacciarsi in varie correnti della filosofia degli ultimi due secoli, Marx e
marxismo compresi. Si continua a dire che ci si è liberati della cultura idealistica. Ma quanti
conoscono l'idealismo da cui ci si deve liberare? Per l'idealismo (e il neoidealismo italiano) è fuori
discussione (come per il realismo) che la natura esiste indipendentemente dalle singole coscienze
degli individui umani. È dalla coscienza «trascendentale» (liquidata con troppa disinvoltura) che la
natura non è indipendente.
La scienza, si diceva sopra, è realista. E la «filosofia analitica», che in questi giorni si farà sentire
all'Università San Raffaele di Milano, sostiene per lo più che per sapere come sia fatto il mondo
bisogna rivolgersi alla scienza moderna (che non è più epistéme ). Sennonché, se il «realismo»
della scienza moderna non vuol essere semplice, ingenuo «senso comune», allora è una tesi
filosofica, è cioè quel realismo filosofico la cui potenza e complessità concettuale e i cui rapporti
con le concezioni non realistiche sfuggono completamente al moderno sapere scientifico - e sarebbe
un peccato se sfuggissero anche al «nuovo realismo», stando al modo in cui esso è stato presentato.
Si aggiunga che la scienza intende fondarsi sull' «osservazione». Ma la gran questione è che la
realtà, che per la scienza esisterebbe egualmente anche se l' uomo non esistesse (l'uomo, dice la
scienza, compare soltanto a un certo punto dello sviluppo dell'universo), è per definizione ciò che
non è osservato dall' uomo, ciò di cui l'uomo non fa esperienza. Ciò significa: non può esserci
esperienza umana di ciò che esiste anche quando l'umano non esiste; e quindi l'affermazione che la
realtà è indipendente dall'uomo finisce anch'essa con l'essere una semplice fede o quella forma di
fede che è il grado anche più alto di «probabilità».
Comune al «nuovo realismo» e al «pensiero debole» di Vattimo e Rovatti è comunque l'istanza
politico-morale messa in primo piano. Si accusano reciprocamente di favorire il totalitarismo. Ora,
la filosofia - come il mito e poi la scienza moderna - è nata per difendere l' uomo dal dolore e dalla
morte dovuti alla natura e alla lotta tra gli uomini. In questo senso la filosofia (come il mito e la
scienza), nascendo dalla paura, è mossa da un' istanza politico-morale. Ma la filosofia si accorge
che il rimedio non può essere quello inaffidabile del mito, ma deve avere «verità» e la «verità» non
può fondarsi sulla dimensione politico-morale. Per la sua assoluta spregiudicatezza la «verità»
deve chiedersi perché la violenza dei più forti debba essere bandita. E deve saper rispondere.
Altrimenti essa è semplice edificazione.
Un'ultima osservazione su Nietzsche. La sua tesi che non esistono fatti ma solo interpretazioni non
va intesa in senso assoluto: riguarda solo un certo insieme di eventi. Infatti, che il divenire del
mondo esista non è per Nietzsche un'interpretazione affidata da ultimo alle decisioni storiche e
quindi cangianti dell' uomo: che il divenire (la storia, il tempo) esista è per Nietzsche - anche per
Nietzsche - l'incontrovertibile verità fondamentale in base a cui è necessario negare ogni realtà
eterna, immutabile, «divina» che sovrasti il divenire e lo domini e guidi. Questa «verità» è la
Grande Fede al cui interno cresce l' intera storia dell' Occidente e, ormai, del Pianeta. La fede che
da tempo, nei miei scritti, si invita a dar conto del suo incontrastato potere.
Addio postmoderno
Benvenuti nell'era dell'autenticità
Edward Docx - La Repubblica, 3 settembre 2011
Ho delle buone notizie per voi. Il 24 settembre potremo ufficialmente dichiarare morto il
postmoderno. Come faccio a saperlo? Perché in quella data al Victoria and Albert Museum si
inaugurerà quella che viene definita la "prima retrospettiva globale" al mondo intitolata
"Postmoderno: stile e sovversione 1970-1990".
Un momento.... Vi sento urlare. Perché dichiarano ciò? Che cosa è stato il postmoderno, dopo
tutto? Non l'ho mai capito. Come è possibile che sia finito? Non siete gli unici. Se esiste una parola
che confonde, irrita, infastidisce, assilla, esaurisce e contamina noi tutti è "postmoderno". E
nondimeno, se lo si capisce, il postmodernismo è scherzoso, intelligente, divertente, affascinante.
Da Madonna a Lady Gaga, da Paul Auster a David Foster Wallace, la sua influenza è arrivata
ovunque e tuttora si espande. È stata l'idea predominante della nostra epoca.
Allora: di che cosa si è trattato, esattamente? Beh, il modo migliore per iniziare a capire il
postmodernismo è facendo riferimento a ciò che c'era prima: il modernismo. A differenza, per
esempio, dell'Illuminismo o del Romanticismo, il postmodernismo racchiude in sé il movimento
che si prefiggeva di ribaltare. A modo suo, il postmodernismo potrebbe essere considerato come il
tardivo sbocciare di un seme più vecchio, piantato da artisti quali Marcel Duchamp, all'apice del
modernismo tra gli anni Venti e Trenta. Di conseguenza, se i modernisti come Picasso e Cézanne si
concentrarono sul design, sulla maestria, sull'unicità e sulla straordinarietà, i postmoderni come
Andy Warhol e Willem de Kooning si sono concentrati sulla mescolanza, l'opportunità, la
ripetizione. Se i modernisti come Virginia Woolf apprezzarono la profondità e la metafisica, i
postmoderni come Martin Amis hanno preferito l'apparenza e l'ironia. In altre parole: il
modernismo predilesse una profonda competenza, ambì a essere europeo e si occupò di universale.
Il postmodernismo ha prediletto i prodotti di consumo e l'America, e ha abbracciato tutte le
situazioni possibili al mondo.
I primi postmodernisti si legarono in un movimento di forte impatto, che mirava a rompere col
passato. Ne derivò una permissività nuova e radicale. Il postmodernismo è stato una rivolta
apprezzabilmente dinamica, un insieme di attività critiche e retoriche che si prefiggevano di
destabilizzare le pietre miliari moderniste dell'identità, del progresso storico e della certezza
epistemica. Più di ogni altra cosa il postmodernismo è stato un modo di pensare e di fare che ha
cercato di eliminare ogni sorta di privilegio da qualsiasi carattere particolare e di sconfessare il
consenso del gusto. Come tutte le grandi idee, è stato una tendenza artistica evolutasi fino ad
assumere significato sociale e politico. Come ha detto il filosofo egiziano-americano Ihab Hassan,
nella nostra epoca si è affermato un "forte desiderio di dis-fare, che ha preso di mira la struttura
politica, la struttura cognitiva, la struttura erotica, la psiche dell'individuo, l'intero territorio del
dibattito occidentale".
Il postmodernismo apparve per la prima volta come termine filosofico nel libro del 1979
dell'intellettuale francese Jean-François Lyotard intitolato "The Postmodern Condition", nel quale
si affermava che gruppi diversi di persone utilizzano il medesimo idioma in modi differenti e ciò
implica che possano arrivare a vedere il mondo con occhi alquanto differenti e personali. Così, per
esempio, il sacerdote utilizza il termine "verità" in modo assai diverso dallo scienziato, che a sua
volta intende la medesima locuzione in modo ancora diverso rispetto a un artista. Di conseguenza,
svanisce completamente il concetto di una visione unica del mondo, di una visione predominante.
Se ne deduce - sostenne ancora Lyotard - che tutte le interpretazioni convivono, e sono su uno
stesso piano. Questo confluire di interpretazioni costituisce l'essenza del postmodernismo.
Purtroppo, il 75% di tutto ciò che è stato scritto su questo movimento è contraddittorio,
inconciliabile, oppure emblematico della spazzatura che ha danneggiato il mondo accademico della
linguistica e della filosofia "continentale" per troppo tempo. Non tutto però è da buttar via. Due
sono gli elementi importanti. Il primo è che il postmodernismo è un'offensiva non soltanto
all'interpretazione dominante, ma anche al dibattito sociale imperante. Ogni forma d'arte è filosofia
e ogni filosofia è politica. Il confronto epistemico del postmodernismo, l'idea di de-privilegiarne un
significato, ha pertanto condotto ad alcune conquiste utili per il genere umano. Se infatti ci si
impegna per sfidare il ragionamento prevalente e predominante, ci si impegna altresì per dare voce
a gruppi fino a quel momento emarginati. Così il postmodernismo ha aiutato la società occidentale
a comprendere la politica della differenza e quindi a correggere le miserabili iniquità ignorate fino a
quel momento. Il secondo punto va maggiormente in profondità. Il postmodernismo mirava a
qualcosa di più che pretendere semplicemente una rivalutazione delle strutture del potere.
Affermava che noi tutti come esseri umani altro non siamo che aggregati di quelle strutture.
Sosteneva che non possiamo prendere le distanze dalle richieste e dalle identità che tali discorsi ci
presentano. Adios, Illuminismo. Bye bye, Romanticismo. Il postmodernismo, invece, afferma che ci
muoviamo attraverso una serie di coordinate su vari fronti - classe sociale, genere, sesso, etnia - e
che queste coordinate di fatto costituiscono la nostra unica identità. Altro non c'è. Questa è la sfida
fondamentale che il postmodernismo ha portato al grande convivio delle idee umane, in quanto ha
cambiato il gioco, passando dall'autodeterminazione alla determinazione dell'altro.
Eccoci però giunti alla domanda trabocchetto, la più subdola di tutte: come sappiamo che il
postmodernismo è alla fine, e perché? Prendiamo in considerazione le arti, la linea del fronte. Non
si può affermare che l'impatto del postmodernismo sia minore o in via di estinzione. Anzi, il
postmodernismo è esso stesso diventato il sostituito dell'ideologia dominante, e sta prendendo
posto nella gamma di possibilità artistiche e intellettuali, accanto a tutte le altre grandi idee. Tutti
questi movimenti in modo impercettibile plasmano la nostra immaginazione e il modo col quale
creiamo e interagiamo. Ma, sempre più spesso, il postmodernismo sta diventando "soltanto" una
delle possibilità che possiamo utilizzare. Perché? Perché tutti noi siamo sempre più a nostro agio
con l'idea di avere in testa due concetti inconciliabili: che nessun sistema di significato possa
detenere il monopolio sulla verità, e che nondimeno dobbiamo riformulare la verità tramite il
nostro sistema scelto di significati.
Forse, il modo migliore per spiegare le ragioni di questo sviluppo è usare la mia forma d'arte, il
romanzo. Il postmodernismo ha influito sulla letteratura sin da quando sono nato. In effetti, il
modo stesso col quale ho scritto questo articolo - mescolando parzialmente a livello di
consapevolezza tono formale e tono informale - è in debito verso le sue stesse idee. Stile alto e stile
basso coesistono allo scopo precipuo di creare occasioni di stupore, sorpresa, introspezione. Il
problema, però, è quello che potremmo definire il paradosso del postmodernismo. Per qualche
tempo, quando il Comunismo crollò, la supremazia del capitalismo occidentale parve messo a dura
prova proprio ricorrendo alle tattiche ironiche del postmodernismo. Col passare del tempo, però, si
è presentata una nuova difficoltà: tenuto conto che il postmodernismo se la prende con qualsiasi
cosa, ha iniziato ad affermarsi una sensazione di confusione, finché negli ultimi anni è diventata
onnipresente. Una mancanza di fiducia nei dogmi e nell'estetica della letteratura ha permeato la
cultura e pochi si sono sentiti sicuri o esperti a sufficienza da riuscire a distinguere la spazzatura da
ciò che non lo è. Pertanto, in assenza di criteri estetici attendibili, è diventato sempre più
conveniente stimare il valore delle opere in rapporto ai guadagni che esse assicuravano. Così,
paradossalmente, siamo arrivati a una fase nella quale la letteratura stessa è ormai minacciata,
prima dal dogma artistico del postmodernismo, poi dagli effetti involontari di tale dogma,
l'egemonia dei marketplace.
Esiste inoltre un paradosso parallelo, in politica e in filosofia. Se deprivilegiamo tutte le posizioni,
non possiamo affermare alcuna posizione, pertanto non possiamo prendere parte alla società e
quindi, in definitiva, un postmodernismo aggressivo diventa indistinguibile da una specie di inerte
conservatorismo. La soluzione postmoderna non servirà più da risposta al mondo nel quale ci
ritroviamo a vivere. In quanto esseri umani, noi non desideriamo esplicitamente essere lasciati in
compagnia del solo mercato. Perfino i miliardari vogliono essere collezionisti di opere d'arte. Certo,
internet è quanto di più postmoderno esista su questo pianeta. Il suo effetto più immediato in
Occidente pare essere stato la nascita di una generazione che è maggiormente interessata ai social
network che alla rivoluzione sociale. Tuttavia, se sappiamo guardare oltre scopriamo un secondo
effetto negativo indesiderato: una smania a conseguire una sorta di veridicità offline. Desideriamo
essere riscattati dalla volgarità dei nostri consumi, dalla simulazione del nostro continuo
atteggiarci.
Se il problema per i postmodernisti è stato che i modernisti avevano detto loro che cosa fare, allora
il problema dell'attuale generazione è esattamente il contrario: nessuno ci sta dicendo che cosa
fare. Questo crescente desiderio di una maggiore veridicità ci circonda da tutte le parti. Lo
possiamo constatare nella specificità dei movimenti food local, per i cibi a chilometro zero. Lo
possiamo riconoscere nelle campagne pubblicitarie che ambiscono ardentemente a raffigurare
l'autenticità e non la ribellione. Lo possiamo vedere nel modo col quale i brand stanno cercando di
prendere in considerazione un interesse per i valori dell'etica. I valori tornano ad avere importanza.
Se andiamo ancor più in profondità, ci accorgiamo della crescente rivalutazione dello scultore che
sa scolpire e del romanziere che sa scrivere. Jonathan Franzen ne è un esempio calzante: uno
scrittore encomiato in tutto il mondo perché si sottrae alle evasioni di genere o alle strategie
narrative postmoderne, cercando invece di dire qualcosa di intelligente, di autentico, scritto bene,
sulla propria epoca. Ciò che conta, dopo tutto, non è soltanto la storia, ma come è raccontata.
Queste tre idee - specificità, valori, autenticità - sono in aperto conflitto con il postmodernismo.
Stiamo dunque entrando in una nuova era. Potremmo provare a chiamarla "l'Età dell'Autenticità".
Vediamo un po'come andranno le cose.
(Traduzione di Anna Bissanti)
Imparando da Las Vegas
La Repubblica, 3 settembre 2011
Denise Scott Brown approdò a Las Vegas coi suoi studenti dell'Ucla nel 1965 e poi nel 1968,
convincendo il marito Robert Venturi a seguirla. "Learning from Las Vegas" fu il frutto di quelle
indagini. Il libro analizzava, senza scomunicarla, la malfamata città del vizio, «una città che
spavaldamente sembrava fare a meno non solo degli architetti, ma dell'architettura in generale»,
scrive Manuel Orazi nella postfazione alla traduzione italiana. Las Vegas cresceva per accumulo
di oggetti fastosi e improbabili che si accatastavano sui due lati della Route 91, frutto di
speculazione sulle aree. Era l'esempio di come la funzionalità e la razionalità predicate dal
movimento moderno potessero infrangersi contro l'irrompere di gusti e di consumi, contro la
potenza del mercato. Il libro provocò molte reazioni e Scott Brown e Venturi vennero accusati di
snobismo, di apologia del disordine, di giustificare e non solo di studiare.
«Robert Venturi e io ci consideriamo ancora postmoderni, ma in un'accezione che deriva dalle arti
e dalle scienze umane degli anni Sessanta, o anche prima. Quelle idee ci influenzano tuttora e
prendono il nome di "Postmoderno" in molti campi. Siamo al tempo stesso Modernisti, impegnati
nel progetto di aggiornare i dogmi del Moderno per avviare un cambiamento. La definizione di
Postmoderno non va confusa con la deriva a cui abbiamo assistito in architettura e che chiamo, in
senso negativo, "PoMo".
Il "PoMo" ha fatto sì che in passato Venturi negasse di essere postmoderno: è un movimento
puramente commerciale che si distingue per quel disprezzo del sociale che in alcuni circoli, dagli
anni Settanta in poi, è diventato un marchio distintivo. A causa di questa deriva, anche noi siamo
stati accusati di essere superficiali e "ossessionati dai neon".
Al mio grido di allora: "Ci deve essere un modo per incidere sulla società coni nostri progetti", gli
architetti "PoMo" hanno risposto: "Possiamo fare davvero poco per risolvere i problemi sociali,
allora perché tentare?". A noi, invece, la società interessa. Quando dicevo che il nostro saggio
"Imparando da Las Vegas" era in parte un trattato sociale, tutti replicavano: "Stai scherzando!". Ma
oggi gli studenti e i giovani architetti rispondono: "Che altro c'è di nuovo?". Ci auguriamo che le
nuove generazioni raccolgano la fiaccola (il neon?) e si facciano carico di situazioni tecniche e
sociali che noi non siamo in grado di capire perché troppo vecchi e così facendo si mettano al
servizio della necessità e raggiungano lo scopo della bellezza (magari straziante)».
(Il testo è un estratto del saggio di Scott Brown scritto per il catalogo della mostra del Victoria &
Albert Museum)
I passi silenziosi di Chen Zen
L’INGANNO DEL PENSIERO DEBOLE
Pubblicato da Simona Maggiorelli su settembre 16, 2011
Maurizio Ferraris
Con un convegno a Bonn e una lectio magistralis al Festivalfilosofia, il docente dell’Università di Torino
lancia un manifesto per il New Realism. E apre la discussione pubblica
di Simona Maggiorelli
Mentre si annuncia un convegno internazionale che riunirà il Gotha della filosofia a Bonn per discutere della
necessità di un New Realism (dopo anni di ammorbante Pensiero debole) anche in Italia si accende il
dibattito sulla proposta lanciata dal filosofo dell’Università di Torino Maurizio Ferraris. Che sabato 17
settembre (ore 11,30) ne parlerà in una lectio magistralis, in piazza a Carpi nell’ambito del Festivalfilosofia
di Modena. Ad ottobre, poi, uscirà per i tipi di Guanda il suo nuovo libro L’anima e l’iPad .
Professor Ferraris, Pensiero debole e Postmoderno hanno imperversato per anni.
Con qunto danno?
I danni sono venuti soprattutto attraverso il populismo, che ha ricevuto un potente anche se in buona parte
involontario fiancheggiamento ideologico da parte del Postmoderno. E queste ricadute non hanno riguardato
solo le élites più o meno vaste interessate alla filosofia o all’arte postmoderna ma anzitutto una massa di
persone che forse di Postmoderno non hanno mai sentito parlare, o quasi, e che subiscono gli effetti del
populismo mediatico, compreso il primo e il più grande: la convinzione che si tratti di un sistema senza
alternative.
Il filosofo Richard Rorty diceva che non esiste una realtà, «out there», là fuori. Mentre Gianni Vattimo
in Addio alla verità sostiene che la verità ha sempre un che di dispotico. Ora, lui si dice di sinistra,
addirittura comunista. Ma come si può trasformare se stessi e la società a partire da un così assoluto
nihilismo?
Bertrand Russell raccontava che a una cena una signora gli disse: “Trovo che il solipsismo sia una bellissima
teoria, e vorrei fondare una associazione di solipsisti”. Il nichilista che pensa di trasformare il mondo non è
meno paradossale di quella signora. Se non c’è verità e realtà come si può capire se si sta trasformando se
stessi e il mondo o se invece si pensa solo di farlo? A parte questo autoinganno, c’è un problema più grosso.
Se c’è una dottrina che sostiene che non ci sono fatti, solo interpretazioni le vittime di soprusi non potranno
neppure lamentarsi, chiedere giustizia, organizzare una reazione, appunto perché l’ideologia dominante è che
non ci sono fatti e che la verità la si costruisce come la costruiscon certi telegiornali. Così le vittime
subiranno senza avere la speranza che, un giorno, giustizia sarà fatta, il che significa che subiranno
ingiustizia due volte.
Una rinuncia così totale alla ricerca della verità non rischia di dissolvere ogni ricostruzione storica,
obbligandoci a restare muti e inerti di fronte a ogni forma di negazionismo?
Questo è il problema maggiore. Curiosamente, la “scuola del sospetto”, l’idea che si debba dubitare di tutto
ciò che viene assunto come ovvio e viene dichiarato pubblicamente, nasce come esercizio critico, ma può
avere esiti a dir poco dogmatici: chi ha avuto ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato ha dato, scordiamoci il
passato. Una specie di condono tombale cala su tutte le tragedie dell’umanità. Certo, Cartesio diceva che una
volta nella vita, se si vuol essere filosofi, si deve mettere in dubbio tutto. Ma, appunto, diceva che è una
specie di esercizio da farsi una volta sola e in veste di filosofi. Nella vita di tutti i giorni, invece, il dubbio
sistematico è una posizione insostenibile (anche gli scettici si scansano se vedono che gli sta venendo
addosso un tram), e va a finire che uno dubita solo di ciò che gli fa comodo dubitare.
A partire dal ‘68 si è registrato uno strano fenomeno: ogni proposta di un pensiero forte sulla realtà
umana (anche se radicato nella realtà, anche se sottoposto a verifica) è per la sinistra – specie quella di
matrice foucaultiana – sempre fascista. Perché?
Perché il ‘68 è stato l’estensione al mondo sociale della pratica iper-ironica delle avanguardie. Si trattava
sempre di mettere i baffi alla Gioconda, di usare le parole tra virgolette, soprattutto se queste parole erano
“verità” e “realtà”. Il colmo l’ha toccato Roland Barthes quando (scherzando ma non troppo) ha detto che «la
lingua è fascista», perché ha norme e regole. A questo punto il vero parlante antifascista sarebbe lo
sgrammaticato e l’analfabeta, il vero medico antifascista sarebbe quello che non sa curare!
Derubricare l’adesione al nazismo di Heidegger a scelta privata è lecito? O bisogna aprire gli occhi su
quello che molti maestri del ‘68 e teorici del pensiero debole non hanno voluto vedere: ovvero che il
pensiero stesso di Heidegger è nazista? E perché i filosofi irresponsabilmente non hanno voluto vedere
questa pericolosa consustanzialità?
Non è assolutamente lecito considerare il nazismo di Heidegger una “questione privata”. Anche perché,
come lei dice, il pensiero di Heidegger è consustanziale al nazismo. Molti filosofi di sinistra – ma non tutti,
per esempio non Habermas – non hanno voluto vederlo in parte anche perché vederlo non era facilissimo, nel
senso che l’adesione al nazismo era presentata come un incidente di percorso superato già nel ‘34 (era
l’autodifesa di Heidegger), e i testi di Heidegger che circolavano a sinistra non erano certo il Discorso di
rettorato (tradotto molto tardi: in italiano, se non sbaglio, addirittura nel 1988), ma testi apparentemente più
innocui, in cui si diceva che il linguaggio è la casa dell’essere e che l’uomo abita poeticamente. Tranne che
poi anche in quei testi emergevano sprazzi inquietanti, per esempio, in un corso su Nietzsche del 1940, un
elogio del Blitzkrieg in corso, oppure, nella intervista allo Spiegel del 1966 e pubblicata alla sua morte (Ora
in Ormai solo un Dio ci può salvare, Guanda ndr), la tesi secondo cui paragonava la Shoah all’agricoltura
meccanizzata. Ma, a prescindere da questi sprazzi, quello che non si è visto in generale, è che il pensiero
heideggeriano nel suo insieme è iper-gerarchico, e che l’appello al nichilismo e alla volontà di potenza,
l’insistenza sulla Decisione, l’abbandono della nozione tradizionale di “verità”, sono una adesione profonda
e non opportunistica al Führerprinzip. Non è privo di ironia il fatto che questo pensiero sia diventato un
punto di riferimento essenziale per filosofi che militavano a sinistra e che si volevano anti-autoritari. Anche
se tra questi filosofi c’è stato chi come Habermas ha denunciato subito l’equivoco e chi ha lavorato su
Heidegger, ma senza rimuoverne i caratteri inquietanti, come ha fatto Derrida (ma è proprio lui che mi ha
aperto gli occhi su Heidegger). Vista nell’insieme comunque la ricezione è stata indulgente talora sino alla
cecità.
Il Pensiero debole – dice Rovatti – è nato come critica al potere della metafisica. Ma poi è diventato
esso stesso discorso fumoso e astratto. La stessa pratica della decostruzione proposta da Derrida non
ha finito per fiaccare ogni ricerca in una continua e sempre rimandata diffrazione del senso
bloccandola in una paralizzante indecidibilità?
Il Pensiero debole, la Decostruzione, il Postmoderno, sono cose molto diverse, come sottolineava
giustamente Aldo Rovatti, anche se tra loro c’è una “somiglianza di famiglia” e dei temi comuni…
Diciamolo con semplicità: è molto più facile decostruire che non costruire, anche se, ne sono pienamente
convinto, ogni costruzione degna di questo nome richiede una decostruzione, un momento critico della
tradizione, come in effetti è sempre avvenuto tra grandi filosofi: Aristotele ha decostruito Platone, ma se si
fosse limitato a questo non sono sicuro che ce ne ricorderemmo ancora. Inversamente, se sono convinto che
ci ricorderemo ancora per secoli di questo grande e controverso filosofo che è Jacques Derrida, è perché non
è stato semplicemente un decostruttore; è stato anche un grande costruttore, ha lavorato in modo originale e
propositivo sulle nozioni di sovranità, amicizia, giustizia. Cosa che ovviamente non si può dire di altri
decostruttori.
Intervenendo nel dibattito fra New Realism e Postmoderno, Emanuele Severino sul Corriere della Sera
abbozza uno sferzante paragone: «Maurizio Ferraris parla di verità… Anche Benedetto XVI a Madrid
ha invitato i giovani a cercare La Verità». Perché la verità dovrebbe essere appannaggio della
religione e non degli esseri umani?
Nell’esortare i giovani alla ricerca della verità (si intende, ed è una limitazione che non va trascurata, nel
quadro di una “verità superiore”, quella della fede) il papa fa il suo mestiere, così come lo fa quando ricorre
all’epistemologia anarchica di Feyerabend per sostenere che Bellarmino non aveva poi tutti i torti nel
condannare Galileo. Quelli che secondo me non fanno il loro mestiere sono i filosofi che invitano a dire
addio alla verità, o gli epistemologi che sostengono che le teorie scientifiche sono delle specie di “visioni del
mondo” senza una particolare pretesa di verità. A questo punto, ovviamente, lasciando il monopolio della
verità ad altri. La strategia da seguire, ovviamente, è tutta un’altra: riconoscere quanta importanza abbia,
nella vita umana, la verità, e impegnarsi nella sua ricerca e possibilmente nella sua pratica, perché spesso la
verità è sotto gli occhi di tutti, solo è difficile da attuare.
Nel suo Ricostruire la decostruzione (Bompiani) si legge: « Il programma del pensiero postmoderno
prevedeva la liberazione sessuale, a partire dal progetto di rivoluzione desiderante di Deleuze e
Guattari. Ma “l’attivismo sessuale” non ha prodotto liberazione sociale…». Perché secondo lei?
In parte perché è scattato un meccanismo peraltro già studiato da Horkheimer e Adorno. Il sovrano concede
al popolo libertà sessuale, e in cambio tiene per sé non solo la libertà sessuale ma anche tutte altre libertà che
non sono concesse agli altri. Da questo punto di vista, non c’è niente di più conveniente, anche dal punto di
vista economico, della concessione della libertà sessuale. I sudditi se la vedono tra loro, non sono necessarie
strutture costose, per esempio buone università (come sarebbe nel caso che il sovrano concedesse al popolo
la libertà di studio), e non ci sono ricadute rischiose (per esempio il fatto che i sudditi si stufino del sovrano,
come sarebbe nel caso che il popolo si istruisse e prendesse coscienza). In questo senso, l’attivismo sessuale
è stato molto più efficace, per paralizzare eventuali prese di coscienza, del panem et circenses, appunto
perché non richiede neppure la concessione di pane o di giochi. Basta un discorso pubblico in cui si dice che
“le persone a casa loro fanno quello che vogliono”, il cui vero significato è spesso: “le persone a casa loro
fanno quello che voglio”.
La filosofia di Derrida è un curioso pastiche di vecchio e nuovo, lei ha detto in un convegno in sua
memoria. Aggiungendo che il suo rifarsi alla psicoanalisi «è stato un enorme arcaismo». In Filosofia
per dame (Guanda) poi lei scrive: «La psicoanalisi si è industriata a ridurre tutte le colpe a sensi di
colpa non facendo un buon servigio all’umanità»…
L’ombra maggiore della psicoanalisi, a mio avviso, è proprio quella contenuta nel brano che lei riporta: la
confusione tra sensi di colpa e colpe vere e proprie, che fa sì che per uno psicoanalista Hitler sia
essenzialmente uno che ha avuto una infanzia difficile!
Dibattito | Addio al postmoderno?
A proposito del New Realism
di Sossio Giametta
Non bisogna confondere la costruzione puramente logica, di cui l’esempio massimo è l’ontologia di
Parmenide (ma già anche quella di Anassimandro), con la considerazione della realtà empirica. Le
due sfere sono eterogenee e incompatibili. E questa eterogeneità e incompatibilità ha dato luogo
alle dicotomie di razionalismo ed empirismo, idealismo e realismo. Ma poiché si tratta pur sempre
di due modi di vedere la stessa realtà, la tentazione di irrompere con l’una nella sfera dell’altra si è
dimostrata irresistibile nella storia della filosofia occidentale. Anche perché il progresso è possibile
solo nella conoscenza della realtà empirica. Lo si vede in particolare nei casi di Anassimene,
Melisso e Giordano Bruno, per menzionare solo i più clamorosi. Ci sarebbe anche Spinoza, che
addirittura mette insieme le due cose, deus e natura (deus sive natura) solo che è possibile che egli
abbia voluto indicare non un’identità ma una diversità, non una sola cosa con due nomi, ma due
cose diverse che però in definitiva ne sono una sola. Un esempio è da noi Severino, nel quale questa
confusione scalza alla base la sua filosofia. Egli si affanna a distinguere, nella scia di Parmenide,
l’essente dal non essente, ma poi dice, a differenza di Parmenide, che tutte le “cose” sono eterne.
Però le cose che, come Schopenhauer insegna, non sono altro che effetti (per Nietzsche “le cose
sono i limiti dell’uomo”), si esauriscono nelle loro relazioni reciproche e hanno realtà solo nel loro
agire come intuizioni, esistono in quanto “cose” solo nel divenire, ossia, secondo Severino,
nell’apparire che è illusione e non-essente. Come fanno, essendo illusioni non-essenti, a essere
eterne? E d’altra parte, se l’essere o l’essente fosse invece, come a noi sembra, una continua
creazione e dunque un continuo divenire, dove tutto nasce e muore, ma non il nascere e morire
stesso? Ciò gli impedirebbe il ragionamento che trae da Parmenide:
Parmenide mostra che “ciò che è”, l’“essente”, non può provenire dal “non essente” e nel “non
essente” non può dissolversi; e poiché il mondo è l’apparire dell’incominciare ad essere e del
cessare di essere, da parte delle cose, le cose del mondo non possono essere degli “essenti” e il loro
apparire è solo illusione. […] Questa struttura [la sua “struttura originaria del destino della
verità”] mostra che le cose del mondo non possono essere illusione, ma sono “essenti”, e dunque
sono eterne, tutte; sì che il loro variare non può essere inteso come il loro provvisorio sporgere
dal nulla, ma come il comparire e lo scomparire degli eterni.
Così egli ha scritto nel Corriere della Sera del 12 marzo 2008, metamorfosando malamente la
dottrina delle idee di Platone, cioè attribuendo l’eternità alle cose e non alla legge delle cose. Un
autore che invece questa fondamentale distinzione l’ha fatta è Giulio Cesare Vanini. Di poco
posteriore a Bruno e a lui affratellato dal martirio (“Andiamo a morire allegramente da filosofo”,
disse sublimemente al boia che era venuto a prelevarlo per portarlo al rogo, previo strappo della
lingua), ne è il successore naturale: la scepsi dopo la fede e gli eroici furori. Ecco come unisce e
disgiunge le due cose:
Dio è di se stesso principio e fine; manchevole di ciascuno dei due, non bisognoso né dell’uno né
dell’altro, ed è padre e insieme autore di entrambi. Esiste sempre, ma è senza tempo, perché per
lui né scorre il passato né sopraggiunge il futuro. Regna dovunque ma è senza luogo, è immobile
ma senza quiete, infaticabile senza muoversi. Tutto fuori di tutto; è in tutte le cose ma non vi è
compreso; è fuori di esse ma non ne è escluso. Regge l’universo dall’interno, dall’esterno lo ha
creato. Buono pur essendo privo di qualità, grande pur essendo privo di quantità. Totalità senza
parti, immutabile, produce nelle altre cose mutamento. Il suo volere è potere e la volontà gli è
necessaria. È semplice, e nulla è in Lui in potenza, ma tutto in atto, anzi Egli stesso è puro, primo,
medio ed ultimo atto. Infine è tutto su tutto, fuori di tutto, in tutto, oltre tutto, prima di tutto e
tutto dopo tutto (da Mario Carparelli, Morire allegramente da filosofi, Il Prato, p. 10).
Purtroppo, questa confusione tra metafisica e realtà empirica c’è stata anche nel pensiero debole. E
c’è, pur nella correzione, nell’attuale ritorno al pensiero forte, che passa per Umberto Eco, Paul
Boghossian, Diego Marconi, Paolo Flores d’Arcais, Maurizio Ferraris, a partire dal saggio di John
Searle, La costruzione della realtà sociale (1995). Il pensiero forte, infatti, conserva lo stesso
impianto del pensiero debole, fluttua sulla sua stessa onda. Lo corregge, ma in un certo senso lo
prosegue, è trascinato da esso. Non mette il dito sull’errore di fondo: l’illegittima interpretazione
del principio di Nietzsche: “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”. La confusione di Vattimo e
compagni, secondo Ferraris, è tra ontologia ed epistemologia, tra “quello che c’è e quello che
sappiamo a proposito di quello che c’è”. Ma più precisamente la confusione è tra metafisica e fisica.
Il principio di Nietzsche resta valido sul piano metafisico, dove tutto quello che cogliamo è
interpretazione di qualcosa di infinito che non potremo mai cogliere nella sua essenza. Ma è molto
meno valido sul piano fisico. La fysis, la natura, è realtà, ma antropomorfizzata dalla nostra
percezione. Non per niente Nietzsche sostiene che la fisica è l’autodescrizione dell’uomo:.
È sufficiente considerare la scienza un’umanizzazione il più possibile fedele delle cose; noi
impariamo a descrivere in modo sempre più preciso noi stessi quando descriviamo le cose e la
loro successione.
Goethe aveva già detto:
L’uomo non comprenderà mai quanto egli sia antropomorfico.
Aveva però anche detto:
L’uomo è posto come reale in mezzo a un mondo reale ed è dotato di organi tali, per cui può
conoscere e produrre il reale e, inoltre, il possibile.
Che la fisica sia realtà antropomorfizzata, è provato dai continui cambiamenti, cioè miglioramenti
in verità e precisione, e quindi in disantropomorfizzazione, della scienza, sicché le leggi della fisica,
che si vogliono così solide, si evolvono anch’esse nel tempo, vengono continuamente corrette. Basta
pensare a Tolomeo e Copernico, a Newton e Einstein, a Planck ecc.
Di per sé l’ermeneutica non sarebbe dunque che la conseguenza logica, il corollario di tale
principio. Ma in pratica ha dato luogo a una grandiosa confusione. Si è predicata l’inattingibilità
della verità. Ma, tanto per cominciare, nel seno stesso dell’ermeneutica Luigi Pareyson, maestro di
Eco e Vattimo, afferma che la verità è soggetto e non oggetto delle interpretazioni, sicché le
interpretazioni sono le facce cangianti della sua infinità come le epoche, per Platone, sono le facce
cangianti dell’eternità. Dunque l’addio di Vattimo e del pensiero debole alla verità, a qualsiasi
verità e non solo, come sarebbe stato legittimo, alla verità ultima o piuttosto ulteriore, dato che una
verità ultima non esiste; si è sostenuta la costruzione sociale di tutto, anche del mondo naturale,
dopo che per la grande filosofia idealistica la natura era stata interpretata come una mera
costruzione umana. Si è trasportato insomma il principio di Nietzsche dal piano assoluto (la vera
ontologia) alla sfera intraumana, nella quale i fatti ci sono e c’è pure la realtà (empirica), lo “zoccolo
duro” di Eco, il fuoco che brucia, l’acqua che bagna e il mondo naturale inemendabile di Ferraris: il
mondo che si fa valere con le sue leggi per tutti i viventi.
Non cozza ciò con la suddetta imprecisione della fisica? Sì, come il senso di stabilità della terra, per
quanto imperfetta (terremoti, maremoti ecc.), per la quale si costruiscono le case sul Vesuvio, cozza
con il vita motu constat. Dunque la stabilità esiste, esistono “i ritmi distesi della natura” (Th.
Mann), e sono per gli uomini una grande risorsa in mezzo al vertiginoso movimento dell’universo.
Nella sfera intraumana riprendono pertanto pieno senso, con buona pace di Nietzsche, la
conoscenza e la morale. Perché il suo nichilismo, negazione appunto della conoscenza e della
morale, è valido solo sul piano assoluto. In assoluto il mondo non ha un senso unitario,
umanamente rilevabile, bensì tutti i sensi che per le singole creature scaturiscono dall’interno
secondo la loro diversa natura e misura di forza, come dice Nietzsche. Questo è il prospettivismo,
per il quale il mondo appare a ogni essere in una prospettiva particolare, che è anche una sua
abbreviazione, e cattura la realtà entro i limiti e le forme particolari delle singole creature
nell’ambito delle specie a cui queste creature appartengono. Le specie sono le intermediarie tra
l’assoluto e gli individui. Le prospettive degli uomini si costituiscono nell’ambito della specie
umana (specie = l’umanità con la sua storia e le sue potenzialità) e in relazione ad essa. Riposano
sulla forza di gravità che le specie esercitano nei loro membri. Con la forza di gravità la specie tiene
gli individui legati a sé e ai suoi bisogni, che essi tutti rappresentano come organi di un organismo
unitario, e costituiscono il senso della loro vita. In tal modo la gravità impedisce agli uomini di
cadere nell’irrazionale e nel vuoto morale del “niente è vero, tutto è permesso” zarathustriano. Per
conseguenza, l’interpretazione non usurpa più il posto della verità. Le interpretazioni restano
legittime e concorrenti, ognuno ha diritto alla sua, ma possono tutte essere validamente discusse e
caso mai confutate in nome della verità, cioè nell’ambito di una gerarchia basata sull’esperienza.
Flores d’Arcais e Ferraris ne fanno anche se non soprattutto una questione morale e politica.
Secondo loro la soppressione della verità autorizza tutte le falsità, come (dicono) quelle di
Berlusconi. Hanno ragione loro e torto Vattimo, Rovatti e i postmoderni, gli “irrealisti”?
Sebbene non si possa predicare l’indifferenza assoluta della “filosofia” per la politica, e abbiamo
avuto in realtà prove grandiose del contrario, qui le cose non sono, diciamo, grandiose. Anche
quando la fede nella verità era incrollabile o ritenuta tale, si sono dette e messe in giro tutte le
falsità che si son volute dire e mettere in giro. Lo stesso accade nell’altro caso. Credere o non
credere alla verità non cambia e non autorizza sostanzialmente niente sul piano morale e politico.
Vattimo punta sulla solidarietà al posto della verità e pensa che se non c’è la verità non ci sia
neanche il fanatico che crede sia solo la sua ed è pronto a mettere tutto a ferro e fuoco per farla
prevalere su quella degli altri. Crede poi pure che il liberarsi della verità come fondamento, come
Grund fisso, favorisca l’emancipazione. Flores d’Arcais e Ferraris gli danno addosso sostenendo il
contrario. Insomma sia dall’una che dall’altra parte si predicano ragioni valide e ragioni sbagliate.
In realtà la questione della verità non ha conseguenze vincolanti sul piano morale e politico, in
quanto l’atteggiamento che si assume al riguardo dipende molto dal carattere onesto o disonesto e
poco dalle teorie. Può invece avere grande importanza politica, in bene e in male, come la storia
attesta, la dottrina pura, vedi per esempio Nietzsche e Heidegger da un lato e Spinoza dall’altro.
Non posso d’altra parte dimenticare la risposta di Calder a chi gli chiedeva perché non faceva
politica. Indicò i suoi mobiles dicendo: questa è la mia politica.
Che cosa c’è dietro il nuovorealismo?
di Franca D’Agostini
1. Senza filosofia
Il dibattito sul «new realism» e il post-postmoderno aperto sulle pagine di Repubblica da Maurizio
Ferraris, e proseguito con il confronto tra Ferraris e Vattimo (l’uno new realist, o anzi:
nuovorealista, l’altro vetero-postmodernista – o così sembra) soffre a mio parere di un problema di
fondo: l’assenza di filosofia. Certo non si richiede “filosofia” in senso scientifico-accademico sulle
pagine dei giornali, e sarebbe assurdo chiedere a Vattimo e Ferraris che specifichino sui quotidiani
le loro posizioni di rispettivamente avversario e difensore della “verità” e della “realtà”, rispetto a
posizioni oggi attive nel dibattito filosofico, in Italia e altrove, sui temi da loro trattati. Però, specie
quando si parla di concetti così tipicamente e inequivocabilmente filosofici, forse varrebbe la pena
lasciare da parte (almeno un po’) le considerazioni più generiche, per addentrarsi in quel che è il
compito proprio del filosofo, come ricorda molto bene Roberto Casati nella sua recente Prima
lezione di filosofia (Laterza, 2011), ossia la negoziazione concettuale.
Allora sarebbe interessante capire di quali nozioni di realtà e/o di verità stanno parlando, e quali
nuove versioni dei due venerabili concetti propongono. Per esempio, Ferraris è favorevole al
cosiddetto realismo modesto, che semplicemente presuppone l’indipendenza di qualcosa detto
reale, e non specificato, dai nostri strumenti conoscitivi, o preferisce il realismo del senso comune,
secondo cui ‘reale’ è ciò che comunemente riteniamo essere tale? Conoscendo un po’ i lavori di
Ferraris, sarei portata ad accettare la seconda ipotesi, ma sarebbe interessante valutare le sue
ragioni nel contesto della discussione sul postmodernismo, che lui evidentemente interpreta come
anti-realismo nel senso modesto del termine (o forse no?). Quanto a Vattimo: che cosa intende per
‘verità’ quando dice che si tratta di un concetto disprezzabile, in quanto cifra del potere? È forse la
verità pluralista di Crispin Wright, concetto tutto sommato adattabile, che tiene in conto le ragioni
degli scettici e dei perplessi? Conoscendo un po’ i lavori di Vattimo, direi di no, e d’altra parte
Vattimo, come lui stesso dice, non ha neppure una specifica antipatia per qualche forma di
realismo modesto, o minimale.
Questo silenzio dei due contendenti ha due ricadute perlomeno imbarazzanti: 1) che i due autori
sembrano postulare un lettore clamorosamente incapace di capire questioni filosofiche sottili – ma
se sono così sottili da essere incomprensibili, forse non sono così rilevanti, e se invece sono
rilevanti tacerne significa fare un pessimo servizio a chi legge: il gioco è precisamente renderle
accessibili; 2) che non si capisce bene di che cosa stiano parlando, visto che la disputa sembra
molto facilmente componibile: Vattimo non nega che esista una qualche banale realtà su cui a volte
diciamo cose banalmente vere, ed è ovvio che Ferraris non nega che quel che si spaccia per realtà,
specie nelle materie più controverse, è spesso il frutto di ricostruzioni e semicostruzioni
opportunamente (e ingannevolmente) orientate, per cui il nominalmente vero è formidabile
menzogna. Ma allora qual è il problema?
2. Davvero realtà e verità, o non piuttosto qualcosa d’altro?
Ogni discussione filosofica (anche quando il quid filosofico è pallido e incerto) è in certo modo
importante. Ma ho l’impressione che se ci si ferma a una questione di realismo e antirealismo
(specie così genericamente indicata) l’intera disputa risulti pretestuosa, oppure tutto sommato
chiusa in un problema avvertito solo dai discepoli di Derrida, o di qualche altro autore francese,
che dopo un certo numero di anni si sono accorti della inconsistenza di certe posizioni
fantasiosamente iperscettiche, nel frattempo passate di moda.
In particolare la questione interessante di fondo non mi sembra sia tanto il nuovorealismo di
Ferraris, di Searle, e di molti altri, ma piuttosto il ruolo della filosofia rispetto alla sfera pubblica. In
altri termini, ciò che è in gioco non sono i concetti di realtà e di verità (o lo sono derivatamente),
ma piuttosto il “che fare?” in filosofia: esattamente la domanda a cui il «pensiero debole» di
Vattimo e Rovatti tentava di dare una risposta. Allora la questione è: quale ruolo ha la filosofia
rispetto all’agire collettivo e individuale, che vuol dire: rispetto alla politica, all’economia, alla
gestione degli affari pubblici e anche, volendo, privati, degli esseri umani?
Non si tratta affatto di una domanda interna, una questione, come si dice, solo “metafilosofica”. Si
tratta invece, e molto più seriamente, di fare i conti con quel rapporto tra teoria e prassi che per la
nostra tradizione è stato sviluppato in senso filosofico o quasi dai movimenti politici del secondo
Ottocento e del Novecento: il marxismo, il socialismo, ma anche le ideologie totalitarie (che erano
notoriamente sintesi di vari socialismi e conservatorismi).
Di fronte alle crisi mondiali a cui ci ha condotto la pragmatizzazione della politica, e della vita
pubblica in generale, sotto il pretesto della «fine delle ideologie», o di altre super-teorie generiche e
sociologizzanti, la questione “pensiero debole” intesa in questo senso, ossia come sforzo di
articolare filosofia e agire pubblico, diventa interessante, e merita capire quale fosse davvero la
proposta in gioco.
In effetti sono assolutamente d’accordo sull’importanza dei concetti di realtà e verità su cui Ferraris
insiste nei suoi articoli, e condivido il suo disagio nei confronti delle dichiarazioni antimetafisiche
che hanno popolato il dibattito europeo nel secondo Novecento. Più in generale penso che sia
bizzarro da parte di una persona che si occupa di filosofia prendersela genericamente contro l’uno o
l’altro concetto. Ma non sono affatto d’accordo sull’interpretazione della filosofia contemporanea
europea (la cosiddetta “filosofia continentale”), in specie italiana, in termini di sommario e stupido
anti-realismo. Certo, una componente kantiana o anzi hegelo-kantiana è presente in tutta la
filosofia europea, e ciò significa che la base comune è una sorta di costruzionismo o semicostruzionismo. Ma è disastrosamente sviante interpretare il costruzionismo (in particolare quello
di Kant) in termini di anti-realismo (perlomeno nel senso del realismo modesto). Certamente, le
dichiarazioni anti-realiste di Nietzsche sono state influenti, e il Nietzsche realista energetico è stato
a volte dimenticato. Ma tutto ciò era in fondo marginale, rispetto al vero motivo per cui la filosofia
europea (specie quella francese) ha avuto così grande successo pubblico, negli anni Settanta e
Ottanta. E tale motivo con ogni evidenza era: perché proseguiva, portava avanti (più o meno bene),
la discussione sulla politica connected, ossia la prassi politica collegata a una visione della realtà,
della conoscenza, che appunto la filosofia dovrebbe elaborare (rinegoziare).
Di qui emergono due chiare e inaggirabili questioni. La prima è la classica: quale filosofia? È
opinione comune in effetti che l’espressione ‘filosofia’ non designi affatto alcunché di determinato e
specifico, e/o designi (a partire dal secondo Novecento) un campo almeno diviso in due, tra la
cosiddetta filosofia analitica attiva nei paesi di lingua inglese e in Scandinavia, e la filosofia
continentale, appunto l’insieme delle correnti attive in Europa. La seconda questione è: siamo
sicuri che questa connessione non sia precisamente il nostro vero problema, visto il fallimento a dir
poco disastroso delle politiche connected, culminate nei totalitarismi del Novecento?
3. Analitici e continentali
Nei primi anni Ottanta dello scorso secolo i due problemi si presentavano strettamente collegati,
perché precisamente la filosofia analitica figurava come una filosofia di professionisti ed esperti,
piuttosto scettica riguardo alla politica connected, e mirante piuttosto a salvaguardare la qualità del
lavoro filosofico, sottraendolo alla vaghezza manipolatrice della comunicazione pubblica. In tale
vaghezza, invece, era in qualche modo costretta a immergersi la filosofia “continentale”, in quanto
appunto interessata all’uso pubblico della filosofia. Qualità e utilità pubblica funzionavano allora
come consistenza e completezza secondo Gödel: inseguendo l’una si perde l’altra, e viceversa.
In effetti Vattimo aveva iniziato all’epoca del «pensiero debole» una ricognizione più o meno
sistematica sulla filosofia analitica, e dichiarava testualmente: «non è questa l’epoca delle
contrapposizioni, ma della ricomposizione». Si trattava cioè di capire che cosa le due tradizioni
potessero insegnarsi a vicenda, secondo la formula del «doppio apprendimento» suggerita da
Habermas, e quindi potessero convergere verso quel programma o quella speranza di
«emancipazione» che in fondo restava – nelle intenzioni di Vattimo come di altri filosofi europei
della stessa generazione – il vero scopo del lavoro filosofico.
Ora molto spesso quando si effettuano matrimoni di questo tipo si ottengono mésalliances
disastrose, in cui i difetti di un partner si cumulano ai difetti dell’altro, e il risultato è uno
scadimento generale. In luogo del doppio apprendimento habermasiano si ha allora un doppio
disapprendimento: si finisce per dimenticare ciò che di buono era stato pensato nell’una e nell’altra
parte, e ci si assesta invece ostinatamente sui punti bui, che di solito sono anche i più facili, e più
facilmente vendibili. Allora abbiamo visto la semplicità delle domande analitiche fondamentali
diventare semplicismo, o senz’altro formidabile banalità, per adattarsi allo schema della
comunicazione pubblica. Abbiamo visto il raffinato semi-costruzionismo europeo, a contatto con la
pretesa analitica di risolutezza teorica, diventare ottuso antirealismo, palesemente e
irrimediabilmente autocontraddittorio, e perciò inutilizzabile. D’altra parte, abbiamo visto filosofi
di formazione continentale, e perciò di vocazione interessati al giornalismo e al ruolo di intellettuali
pubblici, fingere sottigliezze formali di nessuno scopo e utilizzo; mentre filosofi formatisi
all’antipatica téchne analitica tentavano di diventare a ogni costo simpatici, e brillanti, con risultati
per lo più penosi.
Naturalmente, l’altra questione, proprio in virtù di questo confronto o “doppio apprendimento”
fallito, restava in sospeso.
4. Debole?
Vattimo e Rovatti, per quel che ne so, erano soprattutto interessati alla seconda questione. Si
trattava sostanzialmente di rivedere le basi filosofiche della politica, cercando di procedere oltre il
neomarxismo dialettico (la Scuola di Francoforte) e la filosofia francese della differenza (lanciata
dai post-strutturalisti Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard). A questo scopo si proponeva
l’espressione «pensiero debole», che era visibilmente un’etichetta di natura associativa, un
termine-ombrello, destinato ad accogliere diverse esperienze recenti, da Karl Popper a Jacques
Derrida, accomunate da una visione «indebolita» o «alleggerita» della filosofia, specie rispetto alla
prassi.
Sul modo di intendere questo indebolimento-alleggerimento le opinioni erano quanto mai
divergenti, come testimonia la raccolta del 1983: se la rileggete, vi accorgete che tutti brancolano
un po’ da una parte e dall’altra, e non esiste alcuna théorie d’ensemble. Già, si diceva: questo è per
l’appunto il segno che il debolismo è attivo: nessuna convergenza, nessun dogma, nessuna teoria
superiore o tribunale della ragione.
Però quando qualcuno vi dice: niente teoria soltanto prassi, dovete sempre dubitare, perché questa
è per l’appunto una teoria, e singolarmente antipatica, perché vieta a ogni altra teoria di
pronunciarsi. Allo stesso modo, quando qualcuno vi dice: nessuna convergenza, dovete sospettare
molto: perché o non c’è un bel nulla (visto che ciò che non converge, perlomeno su se stesso, non
c’è), oppure c’è un convergere molto forte su un punto: sul fatto che ogni altra convergenza salvo la
propria è sbagliata.
A parte questo vecchio gioco socratico, “l’associazione” sotto la cifra del debolismo proposta da
Vattimo e Rovatti poteva essere piuttosto ragionevole: tanto la scienza quanto la cultura del
secondo Novecento (anche nella filosofia analitica) sembravano indirizzate verso l’idea di un uso
più duttile e morbido dei canoni e dei principi, e (per quel che ci riguarda) un uso diverso del
rapporto tra teoria filosofica e agire pubblico. Interpretato al meglio, si trattava di un uso più
democratico, ossia meno servile nei confronti della Religione, e della Scienza, e delle presunte
Verità promananti dall’una e dall’altra; un uso anche meno ossequioso nei confronti della Filosofia,
come istituzione o apparato di canoni, ortodossie, linguaggi istituiti.
Da un certo punto di vista, la sfida era ancora quella antica, che sempre ha portato avanti la
filosofia contro la presunzione di sapienza da parte del Potere, e delle sue menzogne. Il Novecento
dubitò che la parola “filosofia” potesse ancora svolgere questo compito critico e innovativo. Invece,
in ogni epoca, il fatto che nelle società democratiche esista ancora una filosofia (almeno
nominalmente) può essere la garanzia che questa sfida resti aperta. O almeno, così credo. In ogni
epoca la filosofia ha il compito di rilanciare la posta, con nuovi linguaggi, nuove categorie, nuove
analisi dei suoi concetti fondamentali, come realtà, verità, bene, giustizia, ecc. che mobilizzano i
significati istituiti. Ma certo deve esserci filosofia, non soltanto in senso nominale: non basta citare
a casaccio qualche Kant e Hegel. E con ciò ritorniamo all’inizio. Spacciare per filosofia un
sociologismo superficiale, che spara con furbizia etichette di comodo, è a mio avviso l’errore di
fondo. Credo che Vattimo, e Ferraris, sappiano fare di meglio. O no?
Dibattito | Addio al postmoderno?
L’ossessione del potere
di Carlo Augusto Viano
Quando, tanti anni fa, intervenni nella discussione sul pensiero debole, Enrico Filippini scrisse su
la Repubblica che dovevo essere un frequentatore dei palazzi Fiat e dei circoli Agnelli. Era una
misera circostanza di fatto e l’affermazione di Filippini era falsa, ma falsa soltanto di fatto. A
Torino, iscritto d’ufficio nel neoilluminismo, anche se non vi avevo mai contribuito attivamente,
autore di un libro che non piaceva a Bobbio, sempre osteggiato dagli spiritualisti locali, che cosa
potevo essere se non un intellettuale funzionale (come si diceva allora) alla Fiat, oggettivamente
(un’altra parola sempre di moda) al suo servizio? Se le cose di fatto non stavano così era colpa mia,
ché non capivo che cosa mi accadeva né sapevo trarre partito da ciò che facevo.
Ricordo spesso questa piccola cosa, quando mi capita di scrivere o di parlare della filosofia italiana
di quegli anni, non perché essa sia importante, ma perché è un piccolo indizio di un’atmosfera e di
una mentalità: si respirava l’ossessione del potere. Il potere era ovunque e, se non lo si vedeva, era
solo perché la sua presenza era diventata così diffusa che non lo si distingueva più dal corso
ordinario delle cose: non un ingrediente della realtà, ma una sostanza magmatica e plastica, capace
di mescolarsi con qualsiasi cosa. Ci si aspettava che filtrasse sotto le porte e il sospetto sistematico
era considerato l’atteggiamento più accorto. C’erano anche degli antidoti specifici: per esempio le
noiose e interminabili elucubrazioni di Husserl, che certamente avrebbero ucciso qualsiasi
funzionario del potere, se si fosse riusciti a fargliele leggere, o le sommarie filippiche di Foucault e
le strampalate e innocue decostruzioni di Derrida.
L’ossessione del potere non era una cosa nuova nella cultura italiana, almeno nella cultura
filosofica. Il Risorgimento? Quell’idea di “fare gli italiani” dopo che era stata fatta l’Italia? Frutto
della febbre nazionalistica che aveva preso ad ardere nei paesi diventati nazioni nel corso
dell’Ottocento? La filosofia militante non era di casa anche in Germania, un paese con una vicenda
nazionale simile alla nostra? E in entrambi i paesi la patria e i partiti totalizzanti arruolavano
intellettuali e condannavano quelli sordi alle lusinghe. Da noi i “grandi intellettuali”, come Croce,
Gramsci o Gobetti, sono sempre stati molto militanti, con più impegno che ricchezza o finezza dei
mezzi concettuali impiegati. Flores d’Arcais cita tra i “buoni”, precursori della riscoperta del
realismo, Abbagnano, Geymonat, Bobbio, con il loro neoilluminismo, e Della Volpe, con la sua
eresia marxista. Il neoilluminismo finì presto con la filosofia popolare di Abbagnano, le mescolanze
avventate di logica, dialettica e razionalismo di Geymonat e l’abbandono della teoria generale del
diritto da parte di Bobbio, tornato presto alla predicazione politica; quanto alle avventure del
marxismo più o meno eretico, le ricordiamo tutti.
A smascherare il potere arrivò anche in Italia la rivincita degli sconfitti. Heidegger era stato servo
abietto del potere più macabro ed era uscito male dalla sconfitta del suo paese, ma riapparve e
diventò la bandiera dell’antipotere, in Italia subito issata anche dagli allievi degli spiritualisti, che
avevano messo insieme fascismo gentiliano e filosofia cattolica. Le riforme e la rivoluzione pacifica
e democratica, strade lungo le quali si erano messe in cammino schiere di intellettuali più o meno
organici, erano prospettive finite. Il grande progresso scientifico e tecnico, che aveva cambiato la
vita nella prima metà del Novecento era illusorio, un mostruoso progetto di dominazione, con
dominatori anonimi, che non poteva essere contrastato in modo selettivo, ma andava rifiutato in
blocco o usato in modo ludico.
A giocare con il potere si perde sempre. Se vuoi indirizzarlo, correggerlo, prenderlo sul serio e farne
una cosa accettabile ne diventi servo; se lo neghi del tutto, ti contagia, ti infetta, facendoti
partecipe. Questo è accaduto ai negatori radicali del potere: sono andati al potere, sono diventati
deputati nazionali o europei, sindaci, sono comparsi ovunque, ospiti incombenti di chiacchiere
televisive, un po’ giullari degli invidiati signori del potere, divertiti dalle loro sfide verbali. La crisi
delle ideologie novecentesche ha aiutato: a corto di compiacenti filosofie della storia, quando le
finte teorie scientifiche dei politici sono state sostituite dalle “narrazioni”, i sospettosi del potere
hanno pagato il loro debito con chi li aveva contagiati di potere. Di narrazioni ne hanno fornite a
iosa, apparentemente originali, in realtà tutte uguali e tutte noiosissime. Soprattutto hanno
assicurato che tutto è narrazione e dunque tutto si può manipolare, raccontare in tanti modi e in
definitiva come si vuole.
Qualche mese fa ho potuto assistere a Reggio Emilia, durante il festival della laicità, a un
interessante dibattito tra Vattimo e Flores d’Arcais. Quest'ultimo sosteneva che le scienze ci hanno
fatto sapere molte cose e giustamente invitava a guardare al loro contenuto, un’indicazione che va
approfondita, in contrasto con la tendenza dei filosofi a guardare alla struttura del sapere
scientifico, ai suoi fondamenti, ai suoi metodi, in sostanza da fuori. I filosofi hanno sempre preso le
cose da questo lato, un po’ perché sapevano poco o nulla dei contenuti delle scienze, un po’ perché
potevano così trasformare le nozioni scientifiche in qualcosa di soggettivo e spirituale, facendo
delle cose le ombre delle idee; ma spesso perfino queste erano ritenute troppo forti e venivano
sostituite con le parole: le cose ombre delle parole. Polemizzando con il pensiero debole ho sempre
evitato di far leva sulle posizioni estremistiche dei suoi esponenti, sfruttando i ridicoli incidenti nei
quali sono caduti alcuni di loro. Ma le risposte di Vattimo a Flores d’Arcais sono state imbarazzanti.
La ripetibilità degli esperimenti? Propaganda, argomento da commesso viaggiatore, che non smette
di tirarla in lungo sui pregi dei suoi prodotti. Il gentilissimo e leale Flores d’Arcais tentava di dire
che sì, la soggettività va bene: chi oserebbe mancare di rispetto a Kant e mettere in piazza i suoi
trucchi? Ma c’è differenza tra la soggettività di una teoria scientifica e quella di una narrazione alla
Foucault o una decostruzione alla Derrida. Niente da fare: Vattimo ha tenuto duro, non è ricorso a
Gadamer, ma ha invocato il soccorso di Apel. Poi, a tavola, un Vattimo sempre spumeggiante e
spiritoso si è innervosito un po’ quando gli si è ricordato che altro è risolvere un problema di
Hilbert altro inventare una teoria filosofica portatile alla Umberto Eco, che i teoremi non li si
approva per far piacere al Pentagono né per alzata di mano.
Nell’intervento sul dibattito tra Vattimo e Ferraris, Flores d’Arcais assume un atteggiamento
prudente e un po’ sospettoso nei confronti della marcia di Ferraris alla conquista della realtà. Con
durezza Flores d’Arcais dice che, al di là di tutte le heideggerate, il rifiuto della realtà e della verità
da parte dei debolisti era soprattutto il rifiuto della validità della conoscenza scientifica. Il realismo
di Ferraris è riconoscimento di ciò che il suo maestro proprio non sopporta? Leggo le cose di
Ferraris, anche se non posso dire di conoscerle a fondo. Ciò che fa sorgere qualche dubbio anche in
me è l’idea di raggiungere la realtà per via filosofica. Chi mai chiederebbe a un filosofo se una cosa è
reale o se un’affermazione è vera? I filosofi attribuiscono o negano la realtà di blocchi interi: le idee,
i numeri, l’anima, la materia ecc. oppure parlano della realtà del reale o della verità delle
affermazioni vere. Quando provano a entrare nei particolari hanno incidenti indimenticabili: dopo
che Eudosso e Callippo avevano provato a contare le sfere nelle quali si muovono i corpi del sistema
solare, Aristotele volle correggerli, introducendo un numero spropositato di sfere, e non fece bella
figura. Di solito i filosofi si tengono sulle generali e si limitano a discutere se esista una realtà
indipendentemente dalle idee che se ne ha o se ci sia una verità indipendentemente dai mezzi con i
quali la si accerta. Sono cose che intrattengono i filosofi, un po’ meno gli altri, anche se diventano
pericolose quando servono a offrire pretesti per cancellare sezioni intere di faccende scomode.
La filosofia occidentale, cioè la filosofia, era all'origine un sistema di credenze sul mondo, e la sua
versione platonica e aristotelica fu il tentativo di conservare questa impostazione quando le
conoscenze sul mondo stavano cambiando. Quando il geocentrismo crollò per i filosofi fu una vera
tragedia, che dovettero fronteggiare ricuperando dottrine stoiche ed epicuree, nate dal rifiuto delle
immagini cosmologiche, fondamentali per Platone e Aristotele. In questa prospettiva si prese a dire
che ciò che si veniva a sapere sulle cose e sul mondo era il prodotto di un sistema di segni e che qui
stava la chiave per accedere alla realtà: c’erano i segni, ma c’era qualcosa oltre i segni? E che cosa di
ciò che pareva stare oltre i segni era reale? Le combinazioni di segni potevano essere vere o false,
ma c’era qualcosa che costituisse la verità delle combinazioni? Di alcune combinazioni di segni era
più facile capire subito se si riferissero a qualcosa o se fossero vere o false, di altre meno, e in certi
casi il sistema di segni usato poteva creare difficoltà proprie e generare inganni, ma erano casi
estremi, che di solito gli utilizzatori dei segni sapevano risolvere per conto loro. Invece i filosofi
pretendono di intervenire loro per dire se c’è qualcosa oltre i segni o non c’è nulla, anche quando i
sistemi di segni e le teorie possono stabilire il proprio grado di attendibilità o di isomorfismo tra i
segni e i loro oggetti. Anche quando riconoscono l’attendibilità delle conoscenze positive i filosofi si
arrogano il compito di spiegare perché esse siano attendibili e di chiarirle, andando oltre la
chiarezza intrinseca alle conoscenze valide.
I filosofi cercano anche di mettere insieme i sistemi di conoscenza organizzati e indipendenti dalle
credenze, tra le quali si aggira la filosofia, e le conoscenze più dirette e circostanziali, quelle con le
quali si trova la via di casa (per dirla con Platone), distinte dalle conoscenze degli astri e dei
numeri. Per i sospettosi radicali nulla si è salvato e l’impostura scientifica ha corrotto anche
l’esperienza ordinaria, nella quale l’uomo ha dimenticato l’essere. Per i realisti bisogna tenere
insieme i due sistemi ed eventualmente fare della conoscenza scientifica una continuazione
dell’esperienza ordinaria. Non è facile, perché le conoscenze scientifiche possono anche nascere dai
dati dell’esperienza ordinaria, come insegnava l’empirismo classico, ma poi quelle conoscenze
tendono a distruggere le certezze correnti. E tra queste ci sono le credenze che pesano, quelle con le
quali le persone costruiscono i propri progetti, le proprie illusioni, le giustificazioni delle proprie
delusioni, le condanne degli altri e le assoluzioni di se stessi.
Hume era un abile analista, che sapeva dar fondo alle risorse della scolastica per offrire, con l’aiuto
della psicologia filosofica aristotelica, un’idea semplificata dell’esperienza da cui nascono le
spiegazioni scientifiche. Così lasciava da parte giudizi e credenze e sanciva la separazione
dell’essere dal dover essere. Ma Hume sapeva che l’indipendenza del dover essere dall’essere aveva
un prezzo anche per il dover essere; ed è questo che il richiamo ottimistico alla sua formula
respinge. Ritorna allora la contrapposizione tra fatti e valori e a questi ultimi si dà la piena
sovranità che al sapere scientifico si riconosce sui fatti. Il regno dei valori sarà anche anarchico e
conflittuale, ma sembra dominato da contrapposizioni dettate da scelte sovrane. Ai teorici del
primato dell’interpretazione sui fatti si rimprovera di giustificare le posizioni di Berlusconi o di
Bush, dando credito alla pretesa di fabbricare la realtà con le parole. L’idea di fabbricare la realtà
con i valori, un’idea cresciuta nella Germania di Marburgo, Heidelberg e Friburgo, patria dei grandi
impostori del Novecento, non è molto diversa. Le cose che dice Flores d’Arcais sulla scienza
economica fanno pensare agli slogan che proclamavano tutto possibile. Sull’economia scientifica
pesa una facile propaganda, ma la battuta sugli economisti e la borsa fa il verso a quelle sugli
statistici che, avendo incontrato un vedente e un cieco, concludono che metà della popolazione è
cieca. Una cosa almeno l’economia scientifica può fare: insegnare che non sempre l’entendance
suivra.
(6 settembre 2011)
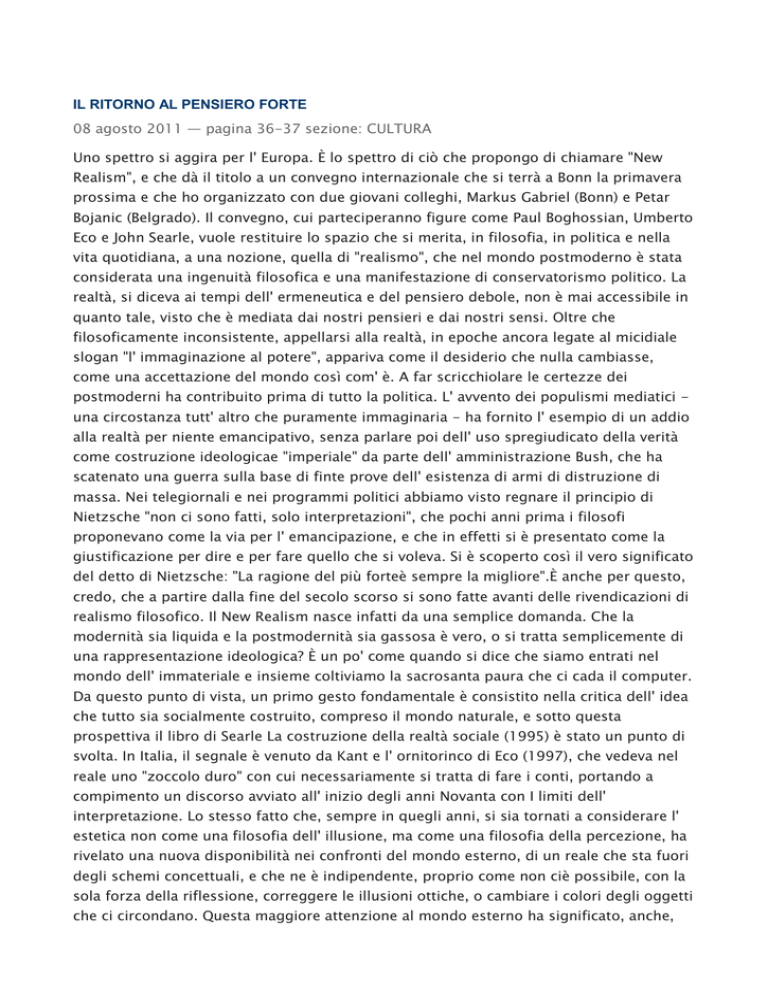
![[nazionale _ iii] lastampa_tuttoscienze_02_untitled_ ___](http://s1.studylibit.com/store/data/005745813_1-840f5eeda0f85c057daadc03dd7f45fe-300x300.png)