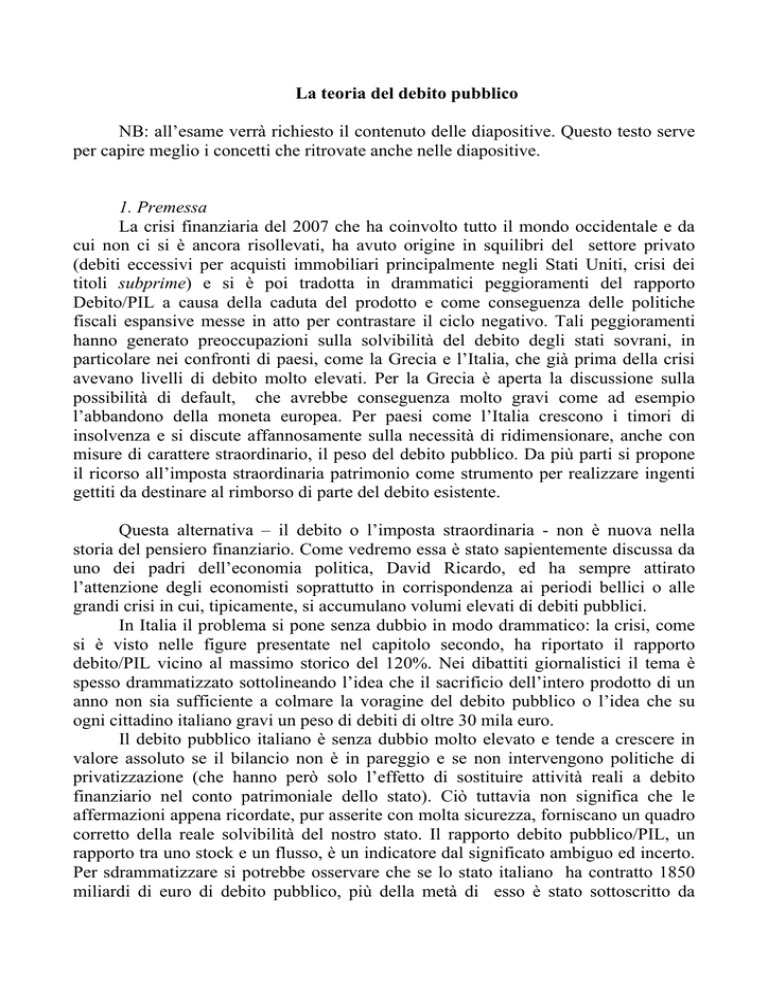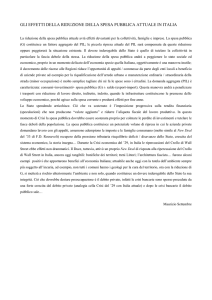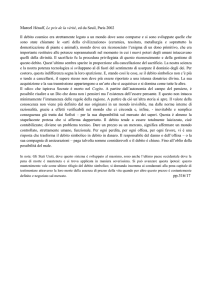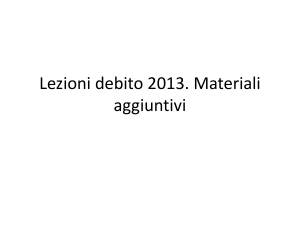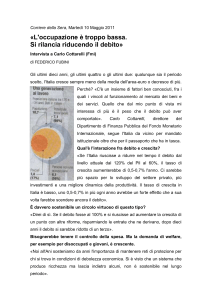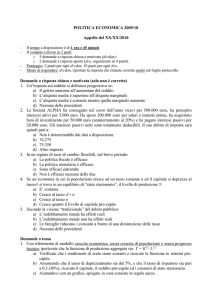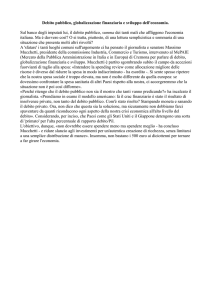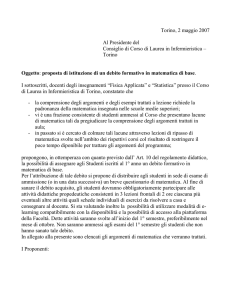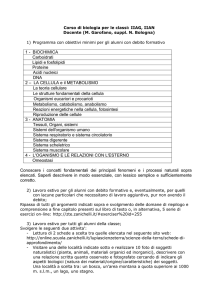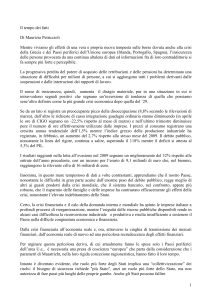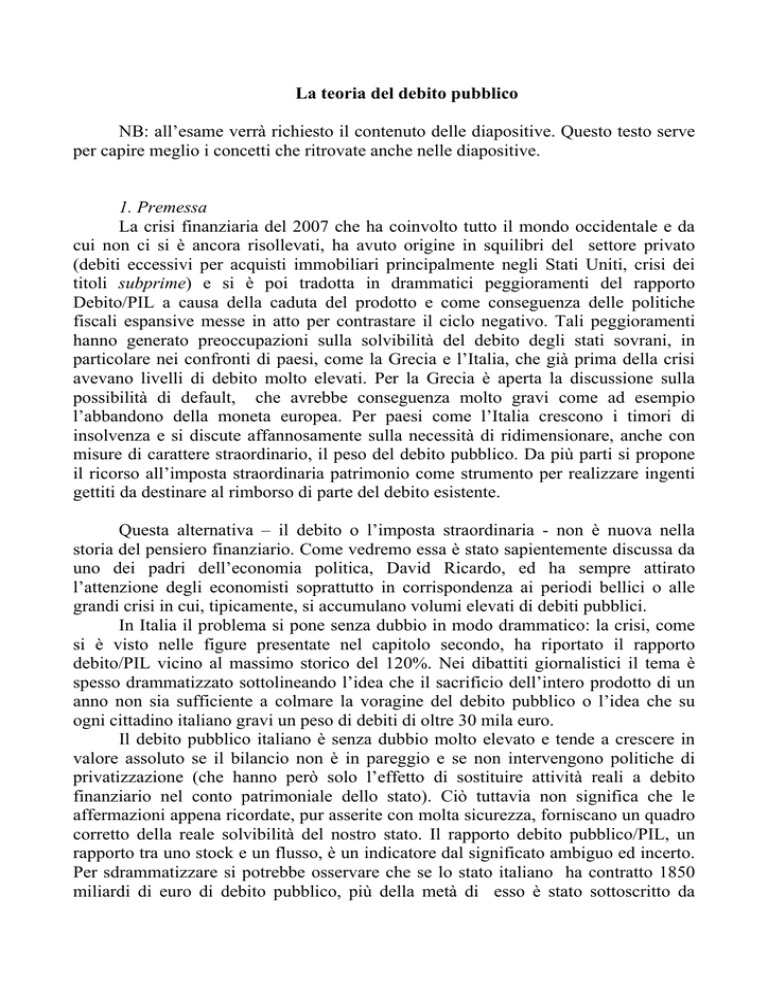
La teoria del debito pubblico
NB: all’esame verrà richiesto il contenuto delle diapositive. Questo testo serve
per capire meglio i concetti che ritrovate anche nelle diapositive.
1. Premessa
La crisi finanziaria del 2007 che ha coinvolto tutto il mondo occidentale e da
cui non ci si è ancora risollevati, ha avuto origine in squilibri del settore privato
(debiti eccessivi per acquisti immobiliari principalmente negli Stati Uniti, crisi dei
titoli subprime) e si è poi tradotta in drammatici peggioramenti del rapporto
Debito/PIL a causa della caduta del prodotto e come conseguenza delle politiche
fiscali espansive messe in atto per contrastare il ciclo negativo. Tali peggioramenti
hanno generato preoccupazioni sulla solvibilità del debito degli stati sovrani, in
particolare nei confronti di paesi, come la Grecia e l’Italia, che già prima della crisi
avevano livelli di debito molto elevati. Per la Grecia è aperta la discussione sulla
possibilità di default, che avrebbe conseguenza molto gravi come ad esempio
l’abbandono della moneta europea. Per paesi come l’Italia crescono i timori di
insolvenza e si discute affannosamente sulla necessità di ridimensionare, anche con
misure di carattere straordinario, il peso del debito pubblico. Da più parti si propone
il ricorso all’imposta straordinaria patrimonio come strumento per realizzare ingenti
gettiti da destinare al rimborso di parte del debito esistente.
Questa alternativa – il debito o l’imposta straordinaria - non è nuova nella
storia del pensiero finanziario. Come vedremo essa è stato sapientemente discussa da
uno dei padri dell’economia politica, David Ricardo, ed ha sempre attirato
l’attenzione degli economisti soprattutto in corrispondenza ai periodi bellici o alle
grandi crisi in cui, tipicamente, si accumulano volumi elevati di debiti pubblici.
In Italia il problema si pone senza dubbio in modo drammatico: la crisi, come
si è visto nelle figure presentate nel capitolo secondo, ha riportato il rapporto
debito/PIL vicino al massimo storico del 120%. Nei dibattiti giornalistici il tema è
spesso drammatizzato sottolineando l’idea che il sacrificio dell’intero prodotto di un
anno non sia sufficiente a colmare la voragine del debito pubblico o l’idea che su
ogni cittadino italiano gravi un peso di debiti di oltre 30 mila euro.
Il debito pubblico italiano è senza dubbio molto elevato e tende a crescere in
valore assoluto se il bilancio non è in pareggio e se non intervengono politiche di
privatizzazione (che hanno però solo l’effetto di sostituire attività reali a debito
finanziario nel conto patrimoniale dello stato). Ciò tuttavia non significa che le
affermazioni appena ricordate, pur asserite con molta sicurezza, forniscano un quadro
corretto della reale solvibilità del nostro stato. Il rapporto debito pubblico/PIL, un
rapporto tra uno stock e un flusso, è un indicatore dal significato ambiguo ed incerto.
Per sdrammatizzare si potrebbe osservare che se lo stato italiano ha contratto 1850
miliardi di euro di debito pubblico, più della metà di esso è stato sottoscritto da
cittadini italiani, che oltre ad avere accumulato risparmi per tale impiego dispongono
di una ricchezza netta privata di 8300 miliardi di cui 4600 sotto forma di immobili.
Anche sul piano strettamente empirico un valore elevato del rapporto non
dipinge di per sé una situazione della finanza pubblica sull’orlo del fallimento. Non è
la prima volta nella storia del nostro paese che ciò accade. E lo stesso può dirsi di
altre economie: nel Regno Unito lo stock del debito pubblico è rimasto superiore al
PIL per quasi un secolo; ha proporzioni ben più ampie di quello dell’Italia il debito
pubblico del Giappone.
In situazioni normali, in cui cioè non vi siano timori di crisi finanziarie
improvvise, l’onere del debito di un paese è infatti rappresentato dal peso degli
interessi passivi che ogni anno devono essere pagati ai sottoscrittori. Gli interessi
passivi nel conto delle AP, come si è visto nel capitolo secondo, sono pari a poco
meno del 5% del PIL. Ciò significa che la pressione fiscale del paese è impegnata per
5 punti per finanziare il servizio del debito: un valore senza dubbio elevato ma
superiore di non più di 2-3 punti di PIL rispetto alla media dei paesi europei.
Differenze di due-tre punti nella pressione fiscale tra due paesi, ceteris paribus, non
dovrebbe generare allarmi particolari.
Ben diversa e maggiore è invece la preoccupazione in periodi, come quello
attuale, di instabilità finanziaria – in cui cioè gli investitori, sulla base di motivazioni
più o meno ragionevoli, temono che vi siano rischi di mancato rimborso del capitale
prestato. In tal caso è importante sapere se la dinamica del debito si pone su un
sentiero che tende alla stabilità e valutare la sostenibilità finanziaria. Questo capitolo
cercherà di fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti di questo problema.
2. Perché esiste il debito pubblico
Se si vuole affrontare il problema del debito pubblico in modo rigoroso, prima
di domandarsi come eliminare il debito, può essere utile ricordare le risposte che gli
studiosi hanno fornito sulla natura del debito pubblico e sul suo ruolo in un’economia
di mercato. In estrema sintesi, ci pare che la teoria economica abbia messo a fuoco
quattro funzioni che esso può svolgere: la modificazione nel tempo del livello
dell’attività economica (funzione di stabilizzazione); la redistribuzione degli oneri di
spese pubbliche tra diverse generazioni; la realizzazione di una distribuzione ottimale
delle aliquote fiscali (tax smoothing); l’eliminazione di cause di fallimento del
mercato, attribuibili alla presenza di incompletezza di mercati.
La prima e più nota funzione è oggetto dei corsi di macroeconomia. Essa è
fondamentalmente legata alla tradizione della macroeconomia keynesiana e pone
l’accento sul ruolo dello strumento fiscale nell’influenzare il livello dell’attività
economica e/o dei prezzi.
La seconda funzione è connessa all’idea che il finanziamento della spesa
pubblica con debito anziché con imposte significhi addossare a generazioni future
l’onere di decisioni prese dalle generazioni presenti. La tesi, molto popolare, ma in
realtà assai controversa, è al centro del lunghissimo dibattito sul debito pubblico
iniziato da Ricardo nel secolo scorso, di cui ci occuperemo più avanti.
La terza funzione, proposta da Barro nel 1979 all’interno della teoria della
tassazione ottimale, parte dalla constatazione che a causa dei costi di benessere
prodotti dall’inevitabile applicazione di imposte distorsive, sia pure sotto ipotesi
semplificate, sarebbe ottimale una distribuzione delle aliquote fiscali costante nel
tempo. Il debito pubblico è lo strumento che permette di realizzare tale obiettivo,
evitando inasprimenti o riduzioni troppo brusche delle aliquote in presenza di shock
alla spesa indotti da fattori esogeni, come guerre, calamità, ecc.
La quarta funzione, sviluppata a livelli molto astratti all’interno della teoria
dell’equilibrio economico generale in condizioni di incertezza e con mercati
incompleti, vede nel debito lo strumento che consente agli operatori economici di
realizzare transazioni, in particolare di assicurazione, rispetto a possibili eventi futuri,
che diversamente, a causa dell’incompletezza dei mercati finanziari, non sarebbero
possibili. L’emissione di debito pubblico potrebbe essere un modo per aprire mercati
non esistenti; lo stato agirebbe quindi come innovatore finanziario.
In questo capitolo non intendiamo discutere tutti gli aspetti sopraccennati,
alcuni dei quali ci porterebbero ad affrontare questioni teoriche molto complesse. Ci
concentreremo invece sull’insieme di problematiche, all’interno della seconda delle
funzioni elencate, che ruotano intorno al c.d. teorema dell’equivalenza ricardiana, che
ci pare abbia più dirette implicazioni di politica economica. Tenuto conto
dell’importanza del contributo originario di Ricardo e della sua influenza sulla
letteratura successiva, soprattutto italiana – dopo avere indicato le connessioni tra
vecchie e nuove querelles – presenteremo una breve esegesi del pensiero ricardiano. I
principali quesiti affrontati saranno: il debito può essere considerato come una
componente della ricchezza finanziaria dell’economia? Un debito elevato pone un
onere a carico delle generazioni future?
L’urgenza dei problemi di politica economica di economie come quella italiana
gravate dal peso di un debito molto elevato ci porterà poi ad affrontare questioni
relative ai limiti di sostenibilità di un debito pubblico crescente. Fino a che limite può
aumentare il debito pubblico? In quali circostanze è più probabile che si scateni una
crisi di fiducia nei confronti dello stato debitore e inizi una crisi finanziaria?
Non ci si devono attendere dall’economia risposte molto circostanziate e
definite a tali quesiti: si possono tuttavia offrire indicazioni sui principali fattori
causali in gioco. Partendo da un famoso contributo di Domar del 1944 gli economisti
hanno svolto molte riflessioni sulle condizioni che determinano l’esplosione del
rapporto debito/PIL e di esse, seppure in via introduttiva, si darà conto nella seconda
parte di questo capitolo.
3. Il debito pubblico nella teoria macroeconomica keynesiana (leggere, questo
par. 3 non sasà oggetto di esame).
Il debito pubblico, dal punto di vista di coloro che lo hanno sottoscritto, è
una forma di impiego finanziario della ricchezza, che esercita i propri effetti sulle
variabili macroeconomiche attraverso gli stessi canali delle altre componenti della
ricchezza, che indicheremo con W. Gli effetti di ricchezza sono di solito esplicitati sia
nelle funzioni che descrivono i flussi della domanda aggregata (in particolare i
consumi), sia nella domanda di attività finanziarie (moneta e titoli, nella consueta
stilizzazione fornita dal modello IS-LM). Un aumento di W determina un effetto
positivo sia sui consumi sia sulla domanda di attività finanziarie (in quest’ultimo caso
la derivata parziale è compresa tra 0 e l’unità). Secondo questo modo di ragionare un
aumento della spesa pubblica finanziato con titoli, e quindi dallo stock del debito
pubblico, determinerebbe un aumento di W e quindi un ulteriore spostamento della IS
verso destra e uno spostamento della LM verso l’alto. Un aumento di spesa finanziato
con moneta determina un identico effetto sulla IS e uno spostamento verso destra
della LM inferiore a quello che si sarebbe verificato in assenza di effetti di ricchezza.
A questi tradizionali risultati dell’analisi macroeconomica keynesiana si è opposto,
nel 1974, R. Barro, un noto esponente della scuola della Nuova macroeconomia
classica. In un famoso saggio dal titolo Are Government Bonds Net Wealth?,
utilizzando un modello a generazioni sovrapposte, sostiene che il debito pubblico non
deve essere incluso nella ricchezza finanziaria del settore privato dell’economia. Un
punto rilevante della sua argomentazione è che i soggetti dell’economia terranno
conto, nel valutare la propria ricchezza, dell’onere che in futuro graverà su di essi a
causa delle imposte che lo stato dovrà introdurre per trovare copertura finanziaria agli
interessi da versare ai sottoscrittori dei titoli e per restituire, alla scadenza del debito,
il capitale preso a prestito. Se gli operatori hanno un comportamento razionale e
previsione perfetta, al valore positivo dei titoli posseduti dai detentori dei titoli
pubblici si contrappone un debito fiscale di eguale ammontare dei contribuenti che
dovranno pagare le imposte future. La conclusione di questo ragionamento è che il
debito pubblico non andrebbe computato nella valutazione della ricchezza nazionale.
Qualora invece gli operatori non abbiano una previsione perfetta e non anticipino
integralmente gli oneri futuri connessi al debito, i titoli sottoscritti potranno, in tutto
o in parte, contribuire alla definizione della ricchezza, W. Solo nel caso di totale
mancanza di previsione degli oneri futuri, secondo questo modo di ragionare, i titoli
potrebbero rientrare pienamente nella definizione di W. Al lettore che abbia già
affrontato lo studio della macroeconomia non sfuggirà come questa conclusione
faccia parte della critica rivolta dalla Nuova macroeconomia classica alla funzione
del consumo keynesiana.
Lo stesso problema era stato intravisto, anche se in un contesto analitico meno
sofisticato, un decennio prima, da un grande sistematore
della sintesi
macroeconomica neoclassica, Don Patinkin, che, nella riedizione della sua opera
Money, Interest and Prices, aveva esaminato come caso particolare del real balance
effect, vale a dire l’effetto legato alla variazione del valore reale delle scorte
monetarie, l’effetto del debito pubblico, assumendo come caso più plausibile quello
di sconto solo parziale delle imposte future. Ma ben prima della considerazione del
ruolo del debito nei modelli macroeconomici, il problema del debito pubblico era
stato affrontato, agli albori della scienza economica, da David Ricardo, che aveva
già formulato le tesi di Barro, la cui analisi a ragione viene infatti indicata come
neoricardiana. Anche se il tipo di problema che Ricardo si poneva non coincideva
esattamente con quello di Barro, le argomentazioni utilizzate dal grande economista
inglese non erano meno rilevanti delle sofisticate analisi moderne. Per questo
ritieniamo utile prendere le mosse dal celebre teorema di Ricardo.
4. L’analisi del debito pubblico di Ricardo
Per Ricardo, e per i classici in genere, il problema del debito pubblico è
considerato nell’ambito della finanza straordinaria, in quella parte della Scienza delle
finanze che si occupa di momenti particolari della vita finanziaria di un paese, ad
esempio la guerra, in cui i governi devono affrontare grandi e impellenti spese di
carattere eccezionale. L’alternativa a cui i governi si trovano dinanzi in questi casi è
se finanziare tali spese straordinarie una tantum con un’imposta straordinaria sul
patrimonio (si presuppone infatti che le fonti ordinarie di gettito siano già state
utilizzate al massimo grado) o con l’emissione di un prestito.
Le due misure finanziarie alternative sono equivalenti o no? Un debito
contratto dallo stato ha lo stesso significato di un debito contratto da un privato?
Ricorrere al prestito pubblico non è un modo per rimandare al futuro l’onere della
spesa straordinaria, gravando quindi sulle generazioni future? Nel caso in cui si
ricorra all’emissione di un prestito è indifferente che esso venga sottoscritto dai
cittadini dello stato che si indebita o da stranieri? Queste erano le domande che
Ricardo e i suoi contemporanei si ponevano, le cui risposte passeremo rapidamente
in rassegna.
L’analisi di Ricardo porta a conclusioni molto chiare: prestito e imposta sono
strumenti equivalenti; l’analogia tra debito pubblico e debito privato non è corretta;
l’onere del debito pubblico non può essere trasferito sulle generazioni future. Egli
tuttavia correda la sua analisi di molte precisazioni e osservazioni, apparentemente
secondarie, a cui spesso gli studiosi successivi si sono più o meno consapevolmente
appellati per motivare conclusioni opposte a quelle del «teorema dell’equivalenza
ricardiana». Il punto di vista di Ricardo merita quindi di essere esaminato con un
certo dettaglio perché in esso possiamo ritrovare gran parte degli sviluppi successivi
di un dibattito quanto mai acceso e sempre vivo tra gli economisti.
Tab.4.1
L’esposizione delle tesi ricardiane è complicata dal fatto che il problema è
stato affrontato in due diverse circostanze: nel capitolo XVII dei Principles (1817) e
nell’opera Funding System (1820). Le sue argomentazioni, pur portando ad una
medesima conclusione, seguono poi due vie analitiche diverse, che con qualche
forzatura interpretativa potremmo indicare come spiegazione «macroeconomica» e
spiegazione «microeconomica».
La tesi macro è la prima avanzata nei Principles e riprende osservazioni già
presenti nel pensiero di altri autori (ad esempio, Melon, che scriveva sui debiti
pubblici nel 1734 nell’opera Essai politique sur le commerce). I prestiti pubblici
implicano il pagamento di interessi ai sottoscrittori dei titoli (il «servizio del
prestito»): lo stato per pagare tali interessi dovrà necessariamente ricorrere a
maggiori imposte. L’operazione del prestito pubblico può quindi essere così
configurata: al momento dell’emissione si ha un trasferimento di potere di acquisto
dai sottoscrittori dei titoli, che supponiamo siano delle rendite perpetue, allo stato.
Successivamente lo stato pagherà interessi ai sottoscrittori prelevando imposte dai
contribuenti. Nei periodi successivi il prestito si risolve quindi in un trasferimento di
risorse dai contribuenti ai sottoscrittori o, per usare la felice espressione di Melon, in
un trasferimento «dalla mano destra alla mano sinistra». L’onere del debito, inteso
come trasferimento reale di risorse, è avvenuto una volta per tutte al momento della
sottoscrizione, esattamente come sarebbe accaduto se lo stato avesse fatto ricorso
allo strumento dell’imposizione straordinaria. Secondo un’efficace espressione usata
da un economista che condivideva la tesi di Ricardo, il prestito non può trasferire al
futuro alcun onere, perché «non si possono combattere con i cavalli di domani le
guerre di oggi». Come mostra la tabella 10.1, l’imposta comporta la sottrazione di
2.000 al tempo t; anche il prestito richiede la rinuncia alla disponibilità di potere di
acquisto nella stessa misura. Nei periodi successivi non si avrà alcun effetto nel caso
dell’imposta, mentre nel caso del prestito si avrà una mera redistribuzione di 100
unità dai contribuenti ai sottoscrittori del prestito.
Sempre nei Principles, poche righe dopo avere enunciato la tesi principale,
Ricardo enuncia tuttavia una prima qualificazione alle sue conclusioni: «Il prestito è
un sistema che tende a renderci meno parsimoniosi e a non farci vedere la nostra
vera situazione». Più avanti ancora Ricardo afferma: «è interesse di ogni
contribuente togliersi questo peso dalle spalle e trasferirne il pagamento su qualche
altra persona, sicché la tentazione di trasferirsi in un altro paese in cui il capitale sia
esentato da tali oneri diventa irresistibile». Si annunciano qui aspetti relativi ai
rapporti con altri paesi che hanno avuto importanti sviluppi.
Ancora poche righe più avanti Ricardo rafforza le sue conclusioni utilizzando
un’altra linea di argomentazione, quella che sopra abbiamo
chiamato
«microeconomica». In questo caso l’economista inglese si immagina un contribuente
tipico, un proprietario terriero, rappresentativo dell’intera comunità nazionale, a cui
lo stato avanzi la richiesta o di un’imposta una tantum di 2 mila sterline o di
sottoscrivere un prestito dello stesso ammontare che porta l’interesse del 5%.
Afferma Ricardo: «Un individuo che possiede 10.000 sterline che gli danno un
reddito di 500 su cui deve pagare 100 sterline l’anno quale [imposta per pagare gli]
interessi del debito, in effetti possiede solo 8.000 sterline e sarebbe altrettanto ricco
sia se continuasse a pagare 100 sterline l’anno, sia se sacrificasse subito, una volta
tanto, 2.000 sterline».
Si noti che in tale argomento microeconomico Ricardo utilizza il concetto di
ammortamento dell’imposta che abbiamo illustrato nel Capitolo terzo par.7.1. Il
patrimonio di 10 mila sterline la cui rendita è gravata di un onere perpetuo di 100
sterline vedrà diminuire il proprio valore di mercato di 2 mila sterline, se il tasso di
sconto di mercato è il 5%. Ma che accade nel caso in cui, come è sostenuto nella
teoria finanziaria, l’ammortamento non si verifichi o si verifichi solo in parte? Anche
questo punto è stato ripreso da studiosi successivi. Anche se questa è la conclusione
a cui porta un modo corretto di ragionare, Ricardo è tuttavia convinto che gli uomini
non la penseranno così. Nel Funding System afferma: Sarebbe difficile persuadere
un tale che possiede 20.000 sterline che un pagamento perpetuo di 50 sterline
all’anno comporta lo stesso onere di un pagamento una tantum di 1.000 sterline. Egli
avrebbe la vaga idea che le 50 sterline all’anno saranno pagate dai posteri e non da
lui; ma se lascia la sua fortuna in eredità a suo figlio e la lascia gravata di un’imposta
perpetua, che differenza fa lasciare 20.000 sterline gravate di imposta o 19.000
sterline senza di essa?
In questo importante passo, Ricardo sembra distinguere tra comportamenti
perfettamente razionali (da cui discenderebbe l’equivalenza tra prestito e imposta) e
il comportamento dell’uomo comune, affetto da una qualche forma di illusione.
Questa consapevolezza dei risultati che si possono derivare da un’analisi condotta
ipotizzando comportamenti perfettamente razionali e informazione perfetta o da
un’analisi che realisticamente tenga conto degli effettivi comportamenti sociali, che
agli schemi astrattamente razionali non si adeguano, dà un carattere di maturità
all’analisi di Ricardo che sembra perduta nei moderni contributi dei sostenitori
dell’ultrarazionalità ricardiana.
Ma l’argomento è portato ancora più avanti. Ricardo in modo ellittico, come è
suo stile letterario, immagina una possibile obiezione: nel caso del prestito, non
sarebbe irrazionale pensare di non dovere pagare le imposte future, dato che
l’orizzonte temporale degli uomini è necessariamente finito. A ciò Ricardo replica
che se l’individuo ha interesse a lasciare ai propri eredi la sua fortuna, l’argomento
della limitatezza dell’orizzonte diviene irrilevante. Se sconta, nelle sue valutazioni,
il benessere dei suoi eredi, si ripropone la conclusione dell’equivalenza. Queste
poche righe includono tutto quanto è stato successivamente teorizzato ricorrendo ai
modelli di generazioni sovrapposte. In particolare, l’idea che l’individuo abbia
interesse ad effettuare lasciti costituisce il cuore dell’argomentazione di Barro del
1974.
Conviene ora sottolineare un importante aspetto del modo di argomentare
«microeconomico» rispetto a quello «macro». Nei due contesti si può forse osservare
che il concetto di onere utilizzato è mutato. Nel contesto macro si trattava di
trasferimento del comando su risorse reali; nel contesto micro invece affiorano anche
altre preoccupazioni: lo sconto delle imposte future, la lunghezza dell’orizzonte
dell’individuo, l’interesse per gli eredi. Tutto ciò spinge chi abbia presenti gli
strumenti dell’economia neoclassica contemporanea ad immaginare il processo di
scelta di un individuo in un contesto di massimizzazione di una funzione di utilità
intertemporale. In questo secondo caso è chiaro che il concetto di onere tenda ad
assumere connotati soggettivi (sacrificio di utilità) e non più oggettivi (perdita di
risorse) come nell’ambito dell’argomentazione macro. Griziotti, Borgatta, Buchanan,
Ferguson e ancora Barro e tutta la letteratura che è seguita all’articolo di Barro si
pongono in questa prospettiva. Qui preme tuttavia sottolineare che la grande varietà
di conclusioni raggiunte da chi ha affrontato questo problema dipende, assai di
frequente, da modificazioni spesso inconsapevoli dei concetti utilizzati di onere,
generazione, carattere perfetto o imperfetto dei mercati, presenza o assenza di motivi
altruistici, di incertezza, ecc. L’analisi micro ora ricordata ci aiuta a capire che il
confronto tra prestito e imposta può in realtà essere visto come il confronto tra due
tipi di imposte: un’imposta straordinaria una tantum e un’imposta ordinaria perpetua
(per il servizio del prestito) il cui valore attuale è identico alla prima.
Seguiamo ancora l’esposizione del Funding System. Poche righe più avanti
Ricardo ritorna su un problema di tipo macroeconomico: gli effetti del prestito e
dell’imposta sull’accumulazione.
Se ad un individuo si chiede di pagare 1.000 di imposta, è probabile che si dia da fare per
risparmiare un’eguale somma del proprio reddito; forse non si comporterebbe nello stesso modo
[...] se lo stato fosse ricorso al prestito per il quale l’individuo sarebbe chiamato a pagare solo 50 di
imposte sul reddito. Le imposte di guerra sono quindi più convenienti (economical), perché una
volta pagate stimolano il risparmio e non lasciano quindi impoverire il capitale della nazione.
Questa considerazione, ripresa negli anni ’40 da Borgatta, costituirà il cuore
dell’analisi di Modigliani del 1963, successivamente generalizzata da Diamond nel
1965. Si noti però che questa preferenza per l’imposta è giustificata sulla base di un
concetto di onere ancora diverso. Il prestito è più oneroso perché rallenta
l’accumulazione. La breve esposizione dei principali spunti contenuti nell’analisi di
Ricardo, di straordinaria sintesi e complessità insieme, può essere riassunta in questo
modo. La tesi principale è il teorema dell’equivalenza tra prestito e imposta e,
conseguentemente, che l’onere del debito pubblico sia in ogni caso sostenuto dalla
generazione presente.
Nell’analisi di Ricardo vengono però utilizzati tre concetti di onere, come:
– trasferimento reale di potere di acquisto (analisi macro);
– sacrificio del contribuente di natura soggettiva (analisi micro);
– rallentamento del ritmo di accumulazione.
Nel corso dell’esposizione abbiamo sottolineato alcune qualificazioni che
saranno riprese dalla letteratura successiva:
– il tema dell’illusione finanziaria;
– il ruolo dell’ipotesi di ammortamento delle imposte future;
– il ruolo dei lasciti intergenerazionali;
– una particolare teoria del risparmio fondata sull’idea che un’imposta una
tantum elevata induca un aumento del risparmio più ampio di una
successione di imposte ordinarie.
Ricardo non affronta esplicitamente l’ultima delle domande che abbiamo
formulato all’inizio di questo paragrafo: il confronto tra un prestito emesso
all’interno o sottoscritto da stranieri. Su questo problema le opinioni sono spesso
state discordi. Anche in tempi recenti, alcuni studiosi hanno sostenuto che un prestito
estero, a differenza di quello interno, consente di trasferire l’onere sulle generazioni
future. Partendo dall’analisi «macroeconomica» ricardiana, con il prestito estero le
imposte per il servizio del debito sono usate per pagare interessi che usciranno dal
paese: non vi sarà quindi il «passaggio dalla mano destra alla mano sinistra». Le
generazioni future, chiamate a pagare tali imposte, subiranno un vero sacrificio.
Questa argomentazione contiene però un vizio logico. È vero che per le generazioni
future non vi sarà la compensazione tra interessi e imposte ordinarie presente con il
prestito interno, ma si deve riflettere nei due casi sulla genesi del debito. Se infatti in
t0 si è utilizzato lo strumento del debito estero, l’economia nel suo complesso (lo
stato e i suoi cittadini) ha potuto usufruire di un accrescimento delle proprie risorse,
che non si verifica con il prestito interno. Nel caso del prestito estero le generazioni
successive, ceteris paribus, avranno ereditato da quelle precedenti una ricchezza
maggiore. Su questo aspetto la parola definitiva era già stata detta da M. Pantaleoni
in un saggio del 1891, che non ha avuto sufficiente diffusione a livello
internazionale. Egli mise in luce che ciò che rileva è l’ammontare dei trasferimenti di
ricchezza che nell’uno o nell’altro caso si verificano tra generazioni successive. Le
generazioni future avrebbero ragione a lamentarsi dei propri avi, solo se questi
lasciassero loro in eredità un capitale insufficiente a fruttare gli interessi sul debito
da versare ai sottoscrittori stranieri. Dal punto di vista teorico quindi con il debito
estero si possono trasferire oneri alle generazioni successive, ma, in considerazione
del ruolo significativo dei lasciti ereditari nella società in cui viviamo, si può
concludere che tale caso ha scarsa rilevanza pratica.
5. I limiti del debito pubblico
La tesi dell’equivalenza ricardiana potrebbe indurci a sdrammatizzare il
problema del debito pubblico: l’onere reale del debito è gia stato sopportato al
momento dell’emissione; oggi si tratta solo di gestire «il passaggio dalla mano destra
alla mano sinistra», vale a dire la redistribuzione tra sottoscrittori e contribuenti. Se
poi, come osservava De Viti de Marco, il debito risultasse abbastanza equamente
distribuito tra tutti i cittadini, non dovrebbe spaventare neppure una politica di
consolidamento del debito. Lo stato potrebbe annunciare: da domani il debito è
ripudiato e per un ammontare corrispondente è ridotta la pressione fiscale. Questi
ragionamenti, come ci insegna Ricardo, sono però veri solo in teoria e sotto ben
precise ipotesi.
Nella realtà non vi è perfetta corrispondenza tra titolari del debito pubblico e
contribuenti. Una proposta di consolidamento (o «ammortamento democratico»
come la chiamava De Viti) non sarebbe neutrale per ciascun soggetto. Gli uomini
sono affetti da illusione finanziaria: se lo stato proponesse di bruciare le cartelle dei
BTP in cambio di un equivalente sgravio fiscale, molti sarebbero indotti a pensare, a
torto o a ragione, di essere stati in qualche modo raggirati dallo stato. In tema di
debito pubblico la fiducia e la reputazione del debitore hanno un’importanza decisiva
e questa considerazione è un buon punto di partenza per affrontare l’ultimo problema
di questo capitolo: i limiti del debito pubblico.
Quando il debito è molto elevato e i sottoscrittori hanno la sensazione che la
sua dinamica possa sfuggire dal controllo del governo, si possono determinare
improvvise crisi di sfiducia che inceppano la complessa gestione del debito,
caratterizzata da continue operazioni di rimborso, di rinnovo e di nuove emissioni. Il
problema diventa ancora più delicato in un contesto di liberalizzazione valutaria in
cui operatori stranieri possono liberamente partecipare al mercato dei titoli, entrando
e uscendo con estrema rapidità. Non è il valore assoluto del debito la grandezza che
può generare sfiducia. In un’economia che cresce e si sviluppa è del tutto naturale
che aumenti il volume delle attività e passività finanziarie, fra le quali è compreso
anche il debito dello stato. L’attenzione degli operatori spesso si concentra sul
rapporto debito/PIL.
Anche con riferimento a questo indicatore, dobbiamo tuttavia dire chiaramente
che non esiste alcuna teoria economica in grado di affermare che il debito pubblico
debba essere in un preciso rapporto con qualche indicatore di attività economica, ad
esempio il livello del reddito nazionale. Non abbiamo conoscenze abbastanza sicure
per prevedere se e quando il raggiungimento di un dato rapporto tra debito pubblico
e PIL dia inizio ad una crisi finanziaria. L’evidenza storica è, sotto questo profilo,
molto variegata. Il rapporto debito/PIL ha assunto, in diversi paesi e in diversi
periodi storici, valori che hanno superato anche tre volte il prodotto nazionale senza
creare crisi finanziarie. In altre circostanze, crisi di fiducia si sono viceversa
manifestate anche con rapporti debito/ PIL largamente inferiori all’unità. È però un
dato di fatto che ben difficilmente saremmo disposti a consegnare i nostri risparmi al
governo di uno stato in cui il rapporto debito/PIL tenda continuamente ad aumentare.
In questa situazione di estrema incertezza teorica, è tuttavia utile cercare di
definire in modo chiaro le principali variabili e le relazioni tra le stesse da cui
dipende la crescita del debito pubblico. Una delle analisi più importanti in questa
direzione è quella, ormai non più recente, di E. Domar, del 1944, alla fine quindi di
un periodo bellico, in cui, come spesso accade, si formano volumi di debito pubblico
molto elevati. Domar costruisce un modello di crescita di un’economia molto
semplificato di cui prende in considerazione solo alcune variabili: il reddito, il livello
del tasso di interesse, lo stock del debito pubblico, il disavanzo pubblico. Fa alcune
ipotesi sulla crescita del prodotto nazionale e sul livello del tasso di interesse e
calcola gli effetti di lungo periodo di politiche fiscali alternative su una variabile che
egli chiama «onere del debito pubblico»: il rapporto tra spesa per interessi per il
servizio del debito e reddito nazionale. La ragione di tale denominazione è intuitiva:
quel rapporto rappresenta quanti punti della pressione tributaria devono essere
destinati al servizio del debito.
L’analisi di Domar è molto parziale, in quanto assume come dati e costanti la
dinamica del reddito, il livello dei tassi di interesse e il livello dei prezzi (assenza di
inflazione). Essa si limita in sostanza a simulare le conseguenze di talune politiche
fiscali sulla dinamica dello stock del debito pubblico in presenza di diversi quadri
macroeconomici di lungo periodo. Anche con questi evidenti limiti, il contributo di
Domar è tuttavia illuminante per inquadrare le relazioni che intercorrono tra le
principali variabili che possono influenzare la crescita del debito pubblico nel tempo.
Per una puntuale comprensione dei risultati, è indispensabile una trattazione
formale, che condurremo nell’ambito di uno schema in cui il tempo è suddiviso in
periodi discreti, della durata, ad esempio, di un anno. Definiamo anzitutto le variabili
che verranno utilizzate nell’analisi che segue.
Yt
INTt
pubblico;
Bt
ht
prodotto interno lordo del periodo t;
interessi corrisposti alla fine del periodo t ai possessori del debito
stock del debito pubblico accumulato alla fine del periodo t;
onere del debito pubblico, ovvero il rapporto tra spesa per
interessi sul
debito, INTt, e prodotto interno nel periodo t;
Dt
disavanzo di bilancio creatosi nel periodo t;
i
tasso di interesse;
Tt , Gt entrate e uscite pubbliche nel periodo t.
Con riferimento a tali variabili, introduciamo le seguenti ipotesi:
a) crescita costante del prodotto interno lordo al tasso annuo n. In simboli:
Yt = Yt – 1 (1 + n) ovvero Yt /Yt – 1 = 1 + n
b) costanza nel tempo del tasso di interesse, i;
c) pagamento posticipato degli interessi sui titoli del debito pubblico:
INTt = i Bt – 1
d) per quanto riguarda la politica fiscale, studieremo due casi:
d1) il primo caso, che svolgeremo nel prossimo paragrafo, secondo
l’originaria analisi di Domar, considera un governo che realizzi ogni anno
un disavanzo complessivo pari ad una percentuale costante del PIL;
d2) il secondo caso, che costituisce un’estensione dell’analisi di Domar,
considera un governo che intenda mantenere costante rispetto al PIL il
disavanzo primario (vale a dire la differenza tra spesa al netto degli
interessi ed entrate).
L’equazione fondamentale da cui prendere le mosse e che attribuisce
carattere dinamico all’analisi è quella che descrive la dinamica del debito
pubblico:
[1]
Bt = Bt – 1 + Dt
Lo stock del debito pubblico alla fine del periodo t è pari allo stock del
debito all’inizio del periodo più il disavanzo (un flusso) che si è formato nel
corso del periodo. Ciò è mostrato con ancora maggiore evidenza nello schema
che segue.
Una prima breve digressione a commento di questa equazione potrà
essere utile a qualcuno dei lettori. L’equazione [1] è dinamica, perché le
variabili che in essa compaiono fanno riferimento a periodi di tempo diversi
(Bt e Dt al periodo t, Bt – 1 al periodo precedente). Tale equazione, in relazione
al modo discreto in cui è considerato il tempo in questo modello, costituisce
un esempio di equazione alle differenze finite del primo ordine, che si possono
considerare «cugine» delle equazioni differenziali. Alle differenze, perché essa
può essere espressa mettendo in luce le variazioni nel tempo di una o più delle
variabili che la compongono. Nel nostro caso, se sottraiamo da entrambi i lati
della [1] il valore di Bt – 1, essa può essere riformulata nel seguente modo: ∆Bt
= Dt, ove ∆ indica la variazione (differenza finita) tra Bt e Bt – 1. Del primo
ordine, perché l’intervallo temporale massimo che compare tra le variabili è di
un periodo, tra t e t – 1. Studiare un’equazione di tipo dinamico significa
domandarsi che cammino temporale seguono le variabili in essa contenute (nel
nostro caso, Bt e Dt); se col trascorrere del tempo queste tendono a valori
costanti (soluzioni stazionarie), se tendono a valori infinitamente grandi o
infinitamente piccoli, o, ancora, come può accadere, se mostrano oscillazioni
cicliche nel tempo. Risolvere l’equazione significa trovare per ciascuna delle
variabili un’espressione, direttamente funzione del tempo, che consenta di
identificare il valore di ciascuna variabile ad un qualunque tempo t (ad
esempio Bt = f(t)). Senza bisogno di conoscere le tecniche matematiche
necessarie per trovare le soluzioni di questo tipo di equazioni, è sufficiente
osservare che il sentiero temporale delle stesse può essere ricostruito se
disponiamo dei loro valori iniziali (nel nostro caso B0 e D1). Per sostituzioni
successive possiamo infatti calcolare B1 = B0 + D1 e poi B2 = B1 + D2, ecc.) e
ragionare su questa successione di valori.
L’attenzione di Domar si concentra, come detto, sulla dinamica
rapporto tra spesa per interessi e prodotto interno che possiamo scrivere:
del
anche questa un’equazione alle differenze finite, per la quale valgono le
stesse considerazioni fatte sopra.
5.1. Disavanzo complessivo costante Esaminiamo ora gli effetti del primo
tipo di politica fiscale, sviluppato nell’originario contributo di Domar (caso
d1). In questo caso ogni anno la politica fiscale è tale da creare un disavanzo
di bilancio pari ad a volte il prodotto interno lordo, vale a dire costante in
rapporto al PIL.
Dt = Gt + iBt – 1 – Tt = aYt
La relazione tra stock del debito e disavanzo potrà essere così scritta:
Bt = Bt – 1 + Dt = Bt – 1 + aYt
È ovvio che in tale ipotesi il livello assoluto del debito pubblico è
destinato a diventare infinito: ogni anno infatti si produce un disavanzo che va
ad aumentare il debito. Come si è già detto, ciò non è in sé preoccupante, se
allo stesso tempo anche le altre grandezze dell’economia e in particolare il
livello del prodotto interno lordo tendono a crescere. Nel nostro caso abbiamo
infatti supposto che il reddito cresca ogni anno al tasso costante n. I problemi
sorgono se il debito tende a crescere in misura più veloce del reddito. In tal
caso il rapporto tra debito e prodotto tende all’infinito e questo è sicuramente
preoccupante, perché è implausibile pensare che possa permanere in una
situazione di stabilità finanziaria un’economia in cui il rapporto tra uno stock
finanziario e il flusso della nuova ricchezza prodotta assume valori sempre più
grandi. Per queste ragioni la nostra analisi non si concentrerà sullo studio della
dinamica nel tempo del livello del debito, bensì del suo rapporto rispetto al
PIL.
Se dividiamo entrambi i membri della precedente equazione per Yt e
indichiamo con bt il rapporto tra debito pubblico e PIL, l’espressione può
essere trasformata nel modo che segue:
e infine:
Anche questa espressione, che descrive la dinamica nel tempo del
rapporto debito/PIL, è un’equazione alla differenze finite del primo ordine.
Ancora una breve digressione su aspetti formali. In generale un’equazione alle
differenze finite del primo ordine come quella appena descritta, in cui il
parametro a sia costante e positivo, tende nel lungo periodo ad un valore
positivo e costante di bt (possiede cioè una soluzione stazionaria, in cui cioè da
un certo periodo in poi il valore di bt si mantiene sempre allo stesso livello) se
il valore del coefficiente che moltiplica bt – 1 è inferiore, in valore assoluto,
all’unità. La ragione è abbastanza intuitiva. Se tale coefficiente (1/(1 + n) nel
nostro caso) fosse maggiore dell’unità, il valore di bt tenderebbe sicuramente
ad esplodere: ogni anno aumenterebbe non solo di a, ma anche per l’effetto di
ampliamento di bt indotto dal coefficiente stesso. Se invece il coefficiente è
minore di uno, si avrà un esito diverso. Per afferrare il punto, ragioniamo
innanzitutto nel caso in cui a sia uguale a zero. In tal caso il valore di bt sarà in
generale sempre inferiore a bt – 1 e così via periodo dopo periodo. Con il passar
del tempo tenderà ad un particolare valore costante, zero. Se invece a è
positivo col passare del tempo tenderà ad un diverso valore, positivo ma
sempre costante. Quando il valore di bt – bt – 1/(1 + n), con il crescere di bt,
avrà raggiunto il valore pari ad a, da quel momento in poi bt resta costante. Per
individuare quale sia questo valore, basta osservare che in tale situazione
stazionaria dovrà essere bt = bt – 1, che possiamo porre pari al valore b. Se
nell’equazione sostituiamo b a bt e bt – 1, e risolviamo per b troviamo il valore
cercato.
Tale equazione ha una soluzione stazionaria (che possiamo chiamare
anche di steady state, o di crescita costante, se ci riferiamo al tasso di crescita
dei livelli delle nostre variabili Bt e Yt) se il coefficiente di bt – 1, vale a dire 1/(1
+ n), è minore dell’unità. Se il tasso di crescita del prodotto nazionale è
positivo, tale condizione è sempre verificata. La situazione stazionaria in cui
la variabile in questione cessa di variare, e quindi bt – 1 = bt = b, sarà:
L’onere degli interessi per il debito pubblico, rapportato al PIL, sarà:
In steady state, dovrà aversi bt – 1 = b e quindi:
L’esercizio impostato da Domar conduce quindi ad una formula analitica
molto semplice. Né il rapporto debito/PIL, né il rapporto interessi passivi/PIL,
nelle ipotesi fatte, tendono ad esplodere, anche se si ipotizza un bilancio
continuamente in disavanzo. L’onere del debito, nell’accezione assunta da
Domar (ht), sarà direttamente proporzionale a i e ad a e inversamente
proporzionale a n. Una lezione da trarre da questo modello è che la riduzione
dell’onere del debito non dipende solo dal parametro a, ma anche da i e n.
Domar mise in guardia i responsabili di politica economica a non contare
troppo e solo sulla riduzione di a (aumento della tassazione e/o riduzione della
spesa pubblica) in quanto le misure necessarie a tale scopo avrebbero avuto
l’effetto di ridurre il tasso di crescita del prodotto e quindi di frustrare, almeno
parzialmente, gli obiettivi del governo.
5.2. Disavanzo primario costante Il risultato di Domar sembrerebbe
abbastanza incoraggiante: se il reddito aumenta nel tempo, il rapporto bt
tenderà ad un valore finito. Nel dibattito di politica economica corrente il
problema è però più complicato. Potrebbe essere difficile per un governo
realizzare una politica del tipo Dt = Gt + iBt – 1 – Tt = aYt, che presuppone che,
se il peso degli interessi aumenta, il governo debba compensarne la crescita
riducendo il disavanzo primario. Poiché la dinamica della spesa per interessi
dipende in parte dall’elevato stock di debito accumulato nel passato e in parte
dalla politica monetaria (che concorre a determinare il tasso di interesse), cioè
da fattori al di fuori del diretto controllo delle autorità di politica fiscale,
queste sono indotte a concentrare la loro attenzione sulla componente primaria
del disavanzo, che sono in grado di controllare. Dal punto di vista analitico è
allora interessante domandarsi quale sarebbe la dinamica del rapporto debito/
PIL e del rapporto interessi/PIL nell’ipotesi che il governo attui una politica
fiscale in cui è mantenuto costante rispetto al PIL non il disavanzo
complessivo, come nel modello originario di Domar, ma solo il disavanzo
primario. In questa ipotesi (caso d2) la relazione che descrive il disavanzo è:
È ovvio che per a = a′ la regola appena descritta genera una crescita del
debito più ampia, in quanto ad essa, oltre alla componente primaria,
contribuisce anche la dinamica della spesa per gli interessi.
L’equazione fondamentale, che esprime la dinamica dello stock del
debito pubblico, diviene in questo caso:
in cui a′ rappresenta appunto il rapporto tra disavanzo primario e PIL.
In rapporto al PIL si avrà:
Questa equazione alle differenze converge ad una soluzione stazionaria se
(1 + i )/(1 + n) < 1 cioè se n > i. In steady state il rapporto debito/PIL dovrà
rispettare la condizione bt = bt – 1 = b:
Le condizioni poste da questa espressione sono più stringenti di quelle
presenti nel modello originario di Domar: in questo caso un valore finito di b
si può realizzare solo se il tasso di crescita dell’economia è superiore al tasso
di interesse. Il permanere di i > n avrebbe come conseguenza l’esplosione del
rapporto debito/PIL e quindi l’inevitabile verificarsi di una crisi finanziaria. Si
può dare una spiegazione intuitiva di questo risultato. Supponiamo che il
disavanzo primario D2 sia nullo: in questo caso il livello del debito risulta
essere Bt = (1 + i) Bt – 1, vale a dire esso cresce ad un tasso annuo pari al tasso
di interesse. È chiaro che se il reddito non cresce almeno nella stessa misura
del debito (cioè se n non è almeno uguale a i ) il rapporto debito/PIL è
destinato a crescere. A maggior ragione se ammettiamo che D2 sia positivo si
dovrà avere n > i.
L’onere del debito, secondo l’accezione di Domar, sarà:
che in steady state assumerà il valore:
Tra le varie ipotesi che stanno alla base di questo modello, una
meriterebbe di essere abbandonata: la costanza del tasso di interesse. Se il
rapporto debito/PIL tende a crescere nel tempo è poco plausibile che il tasso di
interesse resti immutato: prestare denaro allo stato diverrebbe infatti sempre
più rischioso è ciò dovrebbe indurre questi ad offrire tassi di interesse sempre
più elevati. Il controllo della dinamica del debito è quindi strettamente
collegato con la formazione delle aspettative dei sottoscrittori dei titoli
pubblici. In tali ipotesi se il governo mette in atto politiche di riduzione del
disavanzo primario, si potranno avere rischi di caduta del tasso di crescita del
PIL, ma può anche darsi che gli operatori finanziari attribuiscano maggiore
fiducia al governo e che ciò si traduca in un abbassamento del «premio per il
rischio» del paese considerato e in una riduzione del costo del debito. Sembra
appunto questa la situazione in cui si trova il nostro paese. Politiche fiscali
severe hanno l’effetto di ridurre la domanda e quindi il reddito e rendere più
difficile un abbassamento del rapporto debito/PIL. D’altro canto esse possono
avere alla fine effetti positivi se inducono una maggiore fiducia negli operatori
finanziari, consentendo l’eliminazione di quel «premio per il rischio» che un
investitore pretende quando deve prestare denaro ad un soggetto che è già
molto indebitato. Se tale premio si abbassa, i tassi di interesse potranno
diminuire e con essi la spesa per interessi, il disavanzo complessivo e quindi la
crescita del debito. Molto spesso le opinioni di politica economica si dividono
tra quelle di chi teme maggiormente gli effetti negativi delle politiche
restrittive sulla domanda aggregata e quindi sul reddito e di chi teme
maggiormente gli effetti di un innalzamento del premio per il rischio. Una
risposta univoca è però impossibile, perché si tratta di indovinare quali siano
gli umori dei «mercati finanziari», quale sia il momento in cui un paese stia
per entrare in una fase di instabilità finanziaria. Qualora una situazione di
instabilità finanziaria diventasse realtà, il problema del debito sarebbe
brutalmente spazzato via da un male peggiore: l’iperinflazione, che seguirebbe
necessariamente alla creazione di moneta da parte di uno stato che non riesce
più a collocare sul mercato i titoli del debito pubblico.
5.3. Il saldo primario che stabilizza il rapporto debito/PIL. I due casi
esaminati nel precedenti paragrafi hanno descritto soluzioni di steady state
delle equazioni che descrivono la dinamica del rapporto debito/PIL e della
spesa per interessi rispetto al PIL. Nella vita concreta un sistema economico
non si trova di norma in tale situazione astratta stazionaria: le politiche fiscali
non restano costanti indefinitamente; i governi, quando si rendono conto che
l’economia si trova su un sentiero che comporta una tendenza del rapporto
debito/PIL ad esplodere (i > n), tenderanno a reagire per modificare la politica
relativa alla dimensione del disavanzo primario, anche se nel breve periodo
non sono in grado di influire in modo sostanziale sulla crescita del reddito e
sull’andamento dei tassi di interesse. Alla ricerca di politiche fiscali in grado
di tranquillizzare i sottoscrittori dei titoli pubblici, i responsabili della politica
economica potranno ragionevolmente porsi l’obiettivo, quanto meno, di
arrestare la crescita del rapporto debito/PIL agendo immediatamente sul
disavanzo primario. Ci possiamo allora domandare, nel contesto del nostro
modello, in che modo un policy maker possa determinare la misura del
disavanzo primario in grado di arrestare la crescita del rapporto debito/PIL. In
termini formali, con riferimento all’equazione [2], il problema può essere
posto nel seguente modo: nell’anno t – 1 il rapporto debito/PIL era pari a bt – 1;
che valore deve assumere a’ nell’anno t affinché bt sia pari a bt – 1?
La [2] può essere scritta:
L’incognita del nostro problema ora è a’. Se vogliamo che bt = bt-1,
ovvero che ∆bt=0 è necessario che a’ assuma il valore:
Si osserva quindi che se i > n, cioè il tasso di interesse è più elevato del
tasso di crescita, a’ dovrà essere negativo; si dovrà cioè avere un avanzo del
saldo al netto degli interessi. Il contrario accade se i < n.
Il saldo primario che consente di realizzare l’arresto della crescita del
rapporto debito/PIL, rappresentato dalla [3], è oggi divenuto un importante
indicatore della politica fiscale. A differenza dei tradizionali indicatori di
derivazione keynesiana attenti alle condizioni della domanda nel breve periodo,
questo indicatore è utile per valutare le tendenze di lungo periodo della finanza
pubblica di paesi caratterizzati da elevato debito pubblico e che devono
impostare piani a medio termine di rientro. Confrontando infatti il valore che
si ricava dalla [3] con il disavanzo primario effettivo realizzato in un dato
anno, siamo in grado di valutare se il paese considerato stia o meno attuando
una politica coerente con l’obiettivo di arresto della crescita del rapporto
debito/PIL.