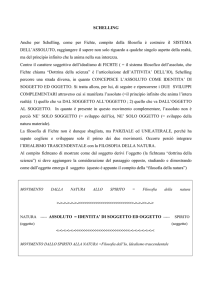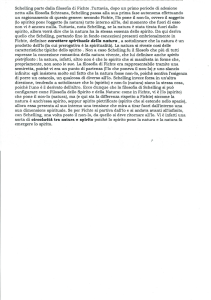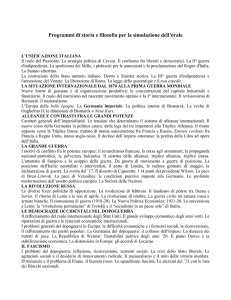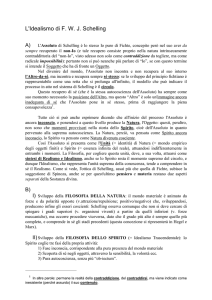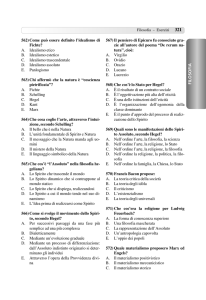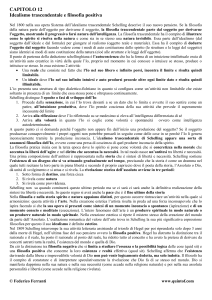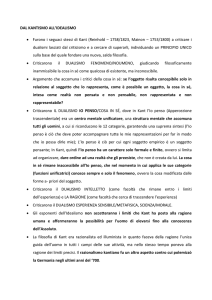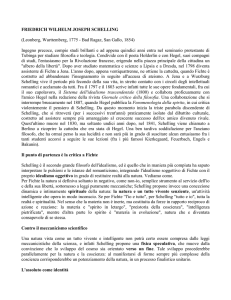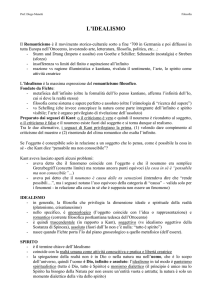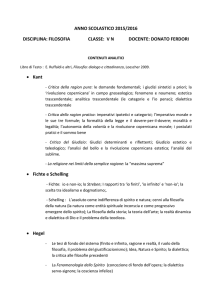FICHTE, SCHELLING E L’IDEALISMO TEDESCO
Gli storici definiscono la filosofia di Fichte idealismo soggettivo e quella di Schelling idealismo
oggettivo, ma questa denominazione oscura il fatto che si tratta di due filosofie molto diverse fra di
loro: la prima ancora illuministica e la seconda pienamente romantica (lo stesso Schelling
reputava Fichte un tardo illuminista e un seguace di Kant). In realtà, con Fichte e poi con
Schelling, fra ‘700 e ‘800, si assiste ad un rapido cambiamento dell’orizzonte filosofico tedesco.
Fichte proseguì sulla via del criticismo illuminista di Kant, ma lo portò a conseguenze che lo
trasformarono in una filosofia antikantiana da lui stesso denominata idealismo (e non più
criticismo). Schelling riprese le critiche di Fichte a Kant e le trasformò in una filosofia pienamente
romantica e anti-illuministica di respiro panteistico che si rifaceva a Giordano Bruno, a Baruch
Spinoza e alle suggestioni di Goethe e di Schiller. Hegel, infine, inquadrò nella sua visione storica
le filosofie di Kant, Fichte e Schelling interpretandole come tappe di un passaggio graduale
attraverso il quale la Germania riuscì a dotarsi di un sistema culturale indipendente ed alternativo
a quello delle altre Nazioni dell’Europa Occidentale che erano, invece, campo di applicazione
dell’illuminismo borghese.
Johann Gottlieb Fichte
(Rammenau, 19 maggio 1762 – Berlino, 27 gennaio 1814)
Dopo Kant e la diffusione dell’Illuminismo nella cornice culturale della Prussia di Federico II, con
Fichte ci troviamo di fronte ad un periodo in cui gli intellettuali, gli uomini di cultura della borghesia
europea, guardano alla Rivoluzione francese – e poi all’ascesa di Napoleone Bonaparte - come ad
un evento epocale che recava la possibilità di un cambiamento sociale e di una forte liberazione
dell’uomo.
Gli obiettivi di Fichte sono tre: 1) ribadire la superiorità della filosofia rispetto ad ogni altra forma di
sapere: 2) stabilire che l’Io [l’Io-penso di Kant] non è una mera forma logica ma una realtà
effettuale – ma non di ordine materiale e neppure metafisico, bensì giuridico-politico; 3) dimostrare
che tutto ciò che esiste nel mondo umano deriva dall’Io come centro di volontà e di conoscenza.
Kant aveva sostenuto che la filosofia antica e medioevale era stata viziata dal dogmatismo
ontologico e metafisico. Il dogma, credenza non dimostrata, era quello della presupposizione
dell’esistenza di un ordine di leggi, all’interno della natura, che faceva perno sull’Uno o su Dio. Per
Kant invece l’Io [la Ragione, l’Io penso, la Scienza] è il legislatore effettivo della natura. Anche se
non della natura-in sé bensì soltanto della natura fenomenica, che è l’unica accessibile all’uomo
attraverso il complesso processo della sintesi-a-priori di dati della sensibilità, schemi
1
trascendentali e forme logiche dell’intelletto. Il motivo per il quale l’uomo non è il totale legislatore
e signore della natura deriva dal fatto che la natura non deriva dall’uomo, ma gli è precedente,
anche se non è possibile stabilire scientificamente o filosoficamente né l’origine della natura né
quella dell’uomo e della sua Ragione.
Con Fichte abbiamo una definizione di dogmatismo più radicale e che fa ricadere nel dogmatismo
lo stesso Kant. Fichte sostiene che tutta la filosofia è stata dogmatica in quanto ha creduto nel
dogma dell’esistenza di una cosa in sé, di una realtà di per sé stante, indipendente dal soggetto
umano, dal suo pensiero e dalla sua volontà. La nozione kantiana di cosa-in-sé - come quella di
noùmeno – erano forme di un persistente dogmatismo filosofico. In tal modo da Kant ai postkantini fino a Fichte si realizza uno sgretolamento del concetto di “cosa in sé”, che permette a
Fichte di affermare che bisogna partire dall’Io, dal soggetto, eliminando completamente la cosa in
sé.
In Kant vi era una contraddizione. Come può Kant sostenere che la cosa in sé è la causa delle
intuizioni, se la cosa in sé è, per definizione, inconoscibile? Infatti, se la cosa in sé è inconoscibile
allora fa parte del noùmeno - del mondo soltanto pensabile – quindi è evidente che ad essa, come
a Dio e all’anima, non si può applicare la categoria di causalità, che è una delle dodici categorie
trascendentali dell’intelletto. Quindi non si può affermare che la cosa in sé è causa delle
sensazioni, anzi non si può neppure dire che la cosa in sé esiste, perché anche l’esistenza è una
delle dodici categorie, quindi, come non si può applicare a Dio la categoria di esistenza non la si
può applicare neppure alla cosa in sé. Fichte aggiunge qui un elemento metodologico importante:
i dogmatici, fra cui rientra a questo punto anche Kant, sbagliano nel vedere le cose come esterne
le une alle altre, sostenendo che esiste il mondo – fatto di molte e diverse cose - e che, d’altrro
canto, esiste anche l’Io: così si crea fra di essi un rapporto di estraneità. Quindi, si chiede Fichte,
in che modo esiste l’Io così che il mondo derivi in tutto e per tutto dall’Io stesso?
Fichte si chiedere se le scienze naturali costituiscono una alternativa alla filosofia di Kant, ma non
è così. Le scienze naturali sono descrittive ed enumerano le cose che si trovano nel loro campo di
osservazione ponendole come preesistenti ed esterne alla scienza stessa. Quindi solo la filosofia
è una scienza assolutamente a-priori, nel senso di una scienza coerentemente deduttiva e fondata
sul ragionamento puro. La filosofia non procedere per enumerazione e descrizione, ma solo per
deduzione perché considera i suoi oggetti come derivanti da se stessa: bisogna partire da un
primo anello della catena e tutti gli altri debbono seguirne come conseguenze logiche. Quindi la
filosofia è per Fichte l’unica vera scienza (scrive ne La dottrina della scienza: Wissensschaftlehre)
nel senso che le varie scienze naturali sono subordinate a postulati e a princîpi non dimostrati (a
cominciare dall’idea che esiste una natura indipendente da esse) e procedono con catene
deduttive e metodi osservativi non discussi nell’ambito del discorso scientifico stesso, Anche la
matematica parte da postulati, cioè da affermazioni non dimostrate.
Per Fichte ci sono due possibilità di approccio alla conoscenza: una è quella di partire dall’oggetto,
dalla cosa che si vuole conoscere (empirismo), l’altra è quella di partire dal soggetto che vuole
conoscere (razionalismo). Fichte sostiene che questa seconda via è propria della filosofia e che
per comprendere la conoscenza e la volontà bisogna partire dal soggetto, dall’io e dalla
coscienza. Ma bisogna star bene attenti a non cadere di nuovo nel dogmatismo. «Nella
conoscenza vi è una doppia serie, dell’essere e del sapere, del reale e dell’ideale [l’oggetto ed il
soggetto]; ed è appunto nell’indivisibilità di questa doppia serie che consiste l’essenza della
filosofia, la quale è dunque sintetica. Se invece alla cosa non compete che una serie semplice,
quella del reale e cioè dell’esser posto tra conoscenza e cosavi è opposizione, estraneità, esse si
trovano rispettivamente in due mondi, tra i quali non c’è un agevole ponte di passaggio».
L’empirismo ed il razionalismo moderni - e anche Kant - si sono trovati di fronte a un problema
insolubile perché sono partiti da una concezione dualistica: 1) ci sono le cose e c’è l’Io, quindi ci
sono le cose che precedono l’Io, o: 2) c’è l’Io che precede le cose ma che è separato da esse
2
(come in Descartes). Fichte rileva che se si parte dalle cose non si riesce ad arrivare all’Io e
viceversa. Gli empiristi si sono sforzati di attenersi al metodo induttivo, ma sono caduti nello
scetticismo. I razionalisti ci hanno provato con il metodo deduttivo a priori, ma il metodo deduttivo
a priori implica un salto non giustificato. Se l’Io resta separato dal mondo non è possibile
ricongiungerlo ad esso. Per questo essi hanno fatto ricorso ad un passaggio indebito che dal
mondo delle costruzioni intellettuali ci porta al mondo reale con la mediazione di Dio, che è la
comune origine di entrambi i mondi – come avviene con Descartes. Kant stesso è caduto nel
dualismo tra fenomeno e cosa in sé, tra la realtà strutturata dal soggetto e la realtà oggettiva che
esisterebbe in se stessa. Ha parlato di sintesi-a-priori tra soggetto e fenomeni, ma ha lasciato
sussistere le cose in se stesse. Conclude Fichte: «Si tratta di dimostrare la possibilità del
passaggio dall’essere al rappresentare, questo è quanto i dogmatici, sia empiristi che razionalisti,
non fanno né riescono a fare».
Fichte ricerca quindi un principio unico, che dovrà essere sia il principio della coscienza, del
soggetto e dell’io, che un principio dell’essere. Lo troverà nell’Io assoluto che è più potente dell’Iopenso di Kant poiché un soggetto ideale (vale a dire in certo modo reale) e non solo formale.
Leggiamo ancora dall’opera principale di Fichte: «Quell’essere, la cui essenza consiste puramente
in questo, che esso pone se stesso come esistente, è l’io come assoluto soggetto. In quanto esso
si pone è, ed in quanto è, si pone, e l’Io perciò è assolutamente e necessariamente per l’Io. Ciò
che non esiste per se stesso non è io. Si domanderà certo: che cosa ero io dunque prima che
giungessi all’autocoscienza? La risposta naturale a questa domanda è: io non ero affatto, perché
io non ero io. Non si può pensare assolutamente a nulla, senza pensare in pari tempo il proprio io,
come cosciente di se stesso; non si può mai astrarre dalla propria autocoscienza».
Fichte rivaluta così una dialettica interna all’Io – esclusa per Kant dalla scienza – che descrive l’Io
nel suo sviluppo interno attraverso l’Io stesso. Parmenide e Aristotele avevano fondato la filosofia
sul principio di identità (A è A): Fichte collega questo principio di identità a quello di noncontraddizione (A non è nonA) e li integra nel successivo principio dialettico secondo il quale: se
nonA è eguale ad A, A sarà sia A che nonA. Questa integrazione di A e nonA la può realizzare
soltanto l’Io poiché l’Io è sia A che nonA.
La prima formula della dottrina dialettica della scienza di Fichte è: “L’io pone se stesso”, l’io nel
porre se stesso pone sé stesso sia come soggetto che come una cosa, un oggetto, e quindi, sin
dall’inizio è sia il sapere che l’essere, il soggetto e l’oggetto. L’io come principio assoluto permette
di ricavare il non-io dal proprio interno, perché l’Io che pone se stesso è sia l’Io come soggetto che
l’Io come oggetto del primo Io: il nonIo quindi è il confine interno dell’Io, una sua parte. Continua
Fichte: «Non vi è nulla di posto originariamente, tranne l’Io; e questo soltanto è posto
assolutamente. Perciò un’opposizione assoluta non può aversi se non ponendo qualcosa di
opposto all’io. Ma ciò che è opposto all’io è il non-io. All’io è opposto assolutamente un non-io».
Come dice Fichte nella seconda proposizione della dottrina della scienza: «L’io nel porre se
stesso pone il non-io». Quindi l’io pone se stesso e nel porre se stesso, pone il non-io.
Andiamo allora verso la sintesi dei primi due principi: «Dalla proposizione annunciata nel presente
paragrafo derivail principio logico A=non A, che io chiamerei principio dell’opposizione». «Il non-io,
solo in tanto può essere posto, in quanto nell’io, nell’identica coscienza a se stessa, è posto un io
al quale il non-io può essere opposto. Ora, il non-io deve essere posto nella coscienza identico a
se stesso, ed in questa medesima coscienza deve essere posto anche l’io in quanto opposto al
non-io». Però quando all’Io si contrappone il non-io, l’io non è più l’Io iniziale, libero ed assoluto,
ma qualche cosa di diverso, in quanto viene limitato dal non-Io.
Il terzo momento della dialettica dell’Io è dato allora da questa formula: l’io oppone, nell’io, all’io
divisibile un non-io divisibile. Vale a dire che, nella misura in cui l’Io si scinde nella coppia Io/nonIo,
3
nasce il principio della scissione, della divisione, della opposizione: «l’Io oppone dentro di sé all’Io
divisibile un nonIo divisibile».
La quarta fase della dialettica dell’Io è la nascita e moltiplicazione degli io empirici, dei soggetti
umani concretamente esistenti, gli Io divisibili limitati. L’Io scopre che in realtà il nonIo è esso
stesso un Io, ma è un altro Io. E l’Io è per se stesso un Io ma è anche un nonIo per l’altro Io.
Nasce l’intersoggettività in quanto il non-io è non un semplice scindersi dell’Io, ma un altro Io. Per
questo nella storia dell’Io, dell’umanità nel suo complesso, vi sarà uno sforzo di raggiungimento
della libertà superando di volta in volta gli ostacoli che sono posti all’Io dal non-Io e quindi dall’altro
Io.
Il non-Io è presente dentro la realtà dell’uomo come un Io che vuole dominare l’altro Io: nella
società, nelle tirannie, in tutte le forme in cui la libertà dell’individuo è ostacolata. La storia è per
Fichte storia di liberazione dell’uomo dalla schiavitù, dalle oppressioni, dai dispotismi. Per Fichte
l’uomo, come un titano, continuamente lotta contro la natura a cui è asservito, ma anche contro gli
altri uomini che ostacolano la sua libertà e contro gli ostacoli interni posti dentro di sé alla sua
libertà. Tuttavia, incorporandosi il non-Io, trasformandolo in una parte del proprio Io, l’uomo
progressivamente ampliava i propri orizzonti di libertà.
La dialettica progressiva di Io/io (tesi), Io/nonIo (antitesi), Io/altro Io (antitesi), Io/Io (sintesi)
corrispondeva alla visione della storia umana che circolava in quell’età che aveva vissuto l’empito
di libertà della rivoluzione americana e francese e poi, nel caso di Fichte (e di Foscolo), le lotte
contro Napoleone trasformatosi da liberatore in tiranno. Fichte scrisse, a tale proposito, i Discorsi
alla nazione tedesca proprio per risollevare lo spirito tedesco contro l’invasione napoleonica. La
Francia ci ha insegnato ad essere liberi e noi Tedeschi dobbiamo essere liberi combattendo anche
contro la Francia.
Fichte afferma così la superiorità della ragion pratica (l’etica, la politica, il diritto) rispetto alla
ragion pura (la scienza). «In breve, non esiste affatto per me un puro e semplice essere, che non
mi riguardi e che io contempli solo per il gusto di contemplarlo; quello che in generale esiste per
me, esiste solo mediante la sua relazione con me. Ma ovunque è possibile solo una relazione con
me e tutte le altre sono soltanto sottospecie di questa: la mia missione di agire moralmente. Il mio
mondo è oggetto e sfera dei miei doveri, e assolutamente niente altro; un altro mondo, o altre
qualità del mio mondo non esistono per me». «Non agiamo perché conosciamo, ma conosciamo
perché siamo destinati ad agire; la ragion pratica è la radice di ogni ragione. Le leggi dell’agire
sono immediatamente certe per gli esseri razionali». Per Fichte conoscere il non-Io serve a capire
meglio come affrontarlo: la conoscenza è subordinata alla pratica e la pratica è finalizzata a
superare gli ostacoli posti dal non-Io. Questa visione implica la centralità del ruolo dell’intellettuale,
su cui Fichte ha scritto La missione del dotto. Quale sarebbe la missione dell’uomo di cultura?
Esattamente quella di individuare quali sono gli ostacoli che il non-Io pone nell’epoca storica, per
aiutare l’Uomo e la Nazione a elaborare la strategia migliore, adatta a superare questi ostacoli.
L’etica di Fichte, quindi, ha carattere politico e non più religioso come accadeva in Kant. La libertà
umana non è una porta verso la santità e il sospirato mondo metafisico, bensì la porta verso
l’agire rivoluzionario.
Fichte si riferisce a Jean Jacques Rousseau e a quegli Illuministi francesi (non agli inglesi) che
avevano interpretato l’Illuminismo come dottrina rivoluzionaria e non riformistica. «Dice Rousseau:
taluni si ritengono padroni di altri uomini, mentre sono invece più schiavi di loro, ma avrebbe
potuto dire ancora più esattamente: chiunque si ritiene padrone di altri uomini è uno schiavo egli
stesso. Se anche non sempre lo sia in realtà, pure ha certamente un’anima da schiavo e striscerà
bassamente ai piedi del primo che sia più forte di lui e lo sottometta. È davvero libero solo colui
che vuol rendere libero tutto ciò che lo circonda, e che riesce a diffondere effettivamente intorno a
sé la libertà, grazie ad un’influenza di efficacia sicura, anche se l’origine di essa possa passare
4
inosservata». È qui ripreso il concetto espresso nella seconda formula dell’imperativo categorico
da Kant per cui gli uomini sono «fini in sé», cioè sono tutti membri dell’umanità razionale, quindi
non si deve mai avere un atteggiamento di strumentalità verso l’altro uomo. «A nessuno è lecito
agire su altri uomini come su materia bruta o sull’animale, onde realizzare per mezzo loro un
qualsiasi scopo suo senza far conto alcuno della loro libertà. Non gli è concesso neppure rendere
virtuoso o saggio o felice alcun essere ragionevole contro la sua volontà. A prescindere dal fatto
che questo sforzo sarebbe vano, che nessuno può divenire virtuoso o saggio o felice se non col
proprio lavoro e con la propria fatica, è certo che egli non deve neppure volerlo fare, quand’anche
potesse o credesse di potere, perché ciò è ingiusto ed egli si porrebbe così in contraddizione con
se stesso. Il fine supremo ed ultimo della società è la completa unità e l’intimo consentimento di
tutti i suoi membri».
Ne Lo Stato commerciale chiuso Fichte sostiene che lo Stato ha il compito di impedire che una
persona prevarichi e invada la sfera di libertà di un’altra persona, quindi lo Stato è un arbitro che
deve tutelare le sfere di libertà degli individui. Ma poi Fichte si sofferma sul diritto di proprietà e
dice che la proprietà è ammissibile soltanto se viene conseguita in base al proprio lavoro. È vero
che il diritto all’esistenza, il diritto alla proprietà, sono diritti inalienabili per l’uomo, però l’uomo si
mantiene in vita e mantiene una proprietà quale gli serve per sopravvivere, solamente attraverso il
lavoro: lavoro che emancipa e che non deve servire ad asservire e sfruttare il prossimo, bensì ad
interagire con esso. Lo Stato ha così un compito fondamentale: quello di garantire la dignità del
lavoro a tutti i suoi cittadini. Fichte sostiene che, per conseguire questo scopo, lo Stato deve
accentrare in sé tutti i mezzi della produzione e deve chiudersi rispetto agli altri Stati, per poter
mettere in moto in forma autosufficiente tutte le proprie forze, le proprie energie produttive. Con
questo Fichte inizia a delineare uno Stato che non è semplicemente il garante giuridico delle
libertà, ma che deve agire nell’economia per garantire non solo formalmente la libertà dei cittadini,
ma sostanzialmente a partire proprio dalla dignità del lavoro per ogni cittadino.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
(Leonberg, 27 gennaio 1775 – Bad Ragaz, 20 agosto 1854)
Schelling, insieme ad Hegel, intende porre la filosofia tedesca su basi diverse sia da quelle di Kant
che di Fichte. L’Io non può essere il fondamento della filosofia, ma lo deve essere l’Assoluto che è
l’unità della Io e della Natura, del Soggetto e dell’Oggetto. Kant era rimasto fermo ad un dualismo
tra l’Io penso e la cosa in sé che era superato solo con la speranza religiosa. Fichte aveva
ipotizzato una dialettica senza fine tra Io e nonIo che conduceva ad un inesauribile tormento della
lotta e della sintesi sempre rinviata, alla infelicità dell’Io.
5
Schelling sostiene invece che l’elemento della filosofia, il suo fondamento (Grund), è l’Assoluto
come unità di Io e Natura, di Io e nonIo, di umano e divino, di finito e infinito. Per fare ciò deve
modificare - seguendo il Rinascimento italiano e Goethe – il concetto della natura che non è più
mero meccanismo o negativo non-Io bensì valore positivo: sintesi, evoluzione, intelletto inconscio.
La filosofia può avere quindi due cominciamenti: 1 dall’Io, l’altro dalla Natura e deve svelare il
punto di sintesi fra questi due elementi che è l’Assoluto.
Schelling afferma infatti in maniera lapidaria: «Io credo che il passaggio dall’infinito al finito
costituisca il problema di ogni filosofia». In effetti tutta la sua filosofia non è altro che il tentativo di
risolvere questo problema. Schelling si pone direttamente il problema dell’Assoluto. In questo
senso si pone all’interno del pensiero romantico. L’assoluto è, al di là dell’io fichtiano, qualche
cosa che comprende in sé l’infinito e il finito, il soggetto e l’oggetto, l’io ed il mondo. Ora, se la
totalità è l’unione di soggetto e oggetto, di finito e infinito, di spirito e materia, di io e mondo, dice
Schelling, si potranno avere due tipi di filosofia: o si cercherà di vedere il rapporto tra oggetto e
soggetto a partire dall’oggetto, oppure si potrà partire dal soggetto per arrivare all’oggetto.
Schelling articola questa sua posizione dopo i primi confronti con la filosofia fichtiana e a
venticinque anni, quando pubblica Il sistema dell’idealismo trascendentale (1801), il suo pensiero
è praticamente concluso: l’Arte è la conoscenza della sintesi, la scoperta dell’Assoluto. Poi ha una
lunga pausa e alla fine riemerge come un filosofo irrazionalista che pone la Religione e la
Mitologia come strumenti di conoscenza dell’Assoluto.
Consideriamo prima la fase che si può definire «filosofia didentità» : «Nello stesso fatto del sapere,
l’oggettivo ed il soggettivo sono così uniti che non si può dire a quale dei due tocchi la priorità».
Assoluto è indistinzione di soggettivo e di oggettivo, non si può dire a quale dei due tocchi la
priorità. «Non c’è qui un primo e un secondo: sono entrambi contemporanei e formano un tutto
unico. A volere spiegare questa identità debbo già averla soppressa». Se cerco di spiegare
l’identità, già mi pongo l’identità come oggetto, e allora mi trovo all’interno del dualismo tra
soggetto e oggetto e ho soppresso l’identità. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che
l’assoluto, come assoluta identità, si potrà cogliere soltanto con un atto extrarazionale, con una
facoltà che non passa per la ragione, per il linguaggio. «Quindi a volere spiegare questa identità
debbo già averla soppressa. Per poterla spiegare, poiché per me non è dato altro all’infuori di quei
6
due fattori del sapere, necessariamente devo preporre l’uno all’altro, uscire dall’uno per venire
all’altro. Da quale dei due si esca non è determinato dalla questione. Ora, sono possibili due casi:
o è posto come primo l’oggettivo e si domanda come si aggiunga un soggettivo che si accorda
con esso (e si ha la filosofia della natura)». Oppure, una volta che si sono divisi soggetto e
oggetto, si parte dall’altro polo, cioè dal soggetto, e si ha la filosofia trascendentale: «è posto
come primo il soggettivo, ed il problema è come vi si aggiunga un oggettivo che si accordi con
esso (e si ha la filosofia dello spirito o filosofia trascendentale)». Quindi sono possibili due filosofie:
o si va dalla natura all’io, dall’oggetto al soggetto, e si ha la filosofia della natura, o si va dall’io al
mondo, si parte dal soggetto per spiegare l’oggetto, e si ha la filosofia dello spirito, la filosofia
trascendentale.
Partiamo quindi dalla filosofia della natura. La natura, se è l’Assoluto oggettivato, come dice
Schelling, evidentemente contiene in sé lo spirito, l’elemento soggettivo e cosciente. Schelling
afferma che la natura non è semplicemente qualche cosa di materiale, ma è anche qualche cosa
di spirituale e di ideale. Schelling arriverà a dire che la natura è preistoria della coscienza o
coscienza pietrificata, cioè è spirito che si manifesta in forme materiali. Tutta la natura, anche
quella bruta, presenta un elemento di spiritualità. In questo senso viene ripreso il naturalismo
italiano del Rinascimento. Nel 1802 Schelling aveva dedicato un’ampia opera a Giordano Bruno e
ripreso lo spirito della filosofia panteista di Giordano Bruno. A questo punto è evidente il forte
distacco da Fichte. In Fichte la natura è il secondo momento della dialettica, cioè è il non-io che
scaturisce dall’io. Prima c’è la posizione dell’io, l’io pone se stesso, poi l’io nel porre se stesso
pone il non-io. La natura in Fichte finisce con l’avere sempre un ruolo subordinato, perché è
sempre non-io, vale a dire non-coscienza, anzi è ostacolo alla realizzazione della coscienza. Lo
spirito si ritrova sempre la materia come qualche cosa che deve superare. La concezione fichtiana
della natura è una concezione negativa, c’è sempre quel “non” davanti, la natura non ha una sua
autonomia, una sua dignità di per se stessa. Invece per Schelling la natura non è estranea allo
spirito, bensí è spirito oggettivato. La concezione della natura di Schelling è una concezione di tipo
organicistico, che si contrappone al meccanicismo della considerazione della natura
Il meccanicismo che cosa implica? Che ogni elemento della natura, ogni pezzo della realtà
naturale è esterno rispetto a un’altra entità con cui interagisce, che gli sta affianco: per il
meccanicismo la natura è costituita di entità esterne le une alle altre. Ma questa impostazione
corrisponde alla logica del finito, per cui ci sono tanti pezzi che poi si sommano insieme; è la
stessa logica che ha portato alla creazione dell’Enciclopedia degli Illuministi francesi. Per
Schelling e per la scienza romantica invece si deve cominciare la conoscenza della natura
dall’infinito e dall’intero: quello che conta, quello che è sempre primario, è il tutto, è l’intero, e la
parte non ha significato se non all’interno dell’intero: non esistono rapporti di esteriorità, esistono
soltanto rapporti di parte a tutto. Come possono esistere rapporti di parte a tutto? Evidentemente
ci deve essere un principio informatore, un principio che unifica le parti. Si tratta di una concezione
della natura nuova, che si può definire organicismo. Scrive Schelling a questo proposito: «Il
meccanismo da solo è ben lungi dal comprendere tutto ciò che costituisce la natura. Infatti non
appena mettiamo piede nel campo della natura organica, cessa per noi ogni concatenazione
meccanica di causa ed effetto. Ciascun prodotto organico sussiste per sé medesimo, la sua
esistenza non è dipendente da un’altra esistenza. Ora, la causa non è mai lo stesso che l’effetto;
solo tra cose del tutto differenti è possibile una relazione di causa ed effetto. Ma l’organizzazione
produce se stessa, deriva da se stessa; ogni singola pianta è soltanto il prodotto di un individuo
della sua specie e così ogni singola organizzazione produce e riproduce via via all’infinito
solamente la propria specie. Ogni organizzazione ha a fondamento un concetto [cioè un principio
unico ispiratore che dà organicità alle parti] perché dove c’è relazione necessaria del tutto con le
sue parti e delle parti con il tutto, lì è il concetto». «Ma questo concetto risiede nella stessa
organizzazione, non può esserne affatto separato: essa organizza se stessa. Non la sua forma
soltanto, ma la sua esistenza risponde ad un fine. Non si poteva organizzare senza già essere
organizzato». In questo c’è una eco anche della Critica del Giudizio di Kant, che aveva individuato
7
un finalismo all’interno della natura. Schelling prosegue: «La pianta si alimenta e dura in vita
grazie all’assimilazione di materie estrinseche, ma non può assimilarsi nulla senza essere già
organizzata». Ci deve essere già un principio informatore, gli organismi sono unitari con loro
stessi, non consistono di parti staccate e separate. Quindi il tutto prevale sulle parti.
Ci sono tre piani di potenza, cioè tre piani di possibilità di sviluppo della Natura. Il primo, che
Schelling chiama propriamente della “realtà”, coincide col mondo inorganico: questo non è
qualcosa di morto, ma, proprio come diceva Giordano Bruno, una natura tutta quanta divina, tutta
quanta animata, come sosteneva anche il naturalismo greco. Non c’è niente di morto, niente di
inerte, tutto ha qualche elemento di spiritualità, cioè di idealità. Questo, per Schelling, è dimostrato
dall’esistenza del magnetismo, dell’elettricità, del chimismo. In tutte queste sfere Schelling vede
sempre operanti due forze, due poli che si contrastano e unificano l’uno con l’altro. Poi c’è una
fascia intermedia, una specie di ponte di passaggio alla natura superiore, alla natura organica, che
è data dalla luce, che Schelling considerava come qualche cosa che si avvia verso il non
materiale. Il vertice della natura è dato invece da una sfera in cui più pienamente si manifesta
l’unione di realtà e di idealità, cioè il mondo organico, in cui Schelling identifica sensibilità,
eccitabilità e riproduzione. Sono, secondo il suo linguaggio, uno la prevalenza dell’oggettivo, l’altro
del soggettivo, e il terzo il momento sintetico. Ora, quando siamo arrivati alla terza potenza della
natura, compare l’elemento di passaggio allo spirito, vale a dire la coscienza umana.
Schelling vede in tutta la natura, a partire dai fenomeni più elementari, l’agitarsi del logos,
dell’idea, che poi sboccia nell’uomo e afferma: «La tendenza necessaria di tutte le scienze
naturali, è di andare dalla natura al principio intelligente. Questo e non altro vi è in fondo ad ogni
tentativo diretto ad introdurre una
teoria nei fenomeni naturali. La scienza della natura
toccherebbe il sommo della perfezione se giungesse a spiritualizzare perfettamente tutte le leggi
naturali in leggi dell’intuizione e del pensiero. I fenomeni (il materiale) debbono scomparire
interamente, e rimanere soltanto le leggi (il formale). Accade perciò che quanto più nel campo
della natura stessa balza fuori la legge, tanto più si dissipa il velo che l’avvolge, gli stessi fenomeni
si rendono più spirituali ed infine spariscono del tutto. I fenomeni ottici non sono altro che una
geometria, le cui linee sono tracciate per mezzo della luce, e questa luce stessa è già di dubbia
materialità. Nei fenomeni del magnetismo scompare ogni traccia materiale, e dei fenomeni di
gravitazione non rimane altro che la loro legge, la cui estrinsecazione in grande è il meccanismo
dei movimenti celesti. Una teoria perfetta della natura sarebbe quella per cui la natura tutta si
risolvesse in un’intelligenza». C’è un progredire dal materiale al puro intelligibile, fino a che si
raggiunge l’uomo. «I morti ed inconsci fenomeni naturali non sono se non tentativi falliti della
natura per riflettere sé medesima; la cosiddetta natura morta è soprattutto un’intelligenza
immatura: perciò nei suoi fenomeni già traluce, ancora allo stato inconscio, il carattere intelligente.
La natura attinge il suo più alto fine, che è quello di divenire interamente oggetto a sé medesima,
con l’ultima e più alta riflessione, che non è altro se non l’uomo, o più generalmente ciò che noi
chiamiamo ragione». In tutta la natura c’è una specie di intelligenza oppressa dal chiuso della
materia, un’intelligenza vincolata. Questa intelligenza si fa strada nelle varie sfere della natura e
poi sboccia pienamente nell’uomo. L’uomo è il momento in cui la natura si comprende. «In tal
modo, per la prima volta, si ha il completo ritorno della natura a se stessa appare evidente che la
natura è originariamente identica a ciò che in noi si rivela come principio intelligente e cosciente».
Si sente qui una eco della concezione rinascimentale dell’uomo come «copula del mondo»,
dell’uomo come elemento di congiunzione di tutte le realtà, perché l’uomo riassume in sé tutta la
natura: macrocosmo e microcosmo.
La filosofia trascendentale, invece, procede in senso inverso, cioè dal soggetto all’oggetto, alla
natura. «Porre come primo l’oggettivo e ricavare da esso il soggettivo, è, come abbiamo già
accennato, il compito della filosofia della natura. Ora, se una filosofia trascendentale esiste, non le
rimane altro che seguire il cammino opposto: partire dal soggettivo come da un primo ed assoluto
e farne derivare l’oggettivo. In tal modo la filosofia della natura e quella dello spirito (o
8
trascendentale) si sono distinte secondo le due possibili direzioni della filosofia, e se ogni filosofia
deve riuscire o a fare della natura una intelligenza o dell’intelligenza una natura, ne segue che la
filosofia trascendentale a cui spetta quest’ultimo ufficio, sia l’altro ramo necessario e fondamentale
della filosofia».
Ci sono tre epoche di sviluppo dell’io, in un primo momento predomina l’oggettività, si ha la
sensazione, nella quale l’io è passivo di fronte ai messaggi che gli vengono dalle realtà sensibili.
Questo momento si può anche paragonare con la fase dell’empirismo ingenuo in filosofia. Nella
seconda fase, la coscienza non rispecchia semplicemente i dati esterni, ma riflette su se stessa,
cioè riflette sulle proprie categorie, diventa consapevolezza di sé nella riflessione. Questo secondo
momento riproduce la deduzione trascendentale di Kant, il rintracciare le categorie, i modi di
organizzazione della conoscenza che Kant aveva delineato. La terza epoca è quella della
spontaneità pura, cioè l’io che pone se stesso, vale a dire il lavoro che ha svolto Fichte. Schelling
sottolinea che questo io che pone se stesso è, oltre che un io conoscente, anche volontà, quindi è
già qualche cosa che si protende verso il mondo, e opera quindi un passaggio alla filosofia pratica.
Mentre nella prima fase del suo sviluppo l’io si trova a recepire, è passivo, o comunque è
secondario rispetto all’oggetto, adesso, nella filosofia pratica, si è pienamente costituito come
soggetto autocosciente e cerca di influenzare la realtà pratica. Prima dipendeva dalla realtà,
adesso cerca di calare l’ideale nella realtà: c’è un movimento inverso.
A questo punto Schelling si pone un problema radicale: come fa l’uomo, l’io, il soggetto a recepire
l’oggetto e come fa ad imprimere la propria volontà sull’oggetto? Se questo avviene è sempre per
il fatto che tra soggetto ed oggetto c’è un’intima comunicazione, c’è una relazione forte. Allora
emerge con evidenza che la filosofia della natura da una parte e la filosofia trascendentale
dall’altra sono filosofie ancora parziali, perché sono filosofie che non danno conto dell’unità, bensí
della scissione, considerano i rapporti tra oggetto e soggetto, ma dividono soggetto ed oggetto.
Allora Schelling deve fare un passo in avanti, deve cercare di cogliere l’identità in se stessa, deve
cercare un mezzo, che gli permetta di cogliere oggettivo e soggettivo insieme, e approda
all’identificazione di questo elemento nell’arte. «Non si può concepire come il mondo oggettivo
possa accomodarsi secondo le nostre rappresentazioni e queste a loro volta secondo il mondo
oggettivo se non si ammette che tra i due mondi, l’ideale ed il reale, esiste un’armonia prestabilita.
Questa armonia prestabilita peraltro non è neanch’essa concepibile, se non si ammette che
l’attività per cui si produce il mondo oggettivo, sia originariamente identica a quella che si
manifesta nel volere e viceversa». L’armonia prestabilita è un termine leibniziano, ma per Leibniz,
se c’è un rapporto tra soggetto ed oggetto è perché c’è un Dio che fornisce dall’inizio dei tempi
un’armonia prestabilita tra questi rapporti.
La via di Schelling è del tutto diversa: bisogna scavare dentro la coscienza (Bewusstsein)
dell’uomo per scoprire la strada: «Ora, è senza dubbio un’attività produttiva quella che si
manifesta nel volere. Ogni atto è libero e produttivo, ma la sua produttività è accompagnata da
coscienza. Si postula dunque che nel soggettivo, nella coscienza stessa, venga dimostrata la
compresenza dell’attività conscia ed inconscia». Quando dice “conscio” vuol dire pienamente
soggettivo, quando dice “inconscio” è come se volesse dire oggettivo. Quando dice “conscio” vuol
dire spirituale, quando dice “inconscio” è come se volesse dire materiale, naturale. «Si postula
dunque che nel soggettivo, nella coscienza stessa, venga dimostrata la compresenza dell’attività
conscia ed inconscia. Ma una simile attività è soltanto quella estetica». L’attività estetica per
Schelling risolve il problema della compresenza di soggettivo e oggettivo, di conscio e inconscio.
«L’arte è l’unico vero ed eterno organo e documento insieme della filosofia, il quale sempre e con
novità incessante attesta quel che la filosofia non può rappresentare esternamente, cioè
l’inconscio nell’operare e nel produrre, e la sua originaria identità col cosciente». Schelling
sostiene che l’artista (il Genio) opera inconsapevolmente, cioè ha l’ispirazione, ciò che Platone
chiamava «divina manìa». Quello che si chiama “ispirazione” viene inconsapevolmente all’artista.
Nella pro- duttività artistica c’è un elemento inconscio, però se non c’è poi uno sforzo cosciente,
9
cioè la capacità di plasmare i materiali, il marmo o il legno, di usare i colori, se non si conoscono le
tecniche con cui si compongono le rime, le note ecc. per dare forma ai materiali inconsci che
vengono dall’ispirazione, l’opera d’arte non nasce. L’opera d’arte è il regno dell’incontro tra il
materiale e lo spirituale, perché nell’opera d’arte non vale la materia in quanto tale, ma viene
attribuito un valore estetico all’opera d’arte per l’elemento ideale, spirituale che è calato
profondamente, in maniera inscindibile, nell’elemento materiale. Chi contempla l’opera d’arte, a un
certo punto si immedesima nell’opera stessa, viene rapito dalla bellezza dell’opera, si ritrova in
uno stato estatico, cioè si identifica con l’oggetto, supera la propria soggettività. Quindi la sfera
dell’arte, sia dal punto di vista di chi la crea, sia dal punto di vista di chi la fruisce, sia dal punto di
vista proprio dell’opera d’arte di per se stessa, è un luogo di incrocio, di intreccio inscindibile di
materiale e di spirituale, di soggettivo ed oggettivo, di conscio e di inconscio.
Ma in Schelling si agita una ulteriore suggestione che lo spinge dal mondo dell’arte verso quello
della mitologia e della religione. Schelling dice: «Essenza di ogni realtà è sempre l’assoluto, nulla
è imperfetto». Ma è chiaro, perché se tutto è assoluto, tutto è bene, niente può essere male e
niente può essere imperfetto. «Essenza di ogni realtà è sempre l’assoluto. Tutte le cose sono
sante...», in tutte le cose c’è il divino, in tutte le cose c’è l’assoluto, tutte le cose sono l’assoluto.
«Nel mondo non potrebbe venire meno neppure un frammento, niente, nessuna entità particolare
del mondo potrebbe venire meno, perché ogni entità del mondo, pure la più miserabile, è santa, è
divina». Appunto egli dice: «L’uno è in tutto, ogni essere è l’assoluto». Per questo Schelling nel
1809 compie una svolta (Kehre). Questa svolta, che fa parlare di un secondo Schelling, di uno
Schelling che ormai si allontana dal razionalismo sia romantico che illuministico apre la strada
all’irrazionalismo e trova una prima formulazione nelle Ricerche filosofiche sull’essenza della
libertà umana del 1809.
Da che cosa è caratterizzata questa svolta? Schelling è pervenuto a un assoluto statico, in cui
tutto è divino, tutto è sacro, ma a questo punto si domanda: come si fa a far derivare da
quest’assoluto così compatto la molteplicità, la pluralità, il divenire, la complessità del mondo
storico? Schelling è costretto a sottolineare che all’interno dell’assoluto già c’è questo principio di
differenziazione. Si arriva ad un punto delicato, perché questo principio di differenziazione, per cui
l’assoluto ha al suo interno un elemento che non è più l’assoluto bensì il finito, che è il suo
contrario. In termini teologici questo è un problema drammatico in quanto il finito comprende
anche il male. Questo significa che all’interno dell’assoluto c’è anche il male. Siccome l’assoluto,
nel secondo Schelling, è sinonimo di Dio, questo significa che il male è presente già in Dio. Il
plurale è presente nell’unità, la differenza è presente nell’identità, il male è presente nel bene.
Lo sforzo titanico di Schelling è quello di rimanere in una concezione coerentemente monistica per
cui il principio è uno solo: l’Assoluto che tutto comprende. Secondo l’eterno atto della
autorivelazione, tutto nel mondo, come lo scorgiamo adesso, è regola, ordine e forma. Ma nel
fondo c’è pur sempre l’irregolare, come se una volta dovesse ricomparire alla luce, e non sembra
mai che l’ordine e la forma siano l’originario, ma che a qualcosa di originariamente irregolare sia
stato imposto l’ordine». Sappiamo che Schelling nella sua fase finale, quando occupò la cattedra
che era stata di Hegel a Berlino (1841) diede avvio a tutte le filosofie irrazionalistiche
posthegeliane. «Questa è nelle cose la base inafferrabile della realtà» cioè «Il residuo non mai
appariscente, ciò che, per quanti sforzi si facciano, non si può risolvere in elemento intellettuale,
ma resta nel fondo eternamente». In questo modo Schelling afferma che nel cuore della realtà c’è
l’irrazionale, non c’è la logica, il logos, la ragione, le leggi ordinate di sviluppo della realtà, bensí
c’è qualcosa di insondabile che sfugge alla ragione, che è irrazionale. E infatti dice: «Da questo
irrazionale è, nel senso proprio, nato l’intelletto. Senza il precedere di questa oscurità, non vi è
alcuna realtà della creatura; la tenebra è il suo retaggio necessario». Quindi al fondo della realtà
c’è la tenebra, non c’è la luce del logos.
10
Schelling elabora – in fine - una teoria del «Dio vivente»: Dio non è uguale a se stesso dall’inizio
dei tempi: Dio cresce, diviene, ha una sua storia. Questa storia coincide con la stessa storia
dell’umanità. Schelling in Le età del mondo cerca di spiegare tutta la storia umana come la storia
dello sviluppo di Dio stesso. All’interno di questa prospettiva, Schelling abbozza due grandi opere,
una Filosofia del mito ed una Filosofia della rivelazione, che sono un tentativo di ripercorrere la
storia delle religioni e di vedere così tutta la storia, fino a quella dei suoi giorni, come una
progressiva crescita e autorivelazione di Dio, il quale si erge alla fine vittorioso; Dio viene definito
come il “vittorioso”, cioè colui che alla fine dei tempi si erge vittorioso sulla tenebra. Mentre Dio
riesce a vincere il male, a ergersi sulle tenebre, a fare trionfare la luce, l’uomo molto spesso si
lega alle tenebre, cade nel male.
La filosofia di Schelling è divenuta un misticismo, una dottrina dell’estasi: se il soggetto, il pensiero
dell’uomo, è infinitamente lontano dall’oggetto, dal cuore della realtà, che è un cuore irrazionale,
dice Schelling, si potrà raggiungere questo irrazionale, si potrà raggiungere il cuore della realtà
soltanto uscendo fuori del soggett con l’estasi. Estasi nel senso etimologico greco di “stare fuori di
sé”: il soggetto deve uscire fuori di se stesso per immergersi nell’assoluto. Solo in tal modo il
negativo della realtà può rivelarsi come il positivo. «La filosofia di oggi è una filosofia negativa, è
una filosofia che pretende di contrapporre sempre il concetto e l’essenza delle cose all’esistenza
delle cose. È una filosofia che passa sempre per il momento della negazione». Invece per
Schelling l’essere che sta là di fronte al soggetto è positus, è positivo. L’essere è quello che è, è
quello che ci sta davanti, nella sua concretezza, nella sua realtà, nella contrapposizione alla
nostra coscienza, quindi ci dobbiamo immedesimare in quell’essere che è positus davanti a noi - e
che in ultima analisi è Dio - senza pensare di volerlo superare, anzi dobbiamo tentare proprio di
raggiungerlo, dobbiamo fermarci così a una filosofia positiva.
11