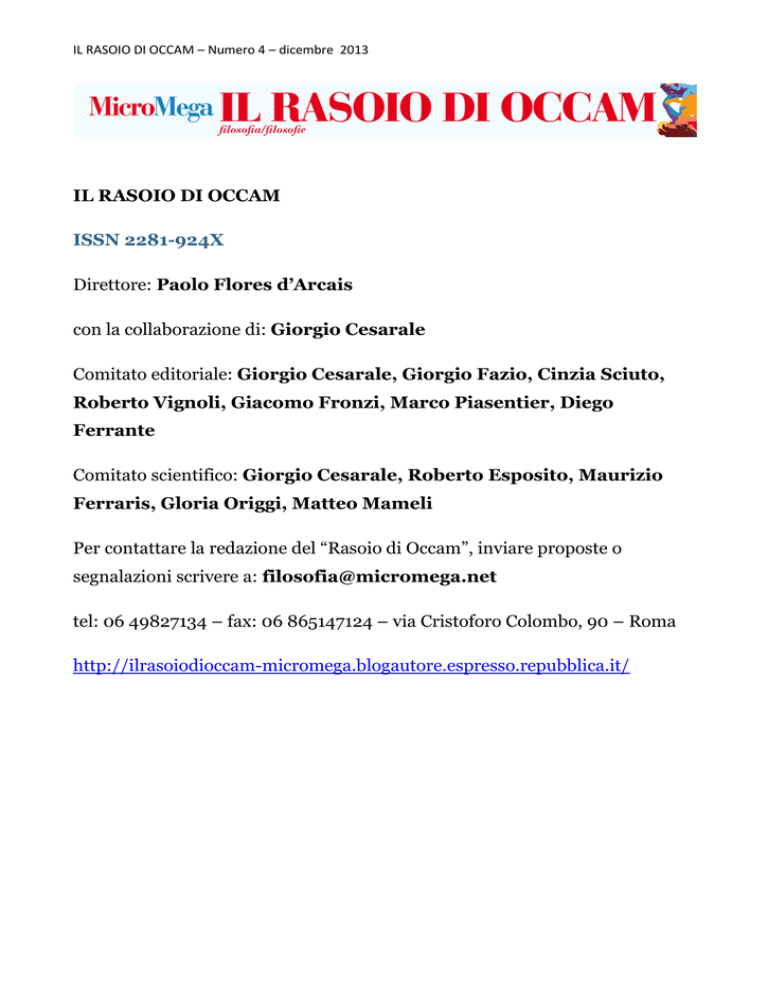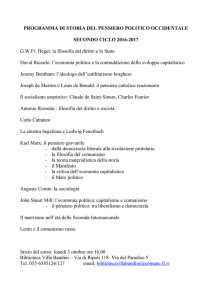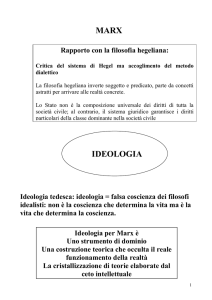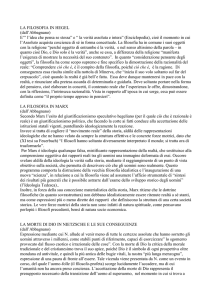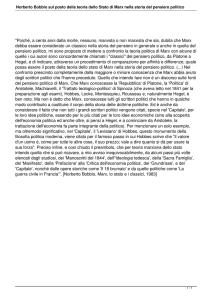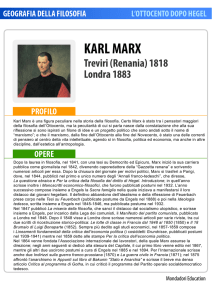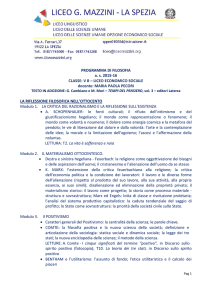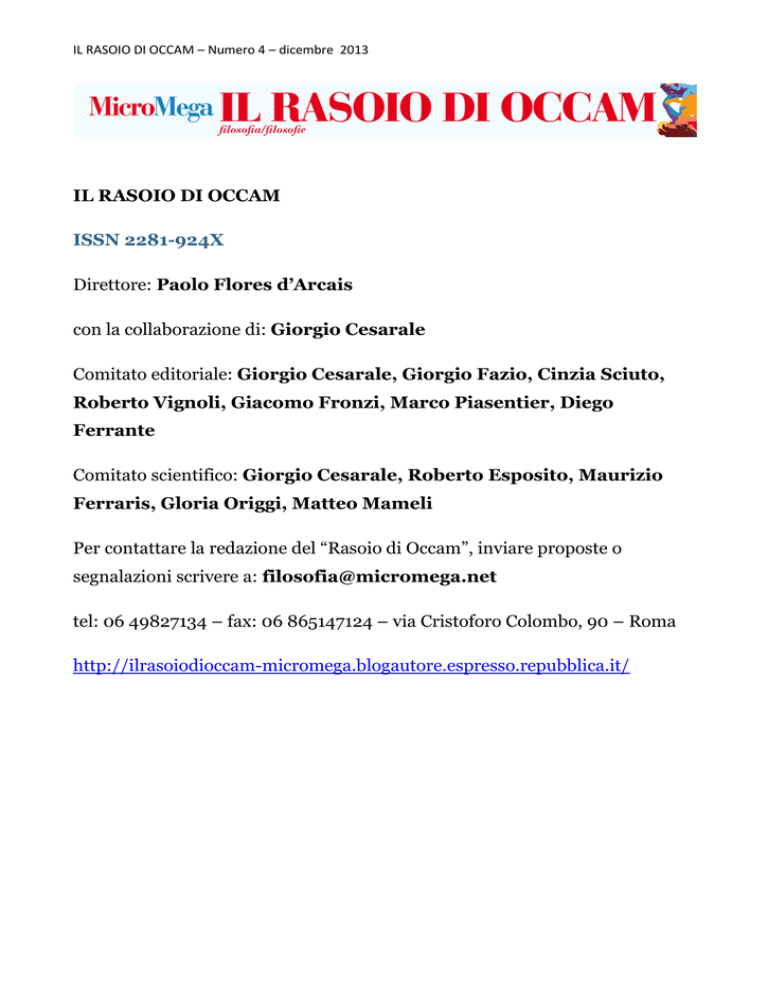
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
IL RASOIO DI OCCAM
ISSN 2281-924X
Direttore: Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di: Giorgio Cesarale
Comitato editoriale: Giorgio Cesarale, Giorgio Fazio, Cinzia Sciuto,
Roberto Vignoli, Giacomo Fronzi, Marco Piasentier, Diego
Ferrante
Comitato scientifico: Giorgio Cesarale, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Gloria Origgi, Matteo Mameli
Per contattare la redazione del “Rasoio di Occam”, inviare proposte o
segnalazioni scrivere a: [email protected]
tel: 06 49827134 – fax: 06 865147124 – via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Marx, Wall Street e la lotta di classe
di RICCARDO CAVALLO
Da poco è apparsa l’ultima fatica di Domenico Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e
filosofica [1] che, muovendosi controcorrente rispetto alla vulgata liberista imperante, si sofferma
su uno dei nodi problematici più significativi dell’opus marx-engelsiano: la teoria della lotta di
classe. Si tratta di un ulteriore tassello che va inserirsi nel ventennale percorso di ricerca del
filosofo urbinate che, oltre a stilare un vero e proprio cahier de doléance sui misfatti dell’Occidente
liberal-capitalista, intende intervenire nelle ferite ancora aperte della tradizione marxista
mettendone in evidenza luci ed ombre.
1. What would Marx Think? Questo interrogativo campeggia sulla copertina della versione europea
del Time del febbraio 2009, cioè nel momento clou della crisi finanziaria che partita dall’esplosione
del sistema dei mutui subprime originatasi negli Stati Uniti, stava per dilagare anche nel resto del
mondo. Non è un caso allora che il prestigioso magazine decida di dedicare la propria cover story
ad un possibile ritorno alle tesi marxiste nell’epoca di Wall Street. Così il celebre ritratto del
filosofo di Treviri diviene immagine pop, dai pixel giallo-oro che scorre al posto dei valori dei titoli
azionari sul rullo della Borsa cui si accompagnano altre frasi fluorescenti che rimandano alla
necessità di elaborare nuove idee per uscire dalla crisi e allo spauracchio del ritorno della povertà.
Tutto insomma lascia presagire che le tesi di Marx, prima fra tutte quella sulla lotta di classe, siano
più che mai da riprendere in considerazione come utile strumento per evitare il baratro generato
dalla voracità autodistruttiva dei mercati.
Malgrado le apparenze, nel suo articolo intitolato Rethinking Marx[2], l’editorialista Peter Gumbel è
ben lungi dal voler inneggiare ad un ritorno del marxismo, cercando anzi di evidenziare come le
idee di Marx, seppur profetiche e a tratti geniali, abbiano nella pratica miseramente fallito. A tale
scopo Gumbel intraprende una sorta di itinerario nei luoghi simbolo della vita del filosofo, ovvero
le tre città che hanno avuto un ruolo determinante durante la sua esistenza: Treviri, sua città natale,
Parigi dove aveva trovato rifugio per un po’ di tempo e infine Londra, in cui trascorse gli ultimi
trentaquattro anni della sua vita e dove tuttora è possibile visitare la sua tomba su cui è scolpita la
sua nota citazione, impressa con lettere dorate: «The philosophers have only interpreted the world
in various ways. The point however is to change it». Tuttavia quello che può sembrare un nostalgico
tour in realtà sembra avere ben poco l’intento di auspicare un ritorno a Marx traducendosi, al
contrario, in un netto rifiuto delle sue teorie. Alla fine del viaggio di Gumbel ciò che rimane è una
visione del marxismo strettamente legata alle sue realizzazioni concrete e più o meno fedeli, nell’Ex
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Unione Sovietica e nei paesi dell’Est Europa. Un panorama piuttosto desolante in cui l’unica via è,
nonostante la crisi, non rinunciare ad un modello economico di tipo capitalistico.
Ma l’accostamento tra l’opera di Marx e la situazione di impasse generata dalla crisi già alla fine
del 2008 aveva inspirato diversi articoli, tra cui quello pubblicato sul settimanale The Economist[3]
che si chiedeva cosa Marx avrebbe pensato e teorizzato di fronte alla crisi e quello, ancora più
eloquente, intitolato Booklovers turn to Karl Marx as financial crisis bites in Germany. Qui senza
mezzi termini Kate Connolly, corrispondente da Berlino per la nota testata inglese The Guardian,
inizia il proprio articolo[4] con la seguente lapidaria affermazione: «Karl Marx is back», per poi
dilungarsi sui motivi del successo editoriale delle opere di Marx, specie tra i giovani studenti
universitari tedeschi, alla ricerca di risposte illuminanti in tempi bui e soprattutto di alternative
valide al dominio dell’Occidente liberal-capitalistico.
Oltre all’impennata di vendite de Il Capitale fino a sfiorare numeri da best seller, testimoniata dalle
stesse parole del responsabile di uno dei maggiori editori specializzati in testi accademici in
Germania, la Karl-Dietz-Verlag, ciò che è apparso ancora più sorprendente è stato il giudizio
espresso da più della metà dei cittadini dell’ex Germania dell’Est che hanno dichiarato di essere
fortemente delusi dal capitalismo che inizialmente li aveva abbagliati con le sue armi seducenti e
ingannevoli mentre un’altra buona parte di loro addirittura spera in un ritorno del socialismo. Tale
sondaggio riportato da un altro giornalista della Reuters in un suo report[5] del 2008 costituisce il
punto di partenza per un interrogativo più che legittimo: perché nonostante gli orrori e le storture
del regime sovietico della DDR nascoste dietro un’apparenza di giustizia sociale e miseramente
svelati al mondo intero dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 i cittadini della Germania
dell’Est rimpiangono il socialismo e disprezzano le ‘gioie del capitalismo’? Se il volto del
socialismo è stato a tratti spietato quello del capitalismo si rivela persino peggiore: come un killer
dai modi di fare ammalianti e cortesi ha prima sedotto la prima vittima con promesse tanto allettanti
quanto irrealizzabili e poi l’ha attaccata e uccisa nel peggiore dei modi. È allora inevitabile che, nel
momento in cui in tanti si accorgono del volto mostruoso del capitale, si riscopra il valore delle
teorie marxiste, specie quelle sulla lotta di classe, sia pure rivisitate, o meglio di un Marx reloaded,
come ha affermato con un abile gioco di parole che richiama un noto film di fantascienza, il
‘pedagogista critico’ Ramin Farahmandpur un paio di anni addietro in un saggio che si interroga
proprio sulla necessità di far studiare l’opera marxista nelle scuole pubbliche per contrastare
l’inarrestabile (quanto deleteria) avanzata della sfrenata società capitalistica[6].
2. In questo contesto va collocata l’ultima fatica di Domenico Losurdo "La lotta di classe. Una
storia politica e filosofica" [7] che, muovendosi controcorrente rispetto alla vulgata liberista
imperante, si sofferma su uno dei nodi problematici più significativi dell’opus marx-engelsiano: la
teoria della lotta di classe. Si tratta di un ulteriore tassello che va inserirsi nel ventennale percorso di
ricerca del filosofo urbinate che, oltre a stilare un vero e proprio cahier de doléance sui misfatti
dell’Occidente liberal-capitalista, intende intervenire nelle ferite ancora aperte della tradizione
marxista mettendone in evidenza luci ed ombre.
La domanda fondamentale da cui prende le mosse la riflessione di Losurdo può essere riassunta nei
termini seguenti: cosa intendono Marx ed Engels per lotta di classe? Per rispondere a questo
interrogativo occorre innanzitutto sapersi orientare nei labirinti marx-engelsiani alla ricerca di quei
frammentari luoghi teorici da cui emergono, nonostante l’evidente asistematicità, i principi-cardine
di tale teoria e rileggerli nel milieu in cui sono maturati.
Operazione a dir poco ardua che richiede, da un lato, una rigorosa analisi logico-filologica dei testi
marx-engelsiani e, in modo particolare, del Manifesto e, dall’altro, un’articolata disamina del
contesto storico, non dimenticando che la stessa lotta di classe – come sottolinea giustamente
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Losurdo – possa essere usata in maniera strumentale dal potere dominante ed essere quindi inserita
nell’ambito di un progetto complessivo di segno conservatore e/o reazionario, com’è stato
efficacemente dimostrato di recente da Luciano Gallino[8], il quale identifica l’offensiva, messa in
atto specialmente nell’ultimo trentennio, dalle classi dominanti per ‘rovesciare’ a proprio vantaggio,
come una nuova lotta di classe atta a scardinare ogni conquista ottenuta dal basso in seguito alle
vecchie lotte sociali.
Perciò la seria e dettagliata ricostruzione losurdiana, seppure non sempre condivisibile, può
costituire indubbiamente un utile filo di Arianna per orientarsi nel dedalo marxiano della teoria
della lotta di classe che, agli occhi dell’Autore, si presenta come una teoria generale del conflitto
sociale, che operando una radicale rottura con le ideologie naturalistiche colloca tale conflitto sul
terreno della storia. La conseguenza è che le innumerevoli forme in cui esso si manifesta nella realtà
non possono essere non tenute in debito conto.
Del resto, ciò si evince dalla scelta, nient’affatto casuale, operata da Marx ed Engels di utilizzare
non il singolare Klassenkampf ma il plurale Klassenkämpfe. A partire da questa arguta precisazione,
la lotta di classe non rinvia solo ed esclusivamente al conflitto tra la borghesia e il proletariato.
Quest’ultimo pertanto non è l’unica forma possibile della lotta di classe ma una delle possibili
forme che essa può assumere concretamente nelle diverse epoche storiche. Riconoscere la
dimensione plurale della lotta di classe significa almeno ammettere che le tre grandi lotte di classe
emancipatrici sono: 1) la lotta per l’emancipazione del proletariato; 2) la lotta per l’emancipazione
delle nazioni oppresse; 3) la lotta per l’emancipazione della donna.
Collocarsi sul terreno della comprensione storico-sociale comporta però il rifiuto di ogni
spiegazione che enfatizzi, in modo unilaterale, elementi etnologico-razziali (esemplificati nella nota
opera di Arthur de Gobineau, Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane) o psico-patologici (si
pensi alla Psicologia delle folle di Gustave Le Bon) sottese ai paradigmi dominanti nella cultura
borghese della seconda metà dell’Ottocento che, in molti casi, finiscono per intrecciarsi e
sovrapporsi. E proprio contro la reductio agli aspetti biologico-naturalistici degli appartenenti alle
classi subalterne, assimilati a barbari o addirittura a soggetti di rango inferiore e la conseguente
legittimazione dell’istituto della schiavitù, che viene elaborata la teoria della lotta di classe. Ma
quest’ultima, Losurdo non si stanca mai di ripeterlo, va intesa non in maniera grettamente
economicistica (lotta per la redistribuzione) ma anche e soprattutto come lotta contro i processi
disumani e coercitivi che caratterizzano la società capitalistica (lotta per il riconoscimento).
Innumerevoli sono le espressioni (anche forti) a cui ricorrono, molte volte, nei loro scritti i due
filosofi e militanti rivoluzionari per denunciare le condizioni miserrime del proletariato che vanno
ben al di là dell’angusto orizzonte economicistico (come vuole la tradizione liberale) coinvolgendo
anche ogni ostacolo all’affermazione dell’uomo in quanto tale e della sua dignità costantemente
calpestata. Qui i riferimenti filosofici a cui ricorre Marx sono piuttosto evidenti e sono rintracciabili
nel paradigma del riconoscimento di hegeliana memoria e, in particolare, nella dialettica tra servo e
padrone immortalata nelle celebri pagine della Fenomenologia dello spirito. Se per un verso Marx
sembra far tesoro della grande lezione hegeliana che considera l’individuo realmente libero solo
quando riconosce e rispetta l’altro quale individuo libero, per un altro la traspone dal piano
individuale a quello collettivo. La denuncia dell’antiumanesimo che pervade il sistema capitalistico
dunque non può ritenersi episodica o marginale ma rappresenta una sorta di leitmotiv che attraversa
il pensiero di Marx ed Engels e non può essere affatto confusa con la retorica umanistica. Ad
incorrere in un siffatto errore è stato, com’è noto, Louis Althusser, il quale aveva parlato di una
rottura epistemologica nell’opera marxiana, laddove Losurdo al contrario scorge solo il passaggio a
un ordine diverso del discorso nell’ambito del quale «la condanna morale dei processi di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
reificazione insiti nella società borghese e del suo antiumanesimo è espressa in modo più sintetico
ed ellittico»[9].
3. Ma l’elemento che più di ogni altra cosa emerge dal lavoro di Losurdo è la costante attenzione
riservata da Marx ed Engels alla questione nazionale che molti studiosi marxisti sulla base del noto
passaggio tratto dal Manifesto in cui si afferma che «gli operai non hanno patria», hanno liquidato
in modo piuttosto frettoloso e superficiale. A smentire un siffatto assunto basta sfogliare le
numerose pagine delle loro opere, rinvenibili in ordine sparso, dedicate a tale questione e, nello
specifico, alla lotta del popolo irlandese contro il dominio degli inglesi da un lato e di quello
polacco contro il regime zarista dall’altro. Il significato politico-rivoluzionario di tali lotte, al di là
delle differenze, sta nel fatto che la questione sociale si presenta quasi sempre come questione
nazionale.
In particolare, il caso irlandese viene visto da Marx con favore per la sua potenzialità di divenire
una sorta di detonatore in grado di far esplodere la rivoluzione anche altrove; invece, quello polacco
si presenta funzionale a fronteggiare la Russia zarista che all’epoca, per il suo essere l’ultimo
bastione della reazione in Europa, rappresentava la principale minaccia verso la classe operaia e la
democrazia. Non è un caso che quest’episodio rimanga impresso nella memoria collettiva grazie
alla lapidaria affermazione di Lenin: «la Russia era ancora addormentata mentre la Polonia era in
fermento».
Allo stesso modo, come non dimenticare il trasporto con cui Marx segue a più riprese le vicende
dell’India definita, non a caso, l’Irlanda dell’Oriente, in cui milioni di operai sono stati costretti a
sacrificare la propria vita non per garantire un futuro migliore al loro paese quanto piuttosto - per
riprendere l’amara constatazione dello stesso Marx - «procurare al milione e mezzo di operai,
occupati in Inghilterra nella medesima industria, tre anni di prosperità su dieci»[10]. Ciò nonostante
- Losurdo non manca di rilevarlo - in molti settori del movimento comunista prevale una sorta di
internazionalismo dai tratti utopistici che mira a liquidare come falsi miti le identità nazionali. Un
esempio emblematico di tale forma mentis è l’atteggiamento cinico e sprezzante dell’anarcosocialista francese Pierre-Joseph Proudhon reo, a detta di Marx ed Engels, di aver irriso e
condannato le aspirazioni nazionali dei popoli oppressi.
Già da queste brevi notazioni si scorge come la loro passione verso l’emancipazione delle
nazionalità oppresse sia inscindibile da quella per l’emancipazione del proletariato. Del resto, la
vittoria della Rivoluzione di Ottobre non si può comprendere - per parafrasare Walter Benjamin omettendo la rilevanza del sentimento nazionale che il bolscevismo aveva sviluppato in tutti i russi
senza distinzione di sorta e che Losurdo ritiene essere addirittura una delle cause (rectius: la causa)
della disgregazione dell’impero sovietico. In ultima analisi, eludere la questione nazionale vuol dire
rovesciare il preteso cosmopolitismo o internazionalismo in una sorta di sciovinismo acritico e
settario.
Un ulteriore aspetto che Losurdo sembra avere a cuore e sul quale si sofferma nelle pagine
conclusive consiste nella messa in guardia dalla ricorrente tentazione populista che, al di là delle sue
diverse varianti, si basa sulla credenza mitologica del valore salvifico del popolo. Credenza oggi
ancora più pressante a causa della crisi teorica che investe la dottrina marxista. In realtà, si tratta di
un fenomeno per niente inedito, in quanto la semplicistica lettura binaria del conflitto la si ritrova,
per esempio, già durante la rivoluzione bolscevica, laddove l’emergere di un rozzo egualitarismo e
un altrettanto grossolano ascetismo universale è ciò che sembra accomunare, al di là delle
differenze, non solo il fervente cristiano Pierre Pascal e l’operaio belga Lazarević ma molti altri
seguaci del bolscevismo, tra cui lo stesso Lenin come si desume dal tenore letterale di alcuni
discorsi pronunciati in questo periodo. Come non rammentare allora le taglienti parole di Antonio
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Gramsci che, nel noto scritto La Rivoluzione contro il Capitale, si scaglia contro il collettivismo
della miseria e della sofferenza?
Essa si ripresenta, in modo ancor più accentuato, negli scritti di Simone Weil che tende a ridurre la
lotta di classe alla riscossa degli umili e dei reietti e che Losurdo, malgrado l’empatia che la filosofa
prova nei confronti del movimento operaio, rigetta ricorrendo a diversi esempi storici (tra cui la
Comune di Parigi e la guerra di secessione americana) che dimostrano con estrema chiarezza la sua
inadeguatezza, vista la diversità dei soggetti che, a seconda delle situazioni concrete, possono
incarnare le istanze rivoluzionarie. Losurdo sembra qui tenere ben a mente il celebre ammonimento
marxiano: «non c’è nulla di più facile che dare all’ascetismo cristiano una mano di vernice
socialista». Da ultimo, una forma più o meno latente di populismo riemerge sia in alcuni lavori di
Slavoj Žižek che non esita a qualificare l’approccio di Weil, secondo cui solo i mendichi e reietti
sono in grado di dire la verità, come «semplice e toccante», sia negli scritti di Antonio Negri e
Michael Hardt, in cui il conflitto tra l’impero e la moltitudine assume anch’esso un’intonazione di
tipo moralistico soprattutto quando si celebra l’eccellenza morale insita nella figura del ribelle che
rimane tale solo fino a quando si tratta di liberare un popolo oppresso ed umiliato ma viene meno
nel momento in cui esso si dismette di tali panni.
4. La lettura del volume di Losurdo si rivela dunque utilissima quanto affatto consolatoria: lo
scenario che si presenta davanti ai nostri occhi è, a dir poco, inquietante se si pensa che la storia
occidentale è stata costellata da brutali episodi, da cui emerge in maniera costante la volontà di
ridurre l’altro in schiavitù, sia in forme più o meno palesi, sia in forme più o meno subdole.
Nonostante i facili trionfalismi diffusisi subito dopo la caduta del Muro di Berlino e la conseguente
dissoluzione dell’impero sovietico, nuove forme di colonialismo e di imperialismo da parte
dell’Occidente che, in realtà, ricordano molto da vicino le forme di schiavitù otto-novecentesche si
stanno sempre più affermando.
Un’analoga riflessione suscita il riaffiorare, in molte metropoli, di una figura, a lungo negletta,
come quella del working poor appartenente a quella fascia di lavoratori che, pur percependo un
reddito, si avvicinano o si trovano al di sotto della soglia di povertà. A dispetto di quanto si possa
pensare, tale fenomeno non riguarda solo coloro che per mancanza di qualifiche diventano
‘obsoleti’ rispetto ai lavoratori più qualificati o in linea con l’avanzamento tecnologico, ma
paradossalmente colpisce soprattutto i giovani in possesso di rilevanti curricula costretti in molti
casi a ‘nascondere’ i propri titoli, pur di svolgere lavori sottopagati e privi di prospettive e adeguate
garanzie. T
ale triste scenario non fa altro che smentire le rassicuranti litanie sulla fine della lotta di classe nella
società novecentesca avanzate dal sociologo Ralph Dahrendorf, il quale all’inizio degli anni
Sessanta la riteneva un’anticaglia del passato da cui bisognava, prima o poi, liberarsi o dal filosofo
Jürgen Habermas che, invece, alcuni decenni dopo, nel sottolineare, ancora una volta, che il
superamento di tale conflitto era addirittura risalente agli anni immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale con l’avvento dello Stato sociale, ometteva un particolare non trascurabile,
cioè le lotte che avevano contribuito all’edificazione di quest’ultimo. In realtà, già agli albori
dell’Ottocento si era diffusa una corrente di pensiero che sosteneva, dopo il tramonto dell’Ancien
Régime e l’avvento della società borghese, l’inesorabile tendenza verso il livellamento delle
differenze e l’inutilità della lotta di classe. Ben lungi dall’aver eliminato i conflitti di classe come
pensavano John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville, la società borghese – come scrivono Marx ed
Engels – in realtà non aveva fatto altro che riproporli in forme nuove, acuendo, sia a livello
nazionale che internazionale, le diseguaglianze.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
La dura lezione che possiamo trarre da queste tragiche vicende, di cui Losurdo ripercorre sia i
passaggi più conosciuti e studiati, sia quelli dimenticati e condannati all’oblio, in cui le
innumerevoli lotte di classe, sviluppatesi a cavallo tra Otto e Novecento, assumono le sembianze
più disparate (guerre di resistenza o di liberazione nazionale, insurrezioni o rivoluzioni
anticoloniali) sta nel fatto che esse, al di là dei distinguo, sono accomunate dall’essere sempre state
lotte nazionali e vanno condotte non solo sul piano politico ma soprattutto su quello economico.
L’esempio paradigmatico, a cui ricorre più volte l’Autore, è quello della nascita di Haiti, a proposito
della quale vengono rievocate le gesta di Touissant Louverture che capeggiò la rivoluzione degli
schiavi avvenuta alla fine del Settecento a Santo Domingo e la cui eco andò ben oltre i confini del
piccolo paese sud americano, innescando un processo a catena di abolizione della schiavitù. La
grande vittoria politica ottenuta sconfiggendo uno degli eserciti più potenti del mondo come quello
napoleonico è stata tutt’altro che duratura, poiché il sistematico isolamento diplomatico e la
persistente offensiva economica da parte degli USA e degli altri paesi occidentali hanno provocato
il collasso del paese sud americano. Forse per evitare che la storia si ripeta, Losurdo si concentra sul
caso cinese e la sua ascesa nell’attuale scenario geopolitico globale che segna, per molti versi, il
tramonto dell’epoca colombiana contrassegnata da secoli di dominio incontrastato dell’Occidente e
la radicale messa in discussione della divisione internazionale del lavoro imposta dal capitalismo.
Lo spettro della lotta di classe che il pensiero mainstream sembrava dunque aver esorcizzato
definitivamente è nuovamente sotto gli occhi di tutti, come evocativamente afferma di recente il
corrispondente da Pechino Michael Schuman sul Time, in un articolo intitolato Marx’s Revenge:
How Class Struggle is Shaping the World[11], in cui, anche sulla base dei risultati di un accurato
studio dell'Economic Policy Institute (EPI) di Washington, riconosce il ruolo profetico di Marx
nella teorizzazione dei guasti del sistema capitalista: l’impoverimento crescente delle masse e la
concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi genera conflitti sempre più stridenti tra le classi
sociali.
Aver narrato i fasti di questa tormentata storia, attraverso la proposta di un’altra narrazione
alternativa a quella dominante, è l’indubbio merito di Losurdo, che coglie altresì nel segno quando
invita provocatoriamente i magnati del capitale e della finanza a rileggersi, di prima o di seconda
mano, Marx. Ma il suo limite sta nell’aver affrontato solo di sfuggita la questione ecologica che
appare oggi un indispensabile terreno di confronto a sinistra, quantomeno se si vogliano, anche in
questo caso, sviluppare criticamente le intuizioni di Marx ed Engels, riconoscendo accanto alla
prima contraddizione (capitale/lavoro) anche la seconda (capitale/natura). Se tali idee sono ancora
vive e feconde non è forse il caso di considerare le lotte ambientaliste intese lato sensu (ivi
compresa quella per la tutela dei beni comuni) come l’ultima ed inedita frontiera della lotta di
classe?
NOTE
[1] D. Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-Bari, 2013.
[2] http://www.time.com/time/specials/packag...
[3] http://www.economist.com/node/20019767
[4] http://www.guardian.co.uk/books/2008/oct...
[5] http://www.reuters.com/article/2008/10/1...
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[6] R. Farahmandpur, Teaching against Consumer Capitalism in the Age of Commercialization and
Corporatization of Public Education, in J.A. Sandlin, P. McLaren (a cura di), Critical Pedagogies
of Consumption, Routledge, London-New York, 2010, pp. 58-66.
[7] D. Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-Bari, 2013.
[8] L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe. Intervista a cura di Paola Borgna, Laterza,
Roma-Bari, 2012.
[9] D. Losurdo, La lotta di classe, cit., p. 91.
[10] Ivi, p. 12.
[11] http://business.time.com/2013/03/25/marx...
Riccardo Cavallo svolge attività didattica e di ricerca con la cattedra di Filosofia del Diritto
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. La sua tesi
dottorale si è aggiudicata nel 2005 il Premio di filosofia “Viaggio a Siracusa”. Tra le sue
pubblicazioni più rilevanti le monografie: L’antiformalismo nella temperie weimariana
(Giappichelli, 2009) e Le categorie politiche del diritto. Carl Schmitt e le aporie del moderno
(Bonanno, 2007).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
In-canto. Omaggio a Luciano Berio
di GIACOMO FRONZI *
Lo scorso 27 maggio 2013 si sono celebrati i dieci anni dalla scomparsa di Luciano Berio, uno dei
compositori (anzi, musicisti) più rappresentativi del panorama musicale contemporaneo. La
complessità e l’articolazione di questa grande figura permettono di tornare a riflettere non solo
sugli sviluppi della musica contemporanea, in particolare nel suo rapporto con i nuovi mezzi
tecnologici, ma anche sulle potenzialità e sulle prerogative dell’arte aujourd’hui.
I discorsi sulla musica non ci inquietano – se così fosse non saremmo qui – però sappiamo che la
musica può renderci inquieti perché, quando è carica di senso, chiede comunque di essere parlata,
interrogata e messa in relazione con un altrove sfuggente.
Luciano Berio, "Un ricordo al futuro"
La storia delle arti del Novecento si è caratterizzata fin dall’inizio come un territorio composito,
attraversato da correnti, tendenze, forme espressive diverse, talvolta opposte. I complessi e
contraddittori sviluppi del «secolo breve», la connotazione «debole» delle narrazioni del mondo di
cui l’uomo novecentesco ha dovuto prendere atto, la ritrovata consapevolezza della tragicità
dell’esistenza, ma anche l’inesauribile bisogno di sperare ancora, di credere nella possibilità di
autorigenerazione dello spirito umano, innervano le arti del xx secolo. Esse si sono fatte carico
strenuamente del tentativo, che solo l’artista può liberamente condurre, di gettare fasci di luce nei
più reconditi e oscuri angoli dell’animo e della società contemporanea, ma anche di far emergere
dalle profondità ambigue proprie dell’essere-umano e delle sue distintive caratteristiche un’inedita e
inesplorata bellezza.
Orientare la propria ricerca verso obiettivi di questo genere significa assegnare all’attività artistica
un compito specifico, che è insieme conoscitivo e morale: contribuire a riflettere sull’uomo, sulle
sue condizioni, sulle sue possibilità di rinnovamento, sulle strutture sociali, sul loro grado di
costrizione e sul loro potenziale emancipativo. Queste funzioni, che sono al contempo sociali e
civili, si possono esprimere al meglio se assumono le forme di un’evoluzione o, all’occorrenza, di
una rivoluzione dei mezzi tecnici, del gusto, dell’atmosfera spirituale e sociale di cui l’arte, quindi
anche la musica, è sia presentimento che riflesso.
Nell’estrema varietà formale e poetica della musica del Novecento, la musica elettroacustica (che
possiamo genericamente considerare come la musica prodotta, in studio o dal vivo, ricorrendo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
all’utilizzo di tecnologie elettriche, elettroniche e digitali) costituisce un fenomeno di grande
interesse. Essa pone una serie notevole di questioni che coinvolgono lo storico della musica e il
filosofo, giacché la sua storia e i suoi sviluppi rinviano anche ad alcune delle grandi questioni
teoriche con le quali si è confrontato il pensiero del Novecento: il rapporto uomo-tecnica, le
ricadute estetiche del progresso, il problematico dialogo tra artisti e pubblico, la reale capacità di
incidenza dell’arte sulla società, e così via. In siffatto contesto, a metà del xx secolo sono emerse
delle figure che più di altre, parafrasando Immanuel Kant, hanno dato la regola alla musica. Tra
queste, spicca senza dubbio Luciano Berio (1925-2003), uno dei compositori che hanno fatto della
libertà di pensiero e della fusione tra dimensione musicale, civile e morale il fulcro attorno al quale
costruire nuovi percorsi sperimentali, e che hanno contribuito in maniera decisiva ad arricchire il
panorama della musica contemporanea[1]. Lo scorso 27 maggio abbiamo celebrato i dieci anni dalla
scomparsa del Maestro ligure e questo contributo intende inserirsi proprio nel solco di quelle
celebrazioni.
Una delle questioni che Berio spesso affrontava era quella relativa alla possibilità di ricondurre la
musica contemporanea a una qualche forma di unitarietà. Proprio come si diceva in apertura, il
carattere esplosivo e rivoluzionario delle avanguardie e delle neoavanguardie ha dato vita a un
panorama tutt’altro che uniforme. Secondo Fedele D’Amico, la crisi sociale è tale «nel senso che
rompe la concordia, dissocia le forze, apre contrasti terribilmente complessi, comunque irriducibili
al semplicistico scontro fra vecchio e nuovo»[2], e dinanzi al disordine generale le reazioni e le
soluzioni sono innumerevoli, e non tutte spiegabili e comprensibili ricorrendo a schemi
evoluzionistici del linguaggio musicale. È il caso, ad esempio, della tonalità, vale a dire del
linguaggio che la cultura occidentale si è data per produrre musica per quattro secoli, la cui messa
sotto scacco non era legata al fatto che essa non aveva più qualcosa da dire, ma al fatto che essa ha
continuato a dire proprio quel che ha sempre detto, a significare quel che ha sempre significato:
qualcosa che non ha più trovato giusta corrispondenza nelle lacerazioni e nei drammi della società
contemporanea. «La “nuova musica” non nasce da fatalità interne all’evolversi del linguaggio, ma
da una scelta morale. Una crisi della tonalità non esiste che per metafora, esiste solo una crisi
dell’uomo; di fronte alla quale si possono prendere varie posizioni»[3]. Da qui discende l’estrema
differenziazione delle risposte che hanno offerto i compositori, nel corso del Novecento, rispetto a
questa crisi globale dell’uomo, spirituale, artistica, morale, culturale in senso ampio.
Anche Berio, nel 1993, manifestava dei dubbi circa la possibilità di esprimere una visione che
potesse essere unitaria rispetto sia al prodotto musicale che al pensiero musicale. E probabilmente
avrebbe anche poco senso, dal punto di vista di Berio, impegnarsi nella ricerca di un filo d’Arianna
che possa aiutare a orientarsi nel «caleidoscopio musicale» del secondo Novecento, così come poco
senso potrebbe avere ipotizzare una tassonomia o una definizione dei tanti e differenti modi di fare,
di fruire e di pensare la musica oggi[4].
Non è un caso che abbia assunto questa posizione proprio un compositore il cui contributo ha
segnato un’epoca, una visione della musica e, perché no, una Weltanschauung. Berio, grazie anche
a una particolarissima vocazione a vivere i fatti sonori, è emerso subito come una delle punte di
diamante della scuola musicale italiana del secondo dopoguerra. Scriveva Mario Bortolotto: «Berio
si avvale di un mestiere agguerritissimo: conoscenza eccellente della musica tradizionale, da
consentirgli i più divertenti rifacimenti o pastiches; inesauribile passione per lo strumentalismo e
anzi il virtuosismo, sì da volgersi con piacere a indagini su ardimentose possibilità tecniche, che è
venuto svolgendo specie nella serie delle Sequenze; curiosità artigianale, che spazia con
imperturbabile calma e indifferenza olimpica, o quasi, dalla musica d’intrattenimento o di consumo
(anche nelle forme più corrive) alle proposte acustiche d’uno studio di fonologia; gusto, soprattutto,
da vero amatore di musica per qualsivoglia espressione dell’arte sua»[5]. E uno dei contesti
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
all’interno dei quali Berio ha potuto esprimere al meglio «l’arte sua» è stato senza dubbio lo Studio
di Fonologia della Rai di Milano[6].
Lo Studio, che resterà in funzione dal 1955 al 1983, è il frutto dell’attività e dell’impegno di
Luciano Berio e Bruno Maderna, nonché della partecipazione di intellettuali e musicologi come
Luigi Rognoni o Piero Santi. Lo Studio, però, non nasce direttamente come centro di produzione
musicale, ma come laboratorio per esperimenti elettroacustici di carattere generale, nel quale si
realizzavano, ad esempio, radiocommedie e radiocronache.
La spinta propulsiva iniziale la imprime proprio Berio. Egli aveva ben compreso – anche ascoltando
i primi lavori elettronici realizzati a Colonia – che il suono elettronico sarebbe potuto essere una
risorsa interessante, un mezzo estremamente utile per la creazione artistica[7]. Come accaduto a
Parigi, Colonia o Tokyo, anche a Milano il nucleo originario della ricerca sperimentale elettronica si
situa quindi inevitabilmente nel solco della radiofonia e nasce con l’intento di dare vita a un’arte
musicale radiofonica ed elettroacustica. Ne è un esempio Ritratto di città (1955-56)[8], frutto di un
lavoro guidato da Bruno Maderna a cui collaborano Berio e Roberto Leydi.
Lo studio milanese, pur intrattenendo rapporti con gli altri due centri europei già citati, se ne
differenzia quasi subito. La «scuola milanese» tenta il superamento della dualità tra musica concreta
e musica elettronica pura[9], prendendo una terza strada, alternativa, che, per un verso, punta a una
maggiore emancipazione tecnologica della musica, per altro verso, si avvale di un prezioso
«atteggiamento speculativo sul materiale sonoro, che però si sottrae al rigore parascientifico
praticato dalla scuola tedesca, o alla “semplificazione costruttiva” della prima musique concrète, per
muovere con decisione nella scoperta e sperimentazione di nuovi significati e intrecci musicali e di
comunicazione»[10].
Berio si inserisce nel dibattito che si era aperto nel contesto milanese relativamente alla questione
della ricerca di un linguaggio che si potesse articolare e che potesse prendere forma a partire dagli
oggetti e dai soggetti della comunicazione. Francesco Giomi, Damiano Meacci e Kilian Schwoon
hanno giustamente scritto che ciò che veramente interessava Berio erano le relazioni che si
stabiliscono tra la mobilità fisico-acustica del suono e l’effettiva mobilità del pensiero musicale. Un
altro aspetto fondamentale relativo poi all’uso della tecnologia applicata alla musica è legato alle
modalità e alle procedure con cui il pensiero musicale riesce ad adattarsi a spazi e situazioni
d’ascolto diverse. Le tecnologie informatiche e quelle di diffusione sonora, allora, offrono al
compositore la possibilità di abitare spazi acustici nuovi e non convenzionali, ma permettono anche
di rendere flessibili spazi tradizionalmente chiusi o, quanto meno, legati a una precisa e consolidata
tipologia di fruizione musicale[11].
Al centro del dibattito vi era quindi il problema del giusto equilibrio tra sperimentazione,
invenzione semantica e artificio sonoro, il tutto sostenuto da un’idea, da un progetto, per così dire,
non strettamente musicale, ma teorico-concettuale, da un pensiero musicale rinnovato. In
particolare, Berio intendeva la tecnologia non semplicemente come “strumento” in senso tecnico,
ma anche come strumento di pensiero che (in questa doppia accezione) agisce direttamente nel
processo creativo[12]. La disponibilità delle risorse tecnologiche è perciò del tutto funzionale a
un’idea, a una concezione della musica tecnologica sostanzialmente etica, umana, che si realizza in
una forma critica della ricerca e della sperimentazione.
La musica – come ha poi sostenuto Luigi Nono – deve quindi saper intervenire nella situazione
contemporanea, nella storia, nel mondo, nella vita reale, producendo nuovi contenuti e nuovi
significati, istituendo nuovi rapporti con il contesto, con il pubblico, con la comunità. Il campo
d’azione della musica, in quest’ottica, risulta ampliato e diversificato. Tale ampliamento poteva
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
scaturire solo da un’intensa attività di ricerca, di investigazione, di indagine. Questa tendenza, nella
prassi praticata da Berio, «conduce sempre a ricercare sviluppi musicali dove l’aspetto semanticocomunicativo prevale sulla ricerca dell’effetto fine a se stesso»[13]. Uno dei tratti distintivi della
musica di Berio è allora da ricondurre, come accade sempre per i grandi artisti, esattamente alla
funzione che il compositore attribuisce alla musica. Ciò che viene privilegiato non è il sofisticato,
ma il complesso, vissuto e rivissuto in chiave comunicativa.
In questo quadro, la prassi elettroacustica finisce col diventare una via di emancipazione e di
progettazione ulteriore dei campi sonori, ricorrendo anche a contaminazioni prodotte dall’intreccio
di mezzi e di sistemi espressivi diversi. Questo accade, ad esempio, in Laborintus II (1965), lavoro
costruito su testi originali di Edoardo Sanguineti e da lui interpretati, in cui emerge chiaramente il
«raggiungimento di questa condizione multipolare che nell’uso della citazione di episodi della
letteratura, nell’uso di lingue antiche e contemporanee, o di sketches sonoro-musicali, spazialmente
e temporalmente separati, è capace di sollecitare un’ampia gestualità drammaturgica»[14]. Il mezzo
elettronico viene utilizzato da Berio come strategia volta alla concatenazione di fatti sonori e di
livelli diversi, come strumento per realizzare un complesso polimorfico. Ulteriore esempio di questa
tendenza concettuale e compositiva è – secondo Mario Bortolotto – «la più riuscita delle sue
composizioni elettroniche»[15], Thema (Omaggio a Joyce), elaborazione elettroacustica della voce
di Cathy Berberian su nastro magnetico con testo di James Joyce, lavoro realizzato nel 1958.
Thema, brano per quattro canali (quindi, quattro altoparlanti) della durata di poco più di 6 minuti, è
una pietra miliare nella storia della musica elettroacustica ed è anche un’opera rappresentativa di un
particolare modo – italiano – di prendere parte alla ventata elettroacustica dell’avanguardia
musicale degli anni Cinquanta.
Con Thema, dopo l’esperienza fatta da Stockhausen con il suo Gesang der Jünglinge (1955-56),
Berio, attraverso il lavoro su contaminazioni prodotte dall’intreccio di mezzi e di sistemi espressivi
diversi, rimette al centro il rapporto tra parola e suono, tra linguaggio narrativo e linguaggio
musicale, senza utilizzare alcun suono propriamente elettronico, ma elaborando segnali vocali
registrati, frasi, parole e fonemi isolati. Thema quindi è tutto giocato sul rapporto tra suono e parola
e risponde a una precisa tendenza: «esplorare e assorbire musicalmente l’intera faccia del
linguaggio»[16].
Berio ha ammesso di essere stato sempre «molto sensibile, forse troppo, all’eccesso di connotazioni
che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. La voce, dal rumore più insolente al canto più
squisito, significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di
associazioni: culturali, musicali, quotidiane, emotive, fisiologiche, ecc.»[17]. E il fascino, l’incanto
della voce di cui Berio è vittima, emerge con chiarezza in lavori successivi a Thema, come
l’“acusmatico” Visage (1961), ma anche Epifanie, Circles, Passaggio (1961-62), Folksongs e
Sequenza III (1965-66).
Ma torniamo alla storia di Thema. Tra il 1958 e il 1959, mentre Berio era impegnato nelle sue
ricerche sul suono, Umberto Eco – due piani sotto lo Studio di fonologia – lavorava su Joyce e
spesso passava la sera a casa Berio, con Luciano e Cathy (mezzosoprano, compositrice e, in quegli
anni, moglie di Berio), leggendo pagine dello scrittore irlandese. Di lì «è nato un esperimento
sonoro il cui titolo originale era Omaggio a Joyce, una sorta di trasmissione radiofonica di
quaranta minuti in cui si iniziava leggendo il capitolo 11 dello Ulysses (quello detto delle Sirene,
un’orgia di onomatopee e allitterazioni), in tre lingue, in inglese, nella versione francese e in quella
italiana; ma poi, siccome Joyce stesso aveva detto che struttura del capitolo era la fuga per
canonem, Berio iniziava a sovrapporre i testi a modo di fuga, prima l’inglese sull’inglese, poi
l’inglese sul francese e così via […]»[18].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Omaggio a Joyce: documenti sulla qualità e onomatopeica del linguaggio poetico sarebbe dovuta
essere una trasmissione radiofonica – mai andata in onda – di circa quaranta minuti, nella quale si
iniziava leggendo il capitolo xi dello Ulysses (1922) di Joyce, un capitolo che – come ha dichiarato
lo stesso autore – ha la struttura della fuga per canonem. E questo ha molto interessato Berio che ha
iniziato così a pensare a come poter combinare la lettura del capitolo, che si sarebbe dovuta
svolgere utilizzando tre versioni: inglese, francese (nella traduzione di Joyce e Valery Larbaud) e
italiana (nella traduzione di Eugenio Montale). Bisognava però gradualmente allontanarsi dalla
espressione enunciativa, lineare del testo, dalla sua condizione significativa, considerando gli aspetti
fonetici e come questi potevano essere trasformati elettroacusticamente. In definitiva: su una
struttura intrinsecamente musicale si inserisce il genio di Berio, che ha iniziato a sovrapporre i testi,
a modo di fuga.
Abbiamo già detto come il testo di Joyce fosse intrinsecamente musicale. Ma c’è anche dell’altro.
Gli sviluppi della poesia tra Ottocento e Novecento sembrano, agli occhi di Berio, condividere
alcuni aspetti con gli sviluppi della musica. Sia l’una che l’altra sono meno circoscritte nei loro
mezzi e meno caratterizzate dai propri rispettivi procedimenti. Non riconosciamo “poesia” solo nel
procedimento della versificazione così come non riconosciamo “musica” esclusivamente all’interno
di parametri prestabiliti da una qualsiasi cultura musicale. All’emancipazione e isolamento della
parola corrisponde, in musica, l’emancipazione e l’isolamento del suono. Vi è inoltre, nei due
ambiti, un’analoga nuova sensibilità verso lo spazio, capace di offrire inedite aperture espressive.
Per quanto possa sembrare esagerato, scrive Berio, si è avuto un progressivo avvicinamento del
«lettore di versi» all’«interprete di musica», quanto meno rispetto al fatto che «ambedue, per
realizzare uno dei numerosi risultati possibili, sono obbligati ad una adesione totale, di coscienza,
all’opera»[19].
Oltre a queste analogie, a questa prossimità, vi è un altro elemento d’interesse. La poesia è anche un
«messaggio verbale distribuito nel tempo» e, rispetto a questa definizione e alle proprietà che le
pertengono, la registrazione e i mezzi della musica elettronica possono offrirne un’idea più reale e
concreta di quanto possa fare una pubblica e teatrale lettura di versi. Partendo da queste premesse,
Berio ha tentato «di verificare sperimentalmente una nuova possibilità di incontro tra la lettura di un
testo poetico e la musica, senza per questo che l’unione debba necessariamente risolversi a
beneficio di uno dei due sistemi espressivi: tentando, piuttosto, di rendere la parola capace di
assimilare e di condizionare completamente il fatto musicale»[20].
Nel periodo in cui Berio ipotizzava e lavorava su questo progetto, si poteva solo immaginare che un
giorno si sarebbe potuto arrivare, lungo questo percorso, alla realizzazione dell’ormai mitico
“spettacolo totale”, nel quale forme espressive diverse potessero annullare ogni gerarchia e si
attivassero e combinassero reciprocamente in un unico e unitario sviluppo. Non si trattava di una
fusione, giacché qui la musica e la lettura «dànno un risultato che par irripetibile, e non apre certo
alcuna strada alla questione vessata del rapporto col testo nella Nuova Musica»[21].
Alla luce di queste considerazioni, si comprende come la registrazione e i mezzi della musica
elettronica potevano essere strumenti efficaci per offrire un’idea più reale e concreta di quanto
possa fare ad esempio una lettura di versi pubblica. Inizia così l’esperienza di Thema.
Ma quali sono state le operazioni compiute da Berio? Egli ha utilizzato inizialmente una voce
femminile per il testo in inglese e due voci maschili per i testi in francese e in italiano. Seguendo
l’andamento del testo di Joyce, ha sovrapposto per tre volte la lettura in inglese a se stessa,
iniziando però a introdurre il riverbero, ma anche apportando delle prime modifiche sui rapporti di
tempo e dinamici, in maniera continua, come in un moto pendolare. Al testo in francese ha aggiunto
una seconda lettura, utilizzando però una voce femminile che andava a sovrapporsi a quella
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
maschile, a sua volta già sovrapposta a se stessa. Ultimo passaggio di questa prima fase di
montaggio è stata la sovrapposizione della lettura del testo in italiano, utilizzando due voci maschili
e una femminile (le voci erano quelle della Berberian, di Eco, Nicoletta Rizzi Marise Flach,
Ruggero De Daninos e Furio Colombo).
Era fondamentale per Berio andare oltre la semplice dizione dei versi, così da liberare la polifonia
latente del testo. Il procedimento utilizzato è stato una combinazione delle tre lingue piuttosto
semplice, che prevedeva il loro scambio in punti ben precisi, individuati con criteri di somiglianza o
di contrasto. Questo passaggio da una lingua all’altra avviene in maniera più o meno rapida, a
seconda della lunghezza dei segmenti di testo utilizzati. L’aspetto interessante è che, una volta che
il meccanismo di passaggio si è stabilizzato, questo passaggio non viene più percepito
dall’ascoltatore come una transizione da un contesto a un altro, ma come un’unica funzione
musicale. E così – come ha scritto Berio nelle note all’opera – accade che «attraverso una selezione
e una riorganizzazione degli elementi fonetici e semantici del testo di Joyce, la giornata di Mr.
Bloom a Dublino (sono le quattro del pomeriggio, all’Ormond Bar) prende una direzione diversa in
cui non è più possibile distinguere tra parola e suono, tra suono e rumore, tra poesia e musica, ma
dove ancora una volta diveniamo consapevoli della natura relativa di queste distinzioni e dei
caratteri espressivi delle loro cangianti funzioni».
Quello che percepiamo all’ascolto, ovviamente, è il risultato di una serie di operazioni tecniche, che
non possono essere colte dall’orecchio, per quanto esperto. Ho accennato alle prime e cioè alla
sovrapposizione e alla combinazione delle letture nelle tre lingue. Ma a Berio interessava
«moltiplicare e accrescere la trasformazione dei colori vocali proposti da una sola voce, scomporre
le parole e riordinare con criteri differenti il materiale vocale risultante», procedendo con
un’ulteriore selezione del materiale musicale. Viene ripresa la registrazione del testo inglese, in
particolare vengono riprese quasi tutte le parole, che vengono ora classificate e unite in accordi
secondo una sorta di serie, che Berio definisce «scala di colori vocali», che va dalla A alla U,
dittonghi compresi. Attraverso una costante variazione di velocità, Berio ha cercato di accentuare la
continuità di questa scala, senza però mai snaturare i singoli caratteri vocali. Il risultato
dell’elaborazione è stato un forte allontanamento dal meccanismo naturale della produzione vocale,
creando così degli accostamenti di consonanti, ad esempio, che il nostro apparato vocale avvicina
con notevole difficoltà (b-p, t-d, t-b, ch-g).
Un altro intervento ancora è stato di tipo ritmico. Nella discontinuità ritmica complessiva, Berio ha
introdotto degli elementi periodici tratti dal testo francese, ma anche la “r” italiana della frase
“morbida parola”. Attraverso l’utilizzo di questi elementi, Berio riesce a rendere più fluida la
transizione tra vocali e consonanti, superando così ogni frattura e distinzione tra suono e rumore.
Berio ha lavorato anche sulle variazioni di durata e di frequenza. L’obiettivo era quello di far venire
fuori nuovi rapporti all’interno del materiale e avvicinarsi il più possibile alla trasformazione
naturale dei suoni vocali, ad esempio il passaggio dalla S (che è un po’ il colore di fondo di tutto il
pezzo e che si percepisce chiaramente in diversi punti del brano[22]) alla F, dalla F alla V e così
via.
L’obiettivo di Berio non era quello di mescolare due diversi sistemi espressivi, quanto quello di
creare un rapporto di continuità tale che si potesse rendere possibile «il passaggio da uno all’altro
senza darlo ad intendere, senza rendere palesi le differenze tra una condotta percettiva di tipo
logico-semantico (quello che si adotta di fronte ad un linguaggio parlato) e una condotta percettiva
di tipo musicale, cioè trascendente e opposta alla precedente sia sul piano del contenuto che sul
piano sonoro»[23]. Secondo Chadabe, «Thema è rilevante in quanto la miriade di suoni dettagliati
presenti sono derivati dal testo. Infatti, la trama di Thema, il suo ritmo e il suo trattamento dei suoni
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
e dei significati delle parole e dei fonemi, procede in parallelo ed estende la musicalità del testo di
Joyce»[24].
Come rileva Enrico Fubini, in riferimento al rapporto tra poesia e musica nel Novecento,
l’attenzione al testo, da parte dei compositori, diviene direttamente proporzionale al suo essere
totalmente assorbito e disciolto nel suono e come suono[25]. Le intenzioni di Berio erano tutt’altro
che semplici da realizzare, tanto più che nella resa concreta del rapporto di continuità, del passaggio
tra i due sistemi espressivi senza darlo a vedere, si correrà sempre il rischio di privilegiare una
dimensione rispetto all’altra. «Evidentemente la “trasfusione” – come dice Boulez – da poesia a
musica si opera a vari livelli del linguaggio e del significato; il risultato è pur sempre una sintesi o
un tentativo di sintesi anche se […] sbilanciata in una o nell’altra direzione»[26]. Berio era convinto
che vi fosse comunque un’insuperabile divergenza tra musica e poesia. Perfino in casi di
eccezionale conformità, come nei Lieder tedeschi, quando ci troviamo di fronte a un miracolo di
accordo quasi spontaneo fra struttura musicale e struttura poetica, rimaniamo consapevoli delle
divergenze, di un disaccordo espressivo tra il disegno musicale e il disegno poetico, tra strofe
musicali e strofe poetiche, tra metro e rima, tra modi musicali e stati d’animo poetici[27].
L’esperimento di Berio sembra voler rimodulare il rapporto tra musica e parola poetica,
immaginando tale rapporto come un procedimento maieutico, dal quale possa scaturire la spontanea
musicalità e polifonia della materia poetica (nella quale tutto è già implicito) e la nuova poeticità
che i mezzi elettroacustici possono far emergere. Detto questo, va però anche tenuto presente che
gli esiti “teatrali” di questo filone della ricerca contemporanea hanno assunto una connotazione
nostalgica rispetto agli elementi di ritualizzazione e, al contempo, di desemantizzazione, come nel
caso di Stockhausen.
Se questo è lo schema e il contesto concettuale all’interno del quale prende forma Thema. Omaggio
a Joyce, vorrei concludere sottolineando un ultimo importante aspetto. Credo che questo lavoro di
Berio, come egli stesso, in fondo, ha tenuto a rilevare, rappresenti un po’ il manifesto di una poetica
e di una visione della musica e della sua funzione.
Thema, ha dichiarato Berio, «è stata un’esperienza fondamentale che conteneva i semi di molti altri
sviluppi. In realtà, dopo essermi occupato di Joyce, di questo specifico lavoro, mi sono interessato
molto di più alle miracolose relazioni tra suono e significato. Il mio successivo lavoro per nastro,
Visage, composto nel 1961, approfondisce questi significati, collegando alcuni aspetti del
linguaggio (stereotipi, gesti e materiale non verbale) con la musica elettronica»[28]. Ma non è tutti
qui. Il Maestro Berio, anche attraverso quest’opera, ha comunicato un’intenzione forte, vale a dire il
superamento del rapporto conflittuale tra suono naturale e suono sintetico, richiamando la necessità
di «purificare i nostri costumi musicali da ogni residuo dualistico». Ma perché ciò possa avvenire, è
necessario che ogni esperienza che coinvolge compositore, interprete e ascoltatore (sempre più
partecipante) passi attraverso un contatto vivo e permanente con la materia sonora e «non attraverso
le sue suggestioni superficiali o attraverso le divagazioni schematiche di qualche malinteso pseudoseriale: di per sé i procedimenti seriali non garantiscono assolutamente nulla: è sempre possibile
serializzare delle pessime idee come è anche possibile versificare pensieri stupidi»[29]. Per ottenere
ciò, però, occorre appunto superare la frattura tra suono sintetico e suono strumentale. È molto
chiara, in Berio, l’intenzione di rifiutare la contrapposizione tra musica elettronica e musica
strumentale. E non si tratta di un rifiuto che rinvia a questioni tecniche, quanto a valutazioni di
ordine concettuale. Nel mantenimento di questa divaricazione, nel pervicace impegno a restare
legati a siffatta dicotomia, Berio intravedeva un grave rischio, quello della separazione di musica e
pensiero, di musica e significato. Da ciò deriva la necessità di riflettere (e far riflettere) con
maggiore lucidità e distacco sulle ricadute concettuali, culturali, estetiche della nuove tecnologie
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
sulla vita musicale. Esse consentono un inaspettato ampliamento del «vocabolario acustico», che
però deve essere preceduto e sostenuto da un pensiero musicale capace di renderlo nuovo[30].
E allora Thema lo possiamo intendere come un manifesto, sì, ma anche come un appello: alla fine
degli anni Cinquanta del xx secolo, Berio – il cui pensare in musica era «costituzionalmente
differente»[31] – invita i compositori ad allargare i propri mezzi musicali, senza distruggere nulla,
facendo sì, anzi, che le scelte personali dei compositori possano continuare a fare da ponte tra una
forma e una materia sempre nuove. Ma a un tale rinnovamento – prosegue Berio – si legano anche i
nostri problemi spirituali, se è vero che esso è (e deve essere) il segno di un rinnovamento della
coscienza, non solamente musicale, degli individui[32].
Torna, ciclicamente e quasi ossessivamente, una tensione etica, una spinta propulsiva verso l’umano
che senza soluzione di continuità segna in modo inequivocabile l’opera e, forse ancor di più e
principalmente, il pensiero musicale di Berio. Non si tratta di moralismo, di pedante tentativo di
assegnare all’arte e alla musica un ruolo e un compito che non possono avere nell’immediato. Esse
riescono però a educare l’uomo (anche in senso schilleriano, se vogliamo), allo scopo di
trasformarlo da individuo isolato in essere sociale, ponendolo in condizione di sviluppare la propria
esistenza in rapporto e in collaborazione con lo sviluppo di quella altrui. Le arti possono contribuire
in maniera decisiva ad affermare il primato di valori non negoziabili: libertà, dignità umana,
eguaglianza dei diritti, giustizia. Questo però a patto che – richiamando Theodor W. Adorno – la
cultura abbandoni il carattere quasi religioso di cui spesso si è ammantata, un carattere falsamente e
inutilmente consolatorio e, per ciò stesso, ideologico. Si tratta sì di una «promesse du bonheur», ma
pur sempre di una promessa che non può e non deve essere mantenuta.
Le celebrazioni per i dieci anni dalla scomparsa di Luciano Berio, uno dei protagonisti principali e
indiscussi della storia della musica e della cultura contemporanee, offrono perciò la possibilità di
riproporre e ricostruire alcuni degli aspetti che ne hanno contraddistinto in maniera unica il percorso
di ricerca e la poetica, ma consentono anche di ripensare alcune questioni relative alla capacità che
la musica e la cultura hanno di dire qualcosa all’uomo contemporaneo su se stesso, sul proprio
passato e, soprattutto, sul proprio futuro.
* Per alcune parti di questo contributo, ho avuto come riferimenti i contenuti della lezione di
musica dedicata a Thema. Omaggio a Joyce da me tenuta per il programma di Radio3 «Lezioni di
musica» (a cura della redazione di Radio3 Suite), andata in onda il 26 maggio scorso, e il mio
volume Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica, EDT, Torino 2013. Ringrazio,
inoltre, la compositrice Alba Francesca Battista, con la quale ho a lungo e proficuamente discusso
su questo “tema”.
NOTE
[1] Sulla figura e l’opera di Luciano Berio vi è un’ampia letteratura. Oltre ai riferimenti presenti in
queste pagine, mi limito a segnalare D. Cohen-Lavinas, Omaggio a Luciano Berio, avec le soutien
de l’Ensemble Itinéraire, l’Hartmann, Paris 2006; G. Morelli, Luciano Berio, in «Belfagor», vol.
lxiv/2, 2009, pp. 122-146; C. Di Luzio, Vielstimmigkeit und Bedeutungsvielfalt im Musiktheater von
Luciano Berio, Schott, Mainz 2010. Di recente, poi, è stato pubblicato un volume che si pone come
un preziosissimo strumento di conoscenza e di approfondimento dell’attività e del pensiero
musicale di Berio, articolato in sei aree tematiche: il modo di intendere il concetto di musica; le
prospettive sul processo compositivo; la concezione della forma; l’interazione tra voce, parola e
gesto; il rapporto tra pensiero elettronico e strumentale; il dialogo con le altre culture musicali: A.I.
De Benedictis, Luciano Berio. Nuove prospettive – Luciano Berio. New Perspectives, Atti
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
dell’omonimo convegno, Siena, Accademia Chigiana (28-31 ottobre 2008), in «Chigiana», vol.
xlviii, Leo S. Olschki, Firenze 2012.
[2] F. D’Amico, La musica contemporanea non è una, in Id., I casi della musica, il Saggiatore,
Milano 1962, pp. 507-13: 508.
[3] Ivi, pp. 511-2.
[4] Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro. Lezioni americane (2006), a cura di T. Pecker Berio,
Einaudi, Torino 2006, p. 5.
[5] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», in Id., Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica
(1969), Einaudi, Torino 1976, pp. 128-48: 128.
[6] Scrive Joel Chadabe: «rispetto all’approccio rigoroso della musique concrète dello studio di
Parigi e alla rigorosa filosofia serialista degli inizi dello studio di Colonia, lo studio di Milano non
era vincolato ad alcuna particolare ideologia o metodo. [...] Allo stesso tempo, le idee musicali di
Berio oltre ad aver rappresentato un riferimento iniziale per il suo successivo lavoro hanno fornito
una sorta di personalità, si potrebbe dire, per lo studio in generale» (J. Chadabe, Electric Sound.
The Past and Promise of Electronic Music, Prentice Hall, Upper Saddle River 1997, p. 48; trad. it.
mia).
[7] Cfr. F.K. Prieberg, Musica ex machina (1960), trad. it. di P. Tonini, Einaudi, Torino 1963, p.
147.
[8] Si tratta di un ritratto sonoro della città di Milano dal mattino a tarda notte, uno «schizzo
sonoro», come l’ha definito Fred Prieberg, costituito essenzialmente da suoni sinusoidali, brevi
rumori e una voce recitante, a cui si alternavano improvvise impennate rumoristiche. «Complessi
elettronici, rumori di ogni giorno in forma denaturata copiati dalla vita, suoni filtrati e il testo del
recitante si mescolavano in un originale e sempre efficace reportage che spesso raggiunge la qualità
lirica della vera poesia» (ivi, p. 155). Era, tuttavia, un lavoro d’esordio, per certi aspetti debole e
con qualche squilibrio.
[9] Va comunque detto che questa dualità è stata meno netta rispetto a quanto viene generalmente
sostenuto. La superficialità della contrapposizione tra l’elettronica pura di ascendenza
stockhauseniana e la musica concreta francese di derivazione schaefferiana (fatte salve certe
evidenti differenze) è confermata dallo stesso Stockhausen, il quale si è rivelato, in fondo, un
compositore concreto, elettronico e acusmatico insieme (cfr. K. Stockhausen, J. Kohl,
Electroacoustic Performance Practice, in «Perspectives of New Music», Vol. 34, No. 1, Winter,
1996, pp. 74-105.)
[10] F. Galante, N. Sani, Musica espansa. Percorsi elettroacustici di fine millennio, Ricordi-Lim,
Milano 2000, p. 75.
[11] Cfr. F. Giomi, D. Meacci, K. Schwoon, Live Electronics in Luciano Berio’s Music, «Computer
Music Journal», Vol. 27, No. 2 (Summer, 2003), pp. 30-46: 30.
[12] Cfr. A. Cremaschi, F. Giomi, “Parrrole”: Berio’s Words on Music Technology, in «Computer
Music Journal», Vol. 28, No. 1 (Spring, 2004), pp. 26-36: 33.
[13] F. Galante, N. Sani, Musica espansa, cit., p. 82.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[14] Ivi, p. 83.
[15] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., pp. 140-1.
[16] L. Berio, Un ricordo al futuro, cit., p. 41.
[17] L. Berio, Intervista sulla musica, a cura di R. Dalmonte, Editori Laterza, Roma-Bari 20113, p.
102.
[18] U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee (1962),
Bompiani, Milano 2004, p. v; il corsivo è nel testo. Come ha dichiarato lo stesso Berio, egli era
«affascinato dall’intenso e ricco intreccio di significati presenti in quel capitolo e dalla relazione tra
l’esposizione e il loro pieno sviluppo» (L. Berio, Interview with Luciano Berio. Thema: Omaggio a
Joyce, in B. Schrader, Introduction to Electro-Acoustic Music, Prentice Hall, New Jersey 1982, pp.
179-83: 179).
[19] L. Berio, Poesia e musica - un’esperienza, in H. Pousseur (a cura di), La musica elettronica,
trad. it. di R. Bianchini e L. Lombardi, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 124-35: 125.
[20] Ibid.
[21] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., p. 141.
[22] Questo accade all’inizio, durante, ma soprattutto alla fine del lavoro, nei 16-17 secondi
conclusivi.
[23] L. Berio, Poesia e musica - un’esperienza, cit., pp. 125-6.
[24] J. Chadabe, Electric sound, cit., p. 50.
[25] E. Fubini, «Da Wagner a Stockhausen: musica e parola, evoluzione di un problematico
incontro», in Id., Il pensiero musicale del Novecento, ETS, Pisa 2007, p. 71.
[26] Ibid.
[27] Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro, cit., p. 39.
[28] L. Berio, Interview with Luciano Berio, cit., p. 182.
[29] L. Berio, Poesia e musica - un’esperienza, cit., p. 134.
[30] Su questo, cfr. A. Cremaschi, F. Giomi, “Parrrole”: Berio’s Words on Music Technology, cit.,
p. 29.
[31] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., p. 132.
[32] L. Berio, Poesia e musica - un’esperienza, cit., p. 135.
Giacomo Fronzi (1981), laureato in Filosofia (Lecce) e in Musicologia (Venezia), dottore di
ricerca, diplomato in pianoforte, svolge attività di ricerca presso la cattedra di Estetica
dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Theodor W. Adorno. Pensiero
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una rivoluzione lunga cent’anni (Mimesis 2012),
Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica (EDT 2013).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Le promesse della Costituzione
di LUIGI PANNARALE
Le costituzioni sono la soluzione del grande paradosso che caratterizza il diritto dell’età moderna,
che consiste nel rendere possibile l’esercizio della libertà come delimitazione che continuamente
riapre possibilità di azione. Attraverso la costruzione dell’asimmetria tra legge costituzionale e
legge ordinaria il diritto può fondarsi su se stesso e trovare una giustificazione plausibile al fatto
che il diritto non può violare i diritti. La nostra Costituzione sembra, tuttavia, afflitta da uno strano
destino: per molto tempo è stata considerata troppo proiettata verso il futuro e di difficile
attuazione, per essere poi troppo presto considerata invecchiata a differenza di altre costituzioni
che, invece, sembrano sopportare con disinvoltura il trascorrere dei secoli.
1. Ambivalenza delle costituzioni
Il concetto di costituzione contiene in sé un’ambivalenza, in quanto appartiene
contemporaneamente al linguaggio della politica ed a quello del diritto.
La nascita delle moderne costituzioni è strettamente connesso con il processo di positivizzazione e
di secolarizzazione del diritto e, in tale processo, trova la sua principale giustificazione. Il diritto
deve, infatti, cercare nuovi fondamenti alla propria legittimazione, che d’ora innanzi si
caratterizzerà come auto-legittimazione.
Attraverso il concetto di costituzione sistema politico e sistema giuridico cercano risposte adeguate
a problemi equivalenti. Per la politica l’affermazione che lo Stato è il creatore del diritto e che il
diritto trova il suo fondamento nello Stato, implica inevitabilmente la necessità di spiegare perché le
decisioni dello Stato abbiano il carattere della vincolatività, in che cosa consista questa
vincolatività, quali siano i suoi destinatari e se, fra essi, sia ricompreso lo Stato medesimo. Per il
diritto, che segue una via opposta ma simmetrica, il problema è quello di spiegare perché lo Stato
abbia la potestà di comandare ed i sudditi abbiano il dovere di obbedire, ovvero perché e come
possa esistere una norma che attribuisce allo Stato una simile potestà e fa gravare sui sudditi un
siffatto dovere[1].
La costituzione non è, dunque, un meccanismo che esaurisce nella sfera politica il proprio ambito
d’azione. Attraverso la costituzione diviene pensabile un controllo giuridico della politica: il
giudizio di costituzionalità sulle leggi trasferisce dalla sfera politica alla sfera giuridica il potere di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
controllo del sistema politico e risolve il problema di un tale controllo attraverso il diritto. Il
riferimento alla costituzione consente di comunicare giuridicamente sull’attività politica,
distinguendo tra lecito e illecito, tra diritto e non-diritto. Non basta più assicurarsi un più o meno
largo consenso nei confronti delle decisioni, perché vi sono dei limiti esterni alla potestà politica di
decidere ed essa può essere illegittima, ancorché suffragata da un ampio consenso popolare. Vero è
che anche la costituzione può essere cambiata, ma soprattutto le costituzioni rigide prevedono delle
procedure di revisione tali da non consentire che i cambiamenti avvengano in modo troppo
disinvolto e sulla base di emozioni momentanee; inoltre tra gli stessi costituzionalisti si discute
molto circa l’individuabilità di un nucleo ristretto di norme, che si sottraggano ad ogni procedura di
revisione, perché il loro cambiamento modificherebbe così radicalmente la natura stessa dello Stato,
da dover essere considerato un atto rivoluzionario più che di semplice modifica della costituzione.
Considerazioni analoghe valgono anche in riferimento alla funzione che la costituzione ha per lo
stesso sistema giuridico.
La positivizzazione consente di mettere in dubbio il potere vincolante del diritto o, quanto meno, di
porsi il problema del fondamento di legittimazione di quel potere e dell’uso della forza che lo
sostiene. Nella tradizione liberale lo Stato di diritto ha il compito di filtrare le azioni precarie della
politica (relative agli interessi) attraverso il diritto. Lo Stato di diritto costituisce la formula
attraverso la quale il sistema giuridico osserva il sistema politico e cerca di controllare le modalità
secondo cui quest’ultimo costruisce una relazione con il suo ambiente sociale. Da tale prospettiva il
carattere distintivo dell’ordinamento statuale, rispetto ad ogni altra forma di ordinamento,
consisterebbe nella sua positività.
Il punto di osservazione del sistema giuridico non è, tuttavia, l’unico dal quale sia possibile
osservare il processo di positivizzazione del diritto. Se si assume la prospettiva del sistema politico,
la giuridificazione costituisce allo stesso tempo una restrizione ed un potenziamento delle decisioni
politiche: il diritto si presta ad essere strumentalizzato dalla politica, ma allo stesso tempo restringe
l’ambito delle possibilità e degli strumenti che la politica può utilizzare di volta in volta per il
raggiungimento dei propri scopi. Inoltre, come è stato teorizzato dalle teorie dell’implementazione,
il sistema giuridico si assume il rischio di scegliere strumenti giuridici non idonei al raggiungimento
dei propri scopi. Non è un caso, quindi, che la semantica della decisione abbia avuto bisogno di una
giustificazione per legittimare un atto di volontà troppo semplificato rispetto alla complessità del
codice politico (soggetti, interessi, obbedienza-resistenza-comando).
La costituzione può, dunque, essere considerata la forma più diffusa e abituale di reazione del
sistema giuridico alla propria autonomia, attraverso la quale esso cerca di rimpiazzare quei sostegni
esterni che erano stati postulati dal giusnaturalismo. La costituzione è in grado di stabilire una
gerarchia delle norme giuridiche, di sancire le condizioni della sua mutabilità e persino della sua
immutabilità, ma soprattutto consente un’applicazione riflessiva della differenza tra legittimo e
illegittimo al diritto stesso, poiché anche le norme giuridiche possono essere (costituzionalmente)
legittime o illegittime.
Attraverso la costruzione dell’asimmetria tra legge costituzionale e legge ordinaria è possibile
interrompere la regressio ad infinitum per la ricerca di un fondamento esterno, il diritto può fondarsi
su se stesso e trovare una giustificazione plausibile al fatto che il diritto non può violare i diritti.
Tuttavia tale asimmetria può reggersi a condizione che ne sia occultato il carattere autologico: “il
codice diritto – non diritto genera la costituzione, perché la costituzione generi il codice diritto –
non diritto”[2]. La soluzione del problema ha un carattere meramente operativo e le sue
giustificazioni teoriche non possono che costituire il tentativo di descrivere come necessario (o
naturale), ciò che è contingente (o artificiale).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
2. Il futuro passato della Costituzione italiana
Rispetto a questo quadro generale, la nostra Costituzione presenta alcune specificità, sia perché essa
è una costituzione scritta alla metà del XX secolo, sia e soprattutto perché essa pone fine alla tragica
esperienza del fascismo e sancisce il ripristino della democrazia.
Subito dopo la sua promulgazione si pose, infatti, il problema di quali conseguenze essa avrebbe
dovuto avere sulla normativa previgente, soprattutto su quella del periodo fascista. A tale riguardo
un ruolo determinante fu svolto dalla Corte di cassazione, che da un lato ribadì l’antico principio
secondo cui il giudice non ha la potestà di disapplicare la legge sotto pretesto della sua
incostituzionalità, dall’altro operò la nota distinzione tra norme “precettizie” (a loro volta complete
o incomplete) e norme “programmatiche”, attraverso la quale poteva rinviare sine die l’effettività
di una buona parte delle norme costituzionali[3].
Questa scelta interpretativa, però, non fu soltanto il frutto di un’ideologia di stampo conservatore,
ma anche la conseguenza della novità costituita dall’introduzione dei “diritti sociali” accanto ai più
tradizionali diritti di libertà. La Costituzione, infatti, non si è limitata a restaurare i diritti liberali,
ma si è spinta a realizzare un’idea di cittadinanza, in cui il cittadino è visto in rapporto ai suoi
legami sociali, in cui si fa strada il dovere di solidarietà: i diritti sono stati liberati dal sospetto del
privilegio. La Costituzione non rappresenta più la garanzia di un ordine dato, ma il punto di
partenza di un processo continuo, di un programma da realizzare, che è immerso esso stesso nelle
contraddizioni della società e corre continuamente il rischio del fallimento.
Tanto più che tra i classici diritti di libertà e i diritti sociali vi è pure una differenza non trascurabile
sotto il profilo economico: mentre la soddisfazione dei primi normalmente non costa nulla allo
Stato, la soddisfazione dei secondi non è soltanto una questione politica, ma anche una questione
finanziaria. Lo stesso Calamandrei evidenziò questa differenza, già alla vigilia della Costituente:
“quando avremo consacrato in lapidari articoli, come programma minimo di civile convivenza
democratica, quei ‘diritti sociali’ senza i quali tutti siamo convinti che non può esistere per il
cittadino vera ed effettiva libertà politica, avremo il dovere di domandarci sinceramente quale potrà
essere il significato pratico di quella proclamazione; quali mezzi avrà la nuova democrazia per
tradurla in realtà; quali speranze non illusorie potrà il povero fondare su quelle solenni promesse di
redenzione sociale […]. Quando ci accingeremo a risolvere il problema della giustizia sociale, forse
dovremo mestamente accorgerci che ci sarà consentito soltanto di porgere alcune premesse:
formulare in articoli promesse consolatrici, segnare mete che servano di faro al cammino dei figli e
dei nipoti; e intanto limitarci ai primi passi, a chiedere a chi soffre di continuare, chissà per quanto,
a soffrire”[4].
Incominciare a prendere sul serio i principi costituzionali fu, perciò, lo strumento attraverso il quale,
a partire dalla seconda metà degli anni ’60, parte della magistratura e del ceto dei giuristi
incominciarono a porsi il problema di un uso alternativo del diritto, che mettesse in discussione il
vecchio formalismo e individuasse nuovi modelli interpretativi più attenti all’evoluzione della realtà
sociale ed ai conflitti in atto nella stessa.
La riformulazione del principio di legalità attraverso l’individuazione di una norma
gerarchicamente sovraordinata introduce, però, anche la possibilità di operazioni di tipo riflessivo:
la distinzione tra diritto e non diritto può essere applicata al diritto stesso. Si pensi, ad esempio, al
caso in cui la clausola che regola gli emendamenti costituzionali venga usata per emendare se
stessa, ovvero al dibattito sulle possibili modifiche alla Costituzione e al tentativo di immunizzare
almeno una parte delle norme costituzionali dalla possibilità di venire modificate, introducendo un
ulteriore gerarchizzazione tra norme costituzionali pure e semplici e principi fondamentali o “diritti
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
supercostituzionali”, i quali come tali devono essere rispettati dallo stesso potere costituente e
salvaguardati anche contro gli attentati provenienti da esso.
La crisi dello Stato di diritto di stampo ottocentesco e il passaggio allo Stato costituzionale segna
contemporaneamente il passaggio dal principio di legalità al principio di legalità costituzionale, che
pone al di sopra della legge, appunto, la Costituzione, destinata ad essere rigida, alla quale viene
attribuito il compito di sottrarre alla decisione politica e all’onnipotenza dei soggetti rappresentativi
aspetti quali la configurazione del potere pubblico, la sua organizzazione interna, la struttura dei
suoi organi e ogni tipo di rapporto tra governanti e governati. Sulla base di questa distinzione di
compiti le leggi ordinarie sono quelle che servono a regolare i rapporti tra i cittadini nella loro
quotidianità: quelle che servono a governare secondo legalità la concreta vita sociale. Ma queste
leggi ordinarie presuppongono l’esistenza e il funzionamento di organi di governo, che non solo le
applichino, ma via via le modifichino e le rinnovino secondo il continuo rinnovarsi delle esigenze
pubbliche; a loro volta questi organi di governo presuppongono l’esistenza di leggi, che abbiano
fissato in anticipo la loro struttura e il loro modo di funzionare e abbiano distribuito tra essi
l’esercizio della sovranità: queste ultime leggi si dicono appunto “costituzionali”.
3. La Costituzione tra stabilità e mutamento
Solo che anche questo modello si è presto mostrato insufficiente, poiché l’agognata unità del
sistema è continuamente rimessa in discussione dal carattere positivo delle stesse norme
costituzionali. Se la Costituzione deve servire a garantire l’unità del sistema[5], essa non può
ignorare e, anzi, deve presupporre le sue divisioni e le sue incoerenze. Proprio per questo le
costituzioni moderne non si presentano più semplicemente come l’insieme delle regole sui poteri o
la definizione dei diritti fondamentali, ma sono utilizzate e comunicate come simboli: la
Costituzione italiana, ad esempio, è il simbolo del patto antifascista, però – come tutti i simboli –
rischia continuamente di diventare fragile ed invisibile.
L’improbabile unità dei sistemi giuridici, nonostante il ricorso alla differenziazione tra norme
ordinarie e norme costituzionali, trova una plausibile spiegazione nel fatto che, nelle società
pluralistiche, non è dato riscontrare la preventiva coagulazione di un ampio consenso sui cosiddetti
“valori fondamentali”. Le moderne costituzioni non sono più il frutto di un processo deliberativo
aperto, pienamente dispiegato, che coinvolga i principali gruppi, corpi costituiti e rappresentanti e
che implichi la disponibilità di ognuno a modificare la propria opinione iniziale alla luce degli
argomenti addotti dagli altri partecipanti e delle nuove informazioni raccolte; il caso più frequente
è, invece, quello della semplice accettazione del dissenso, senza alcun tentativo di mediare le
opinioni contrapposte[6]; non importa, infatti, che esse siano tra loro incompatibili, l’importante che
siano almeno ragionevoli[7]. Stanti l’incapacità di ciascun partecipante di imporre il proprio punto
di vista come egemonico e l’indisponibilità ad accettare come tale quello degli altri, appaiono più
probabili incontri di tipo tattico, che non strategico. È noto il giudizio di Calamandrei sull’assetto di
valori consacrato nella nostra Carta costituzionale: “per compensare le forze di sinistra di una
rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una
rivoluzione promessa”[8].
Il risultato compromissorio, che se ne deduce, evidenzia che l’ambiguità è un carattere essenziale
della democrazia del nostro tempo; esso accresce, anziché limitare gli spazi di creatività della legge
ordinaria, dal momento che sono sempre possibili combinazioni diverse dei principi costituzionali e
l’accordo sulla priorità di un determinato valore, raggiunto secondo il principio di maggioranza per
l’approvazione di una determinata legge, non è detto che valga anche per le leggi successive[9]. La
Costituzione, nonostante sia stata impostata come costituzione rigida, è allo stesso tempo una
costituzione dinamica, nella quale vi sono norme che, pur carenti di precettività, hanno
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
“un’efficacia educativa e quasi si direbbe pedagogica”, “un carattere puramente tendenziale”; si
tratta di una “costituzione che, se il popolo saprà civilmente volere, potrà accompagnarlo, senza
rinunciare a libertà, verso la giustizia sociale”[10].
Forse anche per questo accanto alla distinzione tra legge e costituzione, la dottrina
costituzionalistica ne individua operativamente un’altra, almeno in parte sovrapponibile, tra regole e
principi[11]. Mediante il riferimento ad una pluralità di principi, privi di una gerarchia formalmente
determinata, si cerca, allo stesso tempo, di concepire un diritto che sia più idoneo a garantire la
sopravvivenza di una società pluralista, la cui condizione è il continuo riequilibrio attraverso
transazioni di valore. Solo la virtù etica, infatti, è assoluta; tra i valori, invece, che sono
semplicemente ciò che è desiderabile, si può venire a patti. Il diritto per principi di valore consente
una relativizzazione dell’etica; e relativizzare un’etica non significa rinunziare ad avere una propria
visione del mondo, significa piuttosto avere la consapevolezza che la sopravvivenza del mondo è la
prima indispensabile condizione per realizzare qualsiasi progetto etico[12].
Parafrasando Elster, si può dire che, se i delegati della Convenzione federale di Filadelfia avevano
avuto come principale preoccupazione quella dell’avidità e dell’egoismo dei legislatori futuri e i
delegati dell’Assemblea costituente di Parigi si erano preoccupati soprattutto della loro vanità e
superbia, la Costituente italiana individuò nel dogmatismo arrogante e nello scetticismo
opportunista il motivo prevalente delle proprie scelte[13].
La soluzione di questo problema si è configurata come una continua oscillazione tra sostanzialismo
e proceduralizzazione (sia pure nella sua forma più moderna della legalità costituzionale), già
visibile nella concezione giuridico-politica della democrazia di Kelsen. È vero che, al contrario
dello Stato etico, lo Stato di diritto non impone alcun consenso ed anzi legittima il dissenso; ma
anch’esso non può non prevedere almeno un’eccezione, costituita dai diritti fondamentali, i quali
sono sottratti alla legalità procedurale e alla decisione del politico. Il problema è che anche lo Stato
di diritto è così costretto a presupporre condizioni forse possibili, ma altamente improbabili: prime
fra tutte la revocabilità e la prevedibilità di ogni decisione.
Sembra, perciò, tornare di attualità l’insegnamento di Constant e quella che è stata definita la
“teoria delusa” della costituzione: una carta costituzionale non è un patto progettuale per il futuro
in una società che ha deciso di emendarsi dalle oscurità del proprio passato, ma è una
secolarizzazione in termini giuridici dei meccanismi sociali dell’obbligazione politica; una
secolarizzazione giuridicamente pregnante ma politicamente debole, che contraddice
clamorosamente la pretesa dell’ordinamento giuridico alla stabilità, alla continuità o, comunque, ad
un mutamento entro limiti e secondo procedure prestabiliti. A partire da questa consapevolezza, i
principi di diritto costituzionale non possono più essere considerati principi di giustizia eterni ed
immutabili, che si affermano in forza della loro intrinseca eccellenza. “Un popolo ha sempre il
diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una generazione non può
assoggettare alle sue leggi le generazioni future” (art. 28 della Dichiarazione dei diritti del 1793).
Unico principio, al quale è possibile riconoscere una priorità in virtù del suo carattere più
universalistico, è il principio democratico: è questo principio, per i moderni Stati costituzionali, il
valore dei valori; l’unico valore assoluto che essi riconoscono e che rende, quindi, tutti gli altri
valori sempre contingenti e potenzialmente disponibili da parte della comunità democratica.
“La certezza ricade nella speranza; la legge che aveva la pretesa di decidere ‘il caso’ si scopre
‘caso’, a sua volta di un’altra legge”[14].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Solo che una tale consapevolezza, a mio avviso, è tutt’altro che “deludente”, perché ci conferma che
la lotta per i diritti non termina con la proclamazione di una costituzione, ma ha bisogno di un
impegno costante e quotidiano, perché quei diritti, una volta conquistati, siano anche difesi dai
continui attacchi di quanti vorrebbero imporre altre regole ed altre logiche alla nostra convivenza.
La presenza della Costituzione, per quanto rigida essa sia, non può rassicurarci una volta per tutte,
ma è piuttosto un punto costante di riferimento per un impegno sociale e politico che deve
rinnovarsi e arricchirsi di nuovi contenuti e di nuove motivazioni e che ci sprona ad essere parte
attiva nella attuazione di quei diritti, piuttosto che semplici eredi di quel patrimonio. Si tratta di una
sfida difficile, ma anche molto esaltante.
NOTE
[1] Luhmann N., Il diritto della società, Giappichelli, Torino 2012.
[2] Ivi, p. 474.
[3] Una critica di questa distinzione si trova in S. Rodotà, Ideologie e tecniche della riforma del
diritto civile, in “Rivista del diritto commerciale”, LXV (1967), pp. 83-125.
[4] P. Calamandrei, Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Vallecchi, Firenze 1995,
pp. 108-111,
[5] G. Zagrebelski, Il diritto mite, Einaudi, Torino 1992, pp. 2 sgg.
[6] A. O. Hirschman, Retoriche dell’intransigenza. Perversità, futilità, messa a repentaglio, Il
Mulino, Bologna 1991, p. 171.
[7] J. Rawls, Liberalismo politico, Comunità, Milano 1994.
[8] P. Calamandrei, Questa nostra Costituzione, Bompiani, Milano 1995, p. 8.
[9] G. Zagrebelski, Diritto costituzionale. I. Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Utet,
Torino 1997, p. 61.
[10] P. Calamandrei, Costruire la democrazia, cit., p. 7 sgg.
[11] V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano 1952.
[12] G. Zagrebelski, Il diritto mite, cit., p. 171.
[13] J. Elster, Argomentare e negoziare, Anabasi, Milano 1993, p. 8 e 66 sgg.
[14] E. Resta, La certezza e la speranza, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 92-93.
Luigi Pannarale è avvocato e professore ordinario di Sociologia del diritto nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Bari “A. Moro”. È componente del Consiglio Scientifico della
Società Italiana di Filosofia del Diritto, vicepresidente della Associazione di Studi “Diritto e
Società”, componente del direttivo dell’Italian Society for Law and Literature, direttore scientifico
del Centro Studi dell’Apulia Film Commission. Fa parte della Direzione scientifica della Rivista
“Sociologia del diritto” e del comitato scientifico di riviste nazionali e internazionali. Autore di
saggi e monografie, tra cui Il diritto che guarda (Franco Angeli 2012), Lezioni sui diritti
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
(Multipensa, 2010), Giustiziabilità dei diritti (Franco Angeli 2007). Ha tradotto e curato l’edizione
italiana di N. Luhmann, Diritti fondamentali come istituzione (Dedalo, 2002). Partecipa al progetto
"filosofia in movimento".
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Olismo o individualismo in Marx? Sull’ultimo libro di Ernesto
Screpanti, "Marx dalla totalità alla moltitudine (1841-1843)"
di LUCA BASSO
Nei testi fra il 1841 e il 1843 Marx comincia a elaborare una forma molto sofisticata di
individualismo, definibile come “istituzionale”. A torto, perciò, gli si continua ad attribuire
un’adesione al paradigma olistico ed hegeliano. Questa è la consapevolezza raggiunta nella sua
ricerca critica da Ernesto Screpanti, il quale si viene così avvicinando ad alcune delle più
sollecitanti traiettorie teoriche del post-althusserismo.
In passato, anche sulla base di un “cortocircuito” fra valutazione del marxismo e critica
dell’esperienza storica del socialismo reale, troppo spesso si è interpretato il senso complessivo del
discorso marxiano all’insegna di una sorta di olismo, a scapito del riconoscimento delle capacità e
delle facoltà individuali. Dall’altro lato, in particolare negli anni ’80, il marxismo analitico (Elster,
Roemer…) ha fortemente valorizzato l’approccio dell’individualismo metodologico – seppur
mitigato da politiche di redistribuzione sociale –, sottolineandone una potenziale compatibilità con
la prospettiva delineata da Marx, e nello stesso tempo mettendo in luce, di quest’ultima, una serie di
limiti e di possibili “cadute” olistiche. L’impostazione del marxismo analitico si rivela compatibile,
per molti versi, con una pratica “riformista”, volta ad attutire le diseguaglianze prodotte dal sistema
capitalistico, ma senza mettere in discussione in modo radicale quest’ultimo: così viene fortemente
ridotto, se non annullato, l’elemento della lotta di classe, e quindi il carattere politicamente
dirompente dell’orizzonte marxiano. Il libro di Ernesto Screpanti, Marx dalla totalità alla
moltitudine (1841-1843) (Petite Plaisance, Pistoia 2013), presenta, in primo luogo, il merito di
sottoporre a critica qualsiasi interpretazione olistica del percorso marxiano, senza però con questo
aderire a una visione che in qualche modo legittimi l’individualismo capitalistico, per quanto
mitigato da una serie di misure sociali. A differenza che nei teorici del marxismo analitico, non ci si
trova di fronte a un marxismo senza comunismo: il termine “comunismo” non viene bandito dal
ragionamento, ma piuttosto rideclinato secondo una piegatura libertaria, come emergeva anche da
un suo precedente lavoro, Comunismo libertario. Marx, Engels e l’economia politica della
liberazione (il manifestolibri, Roma 2007, trad. ingl., Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007). In
secondo luogo, l’aspetto interessante del libro è fornito dal fatto che tale critica all’olismo viene
calata in un’analisi specifica di una fase del percorso marxiano, dal 1841 al 1843, che non è stata
sufficientemente approfondita dagli interpreti: qui iniziano a emergere alcuni elementi significativi,
che, seppur in modo non lineare, risulteranno gravidi di sviluppi ulteriori.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Prima di spiegare in che senso, secondo Screpanti, l’itinerario marxiano si contraddistingua, anche
se con contraddizioni e ambiguità interne, per una forma di individualismo, e non di olismo, occorre
chiarire in che modo vengano declinate le categorie in questione: “L’olismo ontologico è basato su
un assioma secondo cui esistono agenti collettivi emergenti rispetto ai loro componenti individuali,
tali cioè che il loro agire non è determinato interamente dall’agire dei componenti individuali e
dalle relazioni tra essi esistenti. Questo assioma può essere trasposto in un postulato di olismo
metodologico, secondo il quale per spiegare l’azione di un agente collettivo non è sufficiente
conoscere i comportamenti e le relazioni dei suoi componenti” (p. 155). Contrapposto all’approccio
olistico, si trova “un postulato di individualismo metodologico, il quale asserisce che per conoscere
il comportamento di un ente collettivo è sufficiente conoscere il comportamento dei suoi
componenti individuali e le relazioni tra essi esistenti […] La definizione della sufficienza piuttosto
che della necessità della riduzione individualistica serve per formulare una definizione generale […]
la rilevanza del postulato d’individualismo metodologico si coglie proprio nell’ambito
dell’ontologia. Infatti esso nega validità al postulato di olismo metodologico […]” (pp. 156-157). Si
rivela necessario precisare che la modalità di individualismo che qui viene delineata non è
l’individualismo “possessivo” moderno, e meno che mai l’individualismo sotteso al neoliberalismo
odierno. In termini generali, il riferimento non è certo a un individuo isolato, a un individuo-atomo,
svincolato dalle condizioni, dalle relazioni e dai contesti in cui opera. Non a caso, viene adoperata
al riguardo la categoria di individualismo istituzionale: “Un tipo particolare di individualismo
metodologico è denominato individualismo istituzionale. Asserisce che i comportamenti individuali
di un aggregato sociale devono essere studiati con riferimento alle istituzioni storicamente
determinate in cui si trovano immersi […] L’individualismo istituzionale […] nega che i
componenti di un ente collettivo possano essere identificati negli individui astratti a cui rinvia gran
parte del pensiero contrattualista e utilitarista“ (pp. 159-160). Secondo Screpanti tale teorizzazione
dell’individualismo istituzionale non costituisce una sorta di “terza via” fra individualismo e
olismo: comunque sia, si distanzia in modo netto da ogni modalità liberale di individualismo e
presenta caratteristiche peculiari, a tal punto da renderlo compatibile, in una sua accezione
machiavellicamente “tumultuaria”, con l’elemento del comunismo marxiano. Ma occorre esaminare
come questa impostazione generale venga calata in un’analisi specifica dei primi testi marxiani.
Il libro è incentrato sui testi dal 1841 al 1843, con particolare rilievo agli scritti inediti rispetto a
quelli editi, e con particolare interesse per gli estratti da testi e autori classici della storia della
filosofia. Sulla base di questa interpretazione interna delle prime opere marxiane, si articola in sei
capitoli (e in due appendici), in cui estremamente rilevante risulta il “corpo a corpo” con Leibniz,
Spinoza, Rousseau, Machiavelli (oltre che, in misura minore, con Montesquieu, Hume e Hamilton),
ai quali Marx ha dedicato specifici estratti. Screpanti sottolinea, da un lato, che l’attraversamento
dei testi dei filosofi indicati si rivela cruciale per la comprensione del percorso marxiano
successivo, e, dall’altro, che ci si trova di fronte a una trascrizione, seppur “orientata”, di opere, e
non a un’elaborazione compiuta. “E’ proprio questo il periodo in cui si compie la conversione
dall’idealismo e dal democraticismo radicale al materialismo e al comunismo […] il passaggio di
Marx al comunismo alla fine del 1843 rimarrebbe un perfetto mistero se non si tenesse conto dei
Quaderni di Kreuznach […] i Quaderni di Kreuznach e la Kritik del 1843 rimarrebbero a loro volta
un perfetto mistero se non si tenesse conto dei Quaderni di Berlino, con cui inizia il percorso di
ricerca che a quegli scritti approda” (p. 6). Nel secondo dopoguerra un forte stimolo alla
valorizzazione delle opere giovanili marxiane è stato rappresentato dalla riflessione di Galvano
Della Volpe, che ha colto nuclei teorici molto rilevanti, e che nello stesso tempo ha interpretato tali
testi in modo acritico, concependoli sic et simpliciter come una compiuta prefigurazione del Marx
“maturo”. Una sorta di contraltare rispetto a tale valorizzazione del giovane Marx è fornita dalla
tematizzazione di Louis Althusser, fortemente critica nei confronti dell’umanismo e del (presunto o
reale) essenzialismo di tale concezione. Secondo Screpanti, la “rottura epistemologica” marxiana si
sarebbe verificata prima del 1844-1845: il presente libro si propone proprio di far emergere la
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
vitalità, seppur con ambivalenze, degli scritti marxiani antecedenti al 1844, sulla base di
un’instabilità interna, di un’oscillazione “tra romanticismo e illuminismo, tra idealismo e scienza”
(p. 12). Questo approccio permette di mettere in discussione, o perlomeno di problematizzare la
questione, per così dire, dei “due” Marx, del “giovane” Marx e del Marx “maturo”: infatti, nella
storia del marxismo troppo frequentemente si è insistito sulla valorizzazione o del “giovane” Marx
o del Marx “maturo”, operando contrapposizioni discutibili sul piano filologico e sulla base di
opzioni teorico-politiche oggi per lo più datate. Inoltre, anche soffermandosi sul cosiddetto
“giovane” Marx, occorre rilevare che non ci si trova di fronte a un corpus perfettamente compatto e
sistematicamente delineato: all’interno del ragionamento esistono tensioni contrastanti, non sempre
risolte in modo chiaro, e quindi anche ambiguità. Ma queste ultime non vengono a configurare un
compiuto organicismo, al contrario di quanto spesso è stato sottolineato.
Tra i Quaderni di Berlino, significativo è quello dedicato a Leibniz, di cui vengono valorizzati in
primis il metodo scientifico e la concezione dell’individualità. Per quanto concerne quest’ultima,
“l’individualità in quanto singolarità irriducibile costituisce il fondamento ontologico della realtà
sociale […]” (p. 18): “Togliendo Dio dal discorso di Leibniz, Marx approda a una ontologia sociale
per la quale gli agenti individuali sono condizionati dalle relazioni sociali e dalle azioni e reazioni
reciproche […] Ciò accade perché gli individui sono incapaci di rappresentarsi l’universo se non a
partire da punti di vista particolari e parziali” (p. 27). Secondo Screpanti è in questi termini che
comincia a prendere corpo la concezione marxiana del soggetto umano quale ‘uomo sociale’.
Sempre all’interno dei Quaderni di Berlino, particolarmente interessanti sono gli estratti dal
Trattato teologico-politico: si tratta di “una ricostruzione intenzionata della teoria politica
spinoziana” (p. 31). Il centro dell’interesse marxiano consiste nella trattazione della democrazia,
che costituisce una sorta di prefigurazione del comunismo. Seppur con una serie di difficoltà
interne, il Marx lettore di Spinoza tenta di dare vita a una concezione realistica della democrazia:
“[Marx] tende a vedere nella democrazia, intesa come autogoverno razionale della moltitudine, una
possibilità storica reale, anzi, quasi una necessità dello sviluppo storico” (pp. 33-34). Qui viene
introdotto il concetto di moltitudine, presente anche nel titolo del libro, nella sua irriducibilità a
popolo compatto e omogeneo, a totalità. Alla base di tale “democrazia” della moltitudine stanno
soggetti individuali. Tale visione non si configura quindi come negazione dell’individualismo: “Un
processo politico realmente democratico deve essere fondato su un postulato d’individualismo etico,
mentre una teoria libertaria della democrazia e della rivoluzione deve essere costruita nel rispetto
del postulato d’individualismo metodologico. Soggetti ultimi dei processi politici sono gli individui
concreti […]” (pp. 35-36). L’attraversamento dei testi leibniziani e spinoziani, seppur sulla base di
percorsi differenziati e complessi, ha permesso di far emergere con sempre maggior forza il ruolo
degli individui, che nel caso di Spinoza vengono a formare una moltitudine insorgente.
Si rivela però necessario esaminare gli elementi idealistici, secondo Screpanti con la loro
problematicità, in particolare attraverso la mediazione di Bruno Bauer e di Ludwig Feuerbach. In
realtà Screpanti opera una precisa differenziazione fra le due influenze indicate: “Tutti gli studi
degli anni 1838-1841, dalla tesi di laurea ai Quaderni di Berlino sono svolti sotto l’egida della
filosofia dell’autocoscienza di Bruno Bauer […]” (p. 41). Dal 1843, e ancor più nel 1844, la figura
di riferimento diventa Feuerbach: ciò si configura come “una condizione di regresso verso posizioni
essenzialiste e olistiche“ (p. 44). Lo stesso concetto di Gattung, presente nella Critica della filosofia
hegeliana del diritto pubblico ma con una funzione non decisiva, col passare del tempo, e in
particolare nel 1844 diventa cruciale, e la sua rilevanza si attenua fortemente solo con le Tesi su
Feuerbach e soprattutto con L’ideologia tedesca. In ogni caso, nel periodo indicato rimane
un’”ombra” hegeliana, con la sua ambivalenza: “[…] Marx stesso ricade talora nell’olismo. Lo fa
ipostatizzando a sua volta un ente collettivo come il popolo […] L’influenza hegeliana sulla
formazione della componente olistica del pensiero di Marx è piuttosto forte, ed è disastrosa. Ciò
nondimeno un’influenza hegeliana si fa sentire anche sulla sua presa di distanza dall’individualismo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
astratto del contrattualismo liberale, e in questo caso è benefica” (p. 50). Infatti, nell’intera
produzione marxiana costante è la critica, con la sua chiara ascendenza hegeliana, al
contrattualismo: si pensi al passo folgorante sulle “Robinsonaden” contenuto nella Einleitung del
’57. Ma tale approccio non implica la presenza di una posizione organicistica e anti-individualistica:
d’altronde, come dimostra la teorizzazione marxiana successiva, dall’Ideologia tedesca ai
Grundrisse, centrale è il riferimento alla libera individualità, possibile solo a partire dai presupposti
forniti dal sistema capitalistico. Il richiamo all’aristotelico zoon politikon deve quindi essere inteso
nei suoi giusti confini: “La distanza tra Aristotele e Marx nella definizione della socialità umana è
notevole: lì abbiamo l’idea di una natura umana che è essenzialmente socievole […], qui
l’antinaturalistica definizione di una plurale soggettività sociale come realtà empirica storicamente
situata […]” (p. 53). E’ importante rimarcare la “carica” antinaturalistica del discorso marxiano, e
quindi la sua irriducibilità non a ogni antropologia, ma a ogni antropologia astratta, essenzialistica
(pur esistendo ambiguità in tal senso, soprattutto nei primi testi).
E’ a partire dalle considerazioni svolte, che mettono in luce la permanenza di moduli idealistici e
insieme l’affacciarsi di elementi che vanno in una direzione diversa, che occorre interpretare un
testo come la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, “fondamentale per la costruzione
della teoria politica del comunismo” (p. 58): “Marx usa la critica individualista all’olismo
ontologico di Hegel per decostruire la sua concezione dello Stato come realtà che si autolegittima
spiritualmente […]“ (pp. 64-65). Marx non si limita a polemizzare contro l’“olismo ontologico di
Hegel”, ma articola una posizione individualistica, radicata però nella concretezza delle sfere sociali
e politiche. Al riguardo è necessario riprendere la differenziazione precedentemente compiuta fra
individualismo metodologico e individualismo istituzionale. Quest’ultimo permette di cogliere il
richiamo agli individui all’interno dei contesti e dei rapporti specifici in cui si trovano ad operare:
“L’individualismo metodologico di Marx assume qui chiaramente la forma di un individualismo
istituzionale, e gli serve per mostrare le modalità con cui i soggetti concreti della storia, cioè gli
individui empirici che compongono una certa società, arrivano a lottare per costituirsi in comunità
politica autogovernata […] Questa ‘formazione’ della costituzione e dello Stato, in quanto
espressione della volontà dei cittadini, è per Marx un processo rivoluzionario; non un presupposto
formale della democrazia ma la realizzazione pratica, entro una precisa situazione storica, di un
movimento in cui si esprime la volontà politica del popolo […]” (pp. 67-68). Ci si trova però di
fronte a una modalità del tutto peculiare di individualismo istituzionale, che prevede non solo il
radicamento nelle condizioni materiali ma anche la destrutturazione di esse, sulla base di un
rapporto “esplosivo” fra teoria e prassi, come emergeva già dalle Tesi su Feuerbach, con il rilievo
sulla valenza rivoluzionaria della filosofia. All’interno di questo dispositivo teorico “inaudito”,
l’elemento della democrazia viene articolato in termini dinamici, e sulla base di un continuo,
“agitatorio” richiamo alla Rivoluzione francese, modello di tutte le rivoluzioni. Nella Kritik la “vera
democrazia” viene intesa come democrazia reale piuttosto che solo formale, in direzione di
un’”estinzione” dello Stato. A testimonianza della forte connessione tra la democrazia, così
delineata, e ciò che successivamente verrà indicato con “comunismo”, Screpanti sottolinea che
“Marx non abbandonerà mai questa teoria. Nell’opera politica più importante della maturità, La
guerra civile in Francia, non farà altro che articolarla e approfondirla come studio di un reale
processo rivoluzionario di costruzione della democrazia comunista“ (p. 74).
Ai fini dell’approfondimento del rapporto, sotteso alla prospettiva qui articolata, fra dimensione
individuale e dimensione collettiva, significativo è il riferimento agli estratti marxiani, anche se si
tratta solo di una trascrizione, selezionata, di testi. Tra i Quaderni di Kreuznach particolarmente
rilevante è quello relativo a Rousseau: “Ci si accorgerà che, nel lavoro di copia-e-incolla, i tagli
sono significativi quanto i plagi e che, come fa con Spinoza, Marx cerca di costruire un suo proprio
discorso modificando i connettivi logici di quello di Rousseau. Ci si renderà conto però che c’è una
grande differenza fra gli appunti su Spinoza e quelli su Rousseau: mentre col filosofo olandese
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Marx costruisce un discorso personale che è diverso ma sostanzialmente non divergente dalla fonte,
con lo svizzero viene alla luce un rapporto più complesso che è nello stesso tempo di assimilazione
e di critica” (p. 85). Da vari punti di vista, decisamente critica è la posizione marxiana nei confronti
di Rousseau. Appare necessario rimarcare questo aspetto, in quanto sia in Francia sia in Italia (in
particolare, con Della Volpe e Colletti) spesso si è operata una forte connessione, ai limiti
dell’identificazione, fra i due filosofi in questione. D’altronde, al di là di altri elementi (basti
pensare, ad esempio, alla giustificazione rousseuaiana della proprietà privata nel Contratto sociale,
da Marx ovviamente criticata), emerge un punto cruciale su cui Marx si distanzia, vale a dire
l’organicismo rousseauiano, l’assorbimento individuale nella comunità. In questo senso, se si vuole
sostenere la tesi del Marx individualista, seppur con tutte le precisazioni del caso, Rousseau non
può che costituire un referente polemico. Nonostante ciò, ci si trova di fronte a un atteggiamento
ambivalente nei confronti di Rousseau: “Da una parte Marx sviluppa una critica esplicita a Hegel e
una implicita a Rousseau per la loro tendenza a definire l’essere sociale in termini olistici […]
Dall’altra, nello studio dei processi che portano all’instaurazione della ‘vera democrazia’ e nella
spiegazione dello stesso significato della democrazia, Marx tende a identificare in un ente
collettivo, che sia il Popolo o il Genere Umano, il Soggetto capace di dar vita e senso alla comunità.
Proprio nella teoria della ‘vera democrazia’ si può cogliere al meglio la schizofrenia filosofica di
Marx” (pp. 123-125). In ogni caso, seppur con oscillazioni, viene riarticolata la nozione di volontà
generale: “[…] Marx […] tende a far coincidere la volontà generale con la ‘volontà di tutti’: è
generale perché tutti hanno contribuito alla sua formazione, non perché è intrinseca alla natura del
bene comune” (p. 95). Se Rousseau attua una forte divaricazione fra volontà generale e volontà di
tutti, Marx invece cerca di far coincidere i due elementi. Come Screpanti mette in luce anche nella
prima delle due appendici, “Da Rousseau a Hegel”, pur assumendo alcuni elementi rousseauiani,
Marx concepisce la relazione fra il soggetto individuale e il soggetto collettivo in termini
sostanzialmente differenti rispetto a Rousseau. Ritorna qui l’idea di un collettivo non come totalità,
ma come moltitudine di singolarità nella loro differenziazione. A partire dalle coordinate indicate
viene articolato l’elemento del comunismo: “E’ un’idea a cui Marx terrà fermo per il resto della
vita: che il comunismo è un’organizzazione sociale che esalta lo sviluppo delle forze produttive
estendendo la cooperazione e l’organizzazione del lavoro, e con ciò espande le libertà individuali”
(p. 97). Un “filo rosso” dell’intera produzione marxiana, dai primi agli ultimi scritti, è costituito
dall’idea secondo cui il comunismo non si configura come negazione delle singolarità, ma al
contrario come loro realizzazione.
Nello stesso tempo, però, Marx riprende un aspetto cruciale del discorso rousseuaiano: “Ciò che
Rousseau cerca di dire è che i delegati del popolo […] non sono i depositari di una volontà a cui il
popolo ha rinunciato con la delega, sono solo dei mandatari dei cittadini. Su quest’idea Marx lo
segue in pieno […] In seguito approfondirà l’idea che il vincolo di mandato, per essere efficace,
deve essere associato a un diritto di revoca“ (pp. 99-101). In Marx ci si trova di fronte alla critica
alla rappresentanza e, conseguentemente, alla delineazione di una sorta di mandato imperativo, con
diritto di revoca, come emerge in modo icastico negli scritti sulla Comune. D’altronde, già nella
Kritik erano presenti elementi di democrazia radicale, anche se con un “rischio” olistico molto forte.
Ma, in conclusione, “il Quaderno Rousseau segna un passo avanti rispetto alla Critica della
filosofia hegeliana del diritto pubblico. Sebbene sembri permanere qualche residuo di olismo etico
anche qui, ora Marx mostra di aver capito che il popolo non è quel tutto mistico esaltato da
Rousseau […] La tendenza a ridurre la volontà generale alla volontà di tutti è il segno di quanto ora
Marx sia andato avanti nel riconoscimento del popolo come moltitudine priva di sostanza etica. Il
passo definitivo lo farà mettendosi a lezione da Machiavelli” (p. 103). Ritorna qui il tentativo di
declinare la dimensione collettiva non sulla base di una sorta di misticismo olistico, ma a partire
dall’esigenza della realizzazione delle singolarità nella loro irriducibilità a uno schema
onnicomprensivo. In questo senso risulta cruciale il concetto di moltitudine, con le sue ascendenze
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
spinoziane e machiavelliane, in quanto permette di tenere aperto, in termini dinamici e anche
conflittuali, il rapporto fra dimensione individuale e dimensione collettiva.
Si arriva così al Quaderno di Kreuznach dedicato a Machiavelli, più scarno di quelli
precedentemente esaminati. In primo luogo centrale è il riferimento a Machiavelli in merito
all’antropologia: “Intorno al problema della definizione della natura umana c’è una forte affinità tra
la concezione realista di Machiavelli e quella di Marx anti-hegeliano […] è solo con la lettura di
Machiavelli che viene fatto un salto decisivo oltre l’idealismo umanista […]” (p. 106). Si assiste
alla destrutturazione di ogni idea astratta di natura umana, e invece a un’indagine specifica di
soggetti concreti, nel loro radicamento in una situazione concreta. D’altronde, successivamente,
nell’Ideologia tedesca si insiste continuamente sull’elemento della determinazione specifica per
connotare la dimensione dell’individualità. E, anche nell’articolare la questione del rapporto fra
soggetto individuale e soggetto collettivo, il richiamo al segretario fiorentino si rivela decisivo: in
Machiavelli non emerge un’idea compatta, olistica di popolo, dal momento che quest’ultimo viene
concepito come “un insieme di agenti, individuali e sociali” (p. 106). Tale considerazione sul
carattere articolato del popolo non presenta alcuna connotazione irenica: ci si trova di fronte a una
“disunione”, a una lacerazione (ad esempio, fra i “Grandi” e il popolo), con la produttività politica
di questo elemento. Inoltre Marx assume la centralità machiavelliana del conflitto, seppur sulla base
di una dislocazione rispetto a Machiavelli, nel senso che sempre più rilevante diventa la sfera
economica. In ogni caso, Marx, più in generale a livello di metodo, assimila da Machiavelli (e
anche da Montesquieu) un approccio materialista e relativista alle questioni etiche. Screpanti
polemizza contro l’idea, presente in vari esponenti del marxismo analitico, di un impianto “morale”
della critica al capitalismo: al contrario, valorizza, di Machiavelli, l’analisi disincantata della
religione, in quanto instrumentum regni, e, ancor di più, dello Stato, di cui viene rifiutata ogni
fondazione teologica ed etica. In ogni caso, come ha rimarcato con forza Louis Althusser in
Machiavelli e noi, il riferimento cruciale, per Machiavelli, è alla “verità effettuale della cosa” nella
sua singolarità e non sulla base di schemi generalizzanti. Machiavelli permette a Marx di pervenire
a “una concezione non idealista della prassi, una concezione per cui la prassi è vista non come la
realizzazione del Concetto nell’azione del Soggetto della storia, bensì come l’azione di particolari
soggetti concreti che usano la teoria per definire e realizzare i propri interessi materiali” (p. 115).
Seppur sulla base di differenze significative (ad esempio, in Machiavelli manca l’elemento della
rivoluzione come abolizione delle classi), la lettura marxiana dei Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio rappresenta una sorta di coronamento del percorso di ricerca iniziato nel 1841, e, anche
nei testi successivi, Hobbes e Spinoza vengono ricondotti a Machiavelli a partire dall’idea secondo
cui il potere si configura come fondamento del diritto. Anche se il marxismo italiano (basti pensare,
ad esempio, a Gramsci e a Labriola) ha insistito sul rapporto Marx-Machiavelli, “nessun filosofo ha
colto tutta l’estensione dell’affinità di pensiero tra Marx e Machiavelli”, e la rilevanza di tale
elemento per la comprensione della “rottura epistemologica” marxiana (p. 121).
Sulla base del percorso indicato, anche attraverso un’analisi minuziosa degli estratti, Screpanti
arriva alla seguente conclusione, con il titolo di “Dr. Marx e Mr. Karl”: “[…] esistono due Marx.
C’è un Dr. Marx dotato di un’anima idealista, in cui prevale un’impostazione di olismo ontologico e
una visione deterministica della storia, e un Mr. Karl con un’anima realista, che adotta un metodo
d’individualismo istituzionale e un approccio scientifico all’indagine sociale. La ricerca del Moro
oscilla continuamente e non arriverà mai a una ‘rottura epistemologica’ definitiva, anche se non c’è
dubbio che gli scritti del 1845-46 marcano un passaggio cruciale […] Ma quella rottura è stata
preceduta da profonde incrinature emerse nel 1841 e nel 1843” (p. 128). Questo approccio possiede
il merito di valorizzare le opere precedenti al 1845-1846, ma facendo riferimento a testi meno
celebrati e meno conosciuti rispetto a La questione ebraica, Per la critica della filosofia del diritto
di Hegel. Introduzione e ai Manoscritti economico-filosofici del 1844, e meno “marcati” dal
modello feuerbachiano, sulla cui rilevanza spesso si è insistito in modo eccessivo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
nell’interpretazione della fase indicata. Il richiamo a Feuerbach permette di problematizzare il tema,
fortemente connesso a quello della presunta dicotomia fra il “giovane” Marx e il Marx “maturo”,
dell’umanismo e dell’antiumanismo. Tale contrapposizione, che ha trovato una ragion d’essere in
particolare negli anni Sessanta e Settanta, nello scenario odierno si rivela improduttiva: se si
vogliono cogliere le potenzialità dei soggetti concreti, non si tratta di ipostatizzare né l’approccio
umanistico, con il suo “rischio” essenzialistico (come in Feuerbach), né quello antiumanistico, che
incontra grandi difficoltà nell’articolazione teorica dell’elemento della soggettività.
In ogni caso, lo scopo complessivo del libro di Screpanti, ribadito anche nella seconda appendice,
“Individualismo e olismo”, consiste nel mettere in discussione quell’olismo ontologico che è
presente anche in alcune impostazioni hegelo-marxiste. Al riguardo appare adeguata la categoria di
individualismo istituzionale: non si tratta di “un compromesso o una via di mezzo tra olismo e
individualismo: è una forma realistica d’individualismo in cui le relazioni che collegano gli agenti
possono essere definite in termini di strutture organizzative, istituzioni normative e abitudini
comportamentali. Ebbene questa concezione era stata intuita da Marx già nel 1841 e imbastita nel
1843. Gli individui sono studiati in quanto uomini concreti influenzati dalle relazioni […] in cui si
trovano immersi […]” (pp. 160-161). All’interno di tale scenario possono venir ammessi solamente
elementi intersoggettivi, che risentono dei comportamenti individuali e delle interazioni sociali, e
che comunque trovano alla propria base situazioni concrete. Arrivati a questa acquisizione, il
riferimento finale è alla trattazione di Althusser: rispetto ad essa, Screpanti, pur condividendo la
critica all’essenzialismo, rileva alcuni aspetti problematici, in particolare in merito ”all’illegittimo
disconoscimento del ruolo della soggettività nei processi politici” (p. 170). Occorre evitare sia
l’individualismo astratto, sia l’”olismo del logos della struttura sociale” (presente anche in
Althusser), in cui gli individui vengono ridotti a funzioni. Emerge una “visione della storia come
processo aperto risultante dall’azione autoliberatoria dei soggetti concreti” (p. 171). Tale
concezione individualistica presenta però caratteristiche peculiari, del tutto differenti non solo
dall’individualismo liberale ma anche da un individualismo come quello sotteso al cosiddetto
marxismo analitico: pur non configurandosi come una “terza via” fra individualismo e olismo,
erode qualsiasi idea astratta di individualità, in qualche modo funzionale allo scenario capitalistico.
Sarebbe interessante confrontare tale accezione di individualismo istituzionale con un approccio
come quello di Etienne Balibar, fondato sull’idea secondo cui l’intero itinerario marxiano si
configuri come tentativo di destrutturare la contrapposizione fra individualismo e olismo, dando
vita a una sorta di ”ontologia della relazione”. Non a caso, in una celebre Tesi su Feuerbach, si fa
riferimento non a un olistico “Ganze”, a un Tutto, ma a un ensemble dei rapporti sociali. Inoltre,
come emerge con forza anche da un passo dei Grundrisse, la società consiste prima di relazioni di
individui, che di individui. “Né la ‘monade’ di Hobbes e di Bentham, né il ‘grande essere’ di
Augusto Comte […] Non ciò che è idealmente ‘in’ ogni individuo (come una forma o una
sostanza), o ciò che servirebbe, dall’esterno, a classificarlo, ma ciò che esiste tra gli individui, per le
loro molteplici interazioni” (E. Balibar, La filosofia di Marx, trad. it. il manifestolibri, Roma 1994,
p. 36). “Transindividuale, infatti, è prima di tutto questa reciprocità che si instaura tra l’individuo e
il collettivo nel movimento dell’insurrezione liberatrice ed egualitaria” (ivi, p. 129). La prospettiva
di Balibar, rispetto all’interpretazione di Screpanti, attribuisce un maggior peso alla dimensione
della relazione, e intende in modo diverso l’individualismo, legando quest’ultimo unicamente alla
sua accezione liberale. Nonostante tali differenze, emerge un elemento comune, ovvero la tensione
verso la valorizzazione delle singolarità nella loro diversificazione, non in distonia con la
dimensione collettiva, concepita a partire dalla pratica politica. Riarticolare quel “sogno di una
cosa” che è il comunismo marxiano, significa attraversare la reciprocità instabile fra l’’individuale’
e il ‘collettivo’, sulla base di coordinate che non possono essere definite una volta per tutte e che
sono continuamente aperte alla rettifica del proprio percorso.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Luca Basso è Ricercatore di Filosofia politica presso l’Università di Padova. È autore di molti
articoli e di tre monografie: Individuo e comunità nella filosofia politica di Leibniz (Rubbettino,
2005), Socialità e isolamento: la singolarità in Marx (Carocci, 2008; trad. inglese Brill, 2012), e
Agire in comune. Antropologia e politica nell’ultimo Marx (Ombre Corte, 2012).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Arthur Coleman Danto. Filosofia Arte Bellezza
di GIACOMO FRONZI
Nonostante la sua centralità nel contesto filosofico internazionale da mezzo secolo a questa parte,
Arthur Coleman Danto è entrato nel dibattito culturale italiano solo da pochi anni. La sua
improvvisa scomparsa – il 25 ottobre scorso – ci offre l’opportunità di ripercorrere alcuni motivi di
un pensiero tra i più lucidi e originali dell’orizzonte filosofico degli ultimi decenni.
[…] quel che è interessante ed essenziale nell’arte è la capacità spontanea che ha l’artista di
permetterci di vedere il suo modo di vedere il mondo – non semplicemente il mondo, come se un
dipinto fosse una finestra, ma il mondo nel modo in cui lui ce lo offre.
A.C. Danto, La trasfigurazione del banale
Spesso accade che per poter sentire parlare di alcuni intellettuali, occorre aspettare di vederli
abbandonare il proscenio della vita. A volte la notorietà (che Andy Warhol – figura chiave delle tesi
centrali del filosofo di cui ora parleremo – considerava un destino comune a tutti, benché racchiuso
in appena un quarto d’ora) non giunge se non con notevolissimo ritardo. Altre volte, invece, essa
sembra accompagnare – seppur in circuiti ristretti – l’attività di certi studiosi. Credo di poter dire
che – nel contesto internazionale e, solo negli ultimi anni, anche in quello italiano – è questo il caso
del filosofo americano Arthur Coleman Danto, scomparso il 25 ottobre scorso, nel suo
appartamento di Manhattan, dove viveva con la seconda moglie, l’artista Barbara Westman.
Danto – che avrebbe compiuto novant’anni il prossimo 1° gennaio – nasce ad Ann Arbor
(Michigan) e cresce a Detroit. Prima di andare studiare Arte e Storia presso la Wayne State
University (che allora si chiamava Wayne University e dove si laurea nel 1948), trascorre un paio
d’anni nell’esercito statunitense. Danto, che da giovane sognava di diventare pittore, nel 1949
consegue un Master in Filosofia alla Columbia University di New York, dove studia con Ernest
Nagel, Suzanne K. Langer e Justus Buchler. Nello stesso anno, va a studiare all’Università di Parigi,
grazie a una borsa di studio annuale Fulbright. Nel 1950 diviene “instructor of philosophy”
all’Università del Colorado e l’anno successivo accetta una posizione simile alla Columbia, dove
consegue il dottorato nel 1952, discutendo una tesi di filosofia della storia. Viene promosso ad
“assistant professor” nel 1954, “associate professor” nel 1959 e “full professor” nel 1966, sempre
alla Columbia. Nel 1975 diviene Johnsonian Professor of Philosophy e, dopo essersi pensionato (nel
1992), è stato nominato Johnsonian Professor Emeritus of Philosophy. Un’attività importante che
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
ha caratterizzato il percorso di Danto, difficilmente separabile da quella di docente e di saggista, è
stata poi quella di critico d’arte, attività che si è espressa al meglio nella scrittura di articoli sulla
famosa rivista «The Nation», per la quale il filosofo americano, dal 1984 al 2009, ha curato una
rubrica ereditata dal pontifex maximus della critica d’arte statunitense, Clement Greenberg.
Sullo sviluppo del pensiero di Danto hanno influito fortemente due elementi: il contesto artistico
newyorkese dagli anni Cinquanta in poi e l’ambiente “analitico” che si raccoglieva attorno al
Dipartimento di filosofia della Columbia University. Sebbene i suoi scritti più discussi e diffusi
siano quelli di filosofia dell’arte, l’itinerario speculativo di Danto non parte da essa, ma vi
giunge[1]. La piattaforma iniziale è, infatti, quella tipica del filosofo analitico (che, per la verità,
non nascondeva un certo interesse anche per la filosofia continentale[2]), alla quale resta fedele nei
decenni, ma nella quale si innesta un evento che indirizzerà la riflessione di Danto verso la teoria
dell’arte. L’anno in cui scrive il saggio The Artworld (1965)[3], Danto visita una mostra presso la
Stable Gallery di New York, nella quale Andy Warhol espone la sua celebre opera intitolata Brillo
Box, costituita da una serie di scatole contenenti spugnette abrasive utilizzate per pulire le pentole.
La visione di qualcosa che era pressoché identica a ciò che si poteva trovare in un comune
supermercato porta Danto a porsi una domanda capitale: perché le scatole esposte da Warhol sono
opere d’arte e quelle esposte in un supermercato non lo sono?[4] Prima di fornire la risposta
formulata dal filosofo americano, occorre, però, fare un passo indietro, giacché il superamento dello
steccato tra oggetto d’uso comune e opera d’arte era già avvenuto mezzo secolo prima.
Nel 1913, com’è noto, Marcel Duchamp prende una banale ruota di bicicletta, infilata al contrario in
uno sgabello, e la presenta come opera d’arte. Nel 1917, all’esposizione della Society of
Independent Artists, Duchamp presenta Fountain: un orinatoio diventa opera d’arte. Cosa significa
tutto ciò? Semplice. R. Mutt (lo pseudonimo con il quale Duchamp firma Fountain) – come lo
stesso autore riferisce in un’intervista alla rivista «The Blind Man» – ha scelto l’opera, non l’ha
creata. I gesti provocatori di Duchamp piombano così come un macigno sull’intero sistema
dell’arte, mettendo in crisi profonde e consolidate certezze. Quella scelta, quanto mai imprevedibile,
spazza via in un sol colpo i tradizionali confini tra artistico ed extrartistico, tra estetico ed
extraestetico. La rivoluzione realizzata da Duchamp, oltre che imprimere una svolta radicale negli
sviluppi della pratica artistica e dell’esperienza estetica, pone alla riflessione teorica delle questioni
del tutto nuove e, nella maggior parte dei casi, irresolubili, introducendo una concezione
procedurale dell’arte: «l’arte non è più sostanziale ma procedurale: non dipende più dall’essenza ma
dalle procedure che la determinano»[5]. Dopo questa bizzarra e dissacratoria operazione nulla
sarebbe più potuto restare come prima; il fare artistico, le modalità espressive, le stesse definizioni
di arte e di artista non sarebbero potute rimanere inalterate. Ma cosa ha rappresentato quel gesto? E
quali conseguenze ha prodotto? La soluzione con cui Duchamp rivoluziona il modo di concepire
l’opera d’arte e la sua realizzazione avrà innumerevoli e inattese conseguenze, tanto nell’ambito
della pratica artistica quanto in quello della riflessione filosofica, all’interno della quale si colloca
Danto. Al di là della valutazione estremamente controversa relativa all’attribuzione del carattere di
“arte” a questo nuovo mezzo espressivo («Artistica, geniale, liberatoria, sovversiva, fu l’idea, e
questo basterebbe, e bastò, a farlo diventare arte»[6]), il readymade consente a Duchamp di
condurre il fruitore verso la scoperta di un senso ulteriore delle cose, della loro “indifferente”
bellezza (così la definisce lo stesso Duchamp). È così che l’artista francese porta a compimento un
duplice riscatto: quello dell’arte e quello del quotidiano, esprimendo la straniante potenza del fatto
artistico e la altrettanto stupefacente, inaspettata potenza dell’oggetto banale, realizzando opere che
si presentano come «dimostrazioni pratiche che una qualche bellezza può essere trovata nei luoghi
più inaspettati»[7]. Potenza che, però, non significa immediatamente senso. Anzi, la vacuità e la
vanità del banale se, per un verso, libera una possibile esperienza del sublime (per via del suo essere
perturbante), per altro verso potrebbe spingere verso l’accettazione dell’insensatezza del tutto
(tipicamente dadaista). Insensatezza, non mancanza di senso.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Un’attitudine di questo tipo possiamo ritrovarla anche in un artista che è passato alla storia come il
massimo esponente della Pop Art americana, Andy Warhol, con la cui arte Danto entra in contatto,
come abbiamo detto, alla Stable Gallery. È lo stesso filosofo americano a chiarire la portata
dell’opera di Warhol: «Se il modernismo è finito con Pollock e con l’Espressionismo Astratto,
quale poteva essere il futuro dell’arte? È Warhol a farsi carico della questione: le sue opere
rendevano impossibile una linea di demarcazione tra arte e realtà (tra le scatole Brillo del
supermercato e la sua Brillo Box). Perciò, a partire dagli anni Sessanta, il futuro dell’arte coincideva
con il superamento di quel confine che ne determinava il distacco dalla vita comune»[8]. Danto
inizia così a interrogarsi circa le domande fondamentali dell’arte, ma anche circa quegli aspetti che
caratterizzano l’arte contemporanea, in particolare la Pop Art americana.
L’esperienza delle avanguardie e delle neoavanguardie, caratterizzata dalla rottura con gli stili, le
tecniche e le concezioni artistiche a essa precedenti, dal ripudio della bellezza e della forma, dalla
critica tanto interna al sistema dell’arte quanto sociale, è stata decisiva per l’elaborazione teorica dei
filosofi analitici. Non è un caso che tra i nodi problematici da loro maggiormente trattati troviamo il
rifiuto della nozione di gusto e del connesso giudizio estetico, la dichiarata impossibilità di definire
le proprietà estetiche, in particolar modo la bellezza, e il problema (destinato a rimanere insoluto) di
carattere ontologico, relativo alla definizione di arte. Danto – partendo dalla premessa per la quale
l’essere umano è un «ente rappresentante»[9] – si è impegnato, nell’arco di diversi decenni, a
elaborare una filosofia dell’arte di tipo essenzialista, intesa, cioè, come l’esplicitazione delle
condizioni necessarie e sufficienti per le quali un’opera d’arte può essere considerata tale o, ancora
meglio, può essere riconosciuta come tale. A tal riguardo, le tesi di Danto sembrano essere la
premessa per la teoria istituzionale dell’arte elaborata nel 1969 da George Dickie e
successivamente riformulata e approfondita nel volume Art and the Aesthetic: An Institutional
Analysis (1974)[10]. Con la sua teoria, Dickie intendeva porre l’accento sulla trama sociale e
istituzionale nella quale si trova invischiata un’opera d’arte, la quale ottiene il riconoscimento dello
status di opera d’arte da parte del cosiddetto «mondo dell’arte» (Artworld), vale a dire critici,
galleristi, curatori, ecc. In verità, Danto terrà a precisare una differenza tra la teoria di Dickie e la
propria: «Dickie pensò che la risposta alla domanda “Che cos’è l’arte?” dovesse consistere in una
definizione dell’arte e quindi formulò la sua teoria sostenendo che è arte qualunque cosa il mondo
dell’arte dichiari tale. Ora, il mondo dell’arte è un’istituzione, che comprende critici, collezionisti,
curatori, artisti, storici dell’arte, e via dicendo, e dal momento che ho ritenuto che non c’è arte senza
un mondo dell’arte, è ovvio che l’arte deve essere qualcosa di istituzionale. Il problema è capire su
che cosa basi le proprie decisioni il mondo dell’arte. Oppure esso dichiara arte una tela squarciata e
basta, come in preda a una specie di impeto? Credo che, se esistono delle ragioni, allora queste
ragioni sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per definire l’arte. […] È sempre necessaria una
spiegazione. In questo senso la mia è una teoria “cognitiva”»[11].
Al di là di questi aspetti, vi è una questione che risulta del tutto centrale e che, in un certo senso,
rende quella di Danto una filosofia dell’arte che potremmo definire di tipo relazionale. La relazione,
in campo estetico[12], può essere considerata sotto diverse prospettive: 1. come rapporto ricettivo
tra opera e soggetto fruitore; 2. come risultato dell’azione “pubblica” ed etica dell’artista; 3. come
rapporto sensibile e piacevole tra un soggetto e un oggetto estetico. A queste accezioni occorre
aggiungerne una ulteriore, relativa alla trattazione teorica della relazione rispetto all’opera d’arte e
connessa alle proprietà a cui, secondo il punto di vista analitico, è necessario riferirsi per poter
distinguere un’opera d’arte da un oggetto d’uso comune, sebbene questi siano percettivamente
indiscernibili. Torniamo così alle domande iniziali: come rilevare, affidandosi esclusivamente a ciò
che viene attestato dai nostri sensi, la differenza tra un banale scolabottiglie e il Porte-bouteilles
(1914) di Duchamp? o tra una normalissima scatola di succo di pomodoro Campbell e la Tomato
Juice Box (1964) di Warhol?
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Danto, partendo dalla critica a quelle tesi di ascendenza wittgensteiniana secondo le quali l’arte e le
opere d’arte sono qualcosa che non può essere definito (è il caso, ad esempio, delle teorie di Morris
Weitz), tenta di percorrere e proporre una via per giungere all’essenza dell’arte, ponendosi questa
domanda: come possono due oggetti percettivamente indiscernibili[13], del tutto identici, possedere
uno statuto ontologico diverso, tale per cui uno diviene opera d’arte e l’altro rimane oggetto d’uso
comune?[14] Prendendo le mosse da questo problema, Danto tenta di risolvere l’enigma non a
partire dalle differenze di natura ‘estetica’ (alias sensoriale), dal momento che non ve ne sono,
bensì a partire dalle proprietà relazionali che legano l’oggetto in questione con elementi esterni a
esso, non percettivamente rilevabili. È grazie all’individuazione delle proprietà relazionali che
legano un’opera d’arte a tutto ciò che l’occhio o i sensi non possono attestare che si rende possibile
l’interpretazione (l’esse dell’opera d’arte non è berkeleyanamente percipi bensì interpretari) e,
conseguentemente, la comprensione di quell’opera. Il tema delle relazioni (o delle «classi di
famiglia») – rilanciato da Danto – ha avuto un certo rilievo nell’ambito dell’estetica analitica[15]
fin dalla metà degli anni Cinquanta. Con The Role of Theory in Aesthetics (1956), Weitz dà l’avvio
a un fitto dibattito sul problema della definizione dell’arte e dell’individuazione dell’essenza
dell’artisticità, dibattito all’interno del quale è emersa la questione relazionale nell’arte. A partire
dalle riflessioni di Weitz, la discussione ha visto coinvolti filosofi come Mandelbaum, Dickie,
Wollheim, Levinson, Beardsley, fino a Danto, la cui proposta, come accennavamo, è centrata
sull’individuazione di quelle proprietà relazionali che consentono a un’opera d’arte di potersi
presentare come tale[16].
L’arte, secondo Danto, solleva primariamente il problema relativo alla propria essenza e può essere
definita sulla base delle relazioni che essa istituisce. Il percorso che egli segue per venire a capo
dell’enigma per il quale due oggetti percettivamente indiscernibili hanno uno statuto ontologico
diverso si basa su questo ragionamento: se a livello percettivo, sensibile, tra le due ‘cose’ non vi è
alcuna differenza, ma l’una è un’opera d’arte e l’altra non lo è, allora tale differenza deve essere
ricondotta a qualcosa di slegato dalla dimensione percettiva. Non si tratta, pertanto, di una proprietà
che colpisce l’occhio o qualche altro organo di senso, ma di una proprietà indifferente alla
percezione, quale è una proprietà relazionale, irrilevabile dai sensi e stabilita, invece, dal «mondo
dell’arte». All’opera d’arte, dunque, non viene attribuita alcuna proprietà rilevabile attraverso
l’esperienza sensibile. Rispetto a questa impostazione generale, viene allora da domandarsi, che fine
fa la bellezza? Possiamo dire che essa, nel corso del xx secolo, è andata incontro a un doppio
destino: per un verso, verrà rifiutata come categoria centrale nell’arte, la quale sarà letta a partire da
un’altra categoria, ugualmente centrale nell’orizzonte teorico dell’estetica, dalle caratteristiche
molto diverse: il sublime; per altro verso, una volta esautorata dall’arte, vivrà un processo, non
privo di contraddizioni, di trasfigurazione e rinascita, informando di sé ogni aspetto
dell’esistenza[17]. La riflessione di Danto non poteva che imbattersi anche in questo tema, rispetto
al quale il filosofo americano sembra prendere una particolare posizione. «Bello!», sostiene Danto,
è ormai un’espressione di approvazione generica, non descrive nulla, è “come un fischio davanti a
qualcosa che entusiasma”. L’idea di bellezza, dunque, viene liquidata come mero «significato
emotivo», in quanto priva di spessore cognitivo. Dalle argomentazioni di Danto emergono due punti
fermi: a) la netta separazione dell’estetica kantiana e del presunto concetto-chiave, la bellezza, dalla
filosofia dell’arte; b) una forte influenza di spunti e temi hegeliani, che, tra l’altro, segnalano una
bizzarra contaminazione tra i presupposti idealistici della prospettiva hegeliana e l’impostazione di
tipo analitico. Da Hegel Danto sembra recuperare per un verso l’idea della distinzione tra bello
naturale e bello artistico, per altro verso la superiorità di quest’ultima rispetto alla bellezza naturale
(essendo, la bellezza artistica, «nata e rinata dallo spirito»). Questo significa che la bellezza artistica
non è un prodotto naturale, ma intellettuale. Il che vuol dire che occuparsi della bellezza è possibile,
per il filosofo, nella misura in cui essa rappresenta una delle «tante qualità estetiche» (e non la sola,
com’era per l’estetica tradizionale). Però, allo stesso tempo, Danto sostiene l’unicità della bellezza
intesa come «valore»: essa non è un valore tra gli altri, per mezzo dei quali viviamo, ma è uno dei
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
valori che definiscono la vita umana nella sua completezza. Esiste, dunque, una bellezza che può
essere rilevante, che rompe con il tabù dell’insignificanza in cui l’aveva confinata il neopositivismo.
Si tratta di una «bellezza interna», in quanto distinta da una «bellezza esterna» ai significati
dell’opera. Danto procede, pertanto, a un recupero della bellezza, seppure non in termini estetici,
ma all’interno di una prospettiva antropologica: la bellezza, inutile come categoria estetica, viene
innalzata a valore per l’uomo e per il mondo della vita[18]. Epperò, se l’estetica sposta lo sguardo
sul mondo della vita, che la società contemporanea tende a rendere sempre più bello, vuol dire che
la bellezza resta una categoria estetica centrale, sebbene non più riferibile al mondo dell’arte.
Espressione (per quanto “aperta”) della filosofia analitica statunitense, cultore appassionato ed
esperto di arte contemporanea, saggista raffinato, critico d’arte erudito e – per alcuni – sofisticato,
Arthur Coleman Danto, per certi aspetti, racchiude in sé alcuni dei tratti tipici della cultura del
secondo Novecento. Nella sua produzione circolano temi e questioni (lo statuto dell’opera d’arte, il
rapporto tra arte e realtà, il senso e la definizione della bellezza oggi, la differenza tra estetica e
filosofia dell’arte, il ruolo della critica d’arte, e così via) che hanno acceso il dibattito filosofico,
estetologico e artistico degli ultimi decenni, periodo in cui le rivoluzioni del pensiero e quelle
artistiche hanno alimentato prospettive interpretative finanche antitetiche, oscillanti tra la
certificazione del tramonto definitivo di un mondo e l’apertura alla speranza.
Giacomo Fronzi (1981), laureato in Filosofia (Lecce) e in Musicologia (Venezia), dottore di
ricerca, diplomato in pianoforte, svolge attività di ricerca presso la cattedra di Estetica
dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Theodor W. Adorno. Pensiero
critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una rivoluzione lunga cent’anni (Mimesis 2012),
Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica (EDT 2013).
[1] Dell’ampio catalogo degli scritti di Danto, vanno ricordati almeno Analytical Philosophy of
History, Cambridge University Press, New York 1965 (trad. it. di P.A. Rovatti, Filosofia analitica
della storia, il mulino, Bologna 1971); Analytical Philosophy of Knowledge, Cambridge University
Press, London 1968; What philosophy is: A guide to the elements, Penguin books, Hermondsworth
1971; Analytical Philosophy of Action, Cambridge University Press, London 1973; The
Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.)-London 1981 (trad. it., introd. e cura di S. Velotti, La trasfigurazione del banale. Una
filosofia dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2008); The Philosophical Disenfranchisement of Art,
Columbia University Press, New York 1986 (trad. it. di C. Barbero, La destituzione filosofica
dell’arte, a cura di T. Andina, appendice bibliografica di A. Lancieri, Aesthetica Edizioni, Palermo
2008); Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-historical Perspective, University of
California Press, Berkeley and Los Angeles 1992 (trad. it. e cura di M. Rotili, Oltre il Brillo Box. Il
mondo dell’arte dopo la fine della storia, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2010); After the End
of Art: Contemporary Art and the Pale of History, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1997
(trad. it. e cura di N. Poo, Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il confine della storia,
Bruno Mondadori, Milano 2008); The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, Carus
Publishing Company, Chicago 2003 (trad. it. di C. Italia, L’abuso della bellezza. Da Kant alla
Brillo box, introd. di M. Senaldi, Postmedia Books, Milano 2008); What Art Is, Yale University
Press, London 2013.
[2] Basti pensare a lavori come Nietzsche as Philosopher, Columbia University Press, New York
1965 e Jean-Paul Sartre, Viking Press, New York 1975.
[3] A.C. Danto, The Artworld, in «Journal of Philosophy», lxi, 19, 1964, pp. 571-84; trad. it. Il
mondo dell’arte, in Estetica analitica, num. mon. di «Studi di estetica», n.s., a. xxxi, n. 27, 2007,
pp. 65-86.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[4] Su Andy Warhol, Danto scriverà una monografia, intitolata Andy Warhol, Yale University
Press, London 2010 (trad. it. di P. Carmagnani, Andy Warhol, Einaudi, Torino 2010).
[5] Y. Michaud, L’arte allo stato gassoso. Un saggio sull’epoca del trionfo dell’estetica (2003),
trad. it. di L. Schettino, Edizioni Idea, Roma 2007, p. 35.
[6] F. Bonami, Lo potevo fare anch’io. Perché l’arte contemporanea è davvero arte, Mondadori,
Milano 2007, p. 13.
[7] A.C. Danto, La trasfigurazione del banale, cit., p. xxiv.
[8] A.C. Danto, Una conversazione (post-storica), con Manrica Rotili, in A.C. Danto, Oltre il Brillo
Box, cit., pp. v-ix: vi. In queste stesse righe, Danto spiega come l’opera di Warhol l’abbia portato a
pensare di trovarsi di fronte alla «fine dell’arte», intesa come la fine della possibilità di una
«narrazione evolutiva», espressione di una nuova era, quella «post-storica». È evidente il
riferimento a Hegel, per il quale il superamento dell’arte, nel mondo moderno, vive una fase di
«dissoluzione» (Auflösung), in relazione alla quale prende forma la nozione di «morte dell’arte».
Questa celebre espressione, che non è hegeliana, al di là di ciò che erroneamente si è talvolta
pensato, sta a indicare non una generale, completa ed effettiva scomparsa del fenomeno artistico,
quanto il fatto che l’arte si esaurisce nel suo essere mezzo per esprimere compiutamente il vero in
forma sensibile. Ripartendo da Hegel, Danto scrive: «Io sono per una fine della storia dell’arte, non
per la fine dell’arte. Non credo che tutto sia già stato fatto e che quindi non possiamo aspettarci più
nulla di sconvolgente dal mondo dell’arte. D’altronde […] l’idea di un futuro dell’arte non storico
fa del presente qualcosa di completamente aperto. Tutto è possibile» (ivi, pp. vi-vii).
[9] Dichiara Danto: «A un certo punto del mio percorso mi venne in chiaro come la totalità della
filosofia fosse in qualche modo connessa con la nozione di rappresentazione […] come le nostre
storie individuali non siano che le storie delle nostre rappresentazioni e del loro mutare nel corso
delle nostre vite; come le rappresentazioni formino sistemi che, a loro volta, costituiscono una
immagine del mondo; come la storia umana sia la storia del modo in cui tale sistema di
rappresentazione cambia attraverso il tempo; come il mondo e il nostro sistema di rappresentazioni
siano interdipendenti, nel senso che talvolta cambiamo il mondo perché si conformi alle nostre
rappresentazioni e tal’altra cambiamo le nostre rappresentazioni affinché si conformino al mondo»
(A.C. Danto, Lectio magistralis, cit. in S. Velotti, Presentazione di A.C. Danto, La destituzione
filosofica dell’arte, cit., p. 11).
[10] Cfr. G. Dickie, Art and the Aesthetic. An institutional analysis, Ithaca, London 1974; Id., «The
New Institutional Theory of Art», proceedings of the 8th Wittgenstein Symposium, 10 (1983), pp.
57-64.
[11] A.C. Danto, Una conversazione (post-storica), cit., p. vii.
[12] Su questi aspetti, mi sia consentito rinviare a G. Fronzi, Etica ed estetica della relazione,
Mimesis, Milano 2010.
[13] Ricordiamo che la questione degli indiscernibili era stata affrontata in particolare da Gottfried
Wilhelm Leibniz.
[14] Angela Vettese contesta il fatto che le diverse versioni di Brillo Box possano essere
considerate identiche. Prendendo in considerazione le scatole originali disegnate dal grafico Steve
Harvey negli anni Trenta, quelle presentate da Warhol nel 1964 e quelle di Mike Bidlo del 1991,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
intitolate Not-Warhol (Brillo Boxes 1969), perché mai dovremmo considerarli oggetti
indiscernibili? «Le scatole di Harvey sono di cartone; quelle di Warhol le riproducono in legno;
quelle di Bidlo, pure di legno, non sono fatte con lo stesso sistema di serigrafia usato da Warhol e
presentano meno imperfezioni e sgocciolature volute. Le prime servivano a contenere merci, le
seconde a portare sul piano dell’arte la grafica nata in ambito commerciale, le terze a mostrare come
si possa diventare una grande della storia dell’arte non inventando un’immagine, ma trasportandola
dalla cultura comune a quella alta […]». In definitiva, «siamo di fronte a oggetti di cui ciascuno è
matrice del secondo, eppure sono dissimili per funzione, per senso storico e anche per costituzione
materiale» (A. Vettese, «Presentare al posto di rappresentare», in Id., Si fa con tutto. Il linguaggio
dell’arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 48-9).
[15] Sull’estetica di stampo analitico e sul pensiero di Danto, cfr. F. D’Agostini, N. Vassallo (a cura
di), Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002; Estetica analitica, 2 voll., numero
monografico di «Studi di Estetica», s. 3, a. xxxi, 27-28, 2003; S. Chiodo (a cura di), Che cos’è
l’arte. La filosofia analitica e l’estetica, Utet, Torino 2007; T. Andina, A. Lancieri (a cura di),
Artworld & Artwork. Arthur C. Danto e l’ontologia dell’arte, in «Rivista di Estetica», n.s., a. xlvii,
35, 2/2007; T. Andina, P. Kobau (a cura di), Il futuro dell’estetica, in «Rivista di Estetica», n.s., a.
xlviii, 38, 2/2008; P. D’Angelo (a cura di), Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Roma-Bari
2008; P. Pellegrino, La bellezza tra arte e tradizione, Congedo Editore, Galatina 2008, in
particolare i capp. «La scomparsa della bellezza nell’estetica analitica» e «Analitici e continentali: il
tema della bellezza e il ruolo dell’estetica» (pp. 104-130); S. Velotti, Estetica analitica. Un
breviario critico, in «Aesthetica Preprint», n. 84, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo
2008; L. Marchetti, Oggetti semi-opachi. Sulla filosofia dell’arte di Arthur C. Danto, Albo
Versorio, Milano 2009; T. Andina, Arthur Danto. Un filosofo pop, Carocci, Roma 2010.
[16] Sul tema della relazione nell’ambito dell’estetica analitica cfr. M. Weitz, The Role of Theory in
Aesthetics, in «Journal of Aesthetics and Art Criticism», xv, 1956 (trad. di A. Ottobre, Il ruolo della
teoria in estetica, in P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica, il mulino,
Bologna 2007, pp. 13-27); A.C. Danto, The Artworld, cit.; Id., Artworks and Real Things, in
«Theoria», 39, 1973; M. Mandelbaum, Family Resemblances and Generalizations concerning the
Arts, in «American Philosophical Quarterly», ii, 1965, pp. 219-228 (poi in G. Dickie, R.J. Sclafani
[a cura di], Aesthetics. A Critical Antology, St. Martin’s Press, New York 1977); G. Dickie,
Defining Art, in «American Philosophical Quarterly», vi, 1969; Id., Art and the Aesthetic. An
institutional analysis, Ithaca, London 1974; J. Levinson, Defining Art Historically, in «British
Journal of Aesthetics», xix, 1979; M.C. Beardsley, Aesthetics. Problems in the Philosophy of
Criticism, Hackett Publishing, Indianapolis 1981.
[17] Per un’analisi delle vicende della bellezza nella storia dell’occidente, cfr., fra i tanti volumi
disponibili, R. Bodei, Le forme del bello, il Mulino, Bologna 1995; G. Carchia, Arte e bellezza, il
Mulino, Bologna 1995; H.-G. Gadamer, L’attualità del bello (1977), trad. it. di R. Dottori e L.
Bottani, Marietti, Genova 1986; A. Marwick, Storia sociale della bellezza. Dal Cinquecento ai
giorni nostri, trad. it. di A.L. Zazo, Leonardo, Milano 1991; F. Rella, L’enigma della bellezza,
Feltrinelli, Milano 1991; G. Santayana, Il senso della bellezza (1896), a cura di G. Patella,
Aesthetica Edizioni, Palermo 1997; S. Zecchi, La bellezza, Bollati Boringhieri, Torino 1990; Id.,
L’artista armato. Contro i crimini della modernità, Mondadori, Milano 1998; U. Eco (a cura di),
Storia della bellezza, Bompiani, Milano 2004; E. Matassi, W. Pedullà, F. Pratesi, La Bellezza, a
cura e con un saggio introduttivo di R. Gaetano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; P. Pellegrino,
La bellezza tra arte e tradizione, cit.; F. Vercellone, Oltre la bellezza, il mulino, Bologna 2008; R.
Scruton, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica (2009), trad. it. di L. Majocchi, Vita &
Pensiero, Milano 2011; N. Zangwill, La metafisica della bellezza (2001), trad. it. e cura di M. Di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Monte, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2011; W. Menninghaus, La promessa della bellezza
(2003), trad. it. di D. Di Maio, a cura di S. Tedesco, Aesthetica, Palermo 2013.
[18] Y. Michaud, L’arte allo stato gassoso, cit., p. 35.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Niente di nuovo, niente di realistico, niente di filosofico
di FRANCA D’AGOSTINI
È in libreria un nuovo libro di Franca D’Agostini: "Realismo? Una questione non controversa",
Bollati Boringhieri: un percorso nei dibattiti filosofici contemporanei sul tema del realismo, dal
postmodernismo a oggi. L’autrice discute, tra l’altro, il new realism di cui si è parlato e si parla
molto, specie in Italia. Qui pubblichiamo un ulteriore intervento di D'Agostini sul tema.
1. Nuoveau realistes
Quando (intorno all’anno 1978) apparve il fenomeno mass mediatico ed editoriale dei «nouveaux
philosophes», chiesero a Gilles Deleuze «che cosa pensi dei nuovi filosofi?» e il filosofo francese,
maestro dei «maestri di Parigi» (perché da lui provenne il meglio del post-strutturalismo) rispose:
«niente». In effetti, era difficile dire che cosa ci fosse propriamente “da pensare” nell’operazione di
Bernard Henry Lévy, André Glucksmann e compagni.
Non si trattava di filosofia ma di una minestra molto riscaldata di tesi diventate quasi ovvie (per
esempio l’affinità tra il totalitarismo comunista e quelli nazista e fascista), rovesciate nella zuppiera
della casa editrice per cui Lévy lavorava, e di vari giornali e televisioni, e offerta da personaggi in
camicia bianca e capelli scompigliati ad arte, a una cena i cui invitati erano per lo più politici di
sinistra preoccupati del declino del comunismo, e con amicizie segrete per la destra.
Qualcosa di molto simile sta succedendo, mi sembra, con il «nuovo realismo», il «movimento
filosofico» di cui si insiste a dare notizia da circa due anni, su Repubblica (l’ultimo annuncio è del
25/10) e in vari altri luoghi. Ma in modo ancora più triste e confuso. Anzitutto perché nel caso dei
nouveaux philosophes era la prima volta che veniva promosso, come si disse, il «supermarket
filosofico», ossia il vero e conclamato ingresso della filosofia nel territorio fangoso dei media e
della comunicazione di massa. Dunque almeno la forma del fenomeno (la zuppiera, per così dire)
era nuova. Poi perché Glucksmann, Lévy e compagni si avvalevano (pur non riconoscendolo) di un
vero movimento di idee nuove che si era prodotto in Francia tra la metà degli anni Sessanta e la
metà dei Settanta, il cosiddetto poststrutturalismo o neostrutturalismo. Invece il nuovo realismo
tenta di trasformare in movimento lo sfondo tutt’altro che movimentista della filosofia
contemporanea. Perché da tempo in ciò che chiamiamo “filosofia” non c’è più (e per fortuna, io
credo) lo strife of systems, la lotta dei sistemi, ma ci sono invece diverse discipline specializzate che
operano parallelamente, e che oggi (a quel che so) stanno cercando un quadro di riferimento
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
comune, una “filosofia prima”, direbbe Aristotele. (Io credo anzi che questa filosofia prima si stia di
fatto delineando. Ma un conto è cercare e descrivere una nuova filosofia prima, un altro conto è
produrre “movimenti”.)
In generale, non c’è mai male nel far circolare parvenze di idee filosofiche, o anche solo i nomi
filosofici tradizionali, come “realtà”, “verità” o anche “filosofia”. Perlomeno, si attira l’attenzione
sul fatto che esistono problemi relativi a questi nomi, e vale la pena che tutti ne tengano conto. Però
c’è sempre un rischio, che non va sottovalutato, ed è il rischio che il risultato ultimo della procedura
sia un annientamento dei contenuti sostanziali che la procedura stessa nominalmente promuove.
Più banalmente: ciò che ne fa le spese, nel «nuovo realismo», secondo me è precisamente il nuovo
realismo, vale a dire: la nuova consapevolezza collettiva che sta affiorando nella vita pubblica circa
i concetti di verità e realtà – e affiora per ragioni molto semplici, di cui in molti hanno parlato
ripetutamente (io stessa): per l’avanzare mondiale della democrazia. E ovviamente ne fanno le
spese anche le novità importanti che la filosofia recente ha prodotto proprio riguardo ai “superconcetti” filosofici di realtà e verità. In altre parole: ciò che ne fa le spese è il nuovo paradigma di
filosofia prima che si sta faticosamente cercando e di fatto forse trovando.
Esattamente nello stesso modo, la nouvelle philosophie azzerò, e rese definitivamente stupida,
quell’ipotesi di nuova filosofia (nuovo marxismo, nuova sinistra) che si stava annunciando in quegli
anni.
2. Stultificazione
È il fenomeno che chiamo stultificazione, dal verbo inglese to stultify, che significa contraddire,
annientare dal punto di vista intellettuale, ma anche rendere irrilevante, stupido. Ed è un fenomeno
abbastanza frequente, in filosofia. In una certa misura è quasi inevitabile, quando avviene il contatto
tra filosofia e mass media. Però, ripeto: credo che tale contatto sia una buona cosa, e anzi sia in una
qualche misura necessario. Non sempre inoltre ha esiti stultificanti. Ma il disastro è assicurato
quando nell’ambiente stesso in cui si effettua l’operazione non si ha la minima idea di che cosa sia
la filosofia, come funzioni, e perché abbia senso occuparsene, ma circola la confusa percezione che
in ciò che si chiama “filosofia” sia in gioco qualcosa di prestigioso, e importante per tutti.
Avviene allora che niente di nuovo, niente di realistico, e soprattutto niente di filosofico venga
presentato come espressione di un nuovo realismo filosofico, e sia in qualche modo quasi
autorizzato a presentarsi per tale. È quanto accade di fatto con il new realism descritto e propagato
da Ferraris, con ostinato e pervasivo metodo di sfruttamento di tutti gli spazi disponibili, e
sistematica cancellazione o elusione delle voci dei contrari o dei perplessi (che non siano troppo
illustri o potenti per poter essere liquidati o ignorati, nel qual caso dovranno essere rabboniti).
Se cercate in effetti che cosa realmente dicano i nuovi realisti di nuovo e di realistico la risposta di
Deleuze è inevitabile: non trovate niente. I due più “movimentisti” del gruppo sono Markus Gabriel
e ovviamente Maurizio Ferraris. Il primo è molto giovane, ed è stato ingaggiato in un’impresa da
cui era meglio dispensarlo. Il secondo sta da tempo presentando come filosofia una produzione di
stile tipicamente postmoderno, fatta di tesi molto vaghe e oscillanti (scienza no, scienza sì, verità
no, ma anche sì, documenti ovunque ma non proprio ovunque, testualismo sì, ma debole,
costruzionismo sì, ma solo in parte, ermeneutica no, però anche sì …), e quando non vaghe e
oscillanti, polemicamente rivolte contro un antirealismo metafisico (effettiva scomparsa dei fatti,
annientati dalle interpretazioni) che nessuno ha mai realmente sostenuto, e che ripetono l’antica
polemica di Sokal e Brickmont e di altri contro il postmodernismo.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Gli altri sono vecchi filosofi che non hanno più molto da dire, come Putnam o Searle, e i cui
“realismi” (ma discuterei l’uso di questa espressione a loro riguardo) non hanno nulla ma proprio
nulla a che fare con i realismi realmente nuovi di cui oggi possiamo parlare. Oppure persone che
visibilmente non hanno alcuna vera competenza sul tema del realismo perché non si occupano di
metafisica, ma di altro (filosofia del linguaggio, letteratura, architettura, ecc.).
Un autore ufficialmente “nuovo-realista” che sembra avere una certa competenza sull’argomento è
Mario De Caro. Se però leggete ciò che De Caro dice (per esempio nel suo intervento in Bentornata
realtà, il libro da lui curato con Ferraris: Einaudi, 2012), scoprite con sorpresa che non si dichiara
affatto realista, e sembra nutrire anche qualche dubbio sulla stessa locuzione, di per sé considerata.
De Caro dice che in filosofia non si tratta di realismo e antirealismo, ma piuttosto di “gradi”
dell’uno dell’altro; e quanto a lui non si colloca in nessun punto della scala. Si limita invece a dar
conto del fatto che nella metafisica analitica le posizioni realistiche sono diventate più importanti,
ma – circostanza per me incomprensibile – evita apertamente di dar conto dell’unico nuovo
realismo oggi circolante, quello cosiddetto «australiano» (che peraltro conosce benissimo).
3. Un caso italiano
È mai possibile che il gran clamore suscitato da Ferraris corrisponda davvero a questa esiguità e
vaghezza di contenuti? Sì è possibile. E la ragione è molto semplice: perché ci sono altre due
importanti differenze da considerare tra i nouveaux philosophes e i nuovorealisti.
La prima è che la nouvelle philosophie emergeva in un’epoca in cui esistevano di fatto ancora
“voci” filosofiche autorevoli, che potevano contrastarla, o comunque costituire un’alternativa. In
altri termini c’era uno sfondo autentico di filosofia pubblica, entro il quale i nuovi filosofi si
rivelavano abbastanza chiaramente per quel che erano. Ed esistevano ancora, come ho detto, e
avevano senso, “movimenti” filosofici. Tanto è vero che la nouvelle philosophie fu presto
sopraffatta dall’emergere ben più potente e devastante del postmodernismo (creatura principalmente
americana).
Invece il nuovo realismo emerge in un’epoca in cui non c’è niente di tutto questo, e forse non ci può
essere, e forse è bene che non ci sia. Dunque è abbastanza naturale che la stultificazione
nuovorealista e la simulazione di movimento che essa produce operino con efficacia, avanzando nel
vuoto, e non trovando reali e seri antagonisti.
La seconda è che i nuoveaux philosophes erano francesi, e i nuovorealisti sono (principalmente)
italiani: il che vuol dire molto. Vuol dire, per esempio, che il nuovorealismo di Ferraris è piombato
in una comunità scientifica particolarmente dissestata da povertà di mezzi e corruzione, e dai frutti
naturali dell’una e dell’altra: il declino inevitabile della qualità intellettuale e morale.
Oggi molti contrastano questo andamento nazionale, e la generazione degli studiosi più brillanti e
onesti non si trova solo all’estero: anche nell’università italiana ne incontriamo molti. Ma proprio
qui incomincia il rischio: che il “movimento” di costoro (che ovviamente non è filosofico, né
ideologico, e meno che mai metafisico ma semplicemente politico-morale) risulti stultificato e
annullato da qualcosa che gli assomiglia, ma non è affatto la stessa cosa. Perché in molti sappiamo
che c’è qualcosa di nuovo in filosofia, e anche nel pensiero comune; ma non sembra essere quello
che con gran clamore ci viene detto essere.
Insomma, il nuovorealismo nella versione ferrarisiana finisce per lasciar passare e incoraggiare il
vecchio frenando le effettive novità che stanno emergendo: un’operazione che in Italia conosciamo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
bene, visto che (così si dice) far mostra di cambiare le cose perché le cose non cambino affatto
contraddistingue lo stile nazionale, da Tomasi di Lampedusa a Silvio Berlusconi.
Che fare? Non ho le idee chiare. Lamentarsi del degrado del linguaggio pubblico non ha il minimo
senso: personalmente, apprezzo la democrazia, e penso che i suoi limiti e le sue crisi di crescita non
vadano condannate, ma se mai curate. Non condivido i lamenti neo-francofortesi contro la civiltà
dei consumi, la follia e la degrazione della comunicazione nella Rete, e così via. In generale non
condivido i lamenti e le denuncie che si presentano senza offrire soluzioni.
Forse la soluzione però ci sarebbe: bisognerebbe riconoscere che operazioni come quella di Ferraris,
e dei suoi modelli (il postmodernismo, il pensiero debole, i nuovi filosofi francesi, e il
movimentismo filosofico di Nietzsche), sono oggi inutili tergiversazioni, perché c’è grande lavoro
da fare, di altro tipo. In altri termini, bisognerebbe porre fine a quello stile di filosofia pubblica
tipicamente tardo-sofista, che solleva gran clamore intorno al niente, allo scopo non lodevole di fare
delle debolezze della filosofia, dell’università, della vita pubblica democratica, una ragione di forza
e di vantaggio personale.
Nata a Torino l’11 settembre del 1952, Franca D'Agostini dopo il liceo classico studia filosofia
nella sua città, dove si laurea nel 1976 con una tesi su “La filosofia della scena di Antonin
Artaud”. Consegue poi il dottorato in filosofia (sempre all’Università di Torino).
Autrice di quindici libri e di saggi e articoli in varie lingue su riviste e volumi collettanei,
collaboratrice dei quotidiani la Stampa, la Repubblica, il Manifesto, ha svolto lezioni e
conferenze in varie Università europee e americane, e ha insegnato a contratto (Teoretica e
Filosofia della Scienza) in varie Università italiane. Dal 2000 insegna Filosofia della Scienza al
Politecnico di Torino e dal 2010 Logic and Epistemology of the Social Sciences alla Graduate
School of Economic, Politic and Social Sciences dell’Università Statale di Milano (Scienze
Politiche).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
La metamorfosi del signor P(otere)
di PAOLO ERCOLANI
Parafrasando un celebre frammento di Eraclito, in cui il grande filosofo antico si riferiva alla
natura, potremmo dire che l’epoca della società in rete, o della globalizzazione, è quella in cui il
Potere ha subito una trasformazione tanto poco percettibile quanto sostanziale e profonda: siamo
infatti passati dal Potere che nasconde, censura, manipola o coarta il flusso delle informazioni (o
disinformazioni), a quello che ama nascondersi, trasfigurare i propri meccanismi di funzionamento
e influenza, mascherare i luoghi del proprio abitare e operare. Lo scopo è sempre lo stesso, la
perpetuazione del Potere stesso, ma le modalità mutate debbono indurre a più di una riflessione.
1. Luci e ombre
Il Potere che ama nascondersi è quello a cui non importa più se e quanto la popolazione possa o
debba sapere, perché il suo essere nascosto, tale per cui non si sa bene chi lo detiene, da dove e con
quali modalità di esercizio, gli consente comunque di attuare un dominio sulla pubblica opinione
(nonché sulle menti e sui corpi degli individui), ancora più capzioso perché in grado di inserirsi nei
meandri della mente collettiva e assurgere al rango di senso comune consolidato, pensiero unico
difficilmente smentibile se non al prezzo di essere tacciati di follia o paranoia.
A un livello squisitamente tecnico la questione non deve sorprendere più di tanto, se è vero che già
Platone ci aveva insegnato che le malattie degli occhi, per cui essi finiscono col non riuscire più a
vedere, sono di due tipi e hanno due cause: «il passaggio dalla luce all’ombra e dall’ombra alla
luce»[1].
Tanto l’oscurità più totale, quanto un eccesso di luce producono degli esseri umani incapaci di
pervenire alla distinzione chiara delle cose e quindi alla conoscenza, limitandoli bene che vada a
una pallida percezione di ombre scambiate per oggetti reali.
E qui entra in gioco la Rete, onnipotente e generosissima dispensatrice di informazioni infinite e di
ogni genere, in cui è possibile rintracciare l’avallo a qualsiasi ipotesi anche strampalata e al suo
contrario.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Il risultato, ovviamente, è quello di una impossibilità di approssimarsi a delle verità nitide,
abbagliati dalla troppa luce dell’«opulenza informativa» e dimentichi che il tutto confina
paurosamente con il nulla.
Entriamo così nel nerbo di quel «cambiamento radicale» nelle modalità di attuazione del disegno
coercitivo del potere di cui ci parlava Maldonado: «Nel passato, anche quello più recente tale
disegno faceva ricorso all’indigenza informativa, ora invece è l’opulenza informativa che viene
privilegiata»[2].
Siamo perfettamente all’interno dell’intuizione di Platone, ripresa efficacemente da Günther Anders
quando nel 1980 descriveva il «metodo odierno» del potere, che impedisce la comprensione non più
fornendo poche notizie ai cittadini, ma fin troppe, mettendoci in una condizione per cui «veniamo
sopraffatti da una tale abbondanza di alberi affinché ci venga impedito di vedere la foresta», e
impedendoci quella «visione d’insieme» delle cose che per Hegel rappresentava una dote
imprescindibile nel cammino della conoscenza[3].
2. L’èra post-democratica
Che non si sta parlando di questioni minimali, è un fatto agevolmente riscontrabile non appena ci si
riferisca ai grandi padri del liberalismo contemporaneo, concordi nell’affermare che il cammino
della democrazia, per quanto imperfetto e irto di contraddizioni, avanza inesorabile soltanto laddove
vi siano cittadini informati e critici, disposti a impegnarsi nelle faccende della società civile in
seguito all’acquisizione di una conoscenza che si traduce in costruzione del bene comune.
Informazione e autonomia critica sono le doti fondamentali dei cittadini di una democrazia, quelle
che permettono di esercitare il «controllo pubblico del potere», «tanto più necessario in un’età come
la nostra in cui gli strumenti tecnici di cui può disporre chi detiene il potere per conoscere
capillarmente tutto quello che fanno i cittadini è enormemente aumentato, e praticamente
illimitato»[4].
Insomma, se una delle essenze dell’essere umano è quella di configurarsi come homo politicus,
nella misura in cui si serve della propria ragione e delle conoscenze a disposizione per contribuire al
progresso della società, questa facoltà va potenziata e resa possibile dalla «pianificazione» di un
consorzio sociale in cui siano ampiamente garantite le libertà degli individui, a partire da quelle
«istituzioni sociali che proteggano la libertà di critica e di pensiero» e impediscano di votarsi a
platoniche «autorità pseudo-razionali»[5].
L’autorità più razionale che ha reso possibile il progredire delle società occidentali è lo Stato, inteso
come res publica e quindi luogo in cui l’individuo è cittadino in quanto caratterizzato da diritti e
doveri universalmente riconosciuti (almeno in linea teorica), a cominciare dal diritto-dovere per
antonomasia: l’espressione di un consenso politico ed elettorale informato e maturo, volto alla
formazione di quel potere legislativo in vista del bene comune.
Naturalmente, il potere dello Stato, esposto alle degenerazioni e agli abusi propri di ogni condizione
di supremazia, oltre che a livello costituzionale e di equilibrio dei poteri, dovrebbe essere
controllato dai cittadini stessi, la cui vigilanza interessata alla tutela dei propri diritti porta a un
controllo efficace degli stessi governanti, secondo quanto sanzionato dalla stessa Corte di giustizia
dell’Unione europea[6].
Si tratta di quella «democrazia di sorveglianza»[7] di cui parla Pierre Rosanvallon, che oggi viene
minata dal forte indebolimento dei due pilastri su cui essa ha trovato fondamento e determinatezza
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
pratica e concettuale: da una parte lo Stato, ormai «incapace di controllare le reti globali della
ricchezza, del potere e delle informazioni»[8]; dall’altra l’opinione pubblica, uniformata, indebolita
e alla fine resa passiva da un sistema di vecchi e nuovi media fondato su quella che Pasolini
chiamava «misologia», cioè da un’operazione meticolosa e sistematica di distruzione del libero
pensiero, dell’autonomia critica e dell’impegno politico e culturale, al punto da qualificare la nostra
come l’epoca della «mediacrazia»[9].
3. L’impero invisibile
Sulle macerie dello Stato e di un’opinione pubblica informata e critica si è determinato un Potere
nuovo, che trova nell’economia e nella tecnica i pilastri su cui fondarsi.
Un Potere sovranazionale e ramificato ben oltre i confini statuali, capace di essere al tempo stesso
in tutti i luoghi e in nessuno. Che alla ricerca del bene comune sociale ha sostituito il perseguimento
del profitto economico, mentre alle dinamiche istituzionali fondate sul consenso e sul
pronunciamento democratico dei cittadini oppone sempre più la platea virtuale, indistinta e quindi
sterile della popolazione in Rete.
Quello che Daniel Estulin ha chiamato «potere invisibile», perfettamente in grado di sostituirsi al
vecchio Stato, esattamente come l’idea di «Paese» viene soppiantata da quella di «Impresa
mondiale Spa» e il «popolo» stesso perde di rilevanza a favore dei più impersonali «interessi»[10].
Lo sappiamo bene noi in Italia, del resto, che per un anno abbiamo avuto un governo, quello
presieduto dai cosiddetti «professori», capitanato da un Presidente del Consiglio (Mario Monti) che
non si faceva alcuno scrupolo a dichiarare che il suo obiettivo non era il benessere dei cittadini e
della loro qualità della vita, bensì il soddisfacimento degli asettici e impersonali diktat numerici
imposti dai famigerati mercati.
Un potere invisibile e apparentemente impersonale, quindi, di cui è arduo scorgere la localizzazione
precisa e anche gli individui che la compongono, ma che vede delimitata con certezza la sua
piattaforma ideologica e programmatica: il neo-liberismo più spinto e incurante delle istanze
politiche e di giustizia sociale, la ricerca spasmodica ed esclusiva del profitto, in nome del quale
tutti gli stati sono chiamati non solo a sottomettersi ai diktat dei mercati, delle agenzie di rating e
dell’FMI, ma a riconfigurarsi del tutto fino ad assumere la nuova identità di stati-mercato o stati
imprese. In cui evidentemente gli abitanti non sono più cittadini depositari di diritti politici e sociali,
ma soggetti consumanti e pedine di un ingranaggio i cui fini non hanno a che fare con il benessere
diretto della popolazione.
Si tratta di un meccanismo tanto efficace quanto pervasivo e globale, che ha condotto lo studioso
finlandese di politica internazionale Heikki Patomäki a esprimersi in termini di «sistema
panottico»[11], quindi capace di vedere tutto e tenere sotto controllo ogni cosa, senza però lasciarsi
scorgere a sua volta con chiarezza da chi non vi è dentro.
Un potere del genere è perfettamente in grado di influenzare e perfino determinare le politiche degli
stati, fino proprio a sostituirvisi del tutto, perché opera in un contesto, quello della globalizzazione e
dei network, che sembra aver realizzato il sogno secolare dei liberisti di ogni tempo: un campo di
azione dove non vi sono regole che intralciano il libero gioco della concorrenza, dove non vi sono
limiti etici o persino morali imposti dai governi, dove insomma non ci sono le leggi né lo Stato, e
persino a livello diplomatico sono le negoziazioni fra grandi imprese a contare nei rapporti di forza
internazionali, ben più di quanto possano incidere gli attori istituzionali e governativi[12].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Si tratta di una regressione rispetto alla grande conquista politica acquisita dal genere umano con la
modernità: se allora si costruirono i grandi stati seguendo l’imperativo per cui «bisogna uscire dallo
stato di natura», oggigiorno siamo tornati a un terreno di libertà talmente assoluta (per i soggetti
economici e tecnocrati più forti e influenti) da configurarsi come anarchia, quella dimensione in cui
l’unico criterio in vigore è la legge del più forte.
4. Homo sapiens/homo videns, homo politicus/homo religiosus
Come è fisiologico e perfino necessario che accada, il terreno su cui è avvenuta questa mutazione
strutturale del potere, è stato sapientemente preparato da quella che possiamo definire una vera e
propria «riconfigurazione dell’essere umano». Insomma, da una vera e propria riconfigurazione
delle menti di coloro che formano l’opinione pubblica, dei cittadini destinatari dei messaggi e della
propaganda che il potere vuole (e ha interesse di) diffondere.
Si tratta di ricostruire in maniera sintetica, e quindi inevitabilmente schematica, un percorso lineare.
Il primo stadio è avvenuto quando, con l’esplodere del mezzo televisivo, le nostre società hanno
gradualmente introiettato la dimensione in cui si rivela «la centralità dello schermo e la nascita di
una cultura delle immagini»[13]. Ciò aveva condotto, per esempio secondo il politologo italiano
Giovanni Sartori, a quella che lui definiva una regressione dall’homo sapiens all’homo videns,
regressione prodotta da un mezzo, quello televisivo, «che inverte il progredire dal sensibile
all’intelligibile e lo rovescia nell’ictu oculi, in un ritorno al puro e semplice vedere» da cui risulta
atrofizzata tutta la nostra capacità astraente, di elaborazione cognitiva di ciò che guardiamo e, con
essa, «di tutta la nostra capacità di capire».
Il secondo stadio è quello per cui è avvenuta la trasformazione dall’homo politicus all’homo
religiosus, ossia da un uomo che si fa carico kantianamente delle proprie responsabilità esistenziali
e sociali, utilizzando la propria ragione per migliorare il consorzio umano senza la presunzione di
risultati ottimali e definitivi, a un uomo che, per dirla con Freud, sacrifica volentieri buona parte
della propria autonomia e libertà per sottomettersi a degli ordini superiori da cui aspettarsi un
risultato ottimale e definitivo. Forze trascendenti o trascendentali che, alla stregua di un dio, come
potrebbero essere la Rete o il Mercato, garantiscano all’uomo di potersi occupare esclusivamente
dei propri scopi individuali ed egoistici perché tanto v’è una mano invisibile, un ordine spontaneo, o
un’armonia prestabilita a garanzia comunque del progresso e della prosperità della società
intera[14].
Si tratta di un passaggio epocale che non ha segnato soltanto il trapasso dalla società industriale a
quella in Rete, ma anche e soprattutto la fine di una certa forma mentis illuministica, in cui
prevaleva il sapere aude di kantiana memoria, a favore di un ritorno al noli altum sapere sed time
che San Paolo aveva lanciato come monito all’uomo cristiano.
Oggigiorno non ci viene più richiesto di votarci alla forza trascendente di un dio, sottomettendoci al
quale otterremo la salvezza eterna, bensì di affidarci anima e corpo alle virtù salvifiche del dio
Mercato, i cui effetti benefici dobbiamo aver fede che saranno garantiti malgrado per ottenere il
risultato sarà necessario un certo numero di vittime. Una forma di escatologia terrena che abbiamo
già visto nel corso della storia, per la quale si doveva essere disposti a tollerare sacrifici e vittime
nell’immediato in vista del bene supremo finale garantito.
5. Dalla società dell’informazione a quella della formazione
Molte di queste riflessioni e considerazioni si sono sviluppate attraverso la lettura di due volumi
recentemente usciti nel nostro Paese. Apparentemente diversi, negli argomenti trattati come nella
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
biografia degli autori (uno degli storici più importanti al mondo da una parte, e quello che forse è il
massimo esperto di televisione in Italia dall’altra), ma in realtà legati da un filo rosso quanto mai
importante, che può essere espresso in questi termini: si tratta di due volumi la cui lettura consente
di comprendere come si sono trasformate le società occidentali nel passaggio epocale dalla società
industriale, o dal vecchio mondo pre-Ottantanove, all’epoca della globalizzazione e dei network.
Carlo Freccero, nel suo Televisione (Bollati Boringhieri 2013), riesce perfettamente, attraverso
appunto l’analisi dell’old media più famoso, a delineare tanto i connotati delle società europee
(tradizionalmente costruite sugli ideali del servizio pubblico, della giustizia sociale e, più in
generale, di una concezione del consorzio umano in cui il profitto non ricopre un ruolo
determinante), quanto i fondamenti culturali della società americana (Stato minimo, competizione
sociale, massima centralità del profitto come ideale regolativo). La seconda è quella che ha prevalso
con l’affermazione del mondo globalizzato, attraverso un passaggio storico culturale che Freccero
sintetizza in una pagina che vale la pena di riportare:
«Il Novecento come teatro delle grandi ideologie politiche finisce simbolicamente con la caduta del
muro di Berlino. Cade il muro dell’ideologia, cade il muro del comunismo […] Ma il crollo di un
muro non significa necessariamente il raggiungimento della libertà. E’ un lieto fine, come nelle
favole. Ma se nelle favole c’è il lieto fine è perché la narrazione si interrompe nel momento
migliore […] Il crollo del muro di Berlino, così come è stato immortalato dai filmati e dalle
fotografie, è diventato un icona di libertà. Ma celebra semplicemente la sostituzione di un ordine
con un altro ordine, di un muro con un altro muro: annunciava l’uscita dal comunismo, ma, allo
stesso tempo, affermava la vittoria di quel liberismo duro e puro, dei cui eccessi paghiamo oggi le
spese dopo il crollo, altrettanto simbolico, del mercato di Wall Street» (C. Freccero, Televisione,
Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 125-126).
Dall’altra parte troviamo lo straordinariamente ricco volume in cui Antonio Carioti intervista, con
domande mai banali né comode, lo storico Luciano Canfora praticamente su duemila anni di storia
del mondo (Intervista sul potere, Laterza, Roma-Bari 2013). Ed è proprio da questa notevole
ricostruzione di lungo periodo (resa possibile dalla cultura storica sterminata di Canfora), in cui la
storia antica si intreccia con quella moderna e contemporanea attraverso accostamenti e similitudini
suggestivi, che si aprono degli squarci illuminanti di riflessione sul cambiamento epocale dei nostri
tempi. Tempi per i quali Canfora arriva a parlare di «post-democrazia», poiché «siamo entrati in
una fase in cui la democrazia politica è quasi completamente archiviata: ormai il potere è in gran
parte delegato a soggetti non elettivi, di carattere tecnico, magari anche ragguardevoli, che si
impongono attraverso strumenti sempre più sofisticati» (p. 28).
Di fronte a un Occidente in piena implosione («la catastrofe è sotto gli occhi di tutti», p. 255), in cui
il potere è esclusivamente potere economico, mentre la cultura e il consenso democratico devono
sottomettersi alle logiche quantitative e strutturalmente inique di un capitalismo a cui è venuto a
mancare il suo contraltare (quel comunismo rispetto al quale Canfora, comunque, non nega un
bilancio storico anche fallimentare), lo storico non si tira indietro e formula una proposta costruttiva
che, ci piace pensare, deriva proprio dal concetto di historia magistra di ciceroniana memoria:
«Io mi limito ad avanzare un’ideuzza, che spesso ripeto. A mio parere, il luogo dove le tendenze
oligarchiche dominanti possono e devono essere messe in discussione è il laboratorio immenso
costituito dal mondo della formazione e della scuola. Per quanto ammaccato in mille modi, nei
nostri paesi avanzati resta una struttura che tocca e pervade l’intera società. E’ lì che l’educazione
anti-oligarchica, su base critica, può farsi strada. Ecco perché, facendo un bilancio di quanto mi è
accaduto di pensare nel corso di questi anni, ritengo che deprezzare e dequalificare il mondo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
dell’insegnamento, tanto nella scuola quanto nell’Università, sia un gesto suicida» (L. Canfora,
Intervista sul potere, a cura di A. Carioti, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 264).
In effetti, da queste parole del grande storico italiano si può evincere quello che è probabilmente il
tratto saliente della società emersa dalla fine del Novecento: una società dell’«informazione» in cui
il Potere ha visto bene di mortificare e marginalizzare al massimo grado il momento della
«formazione», storicamente necessario alla costituzione di un’opinione pubblica critica e impegnata
sul versante della res publica.
Né del resto ci si può più nascondere dietro a presunte teorie del complotto o della cospirazione,
tendenti a dileggiare e smentire coloro che parlano di poteri forti e invisibili perfettamente in grado
di controllare la vita pubblica e, soprattutto, quella privata di milioni di cittadini grazie al
monitoraggio segreto delle telecomunicazioni.
Le recenti rivelazioni fornite al grande pubblico dall’ex tecnico della Central Intelligence Service
Edward Snowden, infatti, dimostrano in maniera inoppugnabile come, per esempio la National
Security Agency del governo americano, ha escogitato un sofisticato sistema tecnologico per
monitorare tutto il traffico pubblico e privato di Internet e non solo, consentendo di ascoltare,
leggere e decrittare e-mail, telefonate e navigazione in Rete dei privati cittadini. Il New York Times
è arrivato a scrivere senza mezze misure che i documenti svelati da Snowden «rendono manifesto
che la Nsa considera la propria abilità di decrittare informazioni una facoltà di vitale importanza, in
cui essa compete con la Russia, la Cina ed altre agenzie di intelligence»[15].
Non ci possiamo permettere la visione idilliaca di un mondo, per dirla con le parole del poeta
Tadeus Borowski, governato dalla giustizia e dalla moralità, perché in realtà la condizione umana è
quella in cui «il delitto non viene punito, né la virtù premiata», ma soprattutto dobbiamo essere
consapevoli che «il mondo è governato dal potere»[16], un potere che è tanto fisiologico che esista
quanto necessario che lo si conosca e lo si tenga quanto più possibile in una posizione trasparente e
al servizio del bene della comunità.
Abdicare rispetto a questo compito, significa rinunciare alla possibilità più essenziale di cui
disponiamo in quanto abitanti di questo pianeta: quella di essere (ragionevolmente) liberi.
NOTE
[1] Platone, Repubblica: VII, 518a, testo greco in Platonis Opera-The Works of Plato, a cura di J.
Burnet, 5 voll., Clarendon Press, Oxford 1901-1907.
[2] T. Maldonado, Critica della ragione informatica, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 89-91.
[3] G. Anders, L’uomo è antiquato. La terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino
1980, p. 234.
[4] N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984, p. 19.
[5] K. Popper, The Open Society and Its Enemies, 2 voll., Routledge & Kegan Paul, London 1973,
v. II, pp. 238-9.
[6] Cfr. L. Dubouis – C. Gueydan, Les Grands Textes du droit de l’Union Européenne, Dalloz,
Paris 2002, t. I, pp. 440-2.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[7] P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, Paris 2006,
cap. I.
[8] M. Castells, Communication Power, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 296.
[9] Cfr. P.P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, Mondadori, Milano 1999, p. 139 per il
concetto di «misologia»; e P. Ercolani, L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione stanno
costruendo una società post-umana, prefazione di Umberto Galimberti, pp. 186 sgg. per la teoria
della «mediacrazia».
[10] D. Estulin, El imperio invisible, Bronce, Barcelona 2011, epílogo.
[11] H. Patomäki, Democratizing Globalization, Zeld, London 2001, p. 101.
[12] Cfr. S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy,
Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), pp. 64 sgg..
[13] J. Van Dijk, The Network Society. Social Aspects of New Media, Sage, London 2006, p. 213.
[14] Per una disamina più approfondita e dettagliata di questo passaggio, mi permetto di rinviare al
mio L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post-umana,
prefazione di Umberto Galimberti, Dedalo, Bari 2012, in particolare il cap. I («L’innocenza del
divenire»).
[15] Cfr. N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web, The New York Times del 6
settembre 2013, p. A1.
[16] Cit. in J. Hillman, Kinds of Power. A Guide to Its Intelligent Uses, Doubleday, New York
1995 p. 244.
Paolo Ercolani insegna storia della filosofia e teoria e tecnica dei nuovi media all’Università di
Urbino. Collabora all’inserto culturale del Corriere della sera («La Lettura»), è redattore
della rivista Critica liberale, oltre che fondatore e membro del comitato scientifico
dell’Osservatorio filosofico (www.filosofiainmovimento.it). Fra i suoi libri, Il novecento
negato. Hayek filosofo politico (Perugia 2006); Tocqueville: un ateo liberale (Bari 2008); La
storia infinita. Marx, il liberalismo e la maledizione di Nietzsche (Napoli 2011) e L’ultimo Dio.
Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post-umana (Bari 2012).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Perché l’individualismo istituzionale non funziona: ancora sul
libro di E. Screpanti, "Marx dalla totalità alla moltitudine
(1841-1843)"
di STEFANO BREDA
Ernesto Screpanti sostiene che una teoria marxista della società, per dirsi scientifica, debba
assumere l’individualismo istituzionale quale criterio metodologico. In questo modo si corre
tuttavia il rischio di non riuscire a spiegare fenomeni complessi in società, come quelle
capitalistiche, in cui la riproduzione della struttura sociale avviene attraverso meccanismi di
dominio impersonale.
Il 14 Ottobre è stata pubblicata su “Il rasoio di Occam” la recensione, scritta da Luca Basso, del
libro di Ernesto Screpanti Marx dalla totalità alla moltitudine (1841-1843). Per un sunto delle tesi
contenute nel libro rimando senz’altro all’ottima ed esauriente recensione. In questa sede vorrei
proporre alcune riflessioni critiche a partire dall’analisi di Screpanti.
Il testo ruota intorno a categorie filosofiche e politiche di estrema attualità. Basti pensare ad alcune
misure proposte dal giovane Marx per una riforma della democrazia rappresentativa: introduzione
del vincolo di mandato; introduzione del diritto di revoca del mandato; abolizione del ceto politico
quale classe professionale (cfr. pp. 73-117)[1]. Tali misure sono oggi al centro di un vivo dibattito
in Italia, il quale si sviluppa per lo più sulla base di un diffuso discorso di stampo olistico, che,
cancellando ogni contrapposizione di classe e ogni conflitto interno alla società, fa della “società
civile” un corpo omogeneo, spesso caratterizzato come un soggetto agente. Il conflitto viene traslato
verso un altro corpo sociale omogeneo, esterno alla società civile, la “casta”, ovvero il ceto politico,
il quale persegue il proprio vantaggio a discapito dell’interesse generale. Le proposte del giovane
Marx vengono in questo modo sussunte entro un ambito che politologicamente si definisce
“populista”, “di destra”. Screpanti mette in evidenza come Marx arrivi a proporre la sua terapia
sulla base di una diagnosi diametralmente opposta. Come si spiega la coincidenza di terapie a fronte
di diagnosi divergenti?
La rappresentazione olistica della società civile impedisce la comprensione della struttura della
società, ovvero esclude a priori dalla visuale la considerazione di quei fattori in grado di spiegare
perché il ceto politico si comporti nei fatti come se fosse un soggetto unico, perché agisca
compattamente in un’unica direzione, indifferente alle richieste “popolari”, svuotando così la forma
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
democratica di ogni significato materiale. Sulla base di una rappresentazione mistificante della
società, si fornisce al fenomeno una soluzione fittizia, salvaguardando così dalla critica le cause del
fenomeno stesso. Il fatto è che nemmeno Marx, tra il 1841 e il 1843, era in possesso di quegli
strumenti teorici in grado di consentirgli la comprensione della struttura delle società capitaliste.
Anche eliminando dal discorso del giovane Marx ogni traccia di olismo e portando a coerenza il suo
individualismo, si ottiene una rappresentazione della società di gran lunga insufficiente a
comprendere le cause del carattere fittizio della democrazia rappresentativa liberale.[2] Olismo e
individualismo non sembrano quindi le categorie centrali con cui comprendere l’evoluzione
successiva del pensiero di Marx.
Se così stanno le cose occorre però problematizzare gli aspetti del testo di Screpanti che vanno oltre
la ricostruzione filologica, assolutamente fondata, degli studi tra il 1841 e il 1843. In generale vorrei
mettere in discussione l’assunto per cui attraverso l’individualismo metodologico, sia pure nella sua
variante “istituzionale”, sarebbe possibile spiegare i fenomeni sociali in una società basata sul modo
di produzione capitalistico. Più in particolare mi sembra che dal punto di vista dell’individualismo
istituzionale quella specifica impresa scientifica che è la critica dell’economia politica di Marx
perda significato, e che quindi l’evoluzione del pensiero di Marx successivo al 1846 non possa
essere completamente ricondotta nei binari di una dicotomia tra olismo e individualismo.
La critica dell’economia politica[3] di Marx non è una particolare teoria accanto ad altre, ma è una
critica delle categorie stesse dell’economia politica, dove “critica” non ha un valore morale, ma
designa il disvelamento degli specifici rapporti sociali che devono sussistere tra gli individui perché
essi si comportino in modo tale da dare senso a quelle categorie. Il procedimento è definibile, in
relazione al problema qui in oggetto, come ricostruzione a posteriori dell’a priori dell’agire
individuale in un contesto caratterizzato dal modo di produzione capitalistico. Marx parte
dall’analisi della categoria pratica “merce”: un prodotto è merce solo in quanto gli individui vi si
rapportano praticamente in una determinata maniera, ovvero quando è inserito in un sistema di
scambio generalizzato, mediato dal denaro. Marx mostra che perché questo sia possibile è
necessario che gli individui si rapportino al prodotto come valore, e che perché ciò sia possibile è
necessario che essi facciano astrazione dal contenuto determinato dei diversi lavori concreti. Il
lavoro di ogni individuo deve essere commensurabile ad ogni altro, deve valere come astratto
lavoro umano, quota parte del lavoro svolto da tutti gli individui nella società. Tale
commensurabilità non ha niente di naturale o di materiale, è un’astrazione (cfr. MEW 25, p. 823)[4]
che ha realtà in quanto tutti agiscono come se il suo contenuto fosse reale. Con questa operazione
iniziale Marx non si è limitato a ripetere ciò che già gli economisti classici avevano sostenuto, e
cioè che il lavoro è la sostanza del valore, al contrario ha dimostrato che il valore è l’astrazione,
socialmente praticata, dalla sostanza materiale del lavoro. Ha cioè negato la concezione
sostanzialista del valore-lavoro.
L’astrazione in cui consiste la forma-merce dei prodotti del lavoro è socialmente valida, dunque ha
effetti concreti sulla realtà (in questo senso si parla di astrazione reale) in quanto è praticata da ogni
individuo. Questo non significa che gli individui effettuino consapevolmente, né tantomeno
intenzionalmente, tale astrazione: non è perché essi si rapportano ai prodotti del lavoro secondo la
categoria del valore che prendono parte ai rapporti sociali dominanti, al contrario: gli individui non
possono che prendere parte ai rapporti sociali in cui si trovano immersi, e quindi si rapportano ai
prodotti del lavoro come a valori. L’astrazione esiste solo perché viene praticata da ogni individuo,
ma al contempo, in una società capitalistica data[5], l’astrazione agisce a priori sull’agire
dell’individuo. Ogni individuo è obbligato a riprodurre la validità dell’astrazione, poiché essa è
sempre già socialmente praticata nel momento in cui l’individuo agisce.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
È sulla base di questi assunti iniziali - che Screpanti bolla un po’ frettolosamente come
«speculazioni» (p. 143) che ci saremmo risparmiati se Marx avesse voluto seguire a pieno la sua
vena individualista - che è possibile leggere in maniera non deterministica il seguito dello sviluppo
della critica dell’economia politica, ed è ancora su questa base che è possibile comprendere in che
senso, in una società dove regni il modo di produzione capitalistico, l’indipendenza personale si
risolva in rapporti di dipendenza materiale, impersonale (cfr. p.es. MEGA II.1.1, pp. 90-91).
Nella critica dell’economia politica si indaga ciò che è specificamente capitalistico nei rapporti
sociali capitalistici. In tale contesto deve assumersi l’indipendenza di scelta e d’azione
dell’individuo come libera da rapporti di dominio personali: la libertà formale dell’individuo è
dimostrata come condizione del darsi del rapporto di lavoro salariato. Tale libertà formale si traduce
però in dipendenza materiale, ovvero l’individuo è libero di agire in un contesto di dominio
impersonale. L’oggetto di studio della critica dell’economia politica non è il comportamento
individuale, bensì la specifica logica di comportamento, alla quale, dati i rapporti sociali
capitalistici, l’individuo deve aderire per non soccombere. Sebbene l’astrazione della forma-valore
dei prodotti, ovvero la loro forma-merce, effettivamente dipenda dall’agire degli «unici soggetti
capaci di porre dei motivi d’azione», ovvero gli «irriducibili individui semplici» (cfr. p. 40), tale
astrazione agisce a priori sul loro agire, determinando il contenuto oggettivo che il loro agire deve
avere se essi vogliono raggiungere i loro scopi soggettivi (a partire dal più banale: la sopravvivenza
fisica). Marx sviluppa progressivamente tale contenuto oggettivo fino a definire le leggi oggettive
che regolano l’agire individuale in una società capitalistica. Queste assumono l’effettività di leggi
oggettive nei confronti dell’individuo proprio in quanto ne determinano l’agire, stabiliscono per
così dire le “regole del gioco”, sebbene non siano che il risultato delle azioni individuali. È per
questo che Marx può parlare di feticismo[6] in riferimento a tali leggi: esse vengono vissute
dall’individuo e teorizzate dall’economia politica classica come leggi naturali dell’agire umano,
proprio perché agiscono a monte dell’azione individuale, mentre qui si rivelano come socialmente
prodotte.
La critica dell’economia politica individua queste leggi, e non le spiega a partire dall’agire
individuale, bensì dall’agire sociale, spiega le azioni degli individui e le relazioni tra di essi come
determinati da quelle leggi e individua i meccanismi (la concorrenza) attraverso cui quelle leggi,
proprio determinando l’agire individuale, si riproducono. In una parola, la critica dell’economia
politica studia la struttura sociale delle società capitalistiche.
La domanda che si pone è se sia possibile ricondurre univocamente tale metodo d’indagine ad una
delle categorie metodologiche indicate da Screpanti: olismo metodologico o individualismo
istituzionale.
Il punto centrale è che, nello schema abbozzato, non si dà semplicemente la possibilità che l’agire
dell’individuo sia «influenzato dal contesto istituzionale» (p. 19) in cui agisce, bensì viene
considerato esclusivamente in quanto è determinato dalla struttura sociale. Tutto ciò che nell’agire
individuale può essere emergente rispetto alla struttura sociale viene escluso dalla trattazione,
poiché l’oggetto di studio è solo ciò che è specifico di tale struttura specifica. La polemica di
Screpanti nei confronti di Althusser, secondo il quale «gli individui sarebbero nient’altro che
“portatori” delle relazioni sociali» (p. 32), è ad un tempo giustificata ed ingiustificata: è giustificata
se stiamo parlando del “pensiero di Marx” in generale, espressione che però si riduce ad indicare
una generica “visione del mondo”, che è per il Marx maturo «meno di ogni altra cosa» (A. Schmidt,
Il concetto di natura in Marx, Laterza, Bari 1969, p. 52); è ingiustificata se stiamo parlando della
critica dell’economia politica, dove gli individui vengono presi in considerazione esclusivamente in
quanto «portatori» di relazioni sociali (cfr. MEW 23, p. 167 e MEW 25, pp. 826-827), non perché
Marx risolva ontologicamente l’individuo nella struttura, ma perché quello è, metodologicamente,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
l’unico aspetto dell’individuo da prendere in considerazione per gli scopi scientifici che si pone
Marx in quel contesto. La critica dell’economia politica non può quindi essere letta come
descrizione sociologica di una società capitalistica, o di determinati concreti fenomeni sociali aventi
luogo in una determinata società capitalistica; essa descrive unicamente ciò che deve darsi, a priori,
in qualsiasi società storicamente e geograficamente determinata, perché essa sia definibile come
capitalistica. È dunque forse poco sensato tentare di coglierne il metodo attraverso categorie
metodologiche valide per lo studio empirico dei fenomeni sociali nella loro concretezza.
Ci è quindi inutile la critica dell’economia politica nell’analisi e nella spiegazione di determinati
fenomeni sociali, storicamente e geograficamente determinati? No. Essa ci indica proprio ciò di cui
non possiamo non tenere conto nello spiegare perché si dia un determinato fenomeno, e che non
potremmo ricavare dagli interessi, dalle motivazioni, dalle credenze e convinzioni degli specifici
agenti coinvolti, né dalle specifiche relazioni che sussistono tra di essi: i meccanismi di dominio
impersonale, i quali attengono alla struttura sociale nella quale gli individui agiscono e nella quale
hanno luogo le relazioni tra di essi.
Riprendiamo un esempio dello stesso Screpanti, anche per render chiaro che non si tratta di
«civetterie dialettiche» (p. 143)[7]:
Una grave crisi è predisposta da vari fattori, tra cui gli effetti dell’accumulazione capitalistica sulla
tendenza del saggio di profitto a cadere. Questi effetti sarebbero il risultato non intenzionale delle
antecedenti decisioni d’investimento dei capitalisti: ognuno di essi, introducendo innovazioni che
fanno aumentare il proprio saggio di profitto, contribuisce a creare condizioni di progresso tecnico
che alla lunga farebbero diminuire il saggio di profitto generale e darebbero origine a crisi sempre
più gravi. Si noti che il progresso tecnico è spiegato non con un’argomentazione di tipo funzionale
riferita ad un soggetto collettivo (ad esempio: l’innovazione si verifica in virtù di una “logica del
capitale”), bensì con una spiegazione causale dei comportamenti individuali e dei loro effetti
aggregati: il singolo capitalista in un dato momento introduce un’innovazione per aumentare il
proprio guadagno, e in tal modo genererebbe un effetto negativo sul saggio medio di profitto in un
tempo successivo (p. 22).
Screpanti qui prende ad esempio un caso di caduta del saggio del profitto conseguente all’aumento
della composizione organica del capitale. Screpanti sottolinea che Marx era convinto che si trattasse
di una legge tendenziale valida in generale (cfr. MEW 25, p. 221), mentre è stato dimostrato che
non è così (cfr. p.es. T. Sablowski, Krisentendenzen der Kapitalakkumulation, in: “Das Argument”
251, 2003), dunque Marx non avrebbe dovuto neanche prendere in considerazione questo
meccanismo nella critica dell’economia politica. Ma Screpanti può ben farlo, perché sta parlando di
un ipotetico caso specifico, storicamente e geograficamente qualificabile, e, a determinate
condizioni, il meccanismo funziona proprio come descritto da Marx. Trattandosi di un caso
specifico, che quindi esula dalla critica dell’economia politica, non possiamo spiegarlo senza fare
ricorso alle motivazioni che spingono gli agenti coinvolti ad agire in un determinato modo. Questo
significa che possiamo spiegare il fenomeno solo sulla base delle motivazioni individuali? Non ci
serve a nulla l’indagine strutturale di cui si è parlato poco sopra?
Screpanti spiega il fenomeno della caduta del saggio medio di profitto come effetto aggregato
dell’introduzione di innovazioni tecnologiche da parte dei capitalisti, individuabili in linea di
principio in un determinato gruppo di singoli individui. L’introduzione di innovazioni tecnologiche
è a sua volta spiegata sulla base dell’interesse, da parte di ogni singolo capitalista, ad aumentare il
proprio saggio di profitto. È una spiegazione sufficiente? Poniamoci la domanda: perché il singolo
capitalista vuole aumentare il proprio saggio di profitto? La risposta, banale e ancora interna alla
sfera delle motivazioni individuali, è: per soddisfare la propria sete di ricchezza. Per
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
l’individualismo istituzionale non è un problema ammettere che tale sete di ricchezza è influenzata
socialmente: è il risultato della cultura in cui si è formato individuo capitalista e delle istituzioni,
degli specifici rapporti in cui è inserito, ma dopotutto si tratta comunque di una motivazione
individuale, che può anche essere presa semplicemente come data nell’analisi del fenomeno “caduta
del saggio di profitto”. Ma è a questo punto che si pone la domanda alla quale la ricostruzione di
Screpanti non fornisce risposta: perché, per soddisfare la propria sete di ricchezza, il singolo
capitalista deve aumentare il saggio di profitto? Non potrebbe arricchirsi anche mediante un saggio
del profitto costante? La risposta va cercata proprio nel meccanismo che Screpanti esclude dalla sua
ricostruzione, perché non si risolve né nelle motivazioni individuali del capitalista né negli specifici
rapporti che egli intrattiene con gli altri singoli capitalisti; si tratta di un meccanismo di dominio
impersonale: la concorrenza. Se non aumenta il proprio saggio di profitto il singolo capitalista non
solo non si arricchisce in maniera costante, ma viene rapidamente espulso dal mercato, finisce in
bancarotta. Attraverso il meccanismo della concorrenza, una determinata logica di azione si impone
ad ogni singolo capitalista (cfr. MEGA II.1.2, p.625 / MEW 42, p.644). Non si tratta di una fumosa
«logica del capitale», come soggetto olistico che teleologicamente impone il proprio volere agli
individui, si tratta del fatto che, dati i presupposti su cui si basa il modo di socializzazione
specificamente capitalistico, il contenuto oggettivo dell’azione specifica di un individuo non è
determinato unicamente dal suo scopo soggettivo.
Facciamo un altro esempio. Una rappresentazione plastica del dominio impersonale è fornita dal
funzionamento dei mercati finanziari e da quella che lo stesso Screpanti, nel libro L’imperialismo
globale e la grande crisi, chiama «disciplina del credito». Stiamo parlando, detta in breve, del
meccanismo per cui le politiche economiche degli stati vengono “dettate” dai mercati finanziari.
La disciplina del credito è una trappola inesorabile che è regolata dalla pura e semplice logica di
mercato. Non c’è bisogno di un tiranno imperiale per attivarla e farla funzionare a dovere. Bastano
gli speculatori, oltre che i ragionieri delle banche e delle organizzazioni internazionali. (E.
Screpanti, L’imperialismo globale e la grande crisi, DEPS, Siena 2013, p. 95)
Qui Screpanti avanza prima una spiegazione di tipo olistico (la logica di mercato), poi, giustamente,
riconduce il soggetto olistico, il mercato, alle azioni degli individui che lo compongono
(speculatori, ragionieri etc.). Infatti:
Non c’è una mente perversa che pianifica tutto. La speculazione non la comanda nessuno. La
reazione è organica, spontanea. Ed è una reazione complessa in cui moltissimi soggetti decisionali
agiscono autonomamente perseguendo finalità eterogenee, contribuendo però a innescare processi
che si risolvono oggettivamente, “naturalmente”, in un’azione punitiva. (ivi, p. 100)
A questo punto però, per spiegare ad esempio il fenomeno “mancata approvazione di misure volte a
ridurre la disoccupazione da parte del Governo italiano”, non ci si può limitare a dare la colpa al
soggetto olistico “mercato”, ma neanche semplicemente agli “speculatori”. Occorre quantomeno
spiegare perché gli speculatori abbiano agito in un modo anziché in un altro. Qui un individualismo
metodologico puro avrebbe poco da dire, ma l’individualismo istituzionale può fare riferimento alle
«istituzioni normative» e alle «abitudini comportamentali» (p. 20) in cui sono immersi gli individui
nel momento storico preciso: attraverso «l’ideologia, l’educazione, la propaganda» (p. 21) gli
investitori hanno sviluppato l’idea, che le politiche contro la disoccupazione non possano che
nuocere all’economia di un Paese, e che dunque convenga disinvestire non appena tali politiche
vengano ventilate:
Ora, mettete queste “idee” in testa agli speculatori. Se un governo vuole fare politica economica per
curare la disoccupazione […] non può che produrre disastri […]. Appena i “mercati” finanziari
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
cominciano a sospettare una tale scivolata verso il socialismo scatterà la disciplina finanziaria.
Spesso non ci sarà neanche bisogno che il governo avvii quelle perverse politiche, basta che le
annunci. La speculazione sulla moneta o il debito sovrano di quel paese le renderà impotenti prima
ancora che si verifichino le condizioni strutturali che tutti paventano. Così il governo apprenderà la
dura lezione. In altri termini, o il governo si comporta liberamente come vogliono i “mercati” o i
“mercati” lo costringono a comportarsi come vogliono loro. (E. Screpanti, L’imperialismo globale e
la grande crisi, p. 106 - 107)
L’unico argomento debole, in questa ricostruzione, è proprio quello che spiega la decisione del
singolo investitore con le sue convinzioni personali, per quanto condizionate socialmente e
storicamente (cfr. p. 20). Nei fatti non v’è alcun bisogno che l’investitore sia ideologicamente
condizionato perché egli sia necessitato ad agire così come agisce se non vuole cadere sul lastrico.
Potenzialmente ognuno degli investitori esistenti potrebbe essere, come individuo, convinto del
fatto che una politica contro la disoccupazione non possa che giovare ad una economia. Il fatto è
che l’investitore non prende decisioni sulla base delle sue convinzioni personali circa gli effetti
della politica in questione, ma sulla base di quella che è lecito aspettarsi sarà la reazione prevalente
tra gli investitori[8], perché sarà quello a determinare effettivamente l’andamento della valuta o dei
titoli di Stato. Il paradosso è che ognuno degli investitori dovrà fare questo calcolo, ed è proprio
così che si formerà la “reazione prevalente”. «Questo comportamento non è il risultato di una
propensione perversa. È un inevitabile prodotto di un mercato degli investimenti organizzato
secondo le linee descritte» (J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money,
Atlantic, New Dehli 2006, p. 139). Dunque nella nostra spiegazione abbiamo dovuto, da un lato,
considerare gli individui con le loro posizioni di scopo (ottenere un vantaggio economico o almeno
non ricevere uno svantaggio), dall’altro, per spiegare perché, per raggiungere quello scopo, ogni
individuo ha dovuto agire in un determinato modo (si badi: non ha deciso di agire, ma ha dovuto: in
caso contrario avrebbe effettivamente mancato il suo scopo), abbiamo dovuto considerare qualcosa
che va al di là della sfera individuale, per quanto socialmente condizionata: la struttura del mercato.
Ora potremmo cercare di spiegare anche questa tramite l’individualismo istituzionale, finendo in
una sorta di regressus ad infinitum che ci riporterebbe probabilmente a dinamiche proprie della
sfera dell’esempio precedente. Lasciando aperta la questione, mi chiedo se è davvero possibile
risalire, nel caso in oggetto, a responsabilità individuali (non parlo di responsabilità morali, ma
causali), cosa che dovrebbe essere in linea di principio possibile, nell’ottica dell’individualismo
istituzionale (cfr. p. 21), e che però presuppone la libertà d’azione degli individui.
Insomma, in quanto “istituzionale”, l’individualismo istituzionale accetta il fatto che «la
costituzione dei soggetti è condizionata storicamente e socialmente» (p. 20), ma in quanto
individualismo non può mettere in discussione l’assunto di base dell’individualismo metodologico,
e cioè che «le strutture sociali, i comportamenti collettivi e il cambiamento storico sono
l’explanandum; le azioni, gli interessi, le coscienze e le motivazioni degli individui sono
l’explanans», (p. 21). La critica dell’economia politica ci fa notare però che, in una società
caratterizzata da rapporti di dominio impersonali, come una qualsiasi società in cui il modo di
produzione e quindi di socializzazione sia capitalistico, se non abbiamo già capito la struttura
sociale, non possiamo prendere come explanans l’azione individuale, in quanto questa non è mai
interamente causa sui ed è bisognosa anch’essa di spiegazione[9], proprio sulla base della struttura,
la quale invece, una volta data, come prodotto dell’azione, può essere presa, metodologicamente,
come causa sui: è struttura perché viene riprodotta costantemente dall’azione. Si noti che questa
affermazione non costituisce un principio scientifico assoluto: è relativa ad un oggetto di studio
delimitato, i cui limiti definiscono anche i limiti di validità dell’affermazione, la quale non si basa
su, né implica, alcun asserto ontologico.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
In chiusura non si può non fare brevemente riferimento ad un altro punto critico
dell’individualismo: il problema di come si affronta la situazione presente, nella quale la libertà
formale dell’individuo si risolve nel suo asservimento materiale, ovvero come se ne esce e per
raggiungere cosa.
Non è un caso che negli ultimi anni si siano diffuse metafore di tipo religioso/olistico per spiegare
in senso critico la sottomissione del ceto politico ai mercati finanziari: il neoliberismo come culto
pagano del “dio mercato”. Queste metafore esprimono in ultima analisi quello che Marx chiamava
feticismo: ciò che è nei fatti un insieme determinato di rapporti sociali, dunque dipendente
dall’azione degli individui, viene vissuto come una “cosa” indipendente dall’azione stessa e che
anzi la domina. Ma con la critica dell’economia politica Marx non si è limitato a denunciare questo
feticismo come “falsa coscienza”. Al contrario, il suo intento era precisamente quello di identificare
la radice reale, assolutamente concreta di tale feticismo nelle caratteristiche strutturali di quella
specifica forma di rapporto sociale. Marx nega che si tratti di una mistificazione, conscia o
inconscia, che operi nella coscienza dell’individuo e in questo senso usa l’espressione
«mistificazione reale» (MEW 13, p. 34-35). Da questo punto di vista assistiamo oggi ad un
sostanziale passo indietro da parte delle teorie critiche della società: si moltiplicano teorie (e
movimenti sociali) che riducono il problema ad una mistificazione pura e semplice: gli individui
sarebbero dominati da un’idea mistificante, ad esempio quella dell’economia (Serge Latouche[10]),
o del lavoro (Robert Kurz e il gruppo Krisis[11]), o del valore (Wertkritik in generale) o ancora lo
sviluppo e via di seguito. La liberazione, essendo il problema reale considerato per lo più come già
auto-soppressosi[12], consisterebbe in una auto-liberazione da tale mistificazione, un “aprire gli
occhi”, una sorta di “rivoluzione dell’autocoscienza”: si torna in qualche modo a Bruno Bauer.
Ma cos’ha a che fare l’individualismo istituzionale con Bauer e con le teorie critiche citate,
accomunate per il resto solo dall’abbandono di un’ottica di classe? Paradossalmente, nel momento
in cui si afferma che le strutture sociali, i rapporti di produzione e le forme di socializzazione vanno
spiegati sulla base delle azioni individuali e che queste a loro volta dipendono da «gli interessi, le
coscienze e le motivazioni degli individui», per quanto condizionati, il rischio di ricadere dal
materialismo complesso dell’ultimo Marx in qualche forma di idealismo è forte.
Screpanti sottolinea il peso avuto da Bauer nel mantenere il giovane Marx ancorato all’idealismo
(pp. 57-58), ma mette in luce anche il suo ruolo nell’evoluzione di Marx dall’olismo
all’individualismo, dalla totalità alla moltitudine:
C’è però una ricaduta positiva di questo idealismo della coscienza. In Bauer l’autocoscienza si
esprime nelle capacità critiche degli individui, non nell’azione delle collettività; la stessa conquista
della libertà si ottiene con l’azione dei singoli, mentre le collettività sono predisposte a subire
l’assoggettamento universale del potere statale. (p. 58)
L’idea della “rivoluzione dell’autocoscienza” si può considerare come una trasposizione sul piano
sociale della dialettica servo-padrone di Hegel (cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito,
Bompiani, Milano 2000, pp. 283-291): il servo è dominato fintantoché non prenda coscienza del
fatto che è ciò che lo domina, il padrone, a dipendere dal suo agire. Ora, se l’unico ente capace
d’azione, dove “azione” definisce un «cambiamento mosso da fini» (p. 41), è l’individuo, e l’azione
collettiva non è comprensibile che come aggregato di azioni individuali eterogenee, e se la struttura
sociale è il risultato di questo aggregato di azioni individuali eterogenee, allora il mantenimento o la
dissoluzione della struttura sociale esistente diventa una questione meramente quantitativa: dipende
da quanti individui prenderanno coscienza del fatto che è il loro agire a determinare la struttura e
cominceranno ad agire in maniera differente; se il risultato aggregato di queste azioni individuali
sarà sufficiente, la struttura sociale non potrà che cambiare. Questo è il modo d’agire della
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
moltitudine, anche secondo le teorie che si rifanno a Toni Negri: non si tratta di costruire le
condizioni per un agire differente ma di agire la differenza, praticarla direttamente. In tutto ciò
scompare però il fatto che l’individuo in quanto individuo non può agire in maniera radicalmente
differente finché non sia cambiata la struttura sociale: se lo fa, soccombe. Questo è messo in luce
dalla critica dell’economia politica di Marx. L’unica possibilità, da questo punto di vista, risiede
nell’azione collettiva, conseguente ad una posizione collettiva di scopo, posizione collettiva in senso
forte, non come aleatorio incontrarsi di scopi individuali autonomamente formatisi, ma come
costruzione collettiva di uno scopo, il cambiamento (inevitabilmente conflittuale) della struttura
sociale, il cui raggiungimento consenta poi un’agire differente. Si tratta allora prima di tutto di
superare il punto di vista teleologico individuale, il che è proprio ciò che il punto di vista della
moltitudine esclude. In Negri la questione è contraddittoria, perché se da un lato la moltitudine è
rappresentata come «molteplicità incommensurabile» e «singolare» (T. Negri, Per una definizione
ontologica della moltitudine, Moltitudes Web, 2002, p. 2) in opposizione ad ogni unità collettiva di
stampo olistico totale (il «popolo») o parziale (la «classe operaia»), dall’altro è a sua volta
ipostatizzata come soggetto di una «prassi collettiva» (ivi, p. 3). Tale contraddittorietà appare come
un tentativo di uscire dall’impasse pratica di cui sopra. In Screpanti tale contraddittorietà non c’è:
l’esistenza di qualsiasi soggetto collettivo, di qualsiasi ente collettivo che agisca altrimenti che sotto
l’impulso di scopi individuali o loro aggregati aleatori, è coerentemente esclusa, ma non si capisce
allora come sia pensabile uscire dall’impasse, se si accettano gli assunti basilari della critica
dell’economia politica di Marx.
Screpanti afferma che l’individualismo istituzionale è fondamentale per una teoria della rivoluzione,
perché «attribuisce all’azione umana attitudine all’autoliberazione, ovvero la capacità di modificare
intenzionalmente la struttura sociale» (p. 21). Questo è valido anche per un’ottica non individualista
come quella derivante dalla critica dell’economia politica: la struttura sociale dipende dall’azione
umana e quindi può essere dall’azione umana modificata, ma non dall’azione individuale, né
singolare né aggregata, questo almeno per quanto riguarda la specifica struttura sociale capitalistica.
Con il riferimento alla posizione collettiva di scopo il problema è comunque tutt’altro che risolto,
anzi, la questione è appena aperta e richiederebbe la trattazione dei problemi relativi alla teoria delle
classi e della lotta di classe, e un confronto in tal senso con la prospettiva dell’individualismo
istituzionale, cosa che per ragioni di spazio non sarà possibile fare in questa sede.
Tutte le questioni toccate meriterebbero ben altro livello di approfondimento, ma già sulla base di
quanto detto mi sembra si possa mettere in dubbio che “olismo” e “individualismo”, categorie
metodologiche che Screpanti dimostra adattissime a comprendere l’evoluzione di Marx negli anni
’40, siano altrettanto adeguate a caratterizzare il modo di procedere di Marx nei confronti della
specifica problematica posta con la critica dell’economia politica. Ugualmente dubitabile mi sembra
il fatto che ricorrendo alla categoria “moltitudine” si possa evitare di scontrarsi col problema del
rapporto tra agire individuale e struttura sociale.
D’altra parte, appunto perché convinto che la problematica sollevata dalla critica dell’economia
politica non possa essere evitata da una teoria critica della società che si ponga in un’ottica di
emancipazione (sia che la si intenda come emancipazione degli individui, sia come emancipazione
della classe lavoratrice), dubito che una o l’altra delle categorie suddette possa costituire la cifra di
una tale teoria.
NOTE
[1] Laddove si riporti solo il numero delle pagine il riferimento è sempre a E. Screpanti, Marx dalla
totalità alla moltitudine (1841-1843), DEPS, Siena 2011.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[2] Da ciò non si deve trarre automaticamente la conclusione che le misure di riforma elettorale
suddette non possano essere oggi auspicabili, altrimenti si peccherebbe di intellettualismo. Si tratta
però innanzitutto di definire i limiti di tali proposte. Sulla base delle idee del Marx maturo, nessuna
riforma elettorale può portare ad una “vera democrazia”.
[3] Con “critica dell’economia politica” si intenderà qui sempre l’intero corpus di scritti ad essa
relativi, compresi i lavori preparatori del Capitale e i manoscritti non pubblicati. Per quanto
riguarda le tematiche qui in oggetto, considerare il Capitale come un’opera in sé conchiusa è un
errore dal punto di vista filologico. Va sottolineato che la critica dell’economia politica è stata letta,
e viene ancora letta, nelle maniere più disparate. Le ambivalenze innegabilmente presenti nei testi
rendono necessario scegliere la lettura che appare più fondata e più fruttuosa.
[4] I testi di Marx saranno citati con riferimento all’edizione (MEW o MEGA), il numero della
sezione (nel caso della MEGA), il numero di volume e quello di pagina.
[5] Per questo la ricostruzione dell’a priori avviene a posteriori: perché avviene sulla base
dell’osservazione dei comportamenti in una società già dominata dai rapporti sociali capitalistici, e
non sulla base di una ricostruzione storica della produzione pratica di quei rapporti. Vengono
indagati i meccanismi di riproduzione di rapporti sociali specifici, non la loro produzione.
Naturalmente la lettura storicamente egemonica nel marxismo è stata un’altra, a partire dalla teoria
di Engels sulla produzione semplice di merci fino alle posizioni di W.F. Haug.
[6] La categoria del feticismo non si limita all’analisi della forma-merce, ma attraversa l’intera
struttura del Capitale.
[7] Così definisce Screpanti l’impostazione filosofica del Capitale, in opposizione a quella dei
Grundrisse, rovesciando e rivisitando in chiave kuhniana la teoria della “popolarizzazione
progressiva” da molti sostenuta, a partire da Backhaus, cfr. H.G. Backhaus, Zur Dialektik der
Wertform, in: A. Schmidt, (a cura di), Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/M 1971. Va sottolineato che quanto sostenuto in merito al rapporto tra individuo
e struttura emerge dai Grundrisse quanto dal Capitale. Più in generale, mi sembra che la tesi
dell’oscillazione di Marx tra rivoluzione scientifica e normal science sia sostenibile, ma vada
piuttosto riferita all’intero corpus della critica dell’economia politica. Cfr. M. Heinrich, Die
Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher
Revolution und klassischer Tradition, Westfälisches Dampfboot, Münster 2011.
[8] Cfr. p.es. P. Windolf, Was ist Finanzmarktkapitalismus?, in: P. Windolf (Ed.), FinanzmarktKapitalismus, VS Verlag, Wiesbaden 2005, p. 26.
[9] Cfr. M. Heinrich, Über „Praxeologie“, „Ableitungen aus dem Begriff“ und die Lektüre von
Texten, in: „Das Argument“ 254, 2004.
[10] Cfr. S. Latouche, L’invenzione dell’economia, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
[11] Cfr. Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit, in: “Krisis”, giugno 1999.
[12] Un discorso simile vale anche per il Toni Negri teorizzatore della “moltitudine” e del
“comune”, ma la questione in questo caso è più complessa.
Stefano Breda è dottorando alla Freie Universität di Berlino con un progetto su Capitale
fittizio e riproduzione dei rapporti sociali capitalistici.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Moltitudine, classi e azione sociale: risposta a Stefano Breda
di ERNESTO SCREPANTI
Breda crede di poter rigettare l’individualismo istituzionale sulla base di una ricostruzione
hegeliana della teoria marxiana del capitalismo, ma produce un cortocircuito tra la descrizione
della struttura di un modello astratto e la spiegazione nomologico-causale dei processi reali. Una
volta tradotta quella descrizione in un linguaggio comprensibile a tutti si scopre che, proprio
perché la struttura è posta assiomaticamente come “causa sui”, non può sostituirsi a spiegazioni
basate sul metodo dell’individualismo istituzionale.
Voglio subito dire che l’articolo di Stefano Breda mi è piaciuto, nonostante abbia di primo acchito
trovato sconcertanti alcune sue proposizioni. Alla fine ho capito che dice sostanzialmente le stesse
cose che dico io, seppur in un linguaggio diverso.
“Dominio impersonale” è un bell’ossimoro che esprime poeticamente il senso di oppressione che
tutti noi proviamo di fronte a mostri totalizzanti come il “capitale multinazionale”, la “speculazione
internazionale”, il “mercato sovrano”, o anche soltanto “l’Europa che ce lo chiede”, e giù giù fino
alla classe politica costituitasi in “casta”. Ma dal punto di vista scientifico è un non senso.
“Dominio”, “Potere”, “Dipendenza”, sono concetti che definiscono una relazione tra agenti sociali.
Ci deve essere qualcuno (individuo o gruppo) che domina e qualcuno che è dominato. Non possono
essere usati quali definizioni di agenti sociali, come talvolta Breda sembra fare. Può una relazione
essere un soggetto?
Se interpretate in quest’ultimo senso alcune affermazioni di Breda paiono sbalorditive. Cosa sono
“le leggi oggettive… che regolano l’azione degli individui e… ne determinano l’agire”? Le leggi
pongono dei vincoli alle azioni, non le determinano. Le azioni sono determinate da decisioni degli
agenti, non dal contesto in cui queste vengono prese. Se il codice della strada mi proibisce di andare
a più di 130 l’ora, sono comunque io che decido di compiere l’azione di andare a 100, o anche a 140
(essendo disposto a rischiare una multa). E cosa può mai voler dire l’affermazione “ogni individuo
ha dovuto agire in un determinato modo (si badi: non ha deciso, ma ha dovuto)”? Un operaio che
esegue i comandi del padrone deve svolgere certe operazioni lavorative, ma non agisce, in quanto
concretizza una decisione del soggetto che lo domina: il suo apparente agire non è altro che l’agire
del padrone – direbbe Hegel.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Si faccia attenzione, però. Breda non sta dicendo quello che sembra dire. Sta dicendo una cosa
molto più semplice. Sta dicendo che in un modello di società capitalistica gli agenti sociali
intrattengono certe relazioni e, per la logica del modello, si devono comportare in un certo modo. La
tipizzazione è parte essenziale delle pratiche scientifiche. Un modello definisce una struttura
assiomatica di relazioni e di dinamiche comportamentali stabili, tali cioè da riprodurre la struttura
stessa. Nel modello di Marx esistono relazioni di sfruttamento e oppressione tra la classe dei
lavoratori e quella dei capitalisti. La dinamica funziona in modo tale che come classe i lavoratori
non possono sottrarsi a quella relazione, in quanto la “legge generale dell’accumulazione
capitalistica” spinge il salario a un livello così basso da costringere i lavoratori stessi, per
sopravvivere, ad accettare il contratto di lavoro. Condivido in pieno quest’argomentazione. E spero
che Breda mi perdonerà se ho cercato di tradurre le sue tesi in un linguaggio terra terra. Credo di
aver fatto un favore a lui e al lettore, il quale, se non ha conoscenze teologiche, avrà difficoltà a
capire cos’è una “Struttura” che è “causa sui”.
In altri termini Breda svolge la sua argomentazione articolandola su due livelli di discorso. Quello
della modellistica astratta e quello dell’analisi dei processi reali. Io condivido la sua ricostruzione
del modello di Marx e lui sembra condividere la mia analisi volgarmente “empirica” dei
comportamenti effettivi (in L’imperialismo globale e la grande crisi). A volte però quei due livelli
di discorso fanno corto circuito e generano confusione invece che chiarezza, come ad esempio
quando dice che “l’astrazione della forma-valore… agisce a priori sul loro [degli individui] agire,
determinando il contenuto oggettivo che il loro agire deve avere se essi vogliono raggiungere i loro
scopi soggettivi”. Il lettore non versato nella metafisica hegeliana si domanderà come sia possibile
che una forma possa agire e determinare il contenuto soggettivo di un’azione. Non si agiti: Breda
sta semplicemente dicendo che nel modello marxiano di capitalismo le leggi oggettive del mercato
implicano che l’impresa, per sopravvivere, deve ricercare il profitto e il lavoratore, per
sopravvivere, deve ricercare il salario. È una proposizione condivisibile, anche se forse chi è
interessato alla rozza ricerca “empirica” la troverà poco utile.
Ma che c’entra tutto ciò con il metodo dell’individualismo istituzionale? È una critica?
Sembrerebbe esserlo, se Breda intendesse dire che esiste un agente collettivo, ad esempio il mercato
sovrano, ovvero la “forma-merce”, che determina concretamente l’agire degli individui, delle classi,
dei governi, delle imprese, dei sindacati. In tal caso la critica si risolverebbe banalmente nel
contrapporre una pseudo-spiegazione olistica a un’analisi concreta dei processi decisionali in un
contesto di competizione oligopolistica globale. Come dire che, se Marchionne costringe gli operai
a votare democraticamente un aumento del loro sfruttamento e una riduzione dei loro diritti, sotto la
minaccia della delocalizzazione, l’azione non è attribuibile all’AD Fiat-Chrysler, ma alle leggi
naturali di mercato. Il metodo dell’individualismo istituzionale invece c’indurrebbe a dire che le
azioni di Marchionne e di milioni di altri capitalisti mirano a massimizzare i profitti, e quindi lo
sfruttamento; che la possibilità di delocalizzare gli investimenti, cioè di decidere dove investire, li
mette in condizioni di ricattare lavoratori e governi; che, siccome così fan tutti, quelli che non lo
fanno alla lunga vengono espulsi dal mercato (e.g. la Chrysler viene assorbita dalla Fiat), che di
conseguenza il mercato funziona in base a certe leggi “naturali” che nessuno ha programmato, ma
che emergono come risultante delle azioni di tutti quei capitalisti.
Che si diano risultati inintenzionali emergenti delle azioni individuali intenzionali è un principio
pienamente accettato dagli scienziati sociali, compresi i primi teorici dell’individualismo
metodologico (Menger, Schumpeter). Che poi quei risultati condizionino l’agire degli individui e
delle classi è un tema ampiamente sviluppato dai teorici dell’individualismo istituzionale, così come
lo è la convinzione che molti comportamenti individuali sono non intenzionali e non razionali
(Agassi, Jervie). Alcuni usano le espressioni “individualismo sociale” o “individualismo strutturale”
per definire lo stesso metodo. S’intende che l’individuo non è semplicemente influenzato dal
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
contesto istituzionale, come giustamente osserva Breda, ma ne è costituito. L’uomo è un essere
sociale in quanto la sua personalità, la cultura, le aspirazioni etc. sono condizionate dal contesto
sociale in cui si è formato e agisce. In questo particolare senso Breda mi dà ragione quando osserva,
seppur con un’infelice espressione, che l’agire dell’individuo “è determinato dalla struttura sociale”.
Chiaramente non può voler dire che le decisioni sono prese dalla struttura, né che l’individuo è un
un’ape incapace di agire liberamente. In un approccio marxista resta fondamentale il principio che
l’individuo è capace di azione intenzionale autonoma, altrimenti come si fa a ipotizzare che la
struttura sociale può essere modificata con la rivoluzione? Certo, la rivoluzione la fanno le classi
con l’azione collettiva. Ma non ci sarebbe bisogno della politica, della propaganda,
dell’organizzazione, dei programmi di partito, se l’azione collettiva rivoluzionaria fosse un’epifania
dell’ente generico. In realtà è un difficile processo di convergenza delle decisioni dei molti ed
eterogenei individui che compongono le classi. Per questo il metodo dell’individualismo
istituzionale è necessario non soltanto allo scienziato sociale ma anche al politico rivoluzionario.
C’è di peggio: di fronte alla complessità dei processi sociali e delle azioni collettive, e
nell’impossibilità di raccogliere tutte le informazioni micro-sociali necessarie per una completa
riduzione individualistica delle spiegazioni, gli scienziati e i rivoluzionari fanno spesso ricorso a
concetti riferiti ad aggregati sociali (le classi, le nazioni, il capitale etc.) e addirittura cercano di
individuare leggi empiriche che ne regolano la dinamica. È una pratica teorica che nel mio libro ho
definito “olismo euristico”, spiegando come non sia in contrasto col metodo dell’individualismo
istituzionale.
Marx indulge spesso in questa pratica, ad esempio quando elabora le sue “leggi di movimento”, e
spessissimo usa concetti riferiti a entità sociali collettive. Gli si fa un pessimo servizio se
s’interpretano quei concetti in termini olistici, anche se è vero che talvolta lui stesso viene mal
servizio dal linguaggio hegeliano su cui si era formato. Bisogna essere indulgenti. Non si può
pretendere che fosse a conoscenza del Methodenstreit aperto dagli economisti austriaci di fine
Ottocento.
Breda pare ossessionato dalla dialettica hegeliana. Ma anche qui bisogna riconoscere che forse lo è
meno di quanto sembra. A un certo punto cita una mia facezia sulle “civetterie dialettiche”. Il lettore
sprovveduto potrebbe prenderla per una bocciatura sarcastica. Però Breda è troppo ben ferrato in
marxologia per non sapere che quella facezia è un richiamo alla battuta che Marx fece nel poscritto
alla seconda edizione tedesca del Capitale, quando, dopo aver ricordato la propria “critica del lato
mistificatore della dialettica hegeliana”, affermò di aver “civettato qua e là, nel capitolo sul valore,
col modo di esprimersi che gli era peculiare”. C’è da supporre che dopotutto quella citazione di
Breda abbia voluto essere autoironica. Applicando al suo scritto il metodo dell’individualismo
istituzionale si potrebbe dire che qui siamo in presenza di un’azione preterintenzionale deformata
dal contesto filosofico idealista in cui Breda si muove.
A conferma della sensazione che il mio stroncatore, più di quanto lui stresso creda, si trova in buona
sintonia con le opinioni che intenderebbe criticare, vorrei richiamare alcune sue osservazioni che ho
trovato illuminanti. Innanzitutto ha capito che la mia ricostruzione della teoria della “vera
democrazia” del giovane Marx non è allineata con l’andazzo di riprovazione olistica della “casta” e
della falsa democrazia oggi imperante in Italia. Il discorso di Marx, proprio in quanto basato su una
critica individualista e materialista dell’olismo hegeliano, decostruisce i concetti di “interesse
nazionale”, “popolo”, “stato”, “classe universale”. Li decostruisce portando alla luce l’eterogeneità
degli interessi della “moltitudine”, cioè degli individui e delle classi sociali, e mettendo in chiaro
che sono le azioni di questi che determinano l’esistenza di quegli apparenti soggetti collettivi, e non
viceversa.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
È illuminante anche il modo in cui Breda mostra la contraddittorietà del concetto di “moltitudine”
quando è postulato “in opposizione ad ogni entità collettiva” come il “popolo” o la “classe operaia”
e poi ipostatizzato “come soggetto di una prassi collettiva”. In Marx non era così. La sua
moltitudine è un insieme di agenti socialmente caratterizzati (le “classi sociali”, già nel 1842-3) e
capaci di azione collettiva emancipatoria. Breda spiega al lettore che nella mia ricostruzione del
pensiero del giovane Marx ho mirato anche a chiarire quest’argomento.
Infine emerge il problema dei problemi: “La struttura sociale dipende dall’azione umana e quindi
può essere dall’azione umana modificata, ma non dall’azione individuale… Con riferimento alla
Posizione collettiva di scopo il problema è comunque tutt’altro che risolto, anzi, la questione è
appena aperta e richiederebbe la trattazione dei problemi relativi alla teoria delle classi e della lotta
di classe”. Ben detto. Peccato sia una “cosa che per ragioni di spazio non sarà possibile fare in
questa sede”.
In chiusura vorrei informare il lettore che Breda cita dalla prima edizione (2011) del mio libro,
ormai irreperibile. Ne è appena uscita una seconda edizione riveduta e ampliata: Marx dalla totalità
alla moltitudine (1841-1843), Editrice Petite Plaisance, Pistoia 2013.
Ernesto Screpanti insegna Economia della Globalizzazione e Storia del Pensiero Economico
all’Università di Siena.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Le conseguenze del formalismo: la ‘politica della logica’ di
Paul Livingston
di MARCO PIASENTIER
In linea con il proposito della presente rubrica, in questo numero di Knots si analizza un libro che
definisce un itinerario filosofico in cui si intrecciano filosofia politica di matrice continentale e
riflessione analitica sui paradossi semantici e matematici. Paul Livingston è professore di filosofia
presso l’Università del Nuovo Messico; il suo libro, ‘La politica della logica: Badiou, Wittgenstein
e le conseguenze del formalismo’,[1] è stato recentemente pubblicato per la collana ‘Routledge
Studies in Contemporary Philosophy’.
Il testo si propone di articolare la relazione tra logos e bìos, ovvero di rispondere alla domanda su
come il linguaggio – in quanto forma trascendentale – definisca e plasmi la vita umana. Non si tratta
di proporre una ‘logic of politics’, una ‘logica della politica’, ovvero di forzare il pensiero politico
entro un formalismo logico ad esso estraneo, ma di portare alla luce la dimensione intrinsecamente
politica della logica. Scopo di Livingston è la definizione di una ‘politics of logic’, ‘politica della
logica’, secondo la quale l’indagine sul logos è ‘simultaneamente sia logica che politica’ (p. 60):
La questione ultima di questa indagine […] è lo sviluppo di una “politica della logica” che tenti di
comprendere il logos stesso – ciò che Eraclito ha definito tempo addietro come il ‘comune’ – come
ciò che è l’immediata e necessaria forma di ogni esistenza linguistica (p. 8 )
Questa politica della logica permette di aggiornare e trasformare la classica questione teoretica del
bios politikon grazie ad un’indagine (meta-)formale riguardo l’esistenza e l’efficacia di forme e
formalismi atti a plasmare e determinare la vita collettiva. (p. 281)
Il libro si divide in tre parti. Nella prima - ‘Introduzione: un’indagine sulle forme di vita’ Livingston ne propone le linee guida per definire come la vita collettiva rifletta precise strutture
formali. Vengono individuati quattro diversi orientamenti di pensiero. I primi due – trascendentale e
costruttivo - sono ripresi dalla filosofia di Alain Badiou e il terzo analizza il pensiero del filosofo
francese stesso. Il quarto orientamento intreccia logica paraconsistente - in particolare il dialeteismo
del filosofo Graham Priest [2] - e filosofia poststrutturalista[3]. L’incontro tra questi due rami del
pensiero contemporaneo è incarnato dalla filosofia di Wittgenstein (post Tractatus). La seconda e la
terza parte del libro – ‘Criticismo-paradossale’ e ‘Badiou e la posta in gioco nel formalismo’ - sono
rispettivamente dedicate alla trattazione dell’orientamento wittgensteinano-poststrutturalista e
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
dell’orientamento generico, il sistema filosofico di Badiou. L’approccio non è compilativo, ma
volto a far emergere punti di somiglianza e differenza tra i due e, in un’ultima analisi, a dimostrare
la preferibilità di quello critico-paradossale su quello generico.
L’indagine sulla nozione di forma di vita fa da filo conduttore all’intero progetto: a partire da essa,
Livingston definisce il rapporto tra linguaggio, politica e vita. Contro due delle interpretazioni ad
oggi più diffuse – l’una che fissa la nozione di forma di vita entro una matrice puramente
antropologica, ed una che la definisce in termini puramente biologici – l’autore propone una terza
interpretazione. Il rifiuto sia del convenzionalismo intrinseco all’analisi antropologica, che del
riduzionismo biologista, conduce Livingston a sostenere che:
il problema sollevato da Wittgenstein nell’invocare la nozione di forme di vita non va analizzato
semplicemente rispondendo alla questione della natura della vita né tanto meno a quella della sua
forma, ma piuttosto in ciò che risiede tra questi due termini; ovvero cosa significhi per una forma
essere una forma di vita, cosa significa che qualcosa come una forma plasmi una vita (umana). (p.3)
Se il logos è ciò che plasma, dà forma, alla vita, questo atto non può che essere considerato come un
atto politico. Come scrive già Agamben in ‘Homo sacer’:
La domanda: “in che modo il vivente ha il linguaggio?” corrisponde esattamente a quella: “in che
modo la nuda vita abita la polis?” […] La politica si presenta allora come la struttura in senso
proprio fondamentale della metafisica occidentale, in quanto occupa la soglia in cui si esprime
l’articolazione fra il vivente e il logos[4]
È proprio a partire dalla nozione di forma di vita - come intreccio inscindibile tra politica,
linguaggio e vita - che Livingston propone un collegamento tra tradizione continentale ed analitica:
Uno degli obiettivi principali del presente lavoro è, quindi, sostenere che questi due vettori di
riflessione sul linguaggio – l’analisi metalogica da parte “analitica” e il post-strutturalismo nella sua
forma decostruttiva dal lato “continentale” – posso essere allineati ed essere considerati entrambi
utili fonti per una riflessione critica sulle implicazioni politiche del formalismo in quanto tale. Il
loro intreccio può produrre, in particolare, una comprensione formalmente chiara della costruzione
e della struttura delle comunità politiche, come del resto, delle loro possibilità di alterazione e delle
loro dinamiche interne di cambiamento (p.8)
La possibilità e, forse, la necessità di questa operazione risiedono nella centralità che il
poststrutturalismo ed alcuni orientamenti della logica contemporanea attribuiscono alla nozione di
aporia. In logica, il dialeteismo assume l’esistenza di enunciati sia veri che falsi, mettendo così in
discussione il principio di non contraddizione, pilastro portante del pensiero logico classico, definito
dallo stesso Aristotele come ‘il principio più saldo di tutti’. Il termine di-aletheia è stato coniato
proprio per rimarcare l’idea che vi siano enunciati dalla doppia verità. Il risultato aporetico a cui
giunge il dialeteismo è per molti versi equiparabile all’esito aporetico della filosofia francese che,
nel ventesimo secolo, elabora un pensiero fondato sull’intrinseca paradossalità del linguaggio. Si
consideri, ad esempio, la celebre frase di Derrida ‘non c’è un fuori dal linguaggio’. La paradossalità
di tale enunciato è evidente: nel linguaggio si afferma qualcosa sul linguaggio. Questa affermazione
solleva un problema topologico che può essere identificato con la seguente domanda: da dove parli?
Domanda che rappresenta forse uno dei fili conduttori più interessanti per ricostruire la storia di
buona parte della recente filosofia francese e italiana. È precisamente questa la domanda rivolta da
Derrida a Foucault, che sarà poi posta a Derrida da Vattimo e, prima ancora da Foucault stesso. Per
Livingston l’esito più significativo del poststrutturalismo è rappresentato da quelle forme di
pensiero che non neutralizzano la paradossalità di simili interrogativi, ma la assumano come
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
imprescindibile. Il pensiero aporetico diventa quindi il presupposto per definire la libertà, ovvero
quell’eccesso di soggettività che non si lascia imbrigliare completamente entro le maglie di un dato
sistema sociale, ma è in grado in occupare una posizione paradossale, di essere sia dentro che fuori
il sistema stesso. Pensare questo movimento oscillatorio è possibile proprio a partire da un’indagine
formale sul linguaggio.
Stabilire cosa sia il linguaggio sembra richiedere un metalinguaggio dal quale offrire una risposta.
La conseguenza è un regresso all’infinito di metalinguaggi, ciascuno atto a definire le condizioni di
esistenza del precedente. Così facendo, non solo si evita di rispondere alla domanda inerente il
linguaggio in quanto tale, ma si reifica anche la risposta alla questione topologica. L’orientamento
critico-paradossale prede una strada diversa ed afferma che il linguaggio è un’entità completa, ma
paradossale; quindi ogni risposta sul linguaggio viene sempre data nel linguaggio stesso, non in un
metalinguaggio. La risposta alla questione topologica è la dialetheia, ovvero il trovarsi
nell’oscillazione tra un dentro ed un fuori. L’esito paradossale a cui si giunge non è da considerarsi
né il segno di un errore logico, né l’abisso di un caos che forza al mutismo dell’indicibile.
L’aporeticità del linguaggio è, invece, un inizio attorno al quale un altro pensiero può, forse deve,
mettersi al lavoro. Questo pensiero è il punto di contatto che Livingston individua tra
poststrutturalismo, Wittgenstein e Priest.
All’orientamento critico-paradossale viene contrapposto quello generico. Livingston individua in
Badiou la manifestazione più sofisticata di quel pensiero che egli stesso prende a modello per il suo
lavoro, ovvero una filosofia in cui logica e politica sono tra loro da sempre intrecciate. In
un’intervista rilasciata nel 2007[5], il filosofo francese sostiene che ogni ‘pensiero creativo’ è in
realtà l’invenzione di un nuovo modo di formalizzazione, quindi il ‘pensare è l’invenzione di una
forma’. Platone, per primo, affermò che ‘il pensare è pensare forme’. Il paradigma per questo
pensiero è la matematica. L’intervista continua così:
Rimango fedele a questa idea, ma allo stesso tempo, il cuore dell’esperienza più radicale è la
politica. La politica stessa, in un senso, è anche pensare attraverso forme. Non è il pensare accordi,
contratti o la vita buona. No, è il pensare forme. (p. 9)
Nonostante il merito per aver proposto quella che ad oggi è la più completa formulazione della
politica della logica, Livingston critica Badiou in quanto ‘il suo modo di intendere il formalismo
comporta, in diversi punti, scelte teoreticamente fondamentali, che spesso vengono lasciate
implicite’ (p. 10). Il punto di frattura riguarda il giudizio sulla svolta linguistica, che Badiou
considera un sofismo postmoderno in cui, alla ricerca filosofica della verità, si sostituisce uno
spurio gioco retorico. Il recupero di un pensiero della forma - in quanto formalismo matematico
extra-linguistico e capace di cogliere l’essere in quanto essere - è chiaramente in linea con il
giudizio che Badiou dà della filosofia postmoderna. A differenza di Platone, però, Badiou individua
nell’incompletezza l’esito necessario di questo formalismo e - a partire dall’incompletezza teorizza l’evento, ovvero la possibilità di vero cambiamento. In altre parole, ‘la matematica è
ontologia’, ontologia del molteplice: da qui l’idea di un progetto filosofico che si definisce come
‘Platonismo del molteplice’.[6]
Lo scarto che Livingston rintraccia tra l’orientamento generico e quello critico-paradossale può
esser definito nel modo seguente. In primo luogo, l’orientamento critico-paradossale propone una
‘formalizzazione matematica del linguaggio’, mentre quello di Badiou una ‘posizione formale
extra-linguistica della matematica’(p. 190). In secondo luogo, tra questi due orientamenti vi è una
frattura nell’interpretazione del paradosso dell’autoreferenzialità. Mettendo in relazione, con
dovizia e inventiva, la storia della logica moderna e quella della filosofia continentale, Livingston
dimostra che questi due orientamenti partono da uno stesso punto: i paradossi
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
dell’autoreferenzialità. A venir messo in discussione attraverso questi paradossi è la possibilità che
un sistema che soddisfi contemporaneamente le proprietà di coerenza e completezza. Riconosciuto
il presupposto che nessun sistema coerente può essere utilizzato per dimostrare la sua stessa
coerenza, secondo Livingston:
la differenza fondamentale tra l’orientamento generico di Badiou e quello critico-paradossale è la
seguente: a partire dalla scelta a cui forzano i paradossi, dove l’orientamento generico di Badiou
opta per la coerenza e contro la completezza, l’orientamento critico-paradossale si fonda sulla
decisione della completezza contro la coerenza (p.56)
Se quindi Badiou rimane fedele al progetto filosofico di un pensiero della coerenza, l’orientamento
critico-paradossale afferma la completezza, riconoscendo che tale scelta inevitabilmente conduce ad
un esito paradossale. Per l’orientamento critico-paradossale, il linguaggio costituisce un sistema
completo e quindi non c’è nulla che in esso non possa essere articolato. La matematica è quindi una
tecnica linguistica e non un formalismo extra-linguistico attraverso cui sancirne l’incompletezza.
Proprio questo assunto conduce ad affermare l’inconsistenza come caratteristica strutturale ed
inevitabile del linguaggio stesso: se nessun sistema coerente può essere utilizzato per dimostrare la
sua stessa coerenza e non si dà la possibilità di un metalinguaggio da cui stabilire la coerenza del
linguaggio, allora il linguaggio, inteso come totalità, deve essere inconsistente. Al contrario,
Badiou propone l’incompletezza di ogni linguaggio esistente, in nome della coerenza logicomatematica. La nozione di incompletezza chiama in causa il pensiero di uno dei matematici più
influenti della storia della moderna: Kurt Gödel. Pur non essendo possibile in queste poche pagine
rendere giustizia dell’accurata analisi svolta da Livingston sui teoremi del matematico austriaco, è
comunque importante sottolineare, almeno brevemente, la relazione tra gli esiti dei teoremi
dell’incompletezza e il pensiero di Badiou.
Riconoscere un collegamento tra la filosofia di Badiou e la nozione di incompletezza di Gödel
permette di individuare quale sia il dubbio sollevato da Livingston in merito all’orientamento. Non
va dimenticato, infatti, che l’obiettivo filosofico di Gödel era quello di sostenere una forma di
realismo di matrice platonica. La mossa matematica che gli permise di supportare la sua teoria
filosofica era lo scarto tra la nozione di dimostrabilità e di verità. Incompletezza significa che ogni
sistema formale coerente non può dimostrare la sua stessa coerenza, per farlo deve necessariamente
ricorre ad un metasistema. Affermare l’incompletezza significa che il linguaggio, in ultima analisi,
non è in grado di dire tutta la verità su se stesso. Già Wittgenstein, commentando i risultati del
teorema di Gödel,[7] riconobbe la problematicità di una tale conclusione:
la matematica non può essere incompleta; come un senso non può essere incompleto. Quello che
posso comprendere devo comprenderlo interamente[8]
Se quindi la prospettiva di Badiou sembra portare con sé lo spettro di un resto metafisico, nemmeno
la prospettiva critico-paradossale appare scevra da problemi. Dal momento che Wittgenstein,
Derrida, Agamben, Deleuze, Lacan e Priest portano la contraddizione alle sue massime
conseguenze - negando la possibilità di una metateoria che sia esonerata da questa stessa
contraddizione - rimane in parte aperta la questione su come questa scelta non conduca ad una
forma di trivialismo[9]. In altre parole, negare che il principio di non contraddizione possa non
valere in alcune situazioni, comporta il rischio di non avere più un terreno sul quale affermare la
validità della propria posizione rispetto alle altre. Se politica e logica sono tra loro legate, la
conseguenza è proprio che una logica ed una politica aporetica finiscano per non consentire una
reale possibilità di scelta e quindi di cambiamento.[10] Nonostante i dubbi sollevati
dall’orientamento critico-paradossale, come scrive Livingston, esso sembra essere l’unico in grado
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
di render giustizia ‘al modo in cui ciò che possono sembrare le infinite possibilità del senso umano
sono destinate a vivere il vincolo della loro espressione in forme finite del linguaggio’(p. 233).
NOTE
[1] P. Livingston, The Politics of Logic: Badiou, Wittgenstein, and the Consequences of Formalism,
Routledge, 2012.
[2] Per una presentazione in lingua italiana del pensiero di Priest si veda F. Berto, Teorie
dell'assurdo. I rivali del principio di non-contraddizione, Carocci, 2009.
[3] Per una introduzione chiara e competa al poststrutturalismo ed alle sue affinità con la filosofia
italiana si veda D. Tarizzo, Il Pensiero libero. La filosofia francese dopo lo strutturalismo,
Raffaello Cortina Editore, 2003.
[4] G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995, p. 11.
[5] Intervista con Tzuchien Tho. The concept of Model, Forty Years later: An interview with Alain
Badiou. In The Concept of Model. Trans. By Tzuchien Tho e Zachary Luke Fraser. Victoria,
Australia: re.press, p. 102-3.
[6] A questo riguardo si veda A. Badiou, Manifesto per la filosofia, trad. it di F. Elefante, Cronopio,
2008.
[7] A tal riguardo si veda, ad esempio, F. Berto, Tutti pazzi per Gödel. La guida completa al
Teorema di Incompletezza, Laterza, 2008. In particolar modo l’ultimo capitolo: Gödel contro
Wittgenstein e l’interpretazione paraconsistente, pp. 223-251.
[8] L. Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, Einaudi, 1976, p. 111.
[9] Trivialismo è la teoria per cui ogni proposizione è vera. Se tutte le affermazioni sono vere,
allora, lo sono anche tutte le contraddzioni della forma ‘p e non p’. Si veda, ad esempio,
Paraconstency and Dialetheism, In D. Gabbay, , j. Woods, The Many Valued and Nonmonotonic
Turn in Logic. Elsevier. p. 131; F. Berto, Teorie dell’assurdo, I rivali del principio di noncontraddizione, Carocci, 2009, p. 235.
[10] Per una trattazione dei recenti approcci logici al principio di non contraddizione si veda a cura
di G. Priest, JC. Bell e B. Armour-Garb, The Law of Non-Contradiction. New Philosophical
Essays, Oxford University Press, 2004.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Ius sanguinis o ius soli? Riflessioni sulla storia politica della
cittadinanza in Italia
di VITO FRANCESCO GIRONDA
Quali sono le ragioni che hanno sempre condotto in Italia a privilegiare lo ius sanguinis allo ius
soli? Per rispondere a questa domanda bisogna risalire alle origini dello Stato unitario. In questa
fase lo ius sanguinis è servito a procurare agli italiani un senso di appartenenza “nazionale”,
capace di superare le varie frammentazioni territoriali e di guadagnare il consenso e l’inclusione
delle élites economiche e sociali dei vecchi Stati territoriali. Ma il venir meno di queste esigenze
dovrebbe condurre oggi a elaborare una nuova concezione della cittadinanza.
L’attuale dibattito politico sulla riforma della cittadinanza risente di una forte impostazione emotiva
e di un principio di presunzione d’appartenenza, una concezione particolaristica dell’individuo e
delle sue relazioni sociali quale risorsa culturale da spendere sul terreno della comunicazione
politica.[1] Eppure, guardare alla storia politica dell’istituto giuridico della cittadinanza significa,
storicamente, interrogarsi sulle trasformazioni della moderna statualità otto e novecentesca.[2]
In primo luogo, sul terreno della cittadinanza formale si è giocata una partita fondamentale dei
processi di nation-bulding: chi e attraverso quali criteri identificativi può considerarsi membro di
diritto della comunità politica e, poste determinate condizioni di status economico e di capitale
culturale, esercitare i diritti connessi alla qualità di cittadino? In questo caso, la nazione più che
essere “immaginata” (Benedict Anderson) diventa un fatto reale che ha immediate ripercussioni
sulla vita di ogni singolo individuo e gruppo sociale.[3]
In secondo luogo, la cittadinanza rappresenta una spia importante per analizzare le forme, i
contenuti e i limiti della credenza utopica della modernità attorno all’idea di una società di cittadini.
Infine, riflettere sulle modalità di sviluppo e di codificazione del diritto di cittadinanza permette,
più in generale, di ragionare in ordine alle culture politiche di volta in volta dominanti. Certo, non si
può prescindere da un’attenta valutazione del significato culturale dello ius sanguinis e dello ius soli
nel quadro della moderna statualità nazionale.[4] Un tale approccio culturalista rischia, però, di
semplificare la complessità storica dei modelli idealtipici di costruzione della cittadinanza moderna
come risultato di un processo discorsivo di natura prettamente simbolica che investirebbe immagini
e concezioni della politica dell’identità. Al contrario, ritengo che ogni formazione discorsiva
sottostia a delle condizioni strutturali e processuali.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Per questa ragione, la continuità secolare del primato dello ius sanguinis nella legislazione italiana,
ossia una concezione etnoculturale della cittadinanza in base alla quale per essere membro di una
comunità politica bisogna essere membri di fatto di una comunità prepolitica determinata da fattori
culturali, linguistici e antropologici, piuttosto che un indicatore di un diffuso discorso biologistico
nella storia italiana – eccezione il ventennio fascista – dovrebbe essere interpretato nella sua
plurifunzionalità politica. Lo ius sanguinis è passato dalla tradizione ancora confessionalista del
Regno di Sardegna allo Stato liberale a quello fascista per giungere indisturbato anche allo Stato
democratico repubblicano. La questione fondamentale è chiedersi il perché? Perché nel lungo
periodo le varie legislazioni statali connesse a diversi sistemi politici hanno fatto riferimento al
primato dello ius sangunis? La risposta sta nella singolare funzione del diritto di cittadinanza quale
forma di political governance rispetto alle trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche che
hanno investito il paese nel corso degli ultimi due secoli. Da qui anche il carattere prettamente
politico dell’istituto giuridico della cittadinanza. Andiamo per ordine.
Lo Stato unitario eredita per lunghi tratti il modello di appartenenza formale allo stato del Codice
Albertino del 1837 in base al quale la sudditanza subalpina era stata codificata attorno al principio
della patrilinearità.[5] Lo status di suddito, che oramai coincideva con l’esercizio di alcuni diritti
civili, era una diretta emanazione della discendenza da un suddito subalpino. Le capacità giuridiche
dei singoli venivano, però, legate all’appartenenza alla confessione cattolica (art. 18). La
cittadinanza-sudditanza subalpina diventava uno strumento di chiusura sociale nei confronti delle
minoranze religiose dei valdesi e degli ebrei. In questo modo si voleva testimoniare che il modello
di riferimento comunitario subalpino consisteva, dopo la breve parentesi napoleonica, nel
riaffermare il sano sodalizio tra altare e trono.[6]
Il Codice civile italiano del 1865 fa suo il principio della patrilinearità, si svincola dal
confessionalismo sabaudo e riafferma con forza il modello classico di disuguaglianza di genere
partorito dal Codice napoleonico del 1804, secondo la quale la donna sposata seguiva la condizione
giuridica del marito. Nella normativa sulla cittadinanza italiana entrava di prepotenza il canone
tardo-illuministico dell’unità organica della famiglia.[7] Vittorio Polacco aveva poi giustificato
sulle pagine dell’Archivio giuridico i principi ispiratori del Codice civile italiano del 1865 in
rapporto ad una presunta legge naturale della “associazione domestica”, secondo la quale “un
individuo prima di appartenere a una nazione è membro di una famiglia (...) e per questa ragione è
cittadino di uno Stato nel quale la famiglia e non l’individuo costituisce la cellula elementare”.[8]
Come dire, la donna sposata e i suoi figli possedevano secondo la giuspubblicistica italiana una
sorta di cittadinanza necessaria, tanto che un altro giurista del tempo, Antonio Ricci, affermò che
esiste una nazionalità della famiglia il cui “destino” dipende dalla condizione del pater familias nel
senso che ogni modificazione del suo status comporta una modificazione dello status familiare.[9]
Tradotto poi in termini di disposizione di diritto, per il Codice civile significava che la donna
straniera acquisiva attraverso il matrimonio con un “nazionale” automaticamente la cittadinanza del
marito, mentre una donna italiana perdeva la cittadinanza nazionale attraverso il matrimonio con
uno straniero.
Fin qui i tratti del dettato normativo, ma la questione resta sempre aperta: perché lo ius sanguinis
reggeva l’impalcatura codicistica italiana del 1865? La risposta in questa prima fase della storia
unitaria italiana deve essere ricondotta, molto probabilmente, alla valenza comunicativa dello ius
sanguinis nel rendere fruibile di comprensione un processo di associazione di tipo comunitario,
l’“accomunamento politico” (politische Vergemeinschaftung) di weberiana memoria, il quale trova
una sua ragione d’essere in un senso di appartenenza dei partecipanti in senso affettivo e
tradizionale. Rispetto a che cosa? Sicuramente rispetto alle varie frammentazioni territoriali, alle
crisi di legittimità, alla ricerca del consenso e inclusione delle élites economiche e sociali dei vecchi
Stati territoriali. Il Risorgimento italiano più che essere interpretato attraverso il primato dell’idea
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
di nazione dovrebbe essere riletto come dissenso e in alcuni casi “ribellione” politica delle élites
notabilari locali nei confronti delle procedure burocratico-esecutive delle diverse monarchie
amministrative degli Stati territoriali preunitari.[10]
Il municipalismo e il localismo rappresentano i due assi centrali per comprendere la storia politica
italiana della prima metà del XIX secolo. Il successo del costituirsi del paese Italia in nazione
dipendeva dalla ricerca di un equilibrio contrattuale tra gli interessi delle rappresentanze
(possidenti, proprietari, burocrazie locali) delle società locali, tradizionalmente refrattarie nei
confronti delle prassi di centralizzazione del potere politico e lo Stato. Tutto questo
fondamentalmente voleva dire rispettare il dominante canone risorgimentale del municipio quale
associazione privatistica e patrimoniale, lasciare un’ampia autonomia finanziaria alle élites locali
nella gestione degli “affari” comunali così come istituire dei meccanismi di rappresentanza in grado
di allargare la visibilità istituzionale alle formazioni sociali dei possidenti e dei proprietari e, in
alcuni casi, alla nascente borghesia acculturata.[11]
Come è noto, in relazione a quest’ultima questione essa sarà, poi, egregiamente svolta dal
Parlamento nazionale quale garante del raccordo al centro degli interessi particolaristici delle
società locali. In un tale contesto, marcato da una debolissima identificazione nazionale, il
liberalismo governamentale si premurò fin da subito di presentare alle periferie nazionali
l’unificazione giuridica ed amministrativa non solo nella sua dimensione tecnica di essere neutrale
ed oggettiva, ma nella costruzione di un nuovo spazio di diritto nazionale cercò di riformulare la
relazione tra stato e società sulla base di un’idea di comunità nazionale i cui membri erano tenuti
insieme da legami culturali e da valori ascrittivi, da una appartenenza naturale, organica e olistica
alla nazione. In altre parole, si assiste a una fondamentale traslazione concettuale dal sostantivo
“ordine” all’aggettivo nazionale. Nei primi anni sessanta del XIX secolo si trattava, dunque, di
rappresentare la nazione nella sua dimensione normativa e su questo terreno lo ius sanguinis era
diventato uno strumento comunicativo spendile.[12]
La prima legge organica sulla cittadinanza italiana si ha agli inizi del XX secolo con la riforma del
1912. Codesta riforma dovrebbe essere letta nel quadro più generale dell’intensa attività riformistica
d’inizio Novecento, i cui intenti modernizzatori sono stati “frenati” da specifiche cautele
conservatrici volte ad adeguare l’assento istituzionale alle trasformazioni in atto nella società
italiana senza procedere a radicali modifiche. L’industrializzazione, l’inserimento dell’Italia in un
mercato del lavoro già tendenzialmente globale, la regolamentazione statale in materia di acquisto e
perdita della cittadinanza tra paesi di immigrazione e quelli di emigrazione e non, non da ultimo,
l’emergere di una specifica concezione di politica espansionistica verso l’America meridionale,
furono tutti fattori che condussero ad una politicizzazione della cittadinanza nazionale. All’interno
della modernizzazione difensiva d’inizio XX secolo, la riforma del 1912 rappresenta una legal
regulation (Verrechtlichung) rispetto ai temi sopra citati.
Toccata solo marginalmente dai flussi di migrazione continentale – secondo il censimento italiano
del 1910 gli stranieri residenti erano meno di ottantamila – la politicizzazione della cittadinanza
ruotava attorno all’emigrazione di massa verso il Brasile e l’Argentina, paesi dove vigeva un
principio territoriale puro (ius soli). Oltre che essere motivo di scontro tra lo Stato italiano e i
governi argentini e brasiliani in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, lo status giuridico
degli emigranti transoceanici fu al centro del coagularsi di un’ampia convergenza d’interessi in
relazione all’idea di una politica espansionistica nazionale costruita attorno alla metafora della
colonia libera. In diversi ambienti economici, governativi e culturali l’emigrazione era considerata
uno strumento di espansione economica, una specifica via di colonizzazione e al tempo stesso,
come scrisse Francesco Saverio Nitti sulla pagine della “Riforma sociale”, “una potente valvola di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
sicurezza sociale contro gli odi di classe e l’unica salvezza di un paese privo di risorse e pieno di
uomini”.[13]
Al trauma di Adua, al fallimento del colonialismo diretto, si rispondeva attraverso un’idea di
espansionismo “pacifico” a cui sottostava l’idea di una “italianizzazione” dei territori di
emigrazione attraverso la salvaguardia della fisionomia nazionale degli emigranti italiani. In altre
parole, la locuzione di colonia libera era diventata nell’Italia di fine XIX secolo sinonimo
d’italianità organizzata all’estero. Se si voleva tramutare l’emigrazione in un fattore di potenza era
necessario, così gli umori politici del tempo, adoperarsi a far diventare gli emigranti in Sud America
più “italiani” e, contemporaneamente, bisognava incoraggiare l’emigrante italiano a partecipare
alla vita politica ed amministrativa nei paesi dell’America meridionale e dunque ottenere il diritto di
cittadinanza in questi paesi:
Dobbiamo facilitare ai nostri emigranti l’acquisto della cittadinanza locale. Solo così si potrà
ottenere di rialzare laggiù la dignità dei nostri emigranti. Essi non si sentiranno più come oggi
ripudiati dalla madrepatria e disprezzati dal paese che li alberga. I figli loro, che oggi si vergognano
della loro discendenza, sentiranno simpatia per il paese dei loro padri, che continueranno a
considerarsi come sangue suo, che tende loro le braccia, e non considerarli come rinnegati e cani
renitenti.[14]
Sul terreno giuridico istituzionale l’ostacolo principale per questi propositi espansionistici e
nazionalistici era rappresentato dalle disposizioni contenute all’articolo 11 del Codice civile del
1865 che prevedevano la perdita automatica della cittadinanza italiana al momento della
naturalizzazione in un paese straniero. Fautori e promotori della campagna politica per una
revisione della suddetta norma furono le rappresentante degli interessi economici italiani all’estero
legati alle Camere di Commercio e ai vari Comitati degli italiani all’estero.[15] Codeste
rappresentanze si fecero interpreti dell’utilità politica ed economica da parte dello Stato italiano di
riconoscere una doppia cittadinanza di diritto, ossia di riconoscimento da parte dello stato sia di
origine sia di residenza della contemporanea appartenenza politica dell’individuo emigrato a
entrambe le entità statuali.
Tali richieste trovarono, poi, una forte eco tanto nei gruppi di pressione imprenditoriali vicini al
blocco protezionista quando in quelli con una più spiccata visione liberista. Tutte e due i fronti, pur
partendo da presupposti differenti, erano interessati a politicizzare la questione della condizione
giuridica degli italiani nell’America latina sul fronte di rinnovato programma di politica economica
nazionale. Essi guardavano all’emigrazione transoceanica come opportunità per costruire un
mercato nazionale all’estero in risposta ad un mercato interno al limite della saturazione ed in crisi
per la concorrenza internazionale e, d’altra parte, intravedevano una possibile compensazione
rispetto all’incerta soluzione dei rinnovi dei trattati commerciali con i paesi dell’Europa
continentale. In questa prospettiva l’emigrazione risultava complementare all’espansione solo se
l’emigrante fosse stato in grado di tenere solidi contatti con la madrepatria. Compito dello Stato era
allora quello di agevolare l’acquisizione della cittadinanza nei paesi d’immigrazione senza che ciò
comportasse una perdita della cittadinanza d’origine.
La revisione dell’articolo 11 del Codice civile poneva dunque la classe politica liberale di fronte al
problema di ricercare una convergenza tra un’autocomprensione etnoculturale dell’appartenenza
nazionale e la legittimità di nuove forme di politiche espansionistiche. Tanto per riportare le parole
dell’onorevole Grippo in sede del dibattito parlamentare del 1911, “noi ci troviamo in una
situazione contradittoria, perché mentre diciamo che bisogna facilitare agli italiani che risiedono
negli Stati Uniti e specialmente nell’America del Sud, la partecipazione alla vita politica e
amministrativa, dall’altra parte vogliamo mantenere il sentimento d’italianità, vogliamo cercare di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
non perdere questa grande massa di italiani che vanno nell’America del Sud”.[16] In definitiva si
trattava di risolvere la questione, come scrisse un commentatore politico del tempo, circa la
“compatibilità tra la nuova cittadinanza acquistata dall’emigrante all’estero e la durevolezza della
sua appartenenza alla nazione, la permanenza di certi vincoli etnologici con l’Italia.”[17]
Nelle diverse sedi di dibattito politico (Commissione di riforma, Ufficio centrale del Sanato,
Parlamento) il fronte contro la doppia cittadinanza di diritto fu molto grande. La proposta della
doppia cittadinanza fu considerata una sorta di mostro giuridico, un nuovo Giano bifronte perché
essa non era assolutamente compatibile con i fondamenti costitutivi della stessa cittadinanza. Tanto
per riportare le parole di Vittorio Scialoja relatore in Commissione senatoriale:
Elemento materiale costitutivo dello Stato è il territorio, elemento personale costitutivo dello Stato è
il popolo; chi del popolo fa parte è cittadino e come tale appartiene allo Stato; in questo è membro e
sta quindi con lo Stato un collegamento organico; dato ciò, è un assurdo giuridico l’ammettere la
possibilità che uno stesso membro a due diversi organismi possa appartenere: il collegamento
dell’individuo a uno Stato importa necessariamente l’esclusione di un altro uguale collegamento a
un altro Stato.[18]
Ora, l’aspetto fondamentale che emerge da queste affermazioni è la dominanza nella cultura politica
del liberalismo del paradigma dello stato-persona, dell’idea dello Stato come organismo. Si ricorre
al paradigma organicistico per legittimare il rifiuto della proposta della doppia cittadinanza. Proprio
qui sta la fondamentale logica di affermazione politica e non culturale dello ius sangiunis. Lo ius
sanguinis va visto come un elemento costitutivo dentro il più ampio paradigma della concezione
dello Stato-organico. Per questa ragione bisogna considerare la generale valenza politica di
quest’ultimo nella storia politica dello Stato liberale.
La storiografia giuridica italiana ha osservato che per la giuspubblicistica liberale far quadrato
attorno alla metafora organicistica aveva significato rappresentare in termini esclusivamente
giuridici l’apparato normativo e organizzativo dello stato di diritto liberale.[19] L’ordine giuridico
si identifica con lo Stato e, come giustamente sottolinea Pietro Costa, per questa via si procedeva
indicando le fondamenta dello Stato sulla base di un procedimento ad escludendum. La cultura
giuridica liberale escludeva a priori un’idea contrattualistica dello Stato, in quanto essa sarebbe
viziata dal cosiddetto “atomismo” di derivazione francese che proietterebbe sullo Stato l’ombra
della instabilità (Pietro Costa).
Una tale elaborazione concettuale si proponeva come risposta prettamente politica rispetto ai
crescenti processi di differenziazione del sociale e di mobilitazione politica tra Ottocento e
Novecento, essa era diventata il mantra della modernizzazione difensiva. Infatti, vedendo nello
Stato un’unità organica naturale ovviamente la stessa legittimazione statale era posta oltre la sfera di
giustificazione politica. Secondariamente, era proprio questo che permetteva di sottrarre la
concezione della Stato dai conflitti del sociale, neutralizzando anche per questa via una possibile
dimensione politica espressa dalle rappresentanze degli interessi plurali delle diverse formazioni
sociali. Ebbene, a me sembra che il paradigma dello Stato-organico abbia rappresentato nei circuiti
legislativi il sostrato culturale di quelle politiche di governance nel primo decennio del XX secolo
hanno avviato il processo di nazionalizzazione delle masse attraverso una graduale estensione
formale dei diritti di cittadinanza.
Basti pensare alla strutturazione normativa delle relazioni centro-periferia (legge sulle
municipalizzazioni del 1903) tesa a depoliticizzare le politiche di city government di matrice
socialista e cattolica;[20] oppure, nel modo in cui si affronterà la questione sociale e il tema del
suffragio universale. Sia le politiche di welfare liberale che attraverso il canale amministrativo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
proveranno a istituzionalizzare i conflitti in base a programmi sociali politico-clientelari da una
parte, e sia l’avvento del suffragio universale concesso in virtù di una concezione del voto come
funzione pubblica rappresentarono due tappe importanti nel processo di integrazione delle masse e
in quello di rafforzamento delle istituzioni sociali, senza tuttavia che l’estensione formale dei diritti
di cittadinanza fosse accompagnata da un’effettiva cultura egualitaria dei diritti. [21]
Durante il ventennio fascista lo ius sanguinis assumerà la connotazione di un atto performativo
volto a determinare lo spazio di appartenenza e di esclusione del nuovo razzismo di Stato.[22] In
questo processo la dimensione politica, quella di potenza così come le disposizioni normative
discriminatorie costituivano un continuum, sono state il risultato di uno specifico dispositivo
ideologico. Si è trattato di un dispositivo che per un verso ha avuto una connotazione di tipo
inclusivo perché funzionale alla continuità di una certa idea di politica estera ed espansionistica
giocata attorno al ruolo attivo degli emigranti. A partire dal 1927 la politica migratoria fascista sarà
tutta tesa a preservare l’italianità all’estero, il principio del cosiddetto carattere indelebilis della
cittadinanza. Allo stesso tempo, la nuova stagione del razzismo di Stato poggiava sul principio di
“naturalità” negativa dei gruppi sociali che di volta in volta poteva essere definita su basi culturali,
religiose, politiche o economiche. Lo sarà in riferimento alla produzione normativa di tipo
pervasivo del dominio coloniale fascista, ma anche con le Leggi razziali del 1938 e i vari
provvedimenti amministrativi e legislativi in materia. Anzi, la definizione normativa di “persona
appartenente alla razza ebraica” sintetizzatava tragicamente il trionfo del razzismo biologico
fascista.
Allora, a questo punto la questione finale alla quale bisognerebbe provare a rispondere è perché
l’idea di cittadinanza “nazionale” risultata, storicamente, dal prefigurarsi da una valenza politica
pluriforme dello ius sanguinis si sia conservata anche nell’Italia repubblicana? Credo che la
risposta vada trovata nelle modalità del processo di transizione verso una democrazia costituzionale
che in Italia si avvalsa d’immagini storiche e autorappresentazione collettive volte a rendere fruibili
di comprensione l’idea secondo la quale è l’appartenenza allo Stato, determinata dalla nascita, che
da fondamento di partecipazione alla grammatica dei diritti democratici. Non diversamente dalla
transizione democratica tedesca anche in Italia si afferma una concezione di democrazia
omogenea.[23] Allo stesso tempo, la persistenza dello ius sanguinis nella nostra legislazione
dimostra che la territorialità (Charles Maier), intesa come organizzazione spaziale dai confini
culturali e politici netti imperniata sullo stato-nazione continui ad essere un progetto
onnicomprensivo, un lunghissimo Novecento che non vuole finire.[24]
Ora, rispetto alle nuove condizioni di un paese di fatto d’immigrazione, la questione politica
rimane: con la rottura di un’omogeneità culturale via ius soli, la cittadinanza in pieno senso
democratico come strumento d’aspettative di partecipazione ne uscirebbe indebolita o rafforzata?
Su questo terreno la politica è chiamata a dare delle risposte, urgenti, però.
NOTE
[1] Per una discussione sul dibattito politico italiano mi permetto di rimandare ai miei interventi
Vito Francesco Gironda, La cittadinanza controversa, ovvero il problema di un paese al bivio
(appunti sulla democrazia), in: Critica Liberale 13.05.2013; Riforma della cittadinanza per gli
immigrati. E poi?, in: Politica e Società 17.02.2012; Caro Ministro Riccardi, cos’è lo ius culturae?,
in: sbilanciamoci.info 30.03.2012.
[2] Su tali questioni rimando al mio lavoro Vito Francesco Gironda, Die Politik der
Staatsbürgerschaft. Italien und Deutschland im Vergleich 1800-1914, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2010; Andreas Fahrmeir: Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept, New
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
Haven / London, Yale University Press, 2007; Thomas Faist/ Peter Kivisto, Citizenship: Discourse,
Theory and Transnational Prospects, Oxford, Blackwell, 2007.
[3] B. Anderson, Comunità immaginate: origine e diffusione dei nazionalismi, Roma,
Manifestolibri, 1996 (ed. orig. Imagined Communities, London-New York, Verso, 1982).
[4] A insistere su questa questione è stato soprattutto Rogers Brubaker, Cittadinanza e nazionalità
in Francia e Germania, Bologna, Il Mulino, 1997 (ed. orig. Citizenship and Nationhood in France
and Germany, Cambridge, Harvard University Press, 1992)
[5] Carlo Bersani, Modelli di appartenenza e diritto di cittadinanza in Italia dai codici preunitari
all’Unità, in Rivista di Storia del diritto italiano, LXX, 1997, pp. 277-344.
[6] Daniele Menozzi, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della
cristianità medievale (1758-1848), in: Chittolini, G./Miccoli, G. (a cura di), Storia d’Italia, Annale
IX, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino, G. Enaudi, 1986,
pp. 753-789.
[7] In generale si veda Geneviève Fraisse, Les deux gouvernements: la famille et la cité, Gallimard,
Paris, 2001; Jennifer Ngaire Heuer, The Family and the Nation: Gender and Citizenship in
Revolutionary France, 1789-18 30, Ithaca, Cornell University Press, 2005. Sul caso italiano si
vedano le lucidissime osservazioni di Chiara Saraceno, Le donne nella famiglia: una complessa
costruzione giuridica, in: Barbagli, M./ Kartzer, D.I. (a cura di), Storia della famiglia italiana 17501950, Bologna, Il Mulino, 1992, pp.103-127; Raffaele Romanelli, Individuo, famiglia e collettività
nel codice civile della borghesia italiana, in: Gherardi, R./Gozzi, G. (a cura di), Saperi della
borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, Bologna, IL Mulino, 1995, pp. 351-399.
[8] Vittorio Polacco, La famiglia del naturalizzato secondo il codice civile, in: Archivio Giuridico,
1882, 29, pp. 366-388, citazione p. 379.
[9] Antonio Ricci, Il principio dell’unità della famiglia nell’acquisto della cittadinanza, in: Rivista
italiana di scienze giuridiche, 1891, XIII, pp. 24-53.
[10] Per una panoramica d’insieme si rimanda a Marco Meriggi, Gli Stati italiani prima dell’Unità.
Una storia istituzionale, Bologna, Il Mulino, 2002; Luca Mannori, La crisi dell’ordine plurale.
Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento, in: Giornale di storia costituzionale”, 6, 2003,
pp. 243-271.
[11] Fondamentale resta il lavoro di Raffaele Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società
nell'Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 1988.
[12] Sulla tradizione di una narravita risorgimentale attorno all’idea dell’Italia come comunità
geoparentale e naturale si rimanda a Alberto. B. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela,
santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Enaudi, 2000.
[13] Francesco Saverio Nitti, La nuova fase dell’emigrazione italiana, in: Riforma sociale, 1896, 3,
pp.13-28, citazione a p. 21.
[14] Sidney Sonnino, Relazione al Senato, stato dell’emigrazione, Archivio storico della Camera
dei Deputati, protocollo n. 13427.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 4 – dicembre 2013
[15] Si vedano gli Atti del I e II Congresso degli Italiani all’estero, a cura dell’Istituto Coloniale,
Roma 1909-11.
[16] L’intervento dell’onorevole Grippo si trova in “Atti Parlamentari“, Roma, 1912, p. 2296.
[17] Giulio Cesare Buzzati, Questioni sulla cittadinanza degli Italiani emigrati in America, in:
Rivista di diritto civile, 1909, 2, pp. 445-476, citazione a p. 432.
[18] Vittorio Scaloja, Relazione riforma istituto della cittadinanza, Atti del Senato, Roma 1911, p.
432.
[19] Su tali questioni si rimanda a Pietro Costa, Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella
cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 1986; Luigi Ferrajoli, La cultura
giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; Maurizio Fioravanti, La scienza del
diritto pubbblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè.
2001.
[20] Sulla valenza politica del concetto di comune come ente autarchico si rimanda a Fabio Rugge,
Trasformazioni delle funzioni dell’amministrazione e cultura delle municipalizzazioni, in:
L’amministrazione nella storia moderna, Archivio Isap 3, Milano, 1985, pp. 1233-1288.
[21] Si vedano Giovanni Gozzini, Povertà e stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di
path dependence, in: Zamagni, V. (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal
Medioevo ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2000, pp-578-610; Paolo Pombeni, La rappresentanza
politica, in: Romanelli, R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Roma,
Donzelli, 1995, pp.73-125.
[22] Per le considerazioni a seguire si rimanda ai contributi in Nel nome della razza. Il razzismo
della storia d’Italia 1870-1945, a cura di Alberto Burgio, Bologna, Il Mulino, 2000; Antisemitismo
in Europa negli anni trenta: legislazioni a confronto, a cura di A. Cappelli/R. Broggini, Milano,
Franco Angeli, 2001; Giulia Barrera, Mussolini’s colonial race laws and the state-settler relations
in Africa Orientale Italiana, in: Journal of Modern Italian Studies, 2003, 8, pp. 425-443.
[23] Sul caso tedesco si veda Gustavo Gozzi, Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto
alla democrazia costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 1999.
[24] Charles S. Maier, Secolo corto o epoca lunga? L’unità storica dell’età industriale e le
trasformazioni della territorialità, in: Novecento. I tempi della storia, a cura di C. Pavone, Roma,
Donzelli, 1997, pp. 45-78.
* Vito Francesco Gironda insegna storia delle moderne società presso l’Università di Bielefeld
(Germania). Tra le recenti pubblicazioni si segnalano una storia comparata della politica della
cittadinanza in Italia e in Germania, libro uscito in tedesco (V. F. Gironda, Die Politik der
Staatsbürgerschaft. Italien und Deutschland im Vergleich 1800-1914, Vandenhoeck § Ruprecht,
Göttingen 2010) e insieme a Michele Nani e Stefano Petrungaro, Imperi coloniali. Italia,
Germania e la costruzione del “mondo coloniale”, Ancora del Mediterraneo, Napoli 2009
Membro dell’Osservatorio Filosofico partecipa al progetto culturale di
www.filosofiainmovimento.it