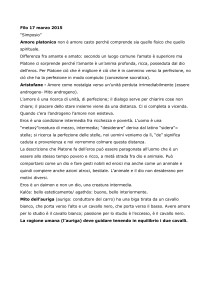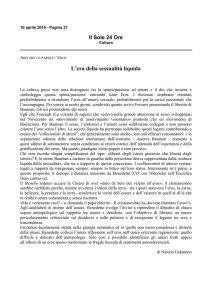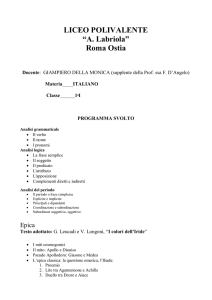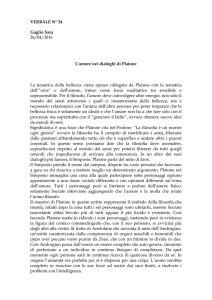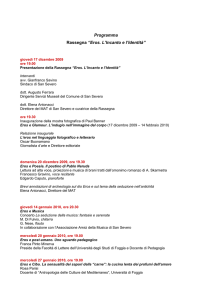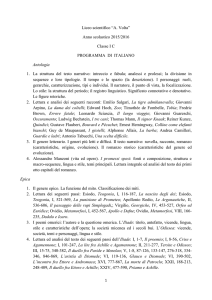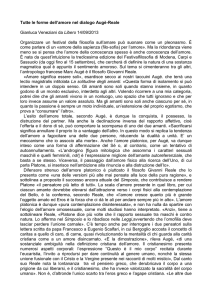EROS E AMICIZIA IN FILOSOFIA E IN LETTERATURA
1
Premessa
Il testo che segue è una rielaborazione fedele del contenuto degli incontri che abbiamo tenuto tra
il Novembre 2009 e il Gennaio 2010 sul tema dell’amore in letteratura e filosofia.
Fedele, non identica. Abbiamo scelto per gli incontri un taglio di carattere seminariale,
volutamente lontano dal metodo didattico che abitualmente si è costretti a usare a scuola. Attorno
ad una serie di testi esemplari sul tema in questione abbiamo infatti cercato di costruire un
percorso che fosse fatto di dialogo, tentativi di interpretazione, domande e sollecitazioni, piuttosto
che di risposte nette e indiscutibili.
I testi con la loro stringente sequenza di parole date, le parole (nostre e degli studenti) con la loro
incalzante volatilità sono stati i veri protagonisti degli incontri. Quindi, molte delle cose che sono
state dette hanno acquisito una struttura diversa nel passaggio dalla forma viva della
comunicazione orale a questa ‘trascrizione’. Quanto segue è dunque una rielaborazione sintetica
del contenuto degli incontri e dello spirito che li ha animati, grazie soprattutto agli appunti che ne
hanno conservato i partecipanti, e che abbiamo cercato qui di fondere in un discorso unitario e
omogeneo.
Vito Cataldo
Carmelo Tramontana
2
Prima Giornata
Noi contemporanei, cristiani, viviamo il mondo come la creazione di Dio, di un dio, una divinità
che sempre è stata e sarà, concepiti dal nulla e al nulla destinati a tornare. Non è stato così per i
greci, dotati di una cultura, una tradizione e soprattutto un’apertura mentale diversa dalla nostra.
Anche se il nostro mondo è, in parte, l’evoluzione del loro, le idee, i pensieri, i ragionamenti sono
notevolmente mutati, a volte tanto da risultare persino opposti. Così, per i popoli della Grecia
antica nulla è stato creato e, di conseguenza, nulla si distrugge, poiché l’essere è sempre.
La parola di Parmenide dice: l’essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere.
Con ciò il filosofo sancisce con la forza del pensiero l’impossibilità logica di pensare e dire il non
essere e l’impossibilità ontologica che il non essere sia. Ai suoi occhi l’essere è necessario in
quanto essere, in quanto cioè dell’essere non può essere detto che non è e non può quindi essere
pensato come non essente in qualche tempo, prima di essere o dopo essere stato. Il nulla non è
quindi possibile, non precede l’essere, né questo può avere avuto origine da quello.
Nella prospettiva cristiana il mondo è il prodotto della creazione di Dio per la quale l’essere viene
tratto dal nulla che gli preesiste. E allora, perché l’essere e non piuttosto il nulla, data la sua
sconcertante possibilità? Il Cristiano dice: c’è l’essere e non il nulla perché così ha voluto Dio.
L’essere dunque è non per una sua intrinseca necessità di non poter non essere ma trova la sua
condizione nella libertà di poter essere che si identifica nell’atto con cui Dio liberamente crea il
mondo.
Esiodo, grande poeta greco vissuto fra l’VIII e il VII secolo a.C., scrisse la più antica narrazione
mitica dell’ origine e del divenire del mondo: la Teogonia.
Nella Teogonia si parla della nascita degli dei, della possibilità che qualcosa possa essere e di un
tempo indefinito a partire del quale qualcosa inizia ad essere.
“Dunque, per primo fu Caos, e poi
Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti
Gli immortali che tengono la vetta nevosa dell’Olimpo,
e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade,
poi Eros, il più bello fra gli immortali,
che rompe le membra, e di tutti gli dei e di tutti gli uomini
doma nel petto il cuore e il saggio consiglio.”
(Esiodo, Teogonia, vv.116-122)
I versi 116 –122 della Teogonia presentano una Triade, ovvero tre divinità coesistenti, quindi
contemporanee. Queste divinità sono Caos, Gaia ed Eros. Il nome Caos deriva dai verbi greci
“chàino” e “chasko” che significano “mi apro”, “tengo la bocca spalancata”. In senso figurato
l’apertura della bocca, manifestando il vuoto che si apre in questo aprirsi, ci regala il significato di
abisso, l’ esperienza del senza fondo. Per i greci la realtà originaria è data dal non ente, ovvero il
Caos come spazio aperto e voragine abissale. Gaia è la Terra, una grande distesa sconfinata,
dimora di tutti gli uomini. Gaia dall’ampio petto, Gaia eterna e indefinita, immensa tanto da
apparire senza fine. Ella è il mondo, sede del Tartaro, la regione più profonda posta nei recessi
della terra. Infine, vi è Eros, immortale e primigenio. Egli è il più bello fra gli dei, è forte e potente.
Senza far distinzione fra dei e mortali, egli ne domina il cuore. Pur senza nulla generare, Eros
presiede alla generazione di tutte le future divinità. La Teogonia, narrazione delle origini degli dei,
non dice di una creazione ma ci parla di un venire alla luce, di un apparire a partire da una
Triade composta da entità primigenie. Caos, l’oscura voragine, l’abisso senza fondo, quasi una
crepa aperta nel nulla, è il fondo oscuro da cui appaiono le divinità, gli esseri e gli enti. Da Caos
appaiono gli esseri, le divinità immortali ma generate, nate in modo eccezionale, per il tramite cioè
del loro ex-cedere venendo fuori dall’abisso.
Nei versi 123-138 Esiodo racconta le nascite delle altre entità cosmiche che derivano da Caos e
Gaia. Da Caos si generano Erebo e la Notte; entrambi insieme concepirono Etere e Giorno. Gaia
invece generò Urano, il cielo che l’avvolge; le alte montagne, dimora delle Ninfe e Ponto, il mare,
“senza amore”. Poi, assieme ad Urano, senza amore ancora, creò Oceano, Caio, Crio, Iperone,
Impeto, Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Faibe e Teti; ed infine nacque Crono, il più tremendo.
La Teogonia infatti ci racconta anche che Urano, temendo i propri figli per la loro grande potenza,
decise di sigillarli all’interno di Gaia. Ma Crono si ribellò, evirando il padre con un falcetto: le
gocce di sangue di Urano cadendo sulla terra diedero vita alle potenze di guerra mentre il suo
sesso sprofondò nei flutti di Oceano dalla cui spuma più tardi emergerà Afrodite, dea della
bellezza che presiede all’amplesso.
3
Se la generazione delle entità cosmiche avviene “senza amore”, ciò accade perché tali entità non
nascono per unione ma per separazione di elementi: Caos e Gaia non si accoppiano ma generano
gli elementi cosmici traendoli fuori dal loro fondo oscuro e indistinto. Eros quindi per Esiodo non
è ancora principio dell’unione della coppia, non unisce ma separa e distingue rendendo manifesta,
portandola alla luce, la molteplicità nascosta nell’oscura unità di Kaos.
Se il mito indica in Kaos l’essere primigenio (insieme a Gaia ed Eros) i primi filosofi chiamarono
“fusis” il principio (perciò furono detti “fisiologi”). I latini tradussero fusis con natura dando luogo
secondo M.Heidegger ad un secolare fraintendimento. Heidegger infatti ritiene che fusis “significa:
ciò che sboccia da se stesso, cioè il dispiegarsi aprendosi e in tale dispiegamento fare apparizione,
il tenersi in questo apparire e dimorarvi”. Per il filosofo tedesco fusis è l’essere che dispiegandosi e
aprendosi lascia accadere e manifestare la molteplicità differenziata degli enti che mantiene e
sorregge nella sua apertura. Se ogni cosa ha il suo fondamento nell’essere, fondamento dell’essere
è il fondo abissale che si schiude.
Esiodo aveva chiamato Kaos questo fondo: mi apro, tengo la bocca spalancata alludono con
intensità terrificante all’abisso che si schiude e nel quale si risolve l’essere. Con Heidegger forse
la filosofia ha continuato a pensare ciò che la parola del mito aveva originariamente soltanto
raccontato.
Seconda Giornata
Eros, divinità primigenia secondo Esiodo, potenza che non genera ma promuove ogni generazione,
che ancora non è il Dio degli amplessi e degli accoppiamenti ma presiede alla formazione di un
mondo traendo la molteplicità degli elementi fuori dalla loro indistinta originaria unità, torna dopo
circa quattro secoli in una nuova narrazione mitologica nel Simposio di Platone. Nell’età arcaica il
mito per i greci non era stato un semplice racconto ma una porta che apriva le profondità del
mondo e ne costituiva il senso più alto. Il mito era parola che spiegava e fondava non attraverso i
significati che portava con sé, ma manifestando ogni volta nella ripetizione del racconto la realtà
vissuta che ne costituiva il contenuto. Con la nascita della filosofia la parola del mito viene
soppiantata dal logos, la parola che non racconta la realtà ma la spiega razionalmente. Il mito
tuttavia fu molto importante anche per Platone, il quale dedicò tutta la sua vita alla ricerca della
verità. Il filosofo chiamò la verità “episteme” e indicò nella ragione e nell’esercizio della filosofia
l’unica via per arrivare ad essa. Nel Simposio il mito, come in altri dialoghi, si insinua piano piano
per spiegare tutto ciò che la filosofia e il suo logos non riescono a dire. Il Simposio è ambientato
nel corso d'un banchetto in casa del poeta Agatone, nel 416 a.C. Il dialogo vede Socrate e i suoi
commensali discutere d'amore. Dopo un'introduzione da parte di Fedro e Pausania, il commensale
Erissimaco afferma che esistono due amori, quello "volgare" (amore fisico, soprattutto
eterosessuale, protetto da Afrodìte Pandémia) e quello "celeste" (amore spirituale, omosessuale,
protetto da Afrodìte Urània). Il secondo può e deve avere una connotazione educativa: attraverso
esso l'amante cerca di migliorare l'amato, spingendolo alla virtù. Il commensale Aristofane (il
commediografo) racconta allora un mito burlesco, il celebre "mito dell'andrògino". Un tempo gli
uomini erano divisi in tre sessi: uno maschile/femminile, uno tutto-maschile ed uno tuttofemminile. Gli androgini erano diversi anche nella forma fisica: “era un tutto pieno: la schiena e i
fianchi a cerchio, quattro bracci e quattro gambe, due volti del tutto uguali sul collo cilindrico, e
una sola testa sui due volti…e così quattro orecchie, due sessi e tutto il resto analogamente”
(Platone, Simposio). Per difendersi da un loro assalto, Zeus spaccò in due gli esseri umani: da ciò
ha origine l'amore, che è il desiderio delle due metà di riunirsi nuovamente. Ovviamente coloro
che derivano da un essere "tutto-maschile" o da uno "tutto-femminile" proveranno attrazione per
persone del loro sesso.
“E quando ad alcuno di questi, sia l’amante di fanciulli o altro, avvenga di incontrare la propria
metà, allora restano entrambi così impetuosamente soggiogati dall’amicizia e dall’intimo amore
che non soffrono di restare staccati l’uno dall’altro per così dire nemmeno per poco tempo”.
(Platone, Simposio)
Quando s’incontra l’altra metà, se così può essere definita, si viene soggiogati reciprocamente,
presi da una forza (filia + eros) alla quale non si riesce più a sfuggire. L’uno si attende qualcosa
dall’altro e non sa nemmeno cosa si attende. Così l’amante non è mai quieto e la sua irrequietezza
riempie le temporanee distanze e le attese, rende struggenti le lontananze e il desiderio del
ricongiungimento lasciando sempre inappagato l’innamorato.
4
“E se ad essi, mentre insieme giacciono, apparisse Efesto con i suoi strumenti e chiedesse: “Cos’è
che volete o uomini, voi, l’uno dall’altro? (…) Forse che desiderate soprattutto essere sempre
quanto più possibile una cosa sola l’uno con l’altro (…)?”. (Platone, Simposio)
È Efesto, un dio, a dare nome all’irrequietezza degli amanti dicendola desiderio di essere una sola
cosa l’uno con l’altro. E dove ha origine questo struggente desiderare? Il mito indica la sua
scaturigine nel sentimento della propria incompletezza, nel non sentirsi bastante, nella percezione
di una fondamentale mancanza d’essere per la quale il proprio essere non è avvertito come tutto
l’essere che si è (stati): “A questa brama d’intierezza, al proseguirla, diamo il nome di amore”.
(Platone, Simposio). Ciò che rende straordinariamente moderno il racconto di Aristofane e lo
differenzia dai discorsi di chi lo ha preceduto ma anche dalla successiva cultura medievalecristiana è il fatto che in esso l’amore assume una dimensione particolarissima configurandosi
come aspirazione alla totalità: l’amante non vuole solo il corpo dell’amato perché il
congiungimento fisico con l’altro, e il conseguente piacere che se ne ricava, non basta tuttavia a
fare di due uno perché il corpo non è tutto ciò che si è. L’amante mira dritto all’anima dell’amato.
La brama non è soltanto desiderio, non vive in un ambito esclusivamente psichico, né appartiene
soltanto alle buie fonti istintuali dell’uomo ma coinvolge e sconvolge tutto l’essere perché dell’altro
vuole tutto l’essere.
Per quanto il mito dell’androgino sia soltanto un racconto che sfugge ad ogni possibile verifica
scientifica, la sua “particolarità” richiamò l’attenzione di S. Freud che in esso vide una ipotesi in
grado di dirci qualcosa sulle origini della sessualità.
In “Al di là del principio del piacere”, Freud descrive lo strano gioco di un bambino, Ernst, intento
a lanciare ripetutamente un rocchetto dietro il letto per poi richiamarlo a sé tramite il filo cui era
legato. Alle due azioni più volte reiterate Ernst accompagnava ogni volta le locuzioni “fort” (via) e
“da” (ecco). Freud interpretò il gioco del bambino come la ripetizione di un avvenimento che aveva
suscitato in lui una forte impressione che ora cercava di padroneggiare ripetendolo attivamente
anziché subirlo passivamente. Praticamente, alla sparizione della madre, cui era molto legato,che
andava via, Ernst reagiva agendo sulla stessa, identificata col rocchetto, ora cacciandola ora
facendola riapparire: il bambino così si vendicava della madre affermando quasi di poter fare a
meno di lei e provocandone addirittura la sparizione. Interrogandosi sull’esperienza di Ernst,
Freud ritenne che la ripetizione di un evento, sottraendo un vissuto al suo passato e rendendolo
sempre attuale, al di là delle sensazioni piacevoli o spiacevoli che gli si accompagnano, potrebbe
essere intesa come il risultato di una forza coattiva che ha lo scopo di ristabilire un equilibrio, che
fattori contingenti hanno turbato, riportando così l’individuo ad un precedente stato originario:
all’indietro, la meta finale di questa regressione che caratterizza le pulsioni dell’Io Freud ritenne
dovesse essere lo stato inorganico da cui la vita ha avuto origine. Questo tendere alla morte
avrebbe il senso di raggiungere uno stato in cui è assente ogni possibile tensione. Nel gioco di
Ernst la manipolazione ed il controllo dell’evento traumatico tramite la sua attiva ripetizione
dovrebbero permettere al bambino di scaricare (abreazione) tutta la tensione psichica provocata
dall’allontanamento della madre e ricondurlo ad uno stato anteriore di equilibrio psichico. Se le
pulsioni dell’Io in ultima analisi sembrano essere pulsioni di morte, allora come si spiegano le
pulsioni sessuali? Queste per Freud sono altro rispetto alle pulsioni dell’Io: se queste tendono
verso la morte le prime spingono invece verso la vita poiché la loro meta non è l’anteriore stato
inorganico ma la fusione di due cellule germinali e il prolungamento della loro vita.
Dopo che ebbe luogo la divisione in due dell’androgino “poiché ogni metà desiderava riunirsi
all’altra sua metà, ecco che le due metà si cercavano e si gettavano l’una nelle braccia dell’altra,
bramose di riformare l’uno” (Platone, Simposio).
Anche il mito postula all’origine di una pulsione il bisogno di ristabilire uno stato anteriore: esso
però non coincide con la materia inorganica e non spinge verso la morte ma verso l’altro della
pulsione sessuale, verso l’unione con esso ed il prolungamento della vita, verso l’appagamento del
bisogno di immortalità.
Freud chiamò Eros la pulsione sessuale ed attribuì ad essa il compito di riunire e tenere insieme
le parti della sostanza vivente. Eros sarebbe attivo fin dalle origini della vita ed assume il carattere
di pulsione di vita, in opposizione alla pulsione di morte.
Terza Giornata
La condizione che caratterizza gli amanti nel mito del Simposio è dunque questa: essi sono
bramosi l’uno dell’altro. Gli amanti non sopportano nemmeno per un minuto di essere separati,
aborrono l’assenza e la lontananza come il male peggiore, vogliono per sé come il bene più grande
d’essere sempre avvinghiati all’altro e fusi con questo a formare così un intero e non due. Sia
5
l’amante che cerca l’amato, sia quello che l’ha già trovato, sperimentano questa tensione verso
l’altro come brama. La nostra lingua conosce anche la parola “passione” per dire una cosa simile.
In generale, noi diciamo di avere passione per qualcosa, il cinema o uno sport, la lettura o la
musica, e così noi esprimiamo il nostro amore per questa cosa presentandola come la cosa che
prende la nostra attenzione, che è sempre presente nei nostri pensieri, che occupa uno spazio
importante nella nostra vita e della quale non vorremmo, non riusciremmo, a fare a meno.
Quando proviamo passione per qualcosa noi diventiamo bramosi di essa; così quando la nostra
passione ha come oggetto l’altro che amiamo essa diventa passione amorosa e conferisce all’amore
una intensità che difficilmente potrebbe essere sperimentata in qualche altro ambito della nostra
esistenza. La passione amorosa ci rende dipendenti dall’amato, sprigiona energie impensabili e ci
fa fare cose altrimenti improbabili, ci fa vivere con un chiodo fisso, ci fa sentire al centro del
mondo e sempre nell’occhio del ciclone, mai soddisfatti e paghi, sempre dentro situazioni esaltanti
e, talora, fuori del comune ma, soprattutto, incapaci di decidere di essa: l’amante non può
scegliere se avere o no la sua passione ma ne è vinto e la subisce, quasi una malattia dell’anima
da cui non pensa nemmeno si debba o si possa guarire. Essa ci vuole “pazienti”, capaci di
sopportarla, di reggerla, disposti a farci consumare da essa come la febbre che brucia il corpo
malato del “paziente”. Tanto grande è la forza della passione, tanto grande il suo fascino che lo
stesso Dante consacrò a Paolo ed a Francesca uno dei canti più belli e commoventi dell’Inferno: il
poeta consegna i due amanti al vento che li avvolge e li trascina insieme per l’eternità e così
riconosce nella passione che li ha portati alla rovina la forza irresistibile che ne ha segnato il
destino. Ancora, oltre la vita, gli amanti che non sopportano di vivere lontano l’uno dall’altro
restano quella cosa eccezionale che hanno sentito di essere in vita: un intero.
“Ma cosa sarebbe allora, esclamai, questo Amore? Un mortale? (…) Che è dunque, o Diotima?”.
“Un demone grande, o Socrate. E difatti ogni essere demoniaco sta in mezzo fra il dio e il mortale”
(Platone, Simposio).
Socrate chiede ad una sacerdotessa per sapere di Amore e la risposta della donna lo dice subito
come “un-essere-di mezzo”: Amore non è né dio né mortale, Amore sta in mezzo fra i due e così
unisce l’uomo al divino, è un demone. La risposta di Diotima non coglie una delle tante
caratteristiche di Amore ma soddisfa essenzialmente la richiesta di Socrate e qualifica Amore nella
sua natura. La risposta è perciò essenziale, ci dice cioè sostanzialmente la cosa, e così va intesa
perché nel suo ascolto noi possiamo trovare ciò che l’amore è fondamentalmente.
“E suo padre e sua madre, domandai, chi sono?”, torna a chiedere Socrate. Stavolta Diotima
racconta:
“quando nacque Afrodite gli dei tennero un banchetto, e fra gli altri anche Poro (Espediente) figlio
di Metidea (Sagacia). Ora, quando ebbero finito, arrivò Penia (Povertà), siccome era stata una gran
festa, per mendicare qualcosa; e si teneva vicino alla porta. Poro intanto, ubriaco di nettare (…)
schiantato dal bere si addormentò. Allora Penia, meditando se, contro le sue miserie, le riuscisse
d’avere un figlio da Poro, gli si sdraiò accanto e rimase incinta di Amore”.
Diotima nomina il padre e la madre di Eros mentre ce ne racconta le origini. Così facendo Diotima
ne prefigura la natura necessaria: Eros viene concepito nello stesso giorno in cui è nata Afrodite, è
stato voluto con l’inganno e il suo concepimento è stato favorito dal nettare, nasce da due esseri
estremamente diversi fra di loro. Per questa ragione va sempre alla ricerca del bello (chè Afrodite è
dea della bellezza) “è sempre povero, ed è molto lontano dall’essere delicato e bello, come pensano
in molti, ma anzi è duro, squallido, scalzo, peregrino, uso a dormire nudo e frusto per terra, sulle
soglie delle case e per le strade, le notti all’addiaccio” (chè è figlio di Penia ed ha sempre la miseria
in casa).
Eros non è “come pensano in molti”. Ci capita infatti di incontrarlo per strada disorientato e
timido, umiliato e mortificato, esposto alle intemperie di un tempo che lo affligge. Spaesato, Eros
vaga lontano dall’amato che lo respinge o alla ricerca dell’amato che non ha mai conosciuto:
mendico, chiede al passante il conforto e la consolazione di chi si sente infelice e il più disgraziato
fra gli uomini. Nessun balsamo riesce a lenire il dolore di un amore perduto, o di un amore
tradito, o di un amore che non è sicuro di sé, o di un amore che non si riesce a vivere e del quale
però non si sa fare a meno. Eros non è sempre bello e sempre felice, sempre devoto e fedele: sa
essere duro e distruttivo, è capace di mentire, inganna chi gli ha giurato amore eterno, a volte è
superficiale e non conosce il suo guadagno, né riconosce la sua perdita.
6
I più pensano ad Eros come l’amore che vorrebbero e cercano nell’amore dei loro giorni il loro
ideale d’amore che non conosce povertà e incertezze, che non esita e non muta.
“Ma da parte del padre è insidiatore dei belli e dei nobili, audace e risoluto, cacciatore tremendo,
sempre a escogitare machiavelli d’ogni tipo e curiosissimo d’intendere, ricco di trappole, intento
tutta la vita a filosofare, e terribile ciurmatore, stregone e sofista. E sortì una natura né immortale
né mortale, ma a volte, se gli va dritta, fiorisce e vive nello stesso giorno, a volte invece muore e
poi risuscita, grazie alla natura del padre; ciò che acquista sempre gli scorre via dalle mani, così
che amore non è mai né povero né ricco”.
(Platone, Simposio)
Amore fiorisce e vive nello stesso giorno, muore, risuscita. Esso è la vita che mai si arresta e come
essa rinnova il ciclo delle nascite e delle morti: non lo possediamo, ci trova e resta con noi, e poi
se ne va e quindi ritorna. Non possiamo comandargli niente ma solo restare disponibili alle sue
vicissitudini e aperti ai suoi ritorni. Eros è sempre sulla via, sempre intento a filosofare, curioso di
sapere; abile incantatore ci ammalia con le sue stregonerie e ci seduce con la parola.
- “Anche fra sapienza e ignoranza si trova a mezza strada, e per questa ragione nessuno degli dei è
filosofo o desidera diventare sapiente (chè lo è già), né chi è già sapiente s’applica alla filosofia.
D’altra parte, neppure gli ignoranti si danno a filosofare né aspirano a diventar saggi (…) che chi
non è né nobile né saggio crede d’aver tutto a sufficienza”.
- “Chi sono allora, o Diotima, replicai, quelli che s’applicano alla filosofia se escludi i sapienti e gli
ignoranti”.
- “Ma lo vedrebbe anche un bambino, rispose, che sono quelli a mezza strada fra i due, e che
Amore è uno di questi. Poiché appunto la sapienza lo è delle cose più belle e Amore è amore del
bello (…)”.
(Platone, Simposio)
Eros è un essere di mezzo, essenzialmente e per necessità. Il suo posto è a metà strada fra gli dei
e gli uomini e partecipa della natura di entrambi non essendo però né uomo né dio. D’altra parte
non è né povero né ricco ma partecipa della natura della madre (Penia-Povertà) e del padre (Porol’Espediente) per la qual cosa con coraggio e audacia è cacciatore e acquisto ma nello stesso
tempo non sa conservare il suo guadagno e tutto gli scivola via dalle mani. Eros non è bello ma è
insidiatore di belli, non possiede la bellezza ma sa procacciarsela con sofismi e tranelli d’ogni tipo.
Anche fra sapienza ed ignoranza Eros occupa una posizione mediana che lo fa essere, al di là di
ogni metafora, sempre a metà strada, in mezzo lì per la strada come colui che è sempre sulla via,
pronto per il suo viaggio, sempre alla ricerca, chè Amore non è mai pago, non si acquieta a lungo
e in lui sempre torna l’inquietudine che lo rimette in cammino. Eros è sempre tratto nelle
lontananze perché sempre mancante e bramoso, mai abbastanza ricco né del tutto povero, non
ignorante ma consapevole di non sapere abbastanza e quindi sempre “curiosissimo d’intendere
[…] intento tutta la vita a filosofare”.
Se allora Eros è filosofo, la filosofia non avrà anch’essa un carattere erotico e demoniaco? E
quindi, se Eros è a metà strada fra dei e uomini alla filosofia si dovrà riconoscere un ruolo
mediatore rispetto alla sapienza divina la quale tutto sa e quindi non si dedica alla filosofia non
essendoci nulla che ancora deve sapere. Inoltre, se Eros è filosofo e amante del bello allora l’amore
per il sapere del filosofo dovrà in qualche modo essere collegato al bello. Alla contemplazione ed
alla comprensione delle più alte e delle più profonde verità non ci porta quindi solo il Logos. Per
Platone si tratta di un’impresa così grandiosa che il solo pensiero non può bastare ma tutto il
proprio essere deve essere mobilitato: la logica, il ragionamento, la razionalità, ma anche l’amore,
la bellezza, l’entusiasmo. Nel grande progetto della conoscenza Platone coinvolge tutte le
componenti della natura umana e ci dice una cosa sicuramente sorprendente: il pensiero umano
non può essere ridotto solo alla sua componente razionale ma è molto di più. Il di più allude alla
sfera erotica ed emozionale e ci seduce alla possibilità che essa possa essere pensata addirittura
come il fondo misterioso ed “irrazionale” da cui emerge quello straordinario fenomeno che è il
pensiero.
7
IV Giornata
Durante il primo degli incontri riservati all’amore in letteratura, abbiamo proceduto svuotando
preliminarmente la parola amore e le sue mille declinazioni di significato, per cercare di osservare
con occhi nuovi e ingenui come nelle immagini della letteratura essa venisse riempita di un
contenuto preciso e allo stesso tempo mobile e variabile.
Abbiamo iniziato seguendo la bussola offerta dagli antichi miti pagani, greci e romani, nella
rielaborazione poetica di Ovidio. Nelle sue Metamorfosi le figure di Dafne e Apollo, Orfeo ed
Euridice e infine Narciso ci hanno offerto una prima guida nel nostro tentativo di costruire un
piccolo dizionario dell’eros nella letteratura occidentale. Così abbiamo tentato di riempire
nuovamente di significato la parola amore, osservando le diverse sfaccettature di cui è ricca.
Abbiamo osservato la descrizione che Ovidio fa dell’amore in tre declinazioni precise:
I.
II.
III.
L’amore non corrisposto, sorto come vendetta del dio Cupido contro
un altro dio, nella storia di Apollo e Dafne;
L’amore imperituro e tenace di Orfeo ed Euridice, una coppia di
sposi, il cui sentimento si spinge sin oltre la barriera insormontabile,
per Orfeo, della morte;
L’amore ossessivo e solitario di Narciso per se stesso
Ciascuno di questi miti ci ha mostrato un volto complesso, una volta osservato da vicino nella
trasposizione poetica offerta da Ovidio. Ogni coppia, compresa quella ‘solitaria’ di Narciso, ha
rivelato un volto nuovo e imprevisto. Così Apollo e Dafne ci hanno raccontato dell’amore rapinoso
e irrefrenabile di un Dio, che può tutto ed è l’emblema della sapienza razionale (Dio protettore
della scienza e della medicina) e che tuttavia soccombe alla ferita d’amore del dio-bambino,
impertinente e terribile nella sua giocosa irrazionalità, Cupido. Apollo, simbolo del controllo
razionale delle passioni, diviene un animale mosso da un desiderio d’amore istintivo e
incontrollabile, che deve però piegarsi al rifiuto irremovibile di Dafne, la preda cacciata dal Dio.
Orfeo ed Euridice, sposi felici separati dalla morte della donna, rappresentano il simbolo
dell’amore fedele che si lancia irrazionalmente, e con un desiderio inconsolabile venato di
angoscia e malinconia, contro l’ostacolo invincibile della morte fisica. Sono la celebrazione e
l’emblema dell’amore eterno. Eppure, osservati più da vicino, sulla scorta anche di altre
rivisitazioni moderne del mito ovidiano, essi non cessano di stupirci: il mito di Orfeo ed Euridice
contiene anche un altro volto, più segreto e imprevisto. Narra del desiderio univoco e, a suo modo,
anch’esso solitario di Orfeo: è solo sua la voce del desiderio che parla nel mito, Euridice è ridotta a
larva, ombra che si piega al volere del marito e lo segue nel suo sogno di riportarla in vita. Amore
eterno, dunque, ma che porta in sé le tracce incancellabili di una cultura maschilista come quella
antica, in cui il desiderio che può essere pronunciato ed è legittimo è sempre quello dell’uomo.
Narciso, infine, ci ha permesso di spingerci verso i territori più moderni dell’amore, o meglio di
quella patologia d’amore che da lui prende il nome. Eppure anche il mito di Narciso, ad una
lettura più attenta, ha rivelato significati complessi che rendono il destino del fanciullo solitario
più complesso di quanto non ci si aspetti. Il giovane che verrà pietosamente trasformato in fiore, il
Narciso, vive due diverse storie d’amore. Prima quella con la ninfa Eco che, rifiutata e disprezzata
dal giovinetto, per consunzione si trasforma in pura voce. Del suo corpo, rifiutato da Narciso, non
rimane nulla: deperisce, si consuma fino a sparire. Di lei rimane solo la voce, che per l’eternità
non potrà fare altro che ripetere il suono delle parole di altri. In Eco, dunque, il desiderio d’amore
viene posto sotto scacco, e appare schiavo di un altro desiderio, che la rifiuta. Il corpo scomparso,
la voce che può solo ripetere suoni non suoi rappresentano un desiderio che ha rinunciato a tutto
nel tentativo, fallito e impossibile, di farsi altro, di congiungersi con l’amato fino a divenire una
sola cosa con lui. Negato questo possibile esito felice del suo amore, ad Eco non ne rimane che
una copia distorta: non ha più una sua identità, l’amore l’ha letteralmente svuotata.
Il destino di Eco anticipa quello di Narciso. Ingannato dalla sua immagine riflessa su uno
specchio d’acqua, il giovane si innamora perdutamente di se stesso. Eppure, nonostante gli indizi,
non comprende che quella non è altro che la sua immagine.
La malattia d’amore procede inesorabilmente in lui: desidera ardentemente, spera, immagina un
esito felice, poi, alla fine, si dispera. Anche dopo aver compreso che quella immagine non ha una
realtà autonoma da sé, non è in grado di staccarsi dallo specchio. Ha compreso l’inganno; ma
amore, ormai entrato in lui tramite gli occhi, procede per una via che non è quella della ragione.
L’interpretazione che Plotino ha dato di questo mito ci ha poi riportato nei territori dell’idea
platonica dell’amore. Per Plotino, che stravolge il mito immaginando che Narciso muoia annegato
8
nell’acqua nel tentativo folle di unirsi alla sua immagine riflessa, il fanciullo diventa simbolo
dell’amante e di ogni uomo. Di fronte a lui si aprono due strade: quella che porta in basso, verso
l’abisso dell’autodistruzione e del nulla che è la materia bruta, qualora scelga di fermarsi
all’apparenza puramente sensibile dei corpi; quella che porta in alto, verso l’uno e il bene, qualora
comprenda che la bellezza fisica che seduce è il primo gradino di una scala che, percorsa nella
direzione corretta (dal bello fisico oltre questo stesso e verso il bene e l’Uno), conduce al sommo
bene:
“Colui che può vada dunque e la segua [la bellezza] nella sua interiorità abbandonando la visione
degli occhi e non si rivolga verso lo splendore dei corpi come prima. È necessario infatti che colui
che vede la bellezza dei corpi non corra ad essi, ma sappia che essi sono immagini e tracce e
ombre e fugga verso quella Bellezza di cui essi sono immagini. Se si corresse loro incontro per
afferrarli come fossero realtà, si sarebbe simili a colui che volle afferrare la sua bella immagine
riflessa sull’acqua – come una favola, mi pare, vuol dimostrarci – ed essendosi piegato troppo
verso la corrente profonda disparve: nello stesso modo colui che tende alle bellezze corporee, non
col corpo, ma con l’anima, piomberà nelle profondità tenebrose e orribili per l’intelligenza e
soggiornerà nell’Ade, cieco compagno delle ombre. Fuggiamo dunque verso la cara patria, questo è
il consiglio più vero che si possa dare”
(Plotino, Enneadi, I 6, 7-8)
Quinta Giornata
Durante il quinto incontro abbiamo esaminato brani tratti dall’Eneide di Virgilio, dalle Confessioni
di Agostino e dal Nuovo Testamento (Giovanni, I Lettera). Nel primo dei brani virgiliani (Eneide, lib.
IV, 9-29) incontriamo Didone ed Enea, figlio di Venere, la dea della bellezza fisica e della
seduzione che si esprime attraverso la voluptas (il piacere), e Anchise. Cupido, inviato dalla madre
Venere, scaglia delle frecce a Didone la quale si innamora di Enea. Didone era moglie di Sicheo,
ma rimasta vedova per la morte del marito, e nella mitografia letteraria rappresenta un celebre
caso di follia d’amore. Didone, angustiata dal desiderio che sente nascere per Enea, e ancora
legata al ricordo di Sicheo, cerca il conforto della sorella Anna, la quale le consiglia di amare Enea
nonostante Didone avesse in cuore ancora l’amore per il marito. Nel dialogo tra le sorelle si
capisce che l’amore per Enea non cancella il primo amore ma si sovrappone ad esso. Infatti
Didone capisce di essersi innamorata di Enea perché riconosce i sintomi del vecchio amore
(vestigia veteris flammae). Il nuovo amore segue le tracce dell’antico, e su questo sembra
inizialmente modellarsi. Da parte sua, Enea, nonostante sappia del sentimento della regina nei
suoi confronti, decide di partire per il Lazio, e dunque di abbandonare Didone alla sua sorte.
Appresa la notizia della partenza del suo amato, Didone prepara i riti e il letto funebre e si trafigge
con una spada, prima di riversarsi sulla catasta di legno pronta per il rito funebre; così la trova la
sorella, la quale, compreso che quel letto era per lei, la colloca pietosamente sopra e le dà fuoco.
Nel secondo brano virgiliano (Eneide, lib. V, 1-7) vi è la descrizione di Enea che si allontana da
Cartagine, salpata la nave dei troiani superstiti. Con lo sguardo rivolto indietro verso quella che
avrebbe potuto essere la sua nuova patria, Enea vede levarsi dalle cima del palazzo regale delle
lugubri fiamme; nonostante ignori che quelle siano le fiamme della pira funebre di Didone, una
vena di malinconica angoscia gli si insinua dentro. Qualcosa in lui gli morde la coscienza e, ignaro
della causa delle fiamme, intuitivamente le collega a quell’amore che non ha voluto concedere alla
regina.
I due amanti, Enea e Didone, diventano ben presto emblemi della follia d’amore da una parte
(Didone) e della crudeltà dell’amante (Enea) dall’altra. Generazioni di lettori sarebbero stati
educati alla varia e contraddittoria fenomenologia della passione amorosa proprio leggendo quegli
episodi virgiliani. Finché, in piena era cristiana, un geniale lettore non avrebbe dato, di Enea e
Didone, una nuova interpretazione. Piuttosto che esaltare la nobile tragicità del loro amore,
Agostino vede nel luttuoso amore di Didone per Enea un ammonimento che il lettore cristiano
deve bene interpretare. Nel primo libro delle Confessioni, Agostino parla della sua propria vita
come un viaggio verso se stesso, uno sprofondare dentro il proprio cuore per arrivare a Dio . Egli
racconta come, giovane studente, si innamorò della storia di Enea e Didone, e cercasse allora di
imitare la grandezza di quegli eroi letterari. Diventato adulto e scoperto il Dio cristiano, egli muta
il suo giudizio di un tempo, e pensa che la letteratura erotica, i cui emblemi sono per lui Enea e
Didone, sia pericolosa perché chi si appassiona a queste storie, e cerca magari di imitarle,
trascura e dimentica la vera natura dell’amore. Questo, per Agostino, è sentimento rivolto
all’unico oggetto degno di amore, ovverosia Dio stesso. Dio, il vero amato, deve essere cercato
9
nell’interiore rifugio dell’uomo, nella sua anima, e non nei beni esteriori. L’inganno di Enea e
Didone diventa, per Agostino, il medesimo di quello che perse Narciso: Didone, e quei lettori che
ne imitano rapiti le gesta e la logica, scambia un’altra creatura terrena, simile a sé e mortale, per
un Dio degno di essere amato.
Le Confessioni possono essere intese come una autobiografia perché Agostino parla della sua vita
confessandosi a Dio e in questo modo usa il racconto autobiografico come uno specchio nel quale
osservarsi. Ma, a differenza di Narciso che sbaglia nel credere l’immagine riflessa dotata di una
propria individualità, Agostino non annega nello specchio delle Confessioni e, riprendendo
l’interpretazione che Plotino aveva dato del mito di Narciso, si serve di quello specchio per risalire
a Dio. In interiore homine: nella parte più interna, intima di noi stessi, scrive Agostino, si nasconde
il vero Altro, Dio. Così Agostino poteva definire l’amore verso l’altro uomo come un mezzo per
raggiungere l’ultimo fine: ovvero l’amore per Dio.
Nella prima lettera di Giovanni si analizza il rapporto tra Dio e le creature dal punto di vista
dell’amore. Il rapporto di Dio con le creature va visto come un legame tra amante e colui che è
amato. Giovanni non usa metafore spaziali, ma solo temporali. Ciò che viene prima, Dio, dà vita.
Dio ha amato per primo e ha dato origine, quindi, al legame amoroso con le creature. Quindi l’atto
del creare è qui inteso come atto d’amore, ovvero Dio in quanto amore non può fare altro che
creare il suo oggetto d’amore. Dio ama per primo e l’uomo non può fare altro che ricambiare. Dio
in questa logica è perfezione e infatti l’amore di Dio non è definito come Eros ma come Agape.
Questa è l’opposto di Eros perché Eros è un vuoto, è il desiderio di avere qualcosa che non si ha,
mentre Agape è caritas, donare qualcosa che si ha. Sebbene da un punto di vista logico-filosofico
la spiegazione dell’amore come caritas data da Giovanni sia ambigua e contraddittoria, in essa
rivive la grande tradizione neoplatonica di amore come una sorta di eccesso di essere che ha
bisogno di espandersi. La creazione in questo universo appare come un atto di amore
sovrabbondante, di ricchezza eccedente ogni limite, e dono è la parola che meglio ne esprime
l’essenza.
Sesta Giornata
Infine, il nostro dialogo si è concluso ragionando su due testi celebri: un brano dei vangeli
(Matteo 22.34) e il quinto canto della Commedia dantesca. Nel primo dei brani, Gesù riassume i
dieci comandamenti mosaici in due, integrandoli sotto il concetto di amore inteso come Agape. I
due comandamenti che racchiudono tutto sono: «amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con
tutta la tua anima e con tutta la tua mente», definito questo come il più grande e il primo dei
comandamenti, e «amerai il prossimo tuo come te stesso». Gesù li definisce anche come simili
l’uno con l’altro. Ma in realtà essi non sono simili. Anche se in entrambi ricorre il verbo amare,
essi esprimono due concetti collegati ma distinti. Nel secondo dei due, innanzi tutto, non si parla
di amore narcisistico («come te stesso»). Amare l’altro come se stesso significa amarlo come
l’uomo giusto ama la parte più nobile di sé, ossia l’anima che, come avrebbe detto Agostino secoli
dopo, è la scintilla divina presente nell’uomo. Amare la parte più nobile, cioè l’anima, vuol dire
amare il creatore, perché amando la creatura si ama il creatore, ma significa anche ritrovare
nell’altro la stessa scintilla che c’è in noi, quindi amare anche noi stessi, amare l’umano. Nella
versione latina del testo biblico non si usa il verbo amo ma diligo, che segnala la scelta di un
oggetto che prevale sugli altri: si ama ciò che è degno di essere amato. Riassumendo, l’amore può
essere visto in due modi diversi: amore inteso come caritas o come passione che travolge, eros.
Ed è ovvio che nella Bibbia si usi il verbo diligo anziché amo, perché si tratta di due concezioni
d’amore totalmente diverse. In poche parole, l’oggetto d’amore più alto è Dio; si devono amare gli
altri non perdendosi, come Narciso, in uno specchio che rimanda semplicemente l’immagine di
una creatura mortale, ma, al contrario, si deve cercare nell’altro, e in se stessi, quell’elemento
comune che rende simili gli uomini tra di loro e a Dio. Quindi, il precetto di Cristo non invita ad
amare semplicemente l’altro con la stessa cura e affezione che rivolgiamo naturalmente a noi
stessi, l’amor proprio egoistico, ma insegna a cercare nell’immagine dell’altro ciò che lo rende
simile a noi e al creatore. Amare non è quindi possedere, in questo caso, ma scavare nella parte
più profonda dell’anima fino a scoprire l’identità imprevista che ci lega all’altro.
Nel quinto canto dell’Inferno, Dante narra la storia di Paolo e Francesca. Costoro sono due
personaggi esistiti realmente, giovani rampolli di famiglie nobili e conosciute al tempo di Dante.
Nel canto parla solo Francesca, Paolo si limita a piangere rimanendole accanto. Francesca,
tuttavia, parla spesso al plurale: sebbene la voce sia solo una, la donna parla a nome di entrambi
gli amanti. Francesca narra che è stato Paolo per primo ad amarla, e che lei non poteva fare altro
che ricambiare il suo amore. Nelle sue parole l’amore viene definito come una forza alla quale non
10
si può resistere; definendo così l’amore, si capisce che Francesca tenta, agli occhi di Dante, di
discolparsi.
L’amore peccaminoso fra Paolo e Francesca è però, nel suo nucleo più essenziale, causato
dall’errore che sorge quando si scambia il mondo dell’immaginazione letteraria con la realtà. Essi
peccano nel momento in cui si immedesimano a tal punto nella storia di Lancillotto e Ginevra,
che stanno leggendo insieme, da volerla replicare nella loro vita.
La lussuria, smodato abbandonarsi alla passione, sembra l’effetto di una lettura errata. Non è la
cattiva letteratura a perdere i due amanti-lettori secondo Dante. Al contrario, cattivo lettore,
come Paolo e Francesca, è chi non riesce a salvare la cattiva letteratura. Paolo e Francesca
peccano perché interpretano male il testo che leggono (il Romanzo di Lancillotto).
Francesca, nel suo discorso, coniuga i verbi e accorda i pronomi dell’azione adulterina sempre al
plurale. Una coppia indivisibile, anche grammaticalmente: leggiavamo, eravamo, ci sospinse,
scolorocci, ci vinse, leggemmo, non vi leggemmo (Inferno, V 127-38). La prima persona plurale non
segnala soltanto la complicità, indica pure l’inizio della tragedia, la “prima radice” del male
(Inferno, V 124): chiudersi in un amore assoluto, plurale e allo stesso tempo solitario, che esclude
tutto il resto della società umana. Ed esclude soprattutto il sommo bene, Dio. Il plurale ossessivo
di Francesca, così come il muto singhiozzo di Paolo che lo completa, sono indizi chiari di idolatria
amorosa. I vizi della superbia e dell’idolatria narcisistica sono entrambi presenti nel peccato di
lussuria. In qualche modo sono presenti anche nella pena dei lussuriosi. All’inizio del regno
infernale Dante aveva incontrato una porta parlante. Questa, istoriata di “parole di colore
oscuro”, intimava al pellegrino di abbandonare la speranza (Inferno, III 9). La porta anticipava,
sotto forma di insegna, la condizione del regno sotterraneo: assenza definitiva di speranza, cioè di
salvezza, per i dannati. La legge è ripetuta anche qui, “nulla speranza li conforta mai,/non che di
posa, ma di minor pena” (Inferno, V 44-5). Francesca prova a Dante cosa significhi questo per
un’anima dannata. L’assenza di speranza si traduce per lei in una pena supplementare. Quella
speranza di “minor pena” che è il dimenticare non può qui esistere. A lei è negato anche il sollievo
dell’oblio: “Nessun maggior dolore/che ricordarsi del tempo felice/ne la miseria” (Inferno V 121-3).
L’angoscia nasce dal sapere che insieme alla speranza di salvezza è negata la speranza dell’oblio.
L’immagine dell’amante, idolatrata in vita, adesso è diventata una parte della pena perché è
impossibile dimenticarla. Francesca è dunque costretta al ricordo perché incalzata dal pellegrino,
che vuole conoscere il «che» e il «come» della colpa (Inferno, V 119). Allontanatosi Dante per
proseguire il viaggio, e ripresa la bufera infernale, Francesca non avrà più occasione di
ripercorrere i dolorosi sentieri della memoria, e spargere così il sale della felicità passata e
perduta sulle ferite dell’eterno presente infernale. Forse, ripartito Dante, vorremmo augurarle che
in futuro nessun viaggiatore pietoso possa mai più costringerla ad aumentare la sofferenza con il
ricordo. Invece, ripresa la bufera e di nuovo soli, i cognati torneranno a fare coppia nella lunga
schiera di anime lussuriose del secondo cerchio.
Trascinati dalla tempesta in ogni direzione, di tanto in tanto capiterà anche che i due, avvinti
come li aveva visti Dante, incrocino lo sguardo, faccia a faccia. In quel momento, come sulla
superficie di uno specchio, Paolo e Francesca si riconosceranno e il ricordo della felicità passata,
eterno come la bufera, tornerà vivido. Il viso dell’altro, come uno specchio che aumenta la pena
col ricordo incancellabile del peccato, è lo specchio di cui non potranno mai liberarsi (“questi, che
mai da me non fia diviso”, Inferno V 135). Torna qui, nel caso di Paolo e Francesca, una nuova
versione del mito di Narciso, torna lo specchio che inganna e perde chi per troppo tempo vi lascia
correre sopra lo sguardo. Per Francesca l’oblio non è possibile, il ricordo si è trasformato in un
eterno fermo immagine che aumenta la sua sofferenza.
Angoscia, speranza, oblio, ricordo sono dunque le ultime parole del nostro piccolo vocabolario
intorno ai concetti di eros e amicizia, le ultime sulle quali ci siamo confrontati e di cui abbiamo
provato a definire il contenuto, spesso contraddittorio e sfuggente. Ma quello di Dante non è stato
l’ultimo testo, ne abbiamo letto un altro concludendo i nostri incontri: quasi a volere lasciare
l’ultima parola ad un testo che tutti insieme leggevamo e che però, a differenza di quanto
avevamo fatto nel corso dei sei incontri, non avremmo discusso insieme. Quasi un filo comune
che ciascuno dei partecipanti avrebbe poi, a suo modo, provveduto a sbrogliare per conto proprio.
È un brano tratto da Tutto sull’amore. Nuove visioni (2000) di bell hooks, scrittrice americana e
docente di letteratura presso il City College di New York:
“Sulla parete della mia cucina ho appeso quattro istantanee. Sono fotografie di un graffito che
vidi per la prima volta parecchi anni fa sul muro di una casa in costruzione, mentre andavo alla
Yale University, dove allora insegnavo. La scritta, dipinta a colori brillanti, diceva: Anche quando
11
tutto sembra perduto continuiamo ad andare in cerca d’amore. A quell’epoca mi ero separata da
poco da un compagno a cui ero stata legata per quasi quindici anni e mi sentivo sopraffatta da
un dolore profondissimo; mi sembrava che il mio cuore e la mia anima fossero travolti da un
immenso mare di sofferenza. Avevo costantemente la sensazione di essere tirata verso il fondo, di
annegare, e cercavo un appiglio che mi aiutasse a tenermi a galla, che mi riportasse a riva sana e
salva. La frase dipinta su quel muro, con il suo disegno infantile di animali dall’aspetto bizzarro,
mi risollevava sempre il morale. Ogni volta che passavo davanti al cantiere l’affermazione della
possibilità di amare e essere amati che emanava da quella scritta mi ridava speranza”
12