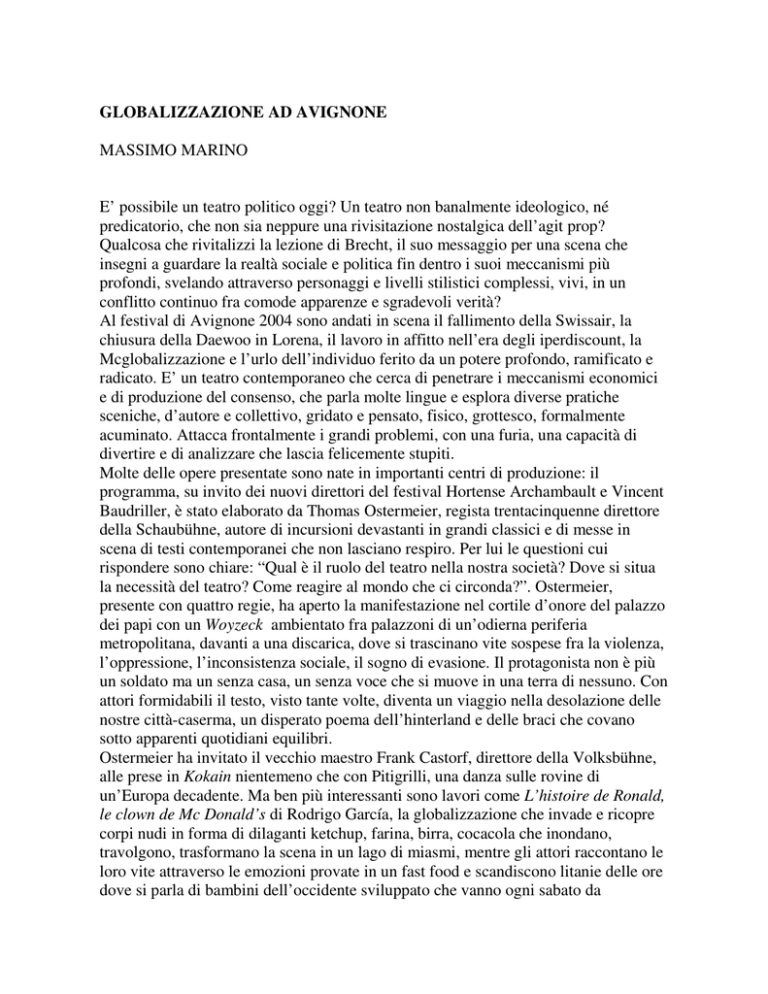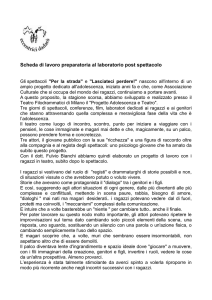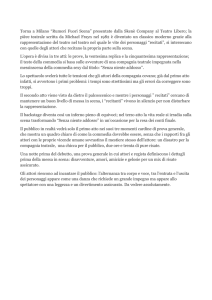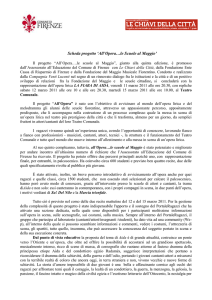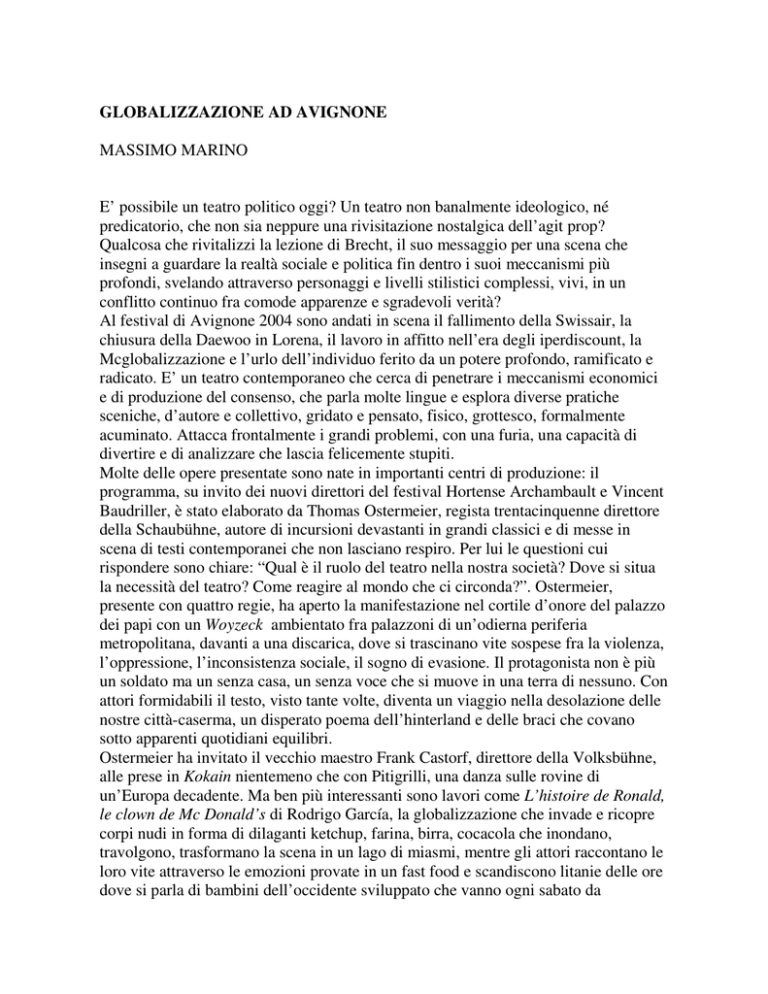
GLOBALIZZAZIONE AD AVIGNONE
MASSIMO MARINO
E’ possibile un teatro politico oggi? Un teatro non banalmente ideologico, né
predicatorio, che non sia neppure una rivisitazione nostalgica dell’agit prop?
Qualcosa che rivitalizzi la lezione di Brecht, il suo messaggio per una scena che
insegni a guardare la realtà sociale e politica fin dentro i suoi meccanismi più
profondi, svelando attraverso personaggi e livelli stilistici complessi, vivi, in un
conflitto continuo fra comode apparenze e sgradevoli verità?
Al festival di Avignone 2004 sono andati in scena il fallimento della Swissair, la
chiusura della Daewoo in Lorena, il lavoro in affitto nell’era degli iperdiscount, la
Mcglobalizzazione e l’urlo dell’individuo ferito da un potere profondo, ramificato e
radicato. E’ un teatro contemporaneo che cerca di penetrare i meccanismi economici
e di produzione del consenso, che parla molte lingue e esplora diverse pratiche
sceniche, d’autore e collettivo, gridato e pensato, fisico, grottesco, formalmente
acuminato. Attacca frontalmente i grandi problemi, con una furia, una capacità di
divertire e di analizzare che lascia felicemente stupiti.
Molte delle opere presentate sono nate in importanti centri di produzione: il
programma, su invito dei nuovi direttori del festival Hortense Archambault e Vincent
Baudriller, è stato elaborato da Thomas Ostermeier, regista trentacinquenne direttore
della Schaubühne, autore di incursioni devastanti in grandi classici e di messe in
scena di testi contemporanei che non lasciano respiro. Per lui le questioni cui
rispondere sono chiare: “Qual è il ruolo del teatro nella nostra società? Dove si situa
la necessità del teatro? Come reagire al mondo che ci circonda?”. Ostermeier,
presente con quattro regie, ha aperto la manifestazione nel cortile d’onore del palazzo
dei papi con un Woyzeck ambientato fra palazzoni di un’odierna periferia
metropolitana, davanti a una discarica, dove si trascinano vite sospese fra la violenza,
l’oppressione, l’inconsistenza sociale, il sogno di evasione. Il protagonista non è più
un soldato ma un senza casa, un senza voce che si muove in una terra di nessuno. Con
attori formidabili il testo, visto tante volte, diventa un viaggio nella desolazione delle
nostre città-caserma, un disperato poema dell’hinterland e delle braci che covano
sotto apparenti quotidiani equilibri.
Ostermeier ha invitato il vecchio maestro Frank Castorf, direttore della Volksbühne,
alle prese in Kokain nientemeno che con Pitigrilli, una danza sulle rovine di
un’Europa decadente. Ma ben più interessanti sono lavori come L’histoire de Ronald,
le clown de Mc Donald’s di Rodrigo García, la globalizzazione che invade e ricopre
corpi nudi in forma di dilaganti ketchup, farina, birra, cocacola che inondano,
travolgono, trasformano la scena in un lago di miasmi, mentre gli attori raccontano le
loro vite attraverso le emozioni provate in un fast food e scandiscono litanie delle ore
dove si parla di bambini dell’occidente sviluppato che vanno ogni sabato da
McDonald’s e di bambini del terzo mondo povero che si vendono come braccia da
lavoro o come oggetti di piacere sessuale per gli abitanti dei paesi ricchi.
Spicca, in questo teatro neo-politico, un monologo come Deux Voix, una magistrale
prova d’attore di Jeroen Willems, con la regia di Johan Simons e del gruppo olandese
ZT Hollandia. Lo spettatore si trova davanti a una tavola ingombra con i resti di un
ricco banchetto: soprattutto bottiglie e bicchieri, pieni, vuoti, semivuoti. Willems
personifica in successione, con una sapienza teatrale vorticosa e controllatissima, i
quattro personaggi di una parte di Petrolio di Pier Paolo Pasolini: il pranzo fra un
dirigente dell’Eni, un agente di collegamento con la mafia, un altro che cura i rapporti
con la chiesa e un intellettuale, rivelando con accenni, piccole trasformazioni fisiche,
leggeri travestimenti, distanza, immedesimazione e ironia, i legami fra i personaggi e
soprattutto fra le loro funzioni di potere. Ma il punto centrale della pièce sono i
discorsi di un ex presidente del consiglio d’amministrazione della Shell, Cor
Herkströter, che racconta con il sorriso sulle labbra la politica di rapina delle
multinazionali nel terzo mondo, la valorizzazione delle peculiarità locali, delle
divisioni per dominare, lavorando per l’avvenire (del profitto) senza curarsi del
cambio di regimi, badando ad assicurare la continuità dello sfruttamento. Parla con
pacatezza suadente di cogliere tutte le occasioni che portano sviluppo, senza
preoccuparsi di altro, enunciando la morale del villaggio globale, confortata dal calo
dell’opposizione conseguente alla caduta del comunismo. E’ il vero burattina io che
muove altri fili di servi o funzionari mediocri e voraci, rappresentati dall’unico attore
con uno scatto fisico, un dettaglio, una mano che entra in un paio di calze di nylon
facendoci vedere uno stupro, un volteggiare dell’intellettuale pronto a se rvire, a
cambiare natura e costume. Un balletto macabro che parte dal grande capitale e gira
intorno al deforme mafioso, che tutti riesce a controllare con una violenza fatta di
sguardi, di controllate assenze, di (metaforiche) prestazioni sessuali umilianti ottenute
con feroce comando. E il tutto è accenno stilizzato, salto fisico, gioco di
trasformazioni.
Pippo Delbono, insieme a Giovanna Marini, a Umberto Orsini, a tantissimi attori e
musicisti, nel suo Urlo, che ha debuttato nelle cave dove nacque il Mahabharata di
Peter Brook, racconta i nervi oscuri del potere, quelli che si diramano fin dentro
ognuno di noi, con un montaggio di immagini danzanti, di voci e suoni che vogliono
colpire fantasia ed emozione, giocando sui ricordi di un tempo passato e sugli orrori
di un presente fatto di oppressione e cancellazione di diversità umane e culturali.
Colpiscono forse più la sfera razionale altri due spettacoli di registi dell’area tedesca,
opere montate in modo collettivo, basate su lunghi processi di improvvisazione, di
una lucidità pungente che cerca di decifrare con rinnovato spirito “brechtiano” il
mondo che ci circonda. Sono spettacoli che tornano a far innamorare del teatro, delle
sue possibilità di conoscenza, della sua capacità di strappare i veli della visione
normalizzata, omologata. Questo è il miglior teatro politico: quello urlato allo
spasimo di René Pollesch, sospeso fra immagine riprodotta, dichiarazioni dirette e
irruzione dei corpi negati nella finzione dell’opera e nella realtà del neoliberi smo, e
quello danzato come un’opera dada che mette in mutande le menzogne del potere di
Christoph Marthaler. Entrambi provano ad affrontare il grande argomento rimosso,
nascosto, del dominio: il denaro, i suoi flussi, gli spostamenti, i rivolgimenti, i
fallimenti e le devastazioni umane che provoca. Le banche e la finanza come nuovo,
lontano, “misterioso” destino. Guardano dentro, sotto la realtà, incidendo e
incrinando i simulacri, trascinando nell’isteria o nella deformazione di un riso feroce,
senza compiacenze o complicità.
Pablo in der Plusfiliale (Pablo all’ipermercato) di René Pollesch, direttore del Prater,
un teatro-studio della Volksbühne, nasconde gli attori alla vista e li rivela solo
attraverso frenetiche riprese video. Chiusi in due carrozzoni danno vita a un surreale
reality show di lavoratori in affitto rinchiusi in un iperdiscount Lidl. Precari, stranieri,
indigeni, donne, uomini, omosessuali, vecchi, giovani, completi di data di scadenza
segnata da un computer sulla loro immagine, tutti si agitano per denunciare, per
sfuggire da una condizione che li inchioda a vendersi, a vendere i corpi,
all’oppressione dell’uomo sulla donna, merci della “nuova economia” che avvelena
ogni relazione sociale, senza scampo. La rabbia, che proclama l’atto terro ristico come
liberatorio, l’isteria di corpi compressi, l’ironica o avvilita rassegnazione irrompono
sul palco con incursioni di attori di formidabile presenza, per poi tornare immagine,
finzione più vera del vero, avviluppante, acida superficie, prestazione totale,
proclama di liberazione che gira a vuoto in uno schermo mentre all’interprete vivo
non resta che ripetere le parole di un allucinatorio, consolante karaoke. Questo
spettacolo chiude una trilogia che fonde la telenovela e la denuncia politica, le
tecniche di ripresa della televisione verità con l’urgenza di liberazione di corpi e
anime dannate dai meccanismi dell’accumulazione.
Groundings (Atterraggi di emergenza) di Christoph Marthaler è un atterraggio
forzato, un varietà corrosivo, una denuncia politica schiumante allegra ferocia. Un
intrattenitore pianista che sembra Groucho Marx: nell’entrare, subito cade. Alcuni
uomini in grisaglia con grandi valigie, in una sala d’aspetto lievemente demodé e
ansiogena concepita da Anna Viebrock. Una insinuante hostess che si trasformerà in
sadica guida di una liquidazione fallimentare e in finale guru di un’evasione mistica.
Sotto i piedi la piantina di Zurigo: bisogna alzarsi i calzoni quando si finisce nel
canale o nel lago; alle spalle la fine della compagnia aerea di bandiera dopo la crisi
seguita all’11 settembre e la brutale chiusura dell’esperienza artistica di Marthaler nel
teatro stabile di Zurigo.
Un gruppo di funzionari, come in Stunde Null o in Spezialisten, è bloccato a terra da
un ritardo. Di trentacinque secondi, annuncia il pianista, poi di dieci ore, di dieci
anni… Il ritardo è il fallimento della Swissair, emblema di puntualità, un coltello nel
cuore del paese della precisione. Uno sgretolamento della fiducia bancaria, un
tentativo di salvataggio, o riciclaggio, rappresentato con balletti e canzoncine
interpretate da clown sbilenchi in abiti da funzionari, con riunioni precarie su quelle
valigie, con confessioni su poltrone che schizzano via sfondando i muri della scena,
mentre gli altri salutano compunti cantando un vecchio coretto della vecchia Svizzera
profonda. Si parla di “nuova economia” con un’ironia che scarnifica: i personaggi
sono costruiti dai fenomenali attori di Marthaler con le caratteristiche dei componenti
del consiglio di amministrazione dello Schauspielhaus di Zurigo, il teatro che lo ha
licenziato con l’accusa di spese eccessive e, soprattutto, di un programma troppo
“avanzato”, che non attirava il pubblico tradizionale.
Un attore invita il pubblico ad alzarsi, a pregare, perché la borsa risalga, perché i
teatri si riempiano... L’etica è il “come” del profitto. La soluzione è decentrare, la
produzione, i teatri, con gli aerei, gli attori, tutti in affitto. La globalizzazione diventa
surreale lezione, defenestrazioni continue, sbracata vigilia notturna con petting
violenti e possessivi. Si trasforma in respirazione d’emergenza ai manichini contenuti
nelle valige, rivestiti con gli abiti degli uomini rottamati, pronti a possederli, a farsi
possedere, in un carnevale macabro, irresistibile, dell’uomo -oggetto. E si chiude sulle
note di Mr. Tamburine man con una fuga in un altro mondo, molto new age, con il
ritorno dei funzionari ai sogni cullanti di quando erano giovani ribelli, un vero e
proprio anticlimax sconsolato e grottesco. Si esce storditi, pensando a chi mai, in
Italia, fra i grandi registi, avrebbe il coraggio di trattare con tanto divertente veleno la
crisi della Fiat e della Parmalat. O almeno quella dell’Alitalia.