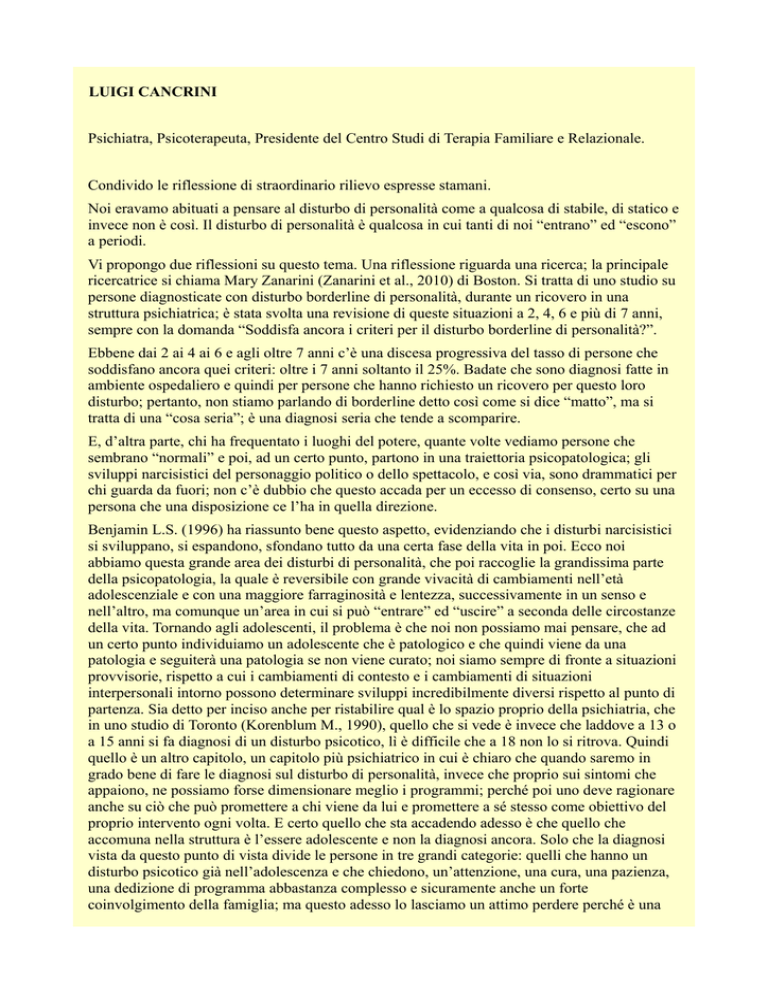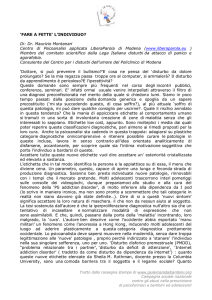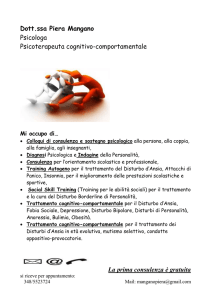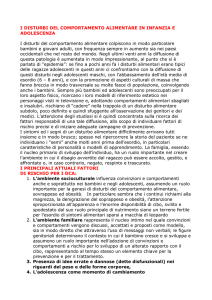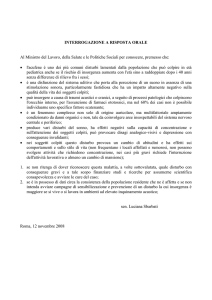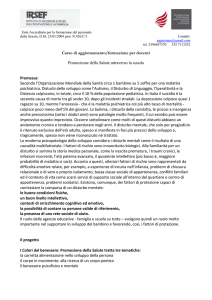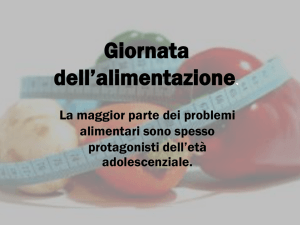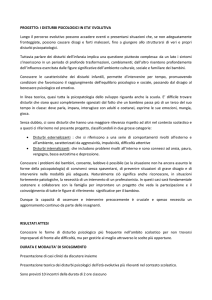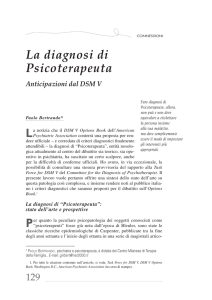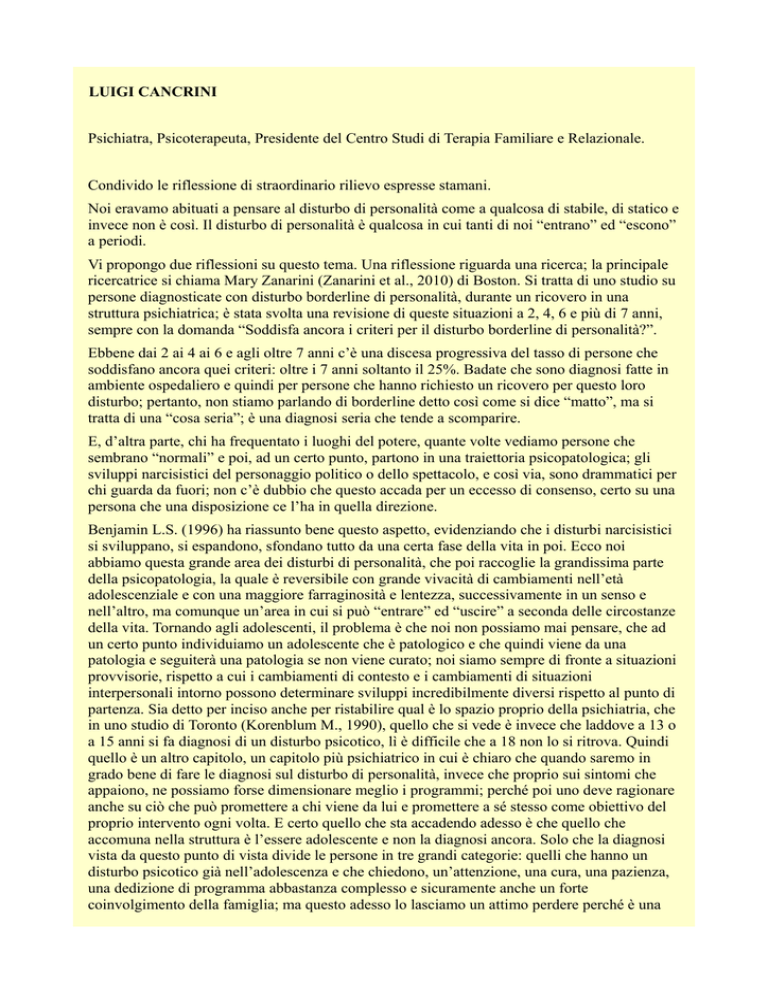
LUIGI CANCRINI
Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
Condivido le riflessione di straordinario rilievo espresse stamani.
Noi eravamo abituati a pensare al disturbo di personalità come a qualcosa di stabile, di statico e
invece non è così. Il disturbo di personalità è qualcosa in cui tanti di noi “entrano” ed “escono”
a periodi.
Vi propongo due riflessioni su questo tema. Una riflessione riguarda una ricerca; la principale
ricercatrice si chiama Mary Zanarini (Zanarini et al., 2010) di Boston. Si tratta di uno studio su
persone diagnosticate con disturbo borderline di personalità, durante un ricovero in una
struttura psichiatrica; è stata svolta una revisione di queste situazioni a 2, 4, 6 e più di 7 anni,
sempre con la domanda “Soddisfa ancora i criteri per il disturbo borderline di personalità?”.
Ebbene dai 2 ai 4 ai 6 e agli oltre 7 anni c’è una discesa progressiva del tasso di persone che
soddisfano ancora quei criteri: oltre i 7 anni soltanto il 25%. Badate che sono diagnosi fatte in
ambiente ospedaliero e quindi per persone che hanno richiesto un ricovero per questo loro
disturbo; pertanto, non stiamo parlando di borderline detto così come si dice “matto”, ma si
tratta di una “cosa seria”; è una diagnosi seria che tende a scomparire.
E, d’altra parte, chi ha frequentato i luoghi del potere, quante volte vediamo persone che
sembrano “normali” e poi, ad un certo punto, partono in una traiettoria psicopatologica; gli
sviluppi narcisistici del personaggio politico o dello spettacolo, e così via, sono drammatici per
chi guarda da fuori; non c’è dubbio che questo accada per un eccesso di consenso, certo su una
persona che una disposizione ce l’ha in quella direzione.
Benjamin L.S. (1996) ha riassunto bene questo aspetto, evidenziando che i disturbi narcisistici
si sviluppano, si espandono, sfondano tutto da una certa fase della vita in poi. Ecco noi
abbiamo questa grande area dei disturbi di personalità, che poi raccoglie la grandissima parte
della psicopatologia, la quale è reversibile con grande vivacità di cambiamenti nell’età
adolescenziale e con una maggiore farraginosità e lentezza, successivamente in un senso e
nell’altro, ma comunque un’area in cui si può “entrare” ed “uscire” a seconda delle circostanze
della vita. Tornando agli adolescenti, il problema è che noi non possiamo mai pensare, che ad
un certo punto individuiamo un adolescente che è patologico e che quindi viene da una
patologia e seguiterà una patologia se non viene curato; noi siamo sempre di fronte a situazioni
provvisorie, rispetto a cui i cambiamenti di contesto e i cambiamenti di situazioni
interpersonali intorno possono determinare sviluppi incredibilmente diversi rispetto al punto di
partenza. Sia detto per inciso anche per ristabilire qual è lo spazio proprio della psichiatria, che
in uno studio di Toronto (Korenblum M., 1990), quello che si vede è invece che laddove a 13 o
a 15 anni si fa diagnosi di un disturbo psicotico, lì è difficile che a 18 non lo si ritrova. Quindi
quello è un altro capitolo, un capitolo più psichiatrico in cui è chiaro che quando saremo in
grado bene di fare le diagnosi sul disturbo di personalità, invece che proprio sui sintomi che
appaiono, ne possiamo forse dimensionare meglio i programmi; perché poi uno deve ragionare
anche su ciò che può promettere a chi viene da lui e promettere a sé stesso come obiettivo del
proprio intervento ogni volta. E certo quello che sta accadendo adesso è che quello che
accomuna nella struttura è l’essere adolescente e non la diagnosi ancora. Solo che la diagnosi
vista da questo punto di vista divide le persone in tre grandi categorie: quelli che hanno un
disturbo psicotico già nell’adolescenza e che chiedono, un’attenzione, una cura, una pazienza,
una dedizione di programma abbastanza complesso e sicuramente anche un forte
coinvolgimento della famiglia; ma questo adesso lo lasciamo un attimo perdere perché è una
parte che non è centrale nel grande numero di persone di cui si è parlato oggi in tutti questi
interventi, anche se a volte spunta anche nelle situazioni del Tribunale, perché certamente la
rottura comportamentale può essere psicotica. La seconda grande categoria è quella delle
persone di cui io ripeto che “entrano” ed “escono” o “entrano” e “possono uscire” che è un
pochino più delicato all’interno di un disturbo di personalità. Vedete, noi dobbiamo avere
ormai una visione della psicopatologia dell’età evolutiva, come giustamente proponeva
Sabatello, in cui le manifestazioni dell’ “entrare” nel disturbo di personalità possono essere a
volte sintomatiche; la grande crisi, che un tempo si chiamava isterica, oppure il disturbo
ossessivo - compulsivo, ma possono essere a volte invece direttamente comportamentali. Cioè
quello che si rivela attraverso la rottura comportamentale, è un disturbo della persona, è uno
che sta male, il ragazzo che fa casino sta male. Questa è una cosa che se noi pensiamo, un
pochino ci aiuta, non è che esiste una differenza tra quello che è cattivo e deve essere
“corretto” e quello che sta male e deve essere “curato”. Una delle manifestazioni dello star
male, che anch’essa va curata, è il comportamento scorretto con tante variazioni, certamente
con tante situazioni complesse, perché sicuramente quello a cui dobbiamo stare molto attenti è
il fatto che questa scorrettezza, illogicità, incoerenza, se volete non eticità, amoralità del
comportamento sia legata ad un disturbo più interno della persona o a qualche cosa di
assimilato all’ambiente per esempio.
In una comunità per minori che, con Saman, abbiamo aperto vicino Foggia, ad Apricena, poco
tempo fa, sui primi 10 ragazzi che sono passati in questo primo anno di attività, ce ne sono
almeno due che hanno un’attività delinquenziale familiare, che sono fonte di sostentamento
criminale per famiglie immerse in una logica di un altro tipo, non rispetto a quella in cui gli
altri invece si trovano. Certamente, il problema è molto più complesso e pone problemi di
ordine vario; insomma, nella rete bisogna dare più importanza all’intervento giudiziario che a
quello psicologico interpersonale, perché è complesso fare un lavoro di terapia familiare in
rapporto con i genitori, se i genitori hanno in mente di portarlo fuori, perché poi gli “serve”.
Questo riguarda tante situazioni in cui bisogna immaginare insieme al ragazzo o ragionando
per lui e, comunque, sempre con lui, se quello di cui ha veramente bisogno è di essere portato
fuori dall’ambiente da cui proviene anche in modo definitivo. Pensate a tutte le baby prostitute
che poi chiedono aiuto, dopo essere state portate in Italia; magari non hanno nemmeno 18 anni,
ma sono un problema serio lo stesso, vanno aiutate a ricostruirsi una vita in ambienti diversi da
quello da cui provengono. Questo è uno dei temi con cui ci si confronta. Però fuori da queste
situazioni il grande problema di questi ragazzi e ragazze è quello di “trovare pace” con i loro
genitori interni, trovando anche un qualche rapporto con quelli che hanno fuori e con quelli
putativi che incontrano nelle varie comunità. Allora, il rapporto con questi ragazzi ha necessità
assoluta di due grandi principi: uno è un principio di ordine, a cui si collega il tema della
responsabilizzazione e uno è un principio di vicinanza e di ascolto che tiene conto del
turbamento profondo che loro si portano dentro. Alloro io dico che l’intervento di comunità è
un intervento continuamente anfibio, di comunità e anche fuori di comunità, in cui bisogna
avere competenze psicoterapeutiche perché sono necessarie per questo ascolto e bisogna avere,
però, anche posizioni e competenze di tipo educativo. Perché guardate, questa è un’illusione
che ho consumato anche io che faccio lo psicoterapeuta ormai da 35 anni: il ragazzo che viene
da te avendo dei comportamenti disordinati e che si lamenta e piange dei genitori, ma rispetto a
cui tu metti in opera solo l’ascolto, è un ragazzo che da te non riceve nessun aiuto. Hai voglia
ad ascoltare ed interpretare, ma non si conclude niente. Si conclude qualcosa quando accanto
all’ascolto, c’è anche la risposta che gli impone di responsabilizzarsi. La responsabilizzazione
nella comunità è un fatto fondamentale di ordine terapeutico. Io credo che sia importante
collegare queste cose a ciò che sappiamo dalla ricerca psicoterapeutica e psicoanalitica in
particolare.
Vedete, Melanie Klein (1932) insisteva molto sul fatto, che le figure parentali introiettate dai
pazienti con problemi di comportamento, di impulsività o, se volete, di antisocialità, sono
figure parentali introiettate estremamente crudeli, estremamente dure contro le quali si esprime
una ribellione continua e totalmente inutile ed autolesiva. Ma c’è uno scontro con un qualcosa
che uno si porta dentro, con una crudeltà che gli è stata inflitta. Nelle ricerche sui disturbi di
personalità, si vede che laddove sono forti le componenti antisociali, è fortissima la
trascuratezza che quel ragazzino ha subito: il neglect, dalla parola inglese, la “trascuratezza”, il
fatto che non si sono accorti delle sue esigenze di base, corrisponde all’antisocialità ed è un
genitore interno estremamente crudele e lontano quello che loro si portano dietro. Allora noi
possiamo ragionevolmente immaginare che quando arrivano in un luogo dove qualcuno li
“ferma” in un modo affettuoso, ma appunto fermo, loro si incontrano e reagiscono in tanti
modi, con un genitore che non è distante, crudele, assurdo come quello che si portano dentro.
Ma loro di questo hanno bisogno, perché al contrario con un atteggiamento troppo vicino,
comprensivo, affettuoso e basato solo su quello, non si risolve niente; perché loro tanto non si
possono fidare e il loro fidarsi passa attraverso la consuetudine con persone che danno loro un
modello di comportamento a cui loro possono appoggiarsi. E’ vero, e Sabatello lo ricordava,
che i disturbi antisociali di personalità sono quelli più difficili da trattare. Noi possiamo dire
che quote antisociali ci sono nella gran parte dei ragazzi di cui stiamo parlando, di cui abbiamo
discusso questa mattina. Più “pura” è l’antisocialità, più evidente e chiara è l’antisocialità, più
difficile è la cura perché quello che è necessario è un tempo lungo per incontrare la persona
dietro questa maschera continuamente beffarda, lontana, distante, aggressiva che fa saltare i
nervi a qualsiasi operatore con tutta la sua pazienza. Però è anche vero che non è un’impresa
impossibile, soprattutto finché sono giovani, finché sono adolescenti. Anche per un
personaggio di Romanzo Criminale di De Cataldo, arrivato a 40 anni, che ha 30 anni di carcere
da scontare, forse non è tanto facile da responsabilizzare, non è così semplice, e pertanto
bisogna immaginare un carico maggiore di difficoltà.
Anche se, guardate, io ho fatto per alcuni anni supervisione in un ospedale psichiatrico
giudiziario e posso assicurarvi che c’è molta vita anche lì ! Ma l’antisociale “puro”
difficilmente va in OPG, l’antisociale “puro” finisce magari nel 41bis e in altre di queste
situazioni tutte segnate dalla repressività. Questo è un discorso che ci porterebbe lontano, ci
porta verso la psicologia penitenziaria.
Però è certa una cosa, stiamo parlando di adolescenti; sono storie che possono essere
modificate quando si ha la possibilità di intervenire in adolescenza perché è ancora un
materiale estremamente plastico. Allora noi dobbiamo passare da una cultura della diagnosi, in
cui colui che fa diagnosi è uno che, con i raggi x della sua esperienza e cultura psicopatologica,
fotografa il disturbo di chi ha davanti e quindi dice “questo che sta così, diventerà cosà”, ad
una situazione in cui la diagnosi è una diagnosi funzionale che recita più o meno così “in
questo momento della sua vita, in questo contesto, in questa situazione, in questo equilibrio
complessivo dei suoi rapporti questa persona presenta questi tratti”, ma con tutte queste
specificazioni intorno. Dopodiché la diagnosi reale da che cosa viene fuori, dal confronto fra
questo e quello che accade a quella persona, man mano che i suoi contesti vengono cambiati
dall’azione terapeutica. Noi dobbiamo sapere che quelli che vanno cambiati sono prima i
contesti e poi la persona. La persona deve essere aiutata a vederle le situazioni di mutamento
contestuale, senza averne paura. Deve essere aiutata a fidarsi, e spesso questa è la cosa più
difficile.
Ora vedete su questo punto, ho fatto in tanti anni un’esperienza significativa soprattutto con le
comunità terapeutiche per tossicodipendenti che sono un’esperienza abbastanza straordinaria.
Con Saman, abbiamo cominciato nel ’95 e sono passati tanti anni. L’accordo che io feci con
Saman quando ho cominciato a lavorare con loro, era di affiancare agli educatori dentro
ognuna delle comunità terapeutiche degli psicoterapeuti che avevano un loro referente, in parte
io, in parte altre persone in altre città dove c’è Saman, per avere una supervisione sul loro
lavoro. Avevamo stabilito un principio, che laddove sul programma c’era differenza di idea fra
il responsabile di comunità, quindi il capo educatore, e i referenti terapeutici, quindi gli
psicoterapeuti, ci fosse una mediazione fatta con me come direttore scientifico di Saman.
Avevamo stabilito, in qualche modo, una pari dignità degli psicoterapeuti con i loro
ragionamenti e degli educatori con i loro ragionamenti, che veniva appianata discutendo nelle
situazioni in cui c’era conflitto su come muoversi. Dopodiché abbiamo immaginato un
percorso dove le supervisioni venivano fatte in equipe, cioè tutti insieme da psicoterapeuti
esterni. Adesso 15 anni di lavoro sono tanti, e le risorse psicoterapeutiche degli educatori
tradizionali di Saman sono straordinarie. Loro non hanno fatto psicoterapia, non hanno fatto
una formazione psicoterapeutica, l’hanno imparata discutendo; certamente anche gli
psicoterapeuti, che hanno lavorato con loro, hanno imparato dagli educatori un numero
straordinario di cose che non sapevano. Allora che cos’è il senso di questa cosa? Il senso di
questa cosa è che responsabilizzare progressivamente una persona, mentre la si accoglie
affettuosamente è un’operazione terapeutica di grandissima potenzialità. Nella comunità
accade questo attraverso una dialettica. Perché vedete, può capitare che il responsabile di
comunità dia una punizione perché c’è stata un’infrazione comportamentale, lo psicoterapeuta
che fa, ascolta la reazione alla punizione. L’utente, il ragazzo o la ragazza, va lì e dice
“Quell’educatore mi ha dato questa punizione ingiusta, lui non capisce, non è possibile non
capisce che cos’è per me questo” e fa tutta la sua sparata. Il terapeuta accoglie, ascolta e poi
cerca di restituire un discorso in cui dice “Si, tu hai le tue regioni, ma anche lui ha le sue.
Perché poi c’è qualche cosa che è la cornice, il gruppo, lo stare insieme. Questa è una realtà a
cui in qualche modo anche tu devi riuscire a partecipare e ad andare dentro”. Vedete, si
ricostituisce una situazione di una famiglia in cui l’istanza normativa e l’istanza di
accoglimento e di ascolto possono essere alternativamente giocate di più, dall’uno o dall’altro
dei due genitori, nel rispetto delle regole che vengono date, ma nel rispetto anche del fatto che
non sempre la regola e la sanzione collegata alla regola può essere compresa; sapendo che è
molto più importante che venga compresa, che non il fatto che venga regolarmente obbedita.
Questo, secondo me, è il punto su cui si esercita oggi il principio più forte dell’azione
terapeutica in tutte queste situazioni.
La capacità degli psicoterapeuti di “comprendere” si mette al servizio dell’equipe. Voglio dire
che, alla fine, in una rete che si occupa di un minore, non è importante che ci sia lo
psicoterapeuta del minore, ci deve essere la competenza psicoterapeutica che circola
nell’equipe, che permette di prendere decisioni e posizioni che sono tali da assicurare al minore
quel livello di comprensione, di vicinanza, di sentirsi con che è fondamentale per lui. Molte
volte, secondo me, non è neppure opportuno che il minore abbia un terapeuta fuori dalla
comunità. Io penso che in molti casi quello che è importante è che lo psicoterapeuta faccia
parte dell’equipe che lavora e possa suggerire all’operatore che è più vicino al minore alcune
risposte. Insomma, che ci si trovi in termini di rete ad utilizzare le competenze e il sapere
psicoterapeutico, non a considerare la psicoterapia qualcosa che sta lì e che è uno dei pezzi del
lavoro terapeutico. Se volete, utilizzando un’immagine, la competenza terapeutica dovrebbe
essere un po’ come il sale nella minestra: senza sale non è buona la minestra, non è che uno si
mette a mangiare solo il sale, insomma non è utile mangiare separatamente la minestra e il sale.
Questo è quello che l’esperienza di questi anni mi ha insegnato.
In secondo luogo, quello che è molto importante che si riesca a capire e a riflettere bene, è che
molti degli adolescenti che arrivano al momento della comunità o del centro diurno o altro,
sono adolescenti che hanno anche una famiglia e che questa famiglia resta con i suoi modi di
muoversi, di porsi, nelle diverse situazioni di rapporto con questi adolescenti.
Melanie Klein (1932) ha scritto una cosa bellissima su questo, nella sua psicoanalisi dei
bambini. Una cosa che la faceva sempre riflettere era come, mesi e mesi di lavoro
psicoterapeutico paziente - sapete che lei vedeva i suoi ragazzini anche tre quattro volte a
settimana - a cui hai dedicato tantissimo tempo, tantissima passione, possono essere distrutti in
un attimo da un aggrottarsi degli occhi della madre. Adesso può essere anche comodo, però è
vero… perché, bene o male, questi genitori che sono fuori dalla comunità e che magari loro
vedono solo per poco, restano fondamentali. Allora noi con Saman, anche con persone più
adulte, abbiamo messo come regola di ingaggio, cioè come regola per accettare i pazienti in
comunità, il fatto che la loro famiglia, potremmo usare un linguaggio poliziesco, “si
costituisca” per un lavoro terapeutico; proponiamo l’idea che, mentre loro cambiano in
comunità, anche gli altri cambiano a casa, anche perché sennò a che serve quel cambiamento ?
Ecco su questo ci si può mettere l’accento un po’ più forte, un po’ meno forte a seconda delle
situazioni, però questa è una cosa importante. Noi non possiamo immaginare e su questo i
terapeuti familiari hanno ragione e io lo rivendico con forza, la terapia non può essere
“rimettere a posto”, cioè non è un meccanico a cui dici “ti porto il figlio, facciamo un controllo
e poi me lo ridai così io continuo e vado avanti”. I comportamenti del figlio sono da rivedere
all’interno di sequenze comunicative che lui ha con i familiari più significativi, il papà, la
mamma, i fratelli; quel che sia, ogni volta c’è da rifletterci bene sopra. Allora questa, secondo
me, se la comunità terapeutica la sceglie come regola d’ingaggio, è una cosa molto importante.
Io credo che questo valga anche per quelli che lavorano in contatto con il minorile penale.
Devo dire che oggi, sentendo la Dottoressa Spagnoletti, capisco quanto il lavoro del magistrato
sia difficile, però credo che noi abbiamo un codice penale minorile straordinario, perché è una
cosa bella quella che si può fare con i nostri minori. Penso a quello che succede in altri paesi in
cui non è assolutamente così. Noi abbiamo la possibilità di progettare con il minore con questa
straordinaria “messa alla prova” all’interno della quale si può fare un progetto importante.
Secondo me, non è tanto importante il fatto che la si chiami “limitazione della libertà
personale”, ma se la comunità terapeutica sta dentro a un progetto di messa alla prova in cui si
coinvolgono terapeuticamente i familiari, quando è possibile farlo chiaramente, questo è uno
strumento. Forse alla parola “messa alla prova” dovremmo aggiungere l’idea che si tratta di un
provvedimento finalizzato ad un lavoro terapeutico, cioè un cambiamento della situazione, non
della persona. “Messa alla prova” è una brutta espressione, come dire “vediamo quanto sei
tarato”, ma se si intende “messa alla prova” in termini di “ti diamo un’occasione e lavoriamo
con te affinché questa occasione ti sia utile” diventa anche un termine interessante. Però la
progettualità che al giudice viene suggerita dall’equipe che si occupa della situazione, deve
comprendere una serie di aspetti che sono quelli della terapia di questo ragazzo, che può
prevedere il suo stare in una comunità, che può prevedere il suo frequentare un centro diurno e
deve prevedere anche la sua attività presso una struttura in cui fa un lavoro socialmente utile, la
sua frequenza alla scuola, quel che sia; ma dentro a questo, ci deve essere il lavoro con la
famiglia, altrimenti è difficile che questa persona possa cambiare solo lei; può capitare perché
abbiamo visto che si guarisce spontaneamente in tante situazioni, a volte la paura che uno si è
preso lo fa tornare indietro. Però nelle situazioni un po’ più complesse, l’intervento terapeutico
deve tener conto dei fattori che sono rilevanti per l’equilibrio psicologico e per il recupero della
possibilità e della capacità di crescere. Queste sono le sfide che abbiamo davanti.
Aggiungo una piccola osservazione in merito a ciò che è stato detto oggi dalla dottoressa
Spagnoletti. Io sto facendo un lavoro di supervisione con un gruppo di psicoterapeute che
prepara dei progetti terapeutici per il Tribunale. Consiglio sempre a loro di dire “Io sono il
terapeuta e dico questo, ma quello che decide è il giudice”. Perché penso che il giudice che
decide entro certi limiti, che sono quelli scanditi dalla scrittura della legge; la dottoressa
Spagnoletti l’ha detto benissimo stamattina. Io credo che ci sono tante situazioni in cui i tempi
non coincidono esattamente e allora il ragazzo deve capire che la realtà è questa. La realtà della
vita non è una realtà in cui le cose si accomodano secondo i tuoi tempi. Il giudice decide e “tu
devi adeguarti, anche se la cosa non ti sembra completamente giusta, ne puoi discutere, ma
devi discuterla nelle sedi giuste” e il terapeuta deve aiutare a comprendere che ci sono nella
vita delle realtà a cui ci si deve adattare, cioè il rispetto della norma, dell’istituzione come
anche dei genitori, dei compagni, dell’insegnante, un domani dei datori di lavoro, del
compagno o della compagna. Il rispetto è un qualche cosa che si basa sull’idea per cui, tante
volte, io penso di aver ragione però abbozzo, perché è così; se non sono capace di abbozzare,
non sono capace di vivere; poi c’è sempre il tempo per dire le cose che riteniamo giuste, per
rimettere in discussione. Non si può pensare di avere tutto e subito. Questo tenere, il giudice, il
tribunale, la giustizia, il provvedimento un po’ fuori dal setting terapeutico. Vedere il setting
terapeutico, come un luogo in cui, anche la comunità terapeutica, voglio dire setting
terapeutico, intendo in senso molto lato, si riflette insieme sul fatto che gli esseri umani sono
limitati, che gli errori ci sono, ma che per vivere insieme agli altri come io voglio che gli altri
tollerino i miei errori, a volte lo pretendo perché do le mie spiegazioni, così io debbo tollerare
quello che a me sembra errore nella condotta dell’altro. Questo è un principio educativo
fondamentale: io credo che tutti cerchiamo di insegnarlo ai figli, anche se non sempre… perché
vedo, seguendo le partite di pallone, i genitori che gridano più loro contro gli altri e i ragazzini
che dicono “Papà sta’ buono, mamma sta’ buona, non ti arrabbiare”. Questo si vede anche a
scuola quando i genitori dicono al figlio che meritava un voto più alto di quello dato
dall’insegnante. Insomma è difficile perché i genitori si mantengono adolescenti fino a 50 anni,
vivono attraverso i figli l’adolescenza e tante cose, ma adesso ci perderemmo… Il principio
educativo su cui si fonda la stabilità dell’essere umano e quindi la buona crescita di un
adolescente è questo. Io credo che rispetto ai ragazzi che rischiano di più di deragliare durante
questo percorso di crescita, questo principio diventa più importante e deve essere seguito con
un’attenzione particolare.
Mi avvio alle conclusioni. Il punto è questo: che tutti coloro che si occupano del minore nella
rete debbono avere un’assoluta univocità di atteggiamenti, univocità che si raggiunge al
termine della discussione che non può essere immaginata o presunta “io faccio questo e tu ti
devi adeguare”. Univocità significa che si discute prima, come si faceva in fondo un tempo nel
partito comunista, si discuteva prima e dopo non si usciva fuori con un’altra idea. E’sempre
facile fare l’anima bella che si schiera con il minore contro gli adulti cattivi; ma al minore non
serve questo, serve qualcuno che sta con lui, con la sua sofferenza, con la sua difficoltà che lo
aiuti a trovare la strada per vivere insieme agli altri, perché altrimenti “non ci si fa”.
Io voglio dirvi che sono contento di essere qui, di aver trovato tutta questa gente che lavora in
questo campo, vi assicuro che è qualche cosa davvero di molto nuovo, che io spero che cresca,
perché questa, in fondo, è una missione della nostra generazione; far sì che questo cresca
sempre di più e che diventi qualcosa che viene come risposta a tutti i minori in difficoltà. Credo
che la percentuale non sia ancora vicina al 100%. C’è ancora molto da lavorare, perché tante di
queste esperienze non più pionieristiche - il tempo dei pionieri è finito - ancora non però
sufficientemente diffuse, diano davvero risposte a tutti quelli che ne hanno bisogno.
Grazie
Bibliografia
Benjamin S.L. (1996), Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità, Tr. it. LAS,
Roma, 1999.
Klein, M. (1932), Psicoanalisi di bambini, Tr. it. Martinelli, Firenze, 1969.
Korenblum M., Personality status: changes through Adolescente, in Psychiatric Clinic of North America,
vol. 13(3) 389-399, 1990.
Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB, Fitzmaurice G: Time to attainment of recovery from borderline
personality disorder and stability of recovery: a 10-year prospective follow-up study, American Journal Psychi