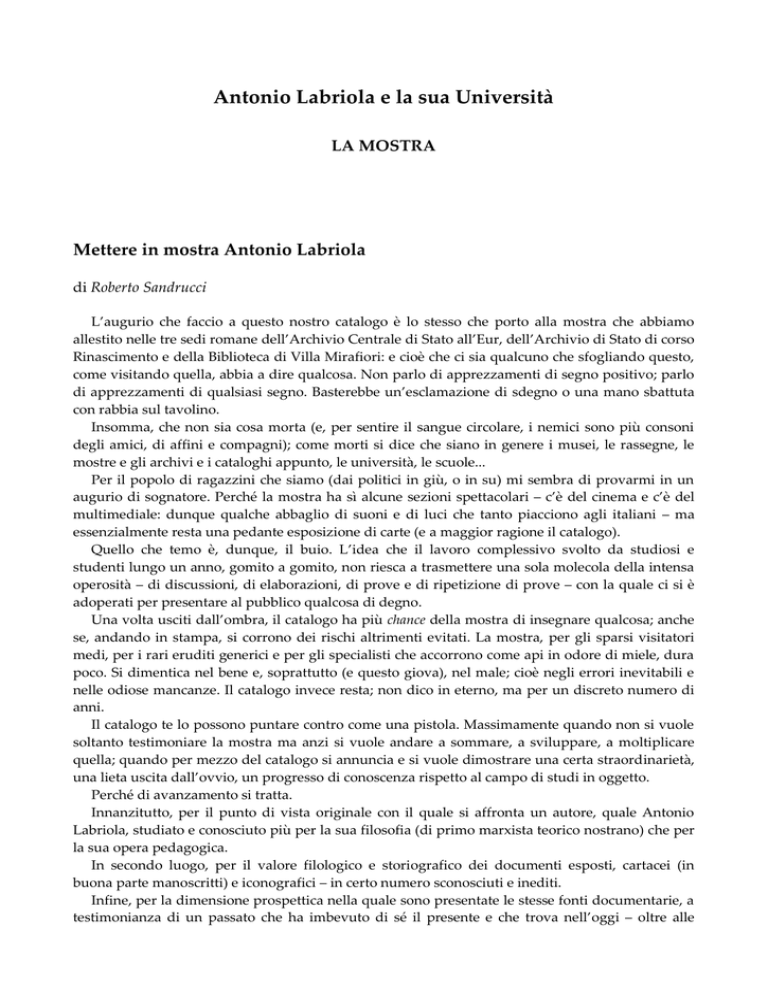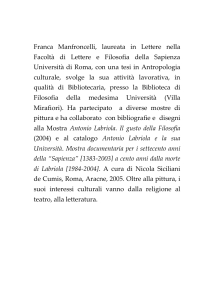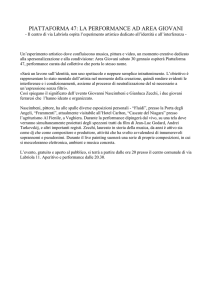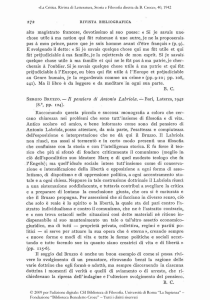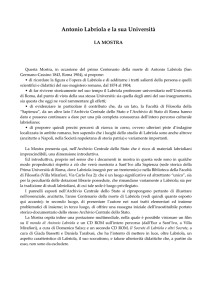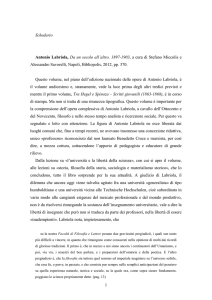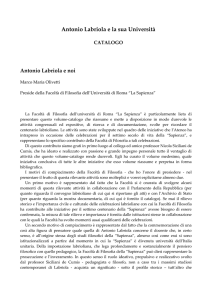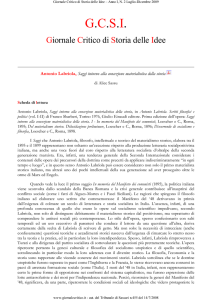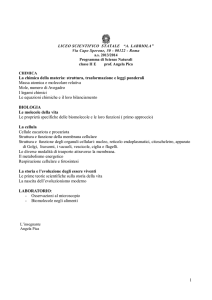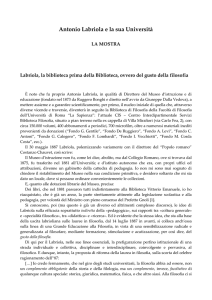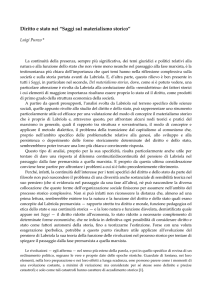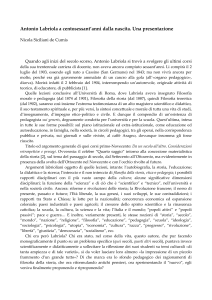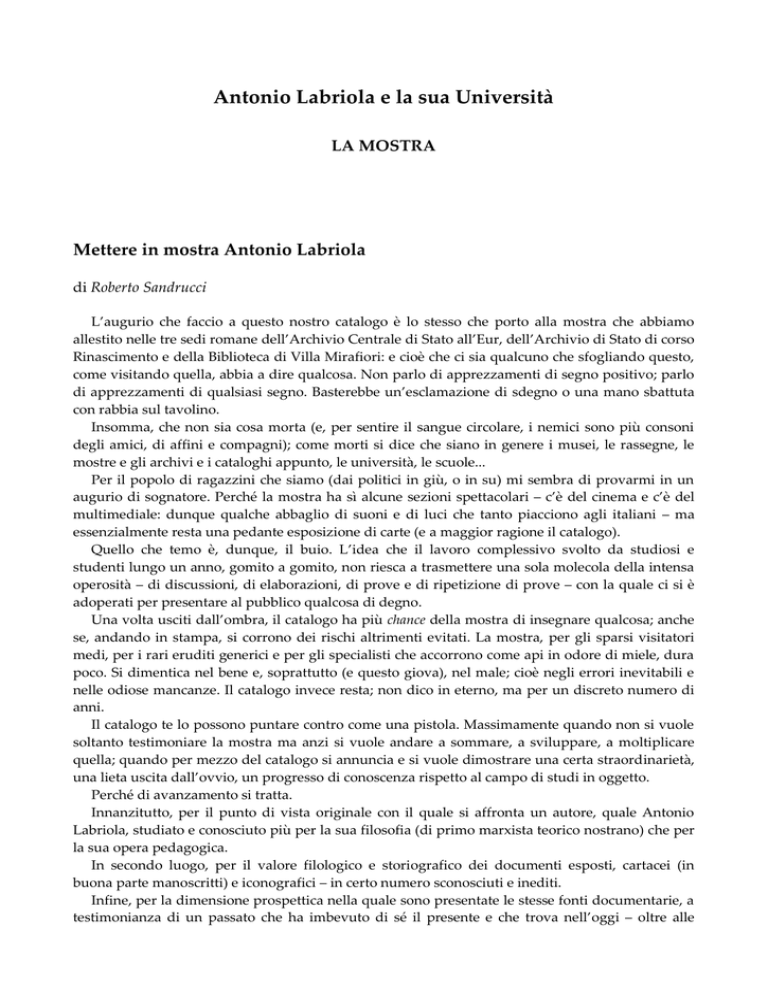
Antonio Labriola e la sua Università
LA MOSTRA
Mettere in mostra Antonio Labriola
di Roberto Sandrucci
L’augurio che faccio a questo nostro catalogo è lo stesso che porto alla mostra che abbiamo
allestito nelle tre sedi romane dell’Archivio Centrale di Stato all’Eur, dell’Archivio di Stato di corso
Rinascimento e della Biblioteca di Villa Mirafiori: e cioè che ci sia qualcuno che sfogliando questo,
come visitando quella, abbia a dire qualcosa. Non parlo di apprezzamenti di segno positivo; parlo
di apprezzamenti di qualsiasi segno. Basterebbe un’esclamazione di sdegno o una mano sbattuta
con rabbia sul tavolino.
Insomma, che non sia cosa morta (e, per sentire il sangue circolare, i nemici sono più consoni
degli amici, di affini e compagni); come morti si dice che siano in genere i musei, le rassegne, le
mostre e gli archivi e i cataloghi appunto, le università, le scuole...
Per il popolo di ragazzini che siamo (dai politici in giù, o in su) mi sembra di provarmi in un
augurio di sognatore. Perché la mostra ha sì alcune sezioni spettacolari – c’è del cinema e c’è del
multimediale: dunque qualche abbaglio di suoni e di luci che tanto piacciono agli italiani – ma
essenzialmente resta una pedante esposizione di carte (e a maggior ragione il catalogo).
Quello che temo è, dunque, il buio. L’idea che il lavoro complessivo svolto da studiosi e
studenti lungo un anno, gomito a gomito, non riesca a trasmettere una sola molecola della intensa
operosità – di discussioni, di elaborazioni, di prove e di ripetizione di prove – con la quale ci si è
adoperati per presentare al pubblico qualcosa di degno.
Una volta usciti dall’ombra, il catalogo ha più chance della mostra di insegnare qualcosa; anche
se, andando in stampa, si corrono dei rischi altrimenti evitati. La mostra, per gli sparsi visitatori
medi, per i rari eruditi generici e per gli specialisti che accorrono come api in odore di miele, dura
poco. Si dimentica nel bene e, soprattutto (e questo giova), nel male; cioè negli errori inevitabili e
nelle odiose mancanze. Il catalogo invece resta; non dico in eterno, ma per un discreto numero di
anni.
Il catalogo te lo possono puntare contro come una pistola. Massimamente quando non si vuole
soltanto testimoniare la mostra ma anzi si vuole andare a sommare, a sviluppare, a moltiplicare
quella; quando per mezzo del catalogo si annuncia e si vuole dimostrare una certa straordinarietà,
una lieta uscita dall’ovvio, un progresso di conoscenza rispetto al campo di studi in oggetto.
Perché di avanzamento si tratta.
Innanzitutto, per il punto di vista originale con il quale si affronta un autore, quale Antonio
Labriola, studiato e conosciuto più per la sua filosofia (di primo marxista teorico nostrano) che per
la sua opera pedagogica.
In secondo luogo, per il valore filologico e storiografico dei documenti esposti, cartacei (in
buona parte manoscritti) e iconografici – in certo numero sconosciuti e inediti.
Infine, per la dimensione prospettica nella quale sono presentate le stesse fonti documentarie, a
testimonianza di un passato che ha imbevuto di sé il presente e che trova nell’oggi – oltre alle
figliolanze dirette della successione storica generale e delle vicende istituzionali particolari – una
serie di riflessi e di consonanze che possono aiutare a comprendere di che vita viviamo.
Quando di Labriola si dice “opera pedagogica”, s’intendono uno specifico e un sintetico.
Lo specifico è dato dai materiali derivanti dalla professione di professore – di uomo di scuola
(negli anni 1865-1870) e soprattutto di università (1871-1903): per gli insegnamenti della Filosofia
della Storia a Napoli, della Filosofia Morale e della Pedagogia a Roma; per la direzione del Museo
d’Istruzione e di Educazione, per la presidenza del Circolo Pedagogico di Roma e per tutte le
attività di contorno evidentemente legate a questi mestieri (commissioni, ispezioni, missioni,
eccetera). Una massa documentaria di lezioni, di corsi, di saggi, di conferenze, atti, relazioni,
verbali, che si fa moltitudine viva non appena la si voglia considerare simpaticamente.
Il sintetico è dato dalla lettura dei suddetti materiali, e di altri che andiamo a dire, entro il
quadro filosofico proprio: che è la filosofia della prassi (pure se in una forma derivata e mitigata).
L’università di Labriola supera i muri dell’accademia per agire nel mondo in tempi e luoghi
supplementari alla Cattedra: perciò non disdegna la piazza e la strada; si serve di quotidiani e
periodici, siede al caffè, entra in fabbrica e in tribunale; e si adopera nei carteggi privati (basti qui
rammentare quelli con l’allievo Benedetto Croce o quelli intrattenuti con i dirigenti del socialismo
internazionale: Engels, Kautsky, Bernstein...). Si fa etica e politica (quel «rispondere coi fatti» tante
volte affermato dal Nostro e così poco professorale!).
La funzione docente esercitata da Labriola è, dunque, un fare fortemente dilatato: tentacolare,
armato di pensiero critico, nutrito di subitanee ire e d'intolleranze croniche, votato allo scontro
sempre.
Una università così intesa supera anche la morte del suo animatore (anno 1904); ingravidata dal
contatto continuo e diretto con le cose , si trova a generare creature in un certo numero, e le più
varie: qualcuna votata alla fedeltà, qualcun'altra che si allontana dal padre in silenzio, altre ancora
accese da ostilità precoci. Più la parte che, pur contando di un qualche debito di abito o di
ragionamento, ignora l’esistenza del legame.
Tutta questa discendenza (il mucchio potrebbe nascondere pure Benito Mussolini) è opportuno
che venga rappresentata, sia nelle parentele prossime sia in quelle lontane; sapendo che ce ne sono
di incerte, di oscure e di scandalose.
Nella mostra e nel catalogo si troveranno, allora, il Labriola intero (intero secondo l'ottica
dichiarata), e a brani – per così dire – il seguito: compariranno Teresa Labriola, Luigi Credaro,
Ernesto Codignola, Ugo Spirito, e Lombardi e Calogero e Garin e Guerra e Mastroianni e Siciliani
de Cumis, e tanti altri – a testimoniare (con le intenzioni e nei modi più vari, come dicevo appena
sopra) l’importanza dell'opera del primo.
Né ci si poteva fermare alla dialettica del dopo, perché ciò che origina a sua volta proviene; così
da incontrare, nell’andare a ritroso, altri contesti e famiglie diverse: da Herbart fino a toccare uno
Spinoza o Giordano Bruno, fino ad abbracciare Socrate.
Questa manovra dello scendere e del risalire nel tempo – tenendo bene al centro il presente
storico come un volano – è d’altronde l’oscillazione profonda che tiene in equilibrio tutta la mostra
e il catalogo di cui si discorre. Ed è il movimento spirituale raccomandato dallo stesso Labriola
nell’approccio e nello studio della natura e del corso dei “fatti umani”, la cui comprensione
dipende, appunto, dalla capacità di ripercorrere – incessantemente – sempre la stessa strada, ora in
un verso, ora nell’altro.
Si tratta di un’attività intellettuale che costa fatica e che richiede pratica di umiltà perché quello
che del divenire una volta sembra svelato e fissato, in un successivo ricercare può traballare o
franare senz’altro.
La mostra rientra in questo procedere: è una forma e una strategia dell’insegnamento della
storia; posta, insieme, come disciplina specialistica, con metodi e tecniche e fini suoi propri di
conoscenza (per noi, intorno alla pedagogica labrioliana), e come propedeutica ispirata
all’obiettivo universale della umanizzazione delle nuove generazioni, attraverso l’uso congiunto di
ragione e sentimento, di indagine scientifica e passione. Tra i visitatori – e non si tratta di un inciso
– si attendono le scolaresche dei liceali.
«Ricorderò soltanto – scriveva Labriola nel 1876 a proposito dell’accezione più larga – che se per
istoria s’intende la nuda narrazione dei fatti per ordine cronologico, come si usa nei manuali, o il
discorso astratto dei filosofi e dei politici su gli accadimenti umani, non è chi possa aspettarsi
dall’insegnamento di essa un qualche frutto educativo [...].
Or la storia che importa d’insegnare pei fini dell’educazione [...] ha da essere come il
complemento dell’esperienza attuale con la narrazione dei fatti che la precedettero e la
prepararono, deve arricchire l’immagine del variato spettacolo delle cose umane presenti con la
esposizione delle assenti e delle passate, deve presentare all’animo il vivo dei rapporti sociali fuori
delle fluttuazioni dell’empirismo giornaliero; in una parola vuol essere il vario del vivere umano
destinato a suscitare il vario degli spirituali interessi».
La ricostruzione storica a cui partecipa una mostra e di cui la mostra stessa rappresenta un
tentativo e una testimonianza, è sempre referenziale: presuppone un pubblico interessato o da
interessare; una mediazione, uno scambio. Vorrebbe avviare le menti più pigre e disadorne,
rinvigorire le attive ma sperse, vorrebbe fare meraviglia, attizzare focherelli e, dove si può – dove
si trova ossigeno in abbondanza di gente preparata –, appiccare incendi che bruciano nel pensiero
come se avessero fauci.
Nel nostro caso – e in molti altri in cui non si vanno ad esporre un Napoleone o Salgado, i
dipinti di Picasso o i Beatles (tanto per fare dei nomi di forte richiamo), e in cui non ci si avvale dei
circuiti e delle strutture museali, con ciò che comporta di massa di denari per promuovere e per
realizzare – la ricostruzione storica serve anche come piccola dimostrazione di ingegno e di
tenacia.
Nella ignoranza collettiva – o dimenticanza o rimozione (dove ogni stato ha una causa propria,
in uguale misura triste e deprecabile) – di Antonio Labriola e delle questioni di cultura, di politica
e di formazione, legate alla sua vita e alla sua riflessione, qualcuno ha continuato a lavorare
convinto della necessità di mantenere vivo (in verità bisognerebbe dire: resuscitare) una possibilità
di dibattito. Sicuri che Labriola possa essere ancora scientificamente – e appassionatamente –
interrogato; che sia disponibile a dare delucidazioni su singoli episodi e avvenimenti generali
dell’Italia post-risorgimentale e del primissimo Novecento; a fornire spiegazioni su illustri e meno
illustri; a parlare di identità nazionale.
Si dice che il marxismo sia entrato in Italia attraverso il corso di lezioni che, negli anni 1888-89,
Labriola tenne all’università di Roma sulla Rivoluzione Francese. Si dice di più: che Labriola (da
liberale e poi radicale) sia diventato marxista attraverso quelle lezioni che teneva lui stesso.
Affermazione, quest’ultima, di grande potenza e immagine di stravolgente bellezza – capace di
ridare fiato a chiunque navighi nelle acque piatte della noia o della disillusione intellettuali.
Affermazioni, entrambe, con buona probabilità, veritiere.
In Labriola la ricerca e la didattica molte volte si sono intrecciate; e così dovrebbe essere sempre:
buone sorelle che si conoscono a perfezione, che sanno andare in soccorso l’una dell’altra, che si
scambiano con gioia ogni bene in loro possesso (le vesti quotidiane al pari dei gioielli). Che
nascono, infine, dalla medesima pianta che si potrebbe descrivere come una specie di arbusto dalla
bizzarra foggia di punto interrogativo.
Vengono alla mente, quanto mai esplicative, le pagine sulla maieutica socratica (1869-70:
Labriola ha ventisei ventisette anni), dove si legge, ad esempio: «Questo lavoro non è una scoverta
ma una creazione; perché non determina la natura di un fatto più o meno remoto dalla immediata
percezione interna, ma esprime la produzione lenta e metodica di un nuovo stato della natura
delle rappresentazioni».
E fa un certo effetto – dà un certo senso di compiutezza, di conti che tornano – seguire Labriola
là dove considera religiosamente, con l’animo del discepolo, il «curioso fenomeno di Socrate che
educa educandosi», che «nell’atto che è incerto di tutto, mediante l’analisi della propria incertezza,
produce per sé e per gli altri il criterio della convinzione».
Gelosa e taccagna è sempre stata la ricerca in Italia; la quale con sordida invidia viene spiata da
chi si occupa solamente di didattica: da sotto in su, come un cane incatenato che mira il padrone
non decidendosi se azzannare o leccargli la mano. Oggi come ieri: uno scienziato (sociale o
naturale che sia) si vuole che valga cento professori di scuola superiore e mille tra maestrine e
maestrini di scuola primaria; e il sapere, reso sterile di norma dall’egoismo di chi lo detiene, pare
non esista che come monumento a se stesso o come puro esercizio di baronaggio.
E facilmente si vedono i risultati di tale sistema: il disagio di istruzione che si registra ad ogni
livello, la perdita di riconoscimento sociale degli educatori, lo svuotamento dell’ufficio stesso delle
istituzioni educative, il disastro morale nel quale versa la comunità umana, presa – quale è – nella
succube adorazione del dio Mercato.
Mi piace pensare che i centotrenta anni della Cattedra romana di Pedagogia abbiano costituito,
in linea di tendenza, una eccezione al malcostume appena descritto. Che la tradizione di
convivenza pacifica, e perciò proficua, di iniziative di ricerca e attività didattiche (così come svolte
nei corsi, nelle esercitazioni, all’interno dei seminari, nei laboratori...) abbia dato generalmente
buoni frutti.
Prova ne sia anche la mostra in oggetto e questo stesso catalogo, per la cui attuazione – come già
si accennava in apertura al presente scritto – è stato decisivo il contributo, pratico e di idee, di
studenti e di neo-laureati; dove hanno trovato spazio lavori eterogenei – di diversa impostazione,
di competenze formate e di altre in graduale evoluzione; dove le proposte interpretative si sono
arricchite mutuamente nel rispetto delle reciproche specificità. E prova ne siano le numerose tesi di
laurea esposte a vario titolo (su Labriola, a partire da Labriola, con Labriola di sfondo o per
sottinteso).
I tre pilastri del Marxismo secondo Labriola – la “critica econonomica”, la “interpretazione
politica” e la “tendenza filosofica” – non possono che ritrovarsi intatti nella mostra e nel catalogo –
ché Labriola è uno solo (e quello che scrive i Saggi sul Materialismo storico è il medesimo di quello
che ha scritto sulla libertà d'insegnamento o La dottrina di Socrate o Dell’insegnamento della storia ).
Ma, tradotti nella pratica universitaria (della sua università), il Marxismo o Comunismo critico,
come Labriola sosteneva si dovesse meglio chiamare la dottrina di Marx, sono divenuti un metodo.
Anzi, il metodo; e la rispettiva, doverosa coerente e continua, azione di bilanciamento e
correzione. Si è incarnato, per così dire; ma non una volta sola nella storia e per via straordinaria:
tutti i giorni e più volte nello stesso giorno, nella quotidianità delle faccende, dei traffici e delle
persone; nei ragionamenti, nei problemi con i relativi inciampi e le soluzioni; nelle contraddizioni,
nei fallimenti, negli errori.
E proprio dai limiti (di soggetto e di oggetto) bisognerebbe sempre cominciare – nel discorrere,
nell'analizzare, nel descrivere, nel filosofare.
Ne era ben consapevole lo stesso Labriola, il quale scriveva a chiare lettere l’ammonimento in
Discorrendo di socialismo e di filosofia, nel noto passo dove si legge: «nell’atto che ci sentiamo legati al
corso delle cose umane, e di questo studiamo le complicate linee e le tortuose pieghe, ci tocchi pur
di essere insiememente e medesimamente, non già rassegnati ed acquiescenti, ma anzi operosi di
conscia e ragionevole opera. Ma... venire al punto da confessare a noi stessi, che il nostro proprio io
individuo, [...] per grande che esso si sia, o ci paia, è assai piccola cosa nel complicato ingranaggio
dei meccanismi sociali: – ma doversi adattare alla persuasione, che i propositi o i conati subiettivi
di ciascun di noi dànno quasi sempre di cozzo nelle resistenze dell’intricato intreccio della vita,
cosicché, o non lascian traccia di sé, o ne lasciano una affatto difforme dal primitivo intento, perché
alterata e trasformata dalle condizioni concomitanti: – ma dover convenire di questo enunciato,
che noi siamo come vissuti dalla storia, e che il nostro contributo personale a questa, per quanto
indispensabile, è sempre un dato minuscolo nell’incrocio delle forze, che si combinano, completano
ed elidono a vicenda».
Ai visitatori e ai lettori servano la mostra e il presente catalogo come nutrimento e ricreazione,
prima di intraprendere o di continuare un qualche fecondo cammino.