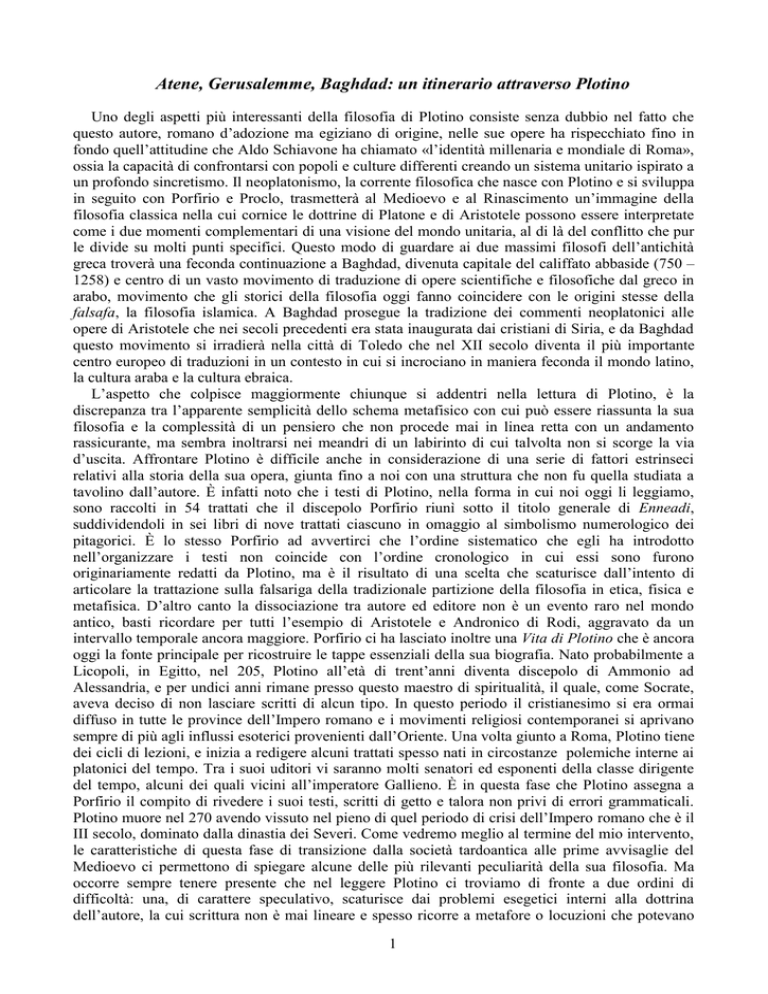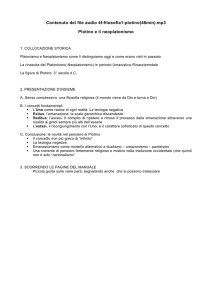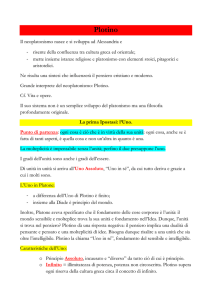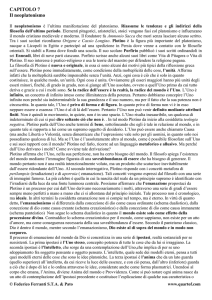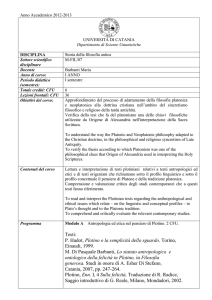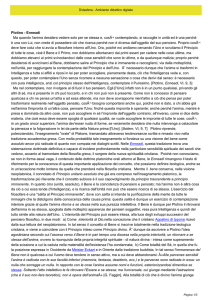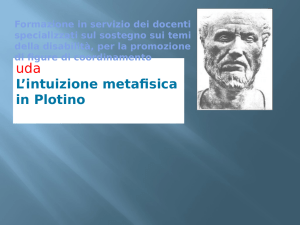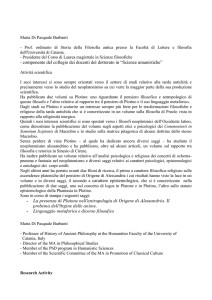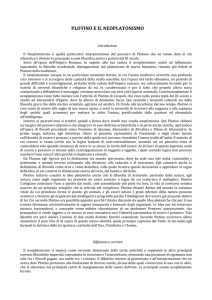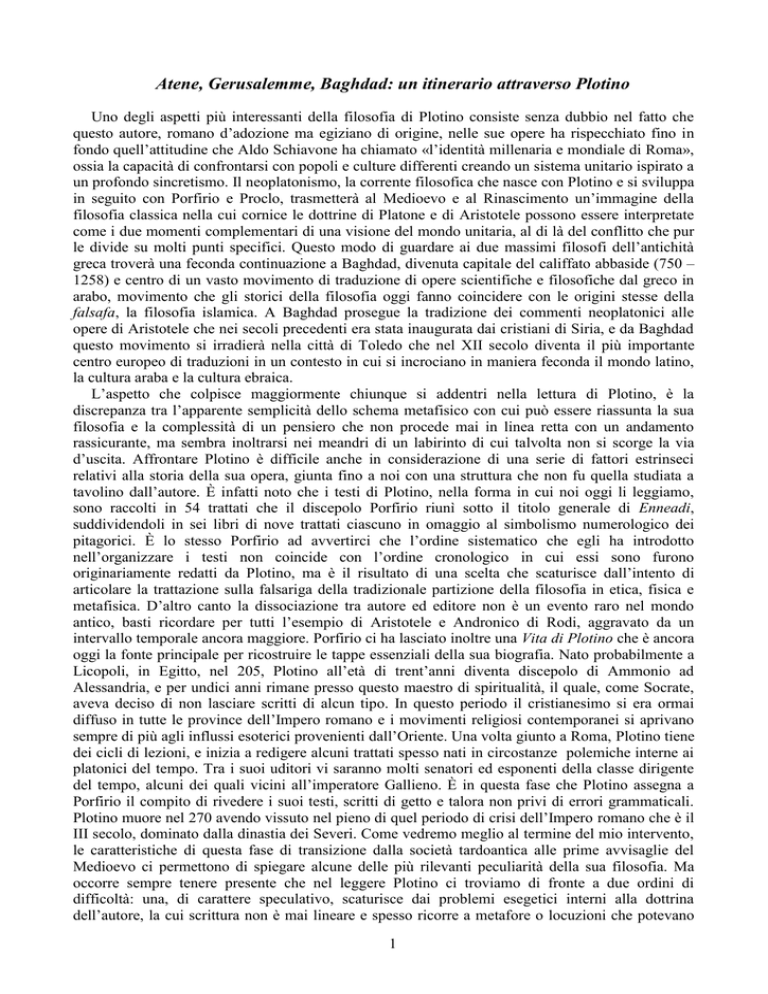
Atene, Gerusalemme, Baghdad: un itinerario attraverso Plotino
Uno degli aspetti più interessanti della filosofia di Plotino consiste senza dubbio nel fatto che
questo autore, romano d’adozione ma egiziano di origine, nelle sue opere ha rispecchiato fino in
fondo quell’attitudine che Aldo Schiavone ha chiamato «l’identità millenaria e mondiale di Roma»,
ossia la capacità di confrontarsi con popoli e culture differenti creando un sistema unitario ispirato a
un profondo sincretismo. Il neoplatonismo, la corrente filosofica che nasce con Plotino e si sviluppa
in seguito con Porfirio e Proclo, trasmetterà al Medioevo e al Rinascimento un’immagine della
filosofia classica nella cui cornice le dottrine di Platone e di Aristotele possono essere interpretate
come i due momenti complementari di una visione del mondo unitaria, al di là del conflitto che pur
le divide su molti punti specifici. Questo modo di guardare ai due massimi filosofi dell’antichità
greca troverà una feconda continuazione a Baghdad, divenuta capitale del califfato abbaside (750 –
1258) e centro di un vasto movimento di traduzione di opere scientifiche e filosofiche dal greco in
arabo, movimento che gli storici della filosofia oggi fanno coincidere con le origini stesse della
falsafa, la filosofia islamica. A Baghdad prosegue la tradizione dei commenti neoplatonici alle
opere di Aristotele che nei secoli precedenti era stata inaugurata dai cristiani di Siria, e da Baghdad
questo movimento si irradierà nella città di Toledo che nel XII secolo diventa il più importante
centro europeo di traduzioni in un contesto in cui si incrociano in maniera feconda il mondo latino,
la cultura araba e la cultura ebraica.
L’aspetto che colpisce maggiormente chiunque si addentri nella lettura di Plotino, è la
discrepanza tra l’apparente semplicità dello schema metafisico con cui può essere riassunta la sua
filosofia e la complessità di un pensiero che non procede mai in linea retta con un andamento
rassicurante, ma sembra inoltrarsi nei meandri di un labirinto di cui talvolta non si scorge la via
d’uscita. Affrontare Plotino è difficile anche in considerazione di una serie di fattori estrinseci
relativi alla storia della sua opera, giunta fino a noi con una struttura che non fu quella studiata a
tavolino dall’autore. È infatti noto che i testi di Plotino, nella forma in cui noi oggi li leggiamo,
sono raccolti in 54 trattati che il discepolo Porfirio riunì sotto il titolo generale di Enneadi,
suddividendoli in sei libri di nove trattati ciascuno in omaggio al simbolismo numerologico dei
pitagorici. È lo stesso Porfirio ad avvertirci che l’ordine sistematico che egli ha introdotto
nell’organizzare i testi non coincide con l’ordine cronologico in cui essi sono furono
originariamente redatti da Plotino, ma è il risultato di una scelta che scaturisce dall’intento di
articolare la trattazione sulla falsariga della tradizionale partizione della filosofia in etica, fisica e
metafisica. D’altro canto la dissociazione tra autore ed editore non è un evento raro nel mondo
antico, basti ricordare per tutti l’esempio di Aristotele e Andronico di Rodi, aggravato da un
intervallo temporale ancora maggiore. Porfirio ci ha lasciato inoltre una Vita di Plotino che è ancora
oggi la fonte principale per ricostruire le tappe essenziali della sua biografia. Nato probabilmente a
Licopoli, in Egitto, nel 205, Plotino all’età di trent’anni diventa discepolo di Ammonio ad
Alessandria, e per undici anni rimane presso questo maestro di spiritualità, il quale, come Socrate,
aveva deciso di non lasciare scritti di alcun tipo. In questo periodo il cristianesimo si era ormai
diffuso in tutte le province dell’Impero romano e i movimenti religiosi contemporanei si aprivano
sempre di più agli influssi esoterici provenienti dall’Oriente. Una volta giunto a Roma, Plotino tiene
dei cicli di lezioni, e inizia a redigere alcuni trattati spesso nati in circostanze polemiche interne ai
platonici del tempo. Tra i suoi uditori vi saranno molti senatori ed esponenti della classe dirigente
del tempo, alcuni dei quali vicini all’imperatore Gallieno. È in questa fase che Plotino assegna a
Porfirio il compito di rivedere i suoi testi, scritti di getto e talora non privi di errori grammaticali.
Plotino muore nel 270 avendo vissuto nel pieno di quel periodo di crisi dell’Impero romano che è il
III secolo, dominato dalla dinastia dei Severi. Come vedremo meglio al termine del mio intervento,
le caratteristiche di questa fase di transizione dalla società tardoantica alle prime avvisaglie del
Medioevo ci permettono di spiegare alcune delle più rilevanti peculiarità della sua filosofia. Ma
occorre sempre tenere presente che nel leggere Plotino ci troviamo di fronte a due ordini di
difficoltà: una, di carattere speculativo, scaturisce dai problemi esegetici interni alla dottrina
dell’autore, la cui scrittura non è mai lineare e spesso ricorre a metafore o locuzioni che potevano
1
risultare ovvie per chi seguiva le sue lezioni, ma che oggi, a noi lettori contemporanei, suonano
enigmatiche; la seconda deriva dal fatto che tali contenuti ci pervengono nella forma e con la
struttura che Porfirio, nella veste di editore, ha impresso agli scritti del maestro, condizionando così
il nostro modo di avvicinarci a questa filosofia già di per sé tanto complessa.
In prima approssimazione possiamo affermare che il progetto da cui trae origine la speculazione
di Plotino consiste nella volontà di restaurare il significato autentico della filosofia platonica
emendandola dalle contraffazioni cui era andata soggetta nel corso del tempo e difendendola dagli
attacchi dei suoi oppositori. Da questo punto di vista Plotino rivendica con orgoglio il carattere
tradizionalista del suo pensiero: «I nostri discorsi non hanno nulla di nuovo e non sono di oggi
[…]; sono gli scritti dello stesso Platone ad attestarci l’antichità di queste teorie» (Enneadi V I, 8,
10-14). Il tratto fondamentale della speculazione di Plotino consiste infatti in una costante ricerca
del divino che assume l’aspetto di un doppio movimento: da un lato è una catabasi, una discesa
dentro il nostro io più profondo, nella consapevolezza, già testimoniata da Eraclito, secondo cui
«non potrai trovare i confini dell’anima, per quanto tu vada, dovessi pure percorrere tutte le strade:
tanto profondo è il suo logos» (fr. 45 DK). Dall’altro si tratta di un’anabasi, una ascesa verso i
livelli di realtà più elevati, secondo un tragitto che nelle sue tappe salienti ripercorre l’itinerario del
prigioniero platonico in fuga dalla caverna di questo mondo sensibile intessuto di parvenze e di
ombre: «mi sforzo di far risalire ciò che vi è di divino in me a ciò che vi è di divino nell’universo»
(Porfirio, Vita di Plotino, II, 25). Da qualunque punto di vista lo si consideri questo itinerario è
comunque un «nostos», un viaggio di ritorno. Non si tratta di scoprire qualcosa di assolutamente
nuovo, ma piuttosto di ritrovare qualcosa che ci appartiene da sempre. Perché il Divino è la potenza
che opera incessantemente dentro di noi, è il pulsare della nostra stessa vita, anzi è il principio che
sorregge l’intero universo e senza il quale nulla potrebbe sussistere. Quando Beatrice, nel primo
canto del Paradiso, spiega che il viaggio estremo che Dante sta compiendo verso Dio è un ritorno
necessario alla Patria celeste – certo: non senza aver prima emendato lo spirito dalla gromma che
offuscava l’immagine di Dio in noi – il Sommo Poeta non fa altro che rielaborare uno schema
schiettamente plotiniano all’interno della visione cristiana. A ben vedere, del resto, l’intera
Commedia è contemporaneamente una catabasi – la discesa all’Inferno – e una anabasi: la scalata
della montagna del Purgatorio, e l’ascesa a Dio in Paradiso attraverso le sfere del cosmo tolemaico.
Ciò che invece è del tutto assente in Plotino, e costituisce lo scarto decisivo rispetto al mondo
cristiano, è l’idea della grazia come causa trascendente del processo di elevazione a Dio. L’impianto
soteriologico di Plotino è quello tipico di una filosofia della salvezza che mantiene un forte accento
aristocratico e anticristiano, anche se Plotino resterà estraneo a polemiche quali quella intervenuta,
ad esempio, tra Origene e Celso.
Per risalire al divino dobbiamo calarci in noi stessi, esplorare l’abisso del nostro io più profondo.
Se è vero, come scrive un po’ umoristicamente Platone nel Cratilo, che «aletheia» (verità)
significa «theia» «ale» (corsa divina), dovremo intendere la ricerca della verità ultima come una
caccia, un inseguimento: dalla ratio – la ragione discorsiva, sillogistica e/o dialettica (la platonica
«dianoia») – alla intuitio (la «noesis»), l’apprensione immediata del Vero nella pura theoria, fino a
culminare nella visione di Dio, in quello stato interiore che Plotino chiama «ekstasis» e che i mistici
del medioevo latino renderanno con l’espressione «excessus mentis». La «corsa alla verità» in
Plotino è un processo razionale che ci immette in una «visione» panoramica: la radura della Verità,
secondo l’immagine del Fedro platonico lungamente commentata nella V Enneade, ha da essere
colta in un solo colpo d’occhio panoramico, ma per giungere a questa visione occorre allenarsi
quotidianamente, è necessario un addestramento duro, è necessario essere, ad un tempo, atleti e
asceti. Questa concezione della spiritualità come esercizio attraversa tutta la grande mistica
occidentale – ebraica, cristiana, e islamica. Occorre «metodo» per diventare mistici. Lo stato di
estasi che il mistico raggiunge nel momento in cui «patisce» su di sé, già in questa vita, la presenza
divina, è il risultato di un vero e proprio allenamento. La mistica è una pratica muscolare che
interessa al tempo stesso l’immaginazione, la ragione, e l’intelletto. Volendo tracciare una mappa,
senza la pretesa con ciò di coartare la complessità del pensiero plotiniano in uno schema rigido,
potremmo distinguere tre fasi. La prima consiste nell’emozione che proviamo contemplando la
2
bellezza dell’universo, e questo è un punto che spesso Plotino tratta nel contesto di una polemica
molto dura contro gli gnostici; la seconda consiste nell’esercizio delle funzioni discorsive tipiche
dell’anima razionale; la terza è quella che ci apparenta alle «intelligenze di lassù», ed è la conquista
della capacità di contemplare le Forme essenziali delle cose, le ragioni ultime della realtà come
sono in se stesse, nel fulgore della loro potenza originaria.
Al contrario dei fedeli delle tre religioni del libro, i Greci non hanno mai avuto bisogno di
inventarsi «prove» per dimostrare l’esistenza di Dio perché la grandiosità del cielo stellato è una
manifestazione immediata della presenza degli dei. La natura spesso ci riempie di sgomento e
stupore, e l’emozione destata in noi dalla bellezza e dal sublime, afferma Plotino, nasce dal fatto
che l’elemento sensibile che percuote l’occhio corporeo risveglia una visione dello spirito. Il Bello è
come uno specchio attraverso il quale riusciamo a comprendere che questo mondo visibile è
immagine del mondo di lassù – «ekei»: «Tutto è trasparente; non vi è nulla di oscuro o che opponga
resistenza; ogni cosa è visibile per tutte le altre fino nell’intimo, perché la luce è trasparente alla
luce; e del resto ogni cosa le racchiude in sé tutte e vede in ciascuna tutte le altre, in modo che in
qualunque luogo ci sono tutte le cose, ognuna è tutte e tutte sono ciascuna cosa e lo splendore non
ha limiti» (Enneadi V 8, 4, 4-8). La bellezza non è altro che il trasparire della forma nel corpo che
la manifesta. Questo è un motivo platonico trattato soprattutto nel Fedro, un testo che per Plotino
assume un valore fondante per l’intera tradizione platonica. La materia non oppone alcun ostacolo
alla forma che essa incarna, e il mondo sensibile da questo punto di vista è uno specchio in cui si
riflette tutto lo splendore del mondo spirituale, di quella Patria che ci attende lassù. Il fondamento
metafisico della bellezza – a parte objecti – sta nella trasparenza della materia; il fondamento
trascendentale della bellezza – a parte subjecti – sta nella capacità di ridestarci alla visione dello
spirito. È dall’occhio della mente, non dall’occhio fisico che si genera la percezione della bellezza.
Il pensiero visivo di cui parlerà Erwin Panofsky è già tutto in questa intuizione plotiniana.
L’intellettualismo estetico di Plotino trae origine dal presupposto secondo cui la bellezza è come
una percezione oscura dell’Invisibile che ci permette di riconoscere l’unità di tutte le cose secondo
quel principio organicistico che egli chiama «anima del mondo» o anima cosmica. Da Platone a
Giordano Bruno la storia della tradizione platonica coincide con la storia di questo concetto
destinato ad essere rimosso con l’avvento del punto di vista meccanicistico introdotto dalla
Rivoluzione scientifica, per poi riaffiorare in epoca romantica con l’idealismo di Schelling.
L’anima del mondo costituisce l’elemento di continuità destinato a colmare lo iato metafisico tra
materia e spirito, tra sensibile e intelligibile. Sulla base del modello introdotto da Platone nel Timeo
anche Plotino sottoscrive la tesi secondo cui l’anima umana procede dall’anima del mondo, e da
questa deriva la sua principale potenza, ossia la razionalità dianoetica: «Poiché se l’anima ha
passato in rassegna tutte le verità e noi vogliamo che le esprima e le articoli in maniera discorsiva,
ella fugge dalle verità alle quali partecipiamo, perché il pensiero discorsivo per esprimere qualcosa
deve cogliere un concetto dopo l’altro, e in ciò consiste il “percorso” [«diexodos»]. Ma quale
“percorso” può esservi in ciò che è assolutamente semplice?» (Enneadi V 3, 17, 15-25). Per
realizzare il processo della conoscenza l’anima deve ancora operare attraverso inferenze e
mediazioni. Deve procedere di principio in principio fino a cogliere il Principio primo di tutte le
cose, quel Principio assolutamente semplice che Plotino indica semplicemente come l’Uno. Ancora
una volta, partendo dal presupposto che l’anima umana è immanente all’anima del mondo, Plotino
ribadisce il concetto secondo cui la discesa in noi stessi coincide con l’innalzamento ai livelli
superiori dell’essere, e quindi ci permette di avvicinarci alla sfera del Divino. Gli strati profondi
dell’interiorità coincidono con i livelli più nobili della scala degli esseri, la «aurea catena» dei
medievali intesa come espressione dell’ordinamento gerarchico del cosmo. Per Plotino, quindi,
l’anima è un Giano bifronte collocato al confine tra il mondo dei sensi e il mondo dell’intelletto:
«Le anime si trovano necessariamente ad essere, per così dire, anfibie: esse conducono ora la vita di
lassù, ora la vita di quaggiù; in misura maggiore la vita di lassù, le anime più capaci di stare a
contatto con l’Intelletto, in misura maggiore la vita di quaggiù, invece, le anime a cui capita il
contrario per natura o per sorte» (Enneadi IV 8, 4, 31-35). La fortuna che questo assioma riscuoterà
nella tradizione successiva è di vasta portata. Il tema dell’uomo come essere anfibio attraversa tutta
3
l’immaginario filosofico e letterario da Plotino ad Alano di Lilla, da Dante a Pico della Mirandola,
da Pascal a Kierkegaard, da Thomas Mann a Henry Miller. Nel Medioevo e nel Rinascimento
questo motivo subirà una variazione che ci è nota soprattutto nella versione che abitualmente
facciamo risalire al De dignitate homine di Pico della Mirandola, anche se essa è già presente nel
trattato dantesco De vulgari eloquentia. L’uomo viene considerato come la creatura di frontiera che
si colloca a metà tra angelo e bruto: se l’angelo rappresenta il perfetto civis della Gerusalemme
celeste che contempla il volto di Dio fin dal primo giorno della creazione, l’animale costituisce un
ingranaggio della grande macchina della natura. L’uomo, al contrario, partecipa di entrambi i
mondi senza mai essere accasato definitivamente in nessuno dei due. Per questa ragione Dante
nella Monarchia descrive la natura umana come quella di un essere «in orizonte eternitatis», sulla
base di una formula che è giunga all’occidente latino attraverso il Liber de causis, un manuale di
metafisica originariamente redatto in arabo che costituisce uno splendido esempio di integrazione
fra le tre culture del libro operanti nella città di Toledo all’altezza del XII secolo. Benché i manuali
scolastici non ne quasi mai facciano menzione, il Liber de causis appartiene alla categoria dei testi
che hanno maggiormente influenzato il pensiero medievale latino. Inizialmente circolò col titolo
Liber Aristotelis de expositione bonitatis purae, e come opera di Aristotele fu tradotto dall’arabo in
latino da Gerardo da Cremona per poi essere successivamente copiato, commentato e adottato nelle
università europee. Oggi sappiamo che il Liber de causis deriva in gran parte dagli Elementi di
teologia di Proclo, e dalle Enneadi di Plotino. Tommaso d’Aquino nel suo commento esplicativo fu
il primo a dimostrare la derivazione del Liber de causis da Proclo, dato che nel frattempo il
confratello Guglielmo di Moerbeke aveva approntato la traduzione latina degli Elementi di teologia.
Ciò che Tommaso non poteva sapere è il fatto che il testo originario fu scritto in arabo da Al-Kindi
o da qualcuno dei suoi collaboratori a Baghdad nel IX secolo, quando l’attuale capitale dell’Iraq era
la capitale dell’Impero abbaside. Al-Kindi, oltre che il fondatore della falsafa, fu l’organizzatore di
un grandioso progetto di traduzione delle opere di Aristotele e Plotino destinato ad avere un ruolo
decisivo nella trasmissione del sapere greco all’occidente cristiano. Quando Alfonso VI di Leòn
conquistò Toledo nel 1054 in questa città esisteva da tempo una comunità ebraica numerosa che
svolgeva un importante ruolo di «mediazione culturale», diremmo noi oggi, tra cristiani e
musulmani, nonostante i conflitti politici che opponevano i proseliti delle tre religioni del libro.
L’attività dei traduttori ricevette un impulso particolare dall’arcivescovo Raimondo di Sauvetat, e
da Toledo si irradiò la conoscenza delle opere di Aristotele in quella versione neoplatonizzante che
era stata elaborata dagli arabi. Contrariamente a quanto ancora oggi si continua a leggere in molti
libri di testo, lo stesso universo dantesco si configura secondo un modello che fonde in maniera
originale le dottrine aristoteliche e neoplatoniche, in particolare il neoplatonismo greco conosciuto
attraverso il Liber de causis, e quello arabo derivante da Avicenna.
Ma torniamo a Plotino. Il processo che ci ha condotto dalla contemplazione della bellezza della
natura all’anima del mondo trova la sua continuazione con la conquista di quel sapere razionale e
discorsivo che appartiene all’anima, premessa necessaria per giungere a una forma ulteriore di
razionalità che Plotino identifica nella figura concettuale dell’Intelletto. Tutto ciò che l’anima
concepisce attraverso passaggi, mediazioni, procedure discorsive, l’Intelletto lo vede
simultaneamente nell’unità di un medesimo atto noetico. Ricorrendo alle immagini della mitologia
tradizionale, Plotino paragona l’Intelletto al dio Kronos: «Il dio più sapiente, anteriore alla
generazione di Zeus ha in se stesso le cose che genera, per cui è pieno intelletto in sazietà [«vous en
korõ»]» (Enneadi V 1, 7, 35-40). L’immagine del dio Kronos che divora i figli, una volta
interpretata in chiave allegorica, ci svela un teorema filosofico: l’intelletto è eternamente volto alla
contemplazione dei propri contenuti di pensiero, gli intelligibili, in maniera tale che non li
percepisce come un oggetto esteriore, come farebbe la coscienza di un essere finito, ma li contiene
tutti in se stesso. L’intelletto, quindi, non è altro dalle idee, e in esso vi è perfetta coincidenza di
essere e pensiero, secondo l’antico motto di Parmenide. In questa dottrina vediamo prefigurata la
tesi di quella perfetta identità di pensante e pensato nell’immanenza dello Spirito di cui la filosofia
idealistica di Giovanni Gentile costituirà l’ultima e più compiuta rielaborazione. Se da un punto di
vista fenomenologico lo spirito si identifica con l’anima, la quale, salendo al di sopra di sé e
4
volgendosi all’intelletto acquisisce la capacità di cogliere gli intelligibili secondo una unità che
trascende le mediazioni del pensiero discorsivo, dal punto di vista della gerarchia delle cause, e
quindi sotto il profilo ontologico, per Plotino è l’Intelletto inteso come ipostasi che genera l’anima.
Il processo attraverso cui si ascende dall’anima all’intelletto si correla ancora una volta con la
catabasi corrispondente: la discesa a un livello più profondo del nostro essere coincide con l’ascesa
verso un livello superiore della realtà intelligibile. L’ultimo tratto del percorso è quello che sfocia
dall’intuizione intellettuale all’estasi mistica intesa come «assimilazione all’Uno» o, il che è lo
stesso, «adsimilatio Dei». La perfetta simplicitas appartiene solo ed esclusivamente a Dio, ma Dio è
ineffabile e trascendente rispetto alle categorie dell’umano intelligere. Salvezza e conoscenza
ultima coincidono e consistono nel diventare «semplici». Ciascuno di noi è chiamato a «scolpire la
propria statua», dichiara Plotino nella prima Enneade, e scolpire vuol dire togliere il superfluo,
portare alla luce l’essenziale, eliminare la croste che impediscono al nostro essere di rilucere in tutto
il fulgore della sua potenza originaria. Questo processo coincide appunto con il risalire verso ciò
che vi è di divino dentro di noi, perché l’anima, anche se immersa nella materia, non ha mai
realmente abbandonato la Patria di lassù: «Poiché l’anima è una realtà così preziosa e divina,
confidando che essa raggiunga dio, ascendi a lui con l’aiuto dell’Intelletto; il tuo slancio, dove che
sia, non cadrà affatto lontano, perché i gradi intermedi non sono molteplici. Cogli dunque l’ambito
che confina con l’anima verso l’alto, più divino di questa stessa realtà divina che è l’anima»
(Enneadi V I, 3, 1-5). Plotino appronta una soteriologia dell’Intelletto in cui la dimensione cristiana
della Grazia è del tutto assente. Con una lucidità speculativa sorprendente, Plotino riesce a saldare il
razionalismo della scienza greca, si pensi all’esempio spesso citato della geometria di Euclide, con
il misticismo della tradizione orfica e di Eleusi. Questa soteriologia a sua volta è come un
ampliamento del concetto platonico di anamnesi. Il ricordo è ciò che salva, il ricordo permette il
ritorno alla Patria, ma il vero ricordo è memoria di ciò che perdura, e non memoria del transeunte.
Per realizzare questo processo è necessario sconfessare il mondo delle immagini, il mondo della
spettacolarità, il mondo delle brighe e delle cure in cui siamo impelagati nel nostro vivere
quotidiano. È necessario porsi in ascolto di ciò che è essenziale. Tutto ciò che è stato per noi motivo
di ira, di speranza, di timore appartiene al corpo ed è destinato a dissolversi con il corpo. Tutto ciò
che ci ha distratto dalla nostra vera essenza, fobie, timori, incertezze del momento, di tutto questo
non resterà nulla. Le immagini che sono sfilate dinanzi ai nostri occhi son fatte della stessa pasta di
cui sono fatti i sogni, e come tracce di un sogno si dissolveranno nel momento in cui
abbandoneremo il corpo. Plotino ci esorta a coltivare la memoria di ciò che permane nel momento
stesso in cui esalta la forza dell’oblio verso ciò che «trapassa» di momento in momento.
Nella fase di passaggio dall’età tardoantica al Medioevo, la filosofia si interroga costantemente
sul tema della cittadinanza, e le dottrine di Plotino da questo punto di vista sono sintomatiche. La
risposta che egli fornisce a tale problema ha una valenza metafisica che si configura come l’esatto
contrario di quella proposta dal cosmopolitismo immanentistico degli stoici. Identificando l’ordine
razionale del cosmo con il Divino, e togliendone ogni alterità rispetto alla natura, gli stoici
distruggono l’idea stessa di patria intesa come radicamento in un determinato luogo, come identità
derivante dalla appartenenza a un «nomos della terra». Se per gli stoici la patria si dissolve
nell’ubiquità della natura, per i seguaci di Plotino la vera patria è la patria dell’anima, non esiste in
nessun luogo fisico, si sublima nella trascendenza di un Altrove che coincide col luogo al quale
dobbiamo tornare. Troviamo un’eco potente di questa riflessione nel concetto di «doppia
cittadinanza» elaborato nel De civitate Dei dal Padre della Chiesa occidentale che forse meglio e
più di altri ha attinto alla sorgente dei neoplatonici, Agostino di Ippona. Originariamente Agostino è
un immigrato nordafricano che nella seconda metà del IV secolo arriva nella Milano imperiale, in
cui è vescovo Sant’Ambrogio. La formazione umanistica di Agostino è fortissima, tale da indurlo
ancora a ostentare un aristocratico disprezzo nei confronti del rozzo antropomorfismo di cui sembra
intessuto il testo biblico. Superata una iniziale adesione al manicheismo, Agostino esce dall’impasse
dello scetticismo proprio grazie all’incontro con la filosofia di Plotino, che si verifica a Milano
grazie alla mediazione di Ambrogio. Da Plotino egli impara che la condizione di straniero su questa
terra appartiene a tutti gli esseri umani, al punto di esserne un tratto definitorio quasi dello stesso
5
rango del tradizionale binomio «animale razionale». La curvatura trascendente che il concetto di
«patria» assume in Agostino, man mano che si avvicina al cristianesimo, ha una prima impronta
neoplatonica. Nel XII libro delle Confessioni questa idea raggiunge il compimento: esempio del
perfetto «civis» è l’angelo, l’essere che fin dal primo giorno della creazione contempla il Volto del
Padre, puro intelletto speculante che ignora la miseria del raziocinare discorsivo. L’angelo vive in
quello stato di perenne beatitudine che Agostino delinea costantemente attraverso le immagini della
«civitas» e della «domus». Il modello da cui Agostino attinge nella definizione dell’intelligenza
angelica, mente pura compiutamente insediata in Dio nello «stabilimentum» della Gerusalemme
celeste, è proprio l’Intelletto di Plotino inteso come seconda ipostasi metafisica. La differenza che
passa tra Intelletto e Anima del mondo viene tradotta dai padri della chiesa nella distinzione tra le
intelligenze angeliche e le anime umane, in un contesto chiaramente improntato a un creazionismo
che non può che respingere l’impianto emanazionistico di Plotino. È la stessa differenza che passa
tra la beatitudine intesa come sazietà intellettuale, e la sete umana di Dio intesa come «nostalgia».
La dimensione nostalgica che caratterizza l’esperienza cristiana della vita terrena, intesa e vissuta
come esilio dalla vera patria di lassù, può essere considerato uno dei molteplici effetti della
ellenizzazione del cristianesimo. Quello di Agostino è un tipico esempio di come il cristianesimo
storicamente si costituisca nei termini di una fede aperta alle influenze del pensiero greco
maggiormente orientate in senso metafisico, nonostante il fatto che la concezione nostalgica della
patria non può prescindere dall’aspetto messianico e dall’idea della promessa escatologica.
Quest’ultimo elemento è estraneo all’universo mentale dei greci, perché oltre a presupporre l’idea
provvidenzialistica di un Dio personale che interviene nella storia, implica altresì quel concetto di
alleanza che appartiene alle matrici ebraiche del monoteismo. La «terra promessa» non può
coincidere con Itaca, e l’itinerario della mente in Dio, se da una parte si configura come un esercizio
di anamnesi volto a recuperare l’originario rapporto di immagine e somiglianza che sussisteva tra
Dio e l’uomo, dall’altra costituisce una renovatio radicale che implica il definitivo abbandono della
terra d’origine. Quando si arriverà alla compiuta Parusia, al disvelarsi del Vero nell’Apocalisse
ultima, ta prota apelthan, questo primo mondo sarà passato e questa terra finita (Apocalisse 21, 4).
Ecco allora che il cristianesimo di Agostino prende forma attraverso un continuo intersecarsi di
Atene e Gerusalemme, tra nostalgia dell’origine e speranza di «vita nova», tra l’escatologia
intermedia del ritorno delle anime in cielo e l’escatologia ultima definita dal messaggio apocalittico.
Tra Atene e Gerusalemme, temporalmente, si colloca Baghdad. L’idea malsana che uno scontro di
civiltà tra Occidente e Islam sia un destino ineluttabile può essere fugata anche attraverso
l’approfondimento e lo studio delle forme della civiltà medievale, e di questo percorso la storia del
neoplatonismo costituisce un momento ineludibile.
Alessandro Raffi, 16 aprile 2010
6