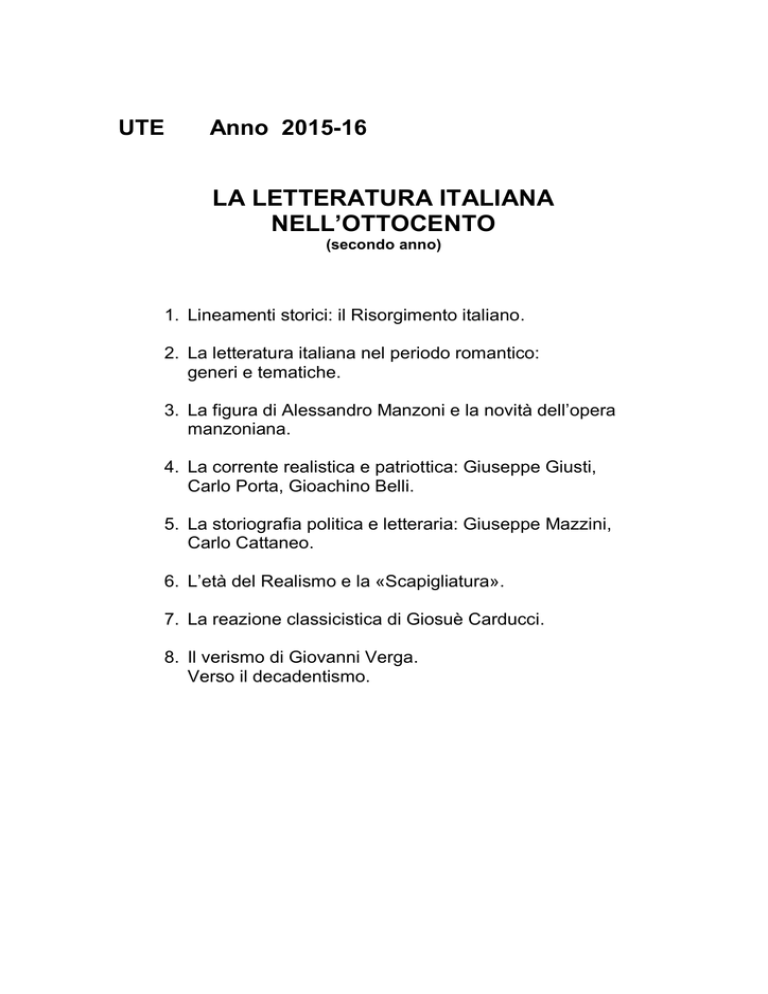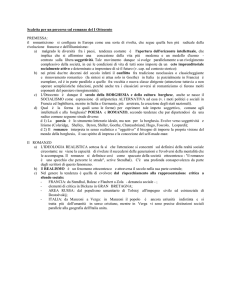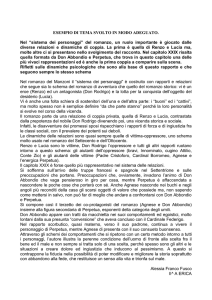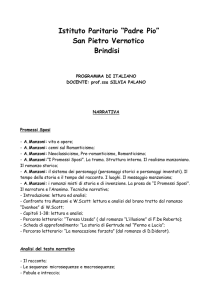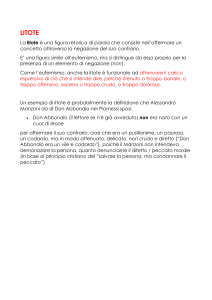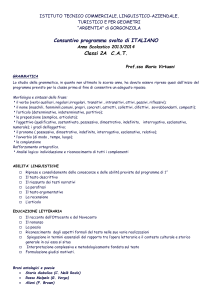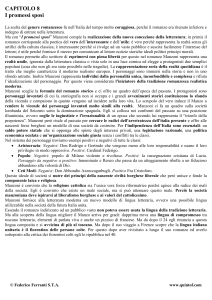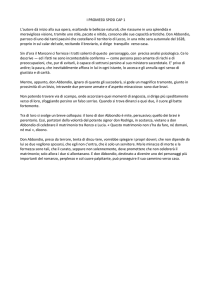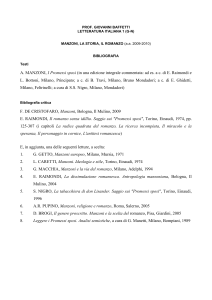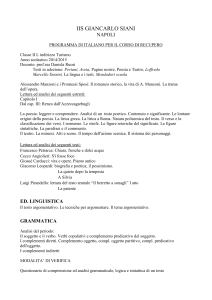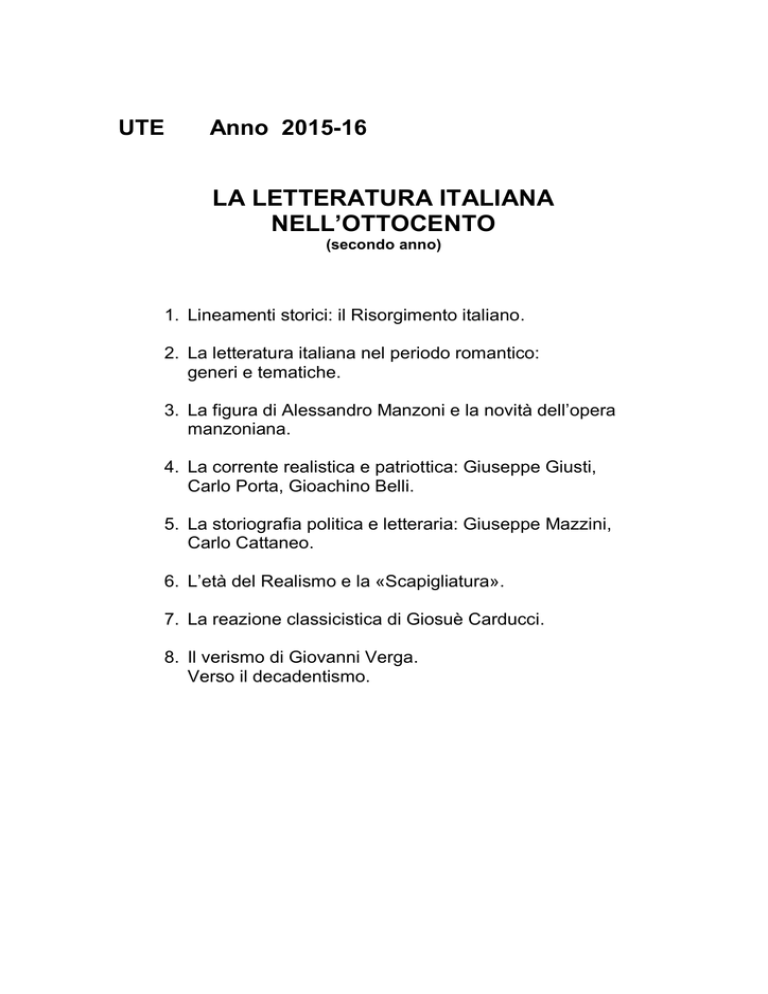
UTE
Anno 2015-16
LA LETTERATURA ITALIANA
NELL’OTTOCENTO
(secondo anno)
1. Lineamenti storici: il Risorgimento italiano.
2. La letteratura italiana nel periodo romantico:
generi e tematiche.
3. La figura di Alessandro Manzoni e la novità dell’opera
manzoniana.
4. La corrente realistica e patriottica: Giuseppe Giusti,
Carlo Porta, Gioachino Belli.
5. La storiografia politica e letteraria: Giuseppe Mazzini,
Carlo Cattaneo.
6. L’età del Realismo e la «Scapigliatura».
7. La reazione classicistica di Giosuè Carducci.
8. Il verismo di Giovanni Verga.
Verso il decadentismo.
LA “RIVOLUZIONE BORGHESE” IN ITALIA: IL RISORGIMENTO
1. Lineamenti storico-sociali
Il RISORGIMENTO è senza dubbio uno dei fenomeni più importanti della nostra storia civile, e
nel tempo stesso uno dei fatti più interessanti della vita europea del secolo scorso. Esso è
veramente una manifestazione di restaurata vita morale, una graduale riconquista di responsabile
coscienza del vivere civile da parte delle generose minoranze attive della società italiana (...).
I primi moti, i primi atti di ribellione all’ordine della Restaurazione si esprimono in senso
costituzionale da parte di quei ceti che, in ognuno dei singoli Stati, tendevano al recupero di quelle
posizioni di vantaggio e di civile dignità di cui avevano goduto nel periodo napoleonico; strumenti di
tale inquieta insoddisfazione sono anzitutto i residui della struttura militare e burocratica
dell’Impero, che la disfatta ha smobilitato e riportato a condizioni di passiva sudditanza. Il metodo
delle cospirazioni, delle congiure, dei pronunciamenti rivela ben presto la propria angusta sterilità.
Sul diffuso malcontento che percorre alcuni strati della società, lesi nei loro interessi dall’assetto
politico fissato a Vienna, si leva ben presto il vivace travaglio della cultura che, collegandosi al
generale processo europeo di elaborazione ed espansione delle idee di libertà, giunge, nella
particolare situazione nostrana, a rafforzare e diffondere il concetto di “nazione”, e ad accomunare
le tendenze pur contrastanti di tutti coloro che sentivano l’esigenza del mutamento, del
rinnovamento (...).
La concordia discors dei programmi, delle proposte circa i metodi per realizzare la libertà
della nazione riflette il rapporto tra le più vive forze della cultura, che hanno una parte determinante
soprattutto nello schieramento estremo, democratico e radicale, e i nuclei di interessi costituiti, di
natura economica (borghesia) e politica (Piemonte), propensi ad un mutamento moderato, tale
cioè da non mettere in gioco l’ordinamento sociale esistente. L’accordo si istituisce quando l’abile
azione del Cavour “diplomatizza” la rivoluzione, legando la soluzione del problema nazionale alla
favorevole congiuntura internazionale e alle tendenze espansive tradizionali dei Savoia: i
democratici scendono allora generosamente in lotta a fianco dei moderati in vista del fine comune,
realisticamente riconoscendo l’importanza del contributo militare e diplomatico del Piemonte. (...)
Nello sforzo unitario di restaurazione d’una coscienza morale, di educazione ad una volontà
collettiva, stava forse l’aspetto più alto e nobile della nostra civiltà del secolo scorso, anche se
esso comportava alcunché di ingenuo, di utopistico, di letterario. Così il Risorgimento,
particolarmente a coloro che ne vissero le passioni, poté apparire il punto d’arrivo, di maturazione,
di tendenze aspirazioni fermenti già presenti in numerose manifestazioni della plurisecolare
vicenda della nostra civiltà (...). In ciò indubbiamente, nella tensione morale dei suoi gruppi migliori
di sostanziare le proprie aspirazioni delle idealità, delle utopie che avevano costituito la trama
vitale della storia del nostro popolo, la società italiana opera un risorgimento. Certo il fervore di
natura mistica presenta i suoi lati deboli (...).
La rivoluzione borghese in Italia si manifesta dunque anzitutto e precipuamente in campo
etico-culturale, con l’adesione agli ideali di libertà che le erano propri nella sua parabola
ascendente europea, rielaborati e spesso ricreati su fondamenti della locale tradizione, entro i limiti
che la particolare condizione della nostra società comportava. Fatto sta che le minoranze attive
operarono con una carica morale positiva, seppero infine forzare la dura crosta che i secoli
precedenti avevano accumulato, la corazza di indifferenza e di passiva accettazione, affrontare
con l’azione la “grande e spaventosa impresa” prevista dagli illuministi.
Il punto d’arrivo sul piano delle pratiche realizzazioni politiche, vale a dire l’unità politicoterritoriale e l’indipendenza dallo straniero, non è ancora il risorgimento come lo avevano sognato i
suoi più puri fautori, o lo è solo in parte. Nel momento in cui la nazione italiana si affaccia tra gli
altri popoli dotati di autogoverno, le idee di libertà, nel rapido evolversi della vita associata europea
sotto lo stimolo di nuove esigenze sociali ed umane, si sono come reincarnate, hanno preso forme
diverse e diversi nomi. (...)
(da ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, AAVV Ed. D’ANNA, Messina 1969,
vol. III Parte Prima, pag.34-36)
2
2. Romanticismo e Risorgimento
Il Romanticismo italiano si identificò con lo spirito liberale e nazionale del nostro
Risorgimento, al quale diede alcuni fondamenti ideologici essenziali. Elaborò, infatti, i nuovi
concetti di patria, nazione e iniziativa popolare, di diritto alla libertà di tutti i popoli, come
fondamento anche di quella individuale e dell’armonico sviluppo della persona, dell’oppressione
politica come diminuzione della dignità umana. Soprattutto li fondò su un’idea della storia come
costruzione progressiva di civiltà cui erano chiamati a collaborare individui e popoli, e ispirò di
conseguenza una nuova fede nell’«Ideale», come fu allora chiamato, e altro non era se non questo
complesso di persuasioni unito al culto dei valori spirituali concepiti come motore primo della realtà
e della storia. E ispirò, infine, l’ardore della lotta e del sacrificio, la religione della libertà. Santorre di
Santarosa, dopo il fallimento dei moti piemontesi, andrà a morire combattendo per la libertà della
Grecia, come fece uno dei maggiori poeti inglesi del tempo, il Byron; il Nullo, dopo l’impresa dei
Mille, cadrà combattendo per la libertà della Polonia. Il sentimento nazionale non si chiuse, allora,
in nazionalismi esclusivistici e aggressivi, ma fu aperto al rispetto di tutte le patrie e di tutte le
nazionalità, alla volontà di collaborare a una battaglia comune per la libertà. Si deve pertanto al
Romanticismo se il movimento nazionale fu sentito come un problema morale prima ancora che
politico.
Nasce di qui lo stretto legame fra letteratura e politica che si ebbe nell’Ottocento, a partire
dalla disputa classico-romantica. Questa, infatti, propose una letteratura militante, intesa alla
trasformazione degli animi, alla fondazione nel popolo d’una coscienza nazionale. Ebbe di qui
origine la ricerca d’un contenuto moderno, attuale, popolare, d’una letteratura aderente al vero,
cioè alla vita reale e agli intimi affetti. Si affermò così, come un modello a cui conformarsi, la figura
dello scrittore d’opposizione, non più celebratore del potere costituito; immerso nella storia, nella
sua storia, quella che era chiamato a costruire con gli altri, nella posizione di suscitatore di energie
morali, e non inteso alla ricerca d’una perfezione statica, in una sorta di eternità fuori del tempo.
Egli esce, pertanto, dal chiuso delle accademie e delle corti, diventa un educatore alla libertà e un
combattente, con gli scritti e con l’azione, sentendosi interprete e guida dell’anima nazionale: colui
che l’aiuta a venire alla luce. Era quest’ultima un’impresa ancor più difficile di quella da svolgere
nel campo politico e militare. Se il Regno d’Italia stabilito da Napoleone aveva determinato una
corrente d’interessi che coinvolgevano buona parte, se non tutta, l’Italia, era infatti necessario che
a questa si accompagnasse una coscienza risoluta del diritto del Paese alla libertà, e cioè a una
propria organizzazione statale. Ma l’ideale unitario si affermò soltanto a poco a poco, dopo il
fallimento dei moti del 1821 e del 1831; dopo, soprattutto che le sconfitte della prima guerra
d’indipendenza, nel ’48-’49, e quelle delle insurrezioni di Roma e di Venezia fecero comprendere la
necessità d’uno sforzo comune e d’una soluzione unitaria.
Gli scrittori furono costantemente presenti in questo processo, e si può dire che la prima,
grande rivoluzione romantica in Italia sia stata la posizione d’un patto nuovo fra essi e il pubblico; il
tentativo di creare una letteratura nazionale e popolare, nella quale i lettori dovessero sentirsi
protagonisti, in cui vedessero rispecchiati e portati a più matura coscienza le proprie tradizioni e
aspirazioni.
Il Risorgimento rimase tuttavia una rivoluzione condotta essenzialmente dalla classe
borghese, anche se questa, nelle rivolte di Milano, Brescia, Venezia, riuscì a coagulare intorno a
sé una vasta partecipazione popolare. Estranee restarono le masse contadine, cui solo pochi fra i
pensatori politici del tempo seppero volgere lo sguardo con un’adeguata comprensione dei loro
problemi e della loro importanza sul piano nazionale. Fu questo un limite del movimento, che
peserà sulla storia futura del Paese. Ma la fondazione d’uno stato moderno, aperto, in condizioni di
parità, al colloquio con l’Europa, consentì all’Italia un ingresso effettivo nella storia.
Sul piano dell’organizzazione della cultura va riscontrato il costituirsi degli scrittori come
gruppo di intellettuali strettamente correlato ai politici e agli uomini d’azione che guidano il riscatto
nazionale; si ha, cioè, un’organizzazione democratica, costantemente commisurata con l’azione,
della produzione letteraria, sottratta ai condizionamenti dei governi autoritari: una letteratura,
insomma, impegnata.
(da LETTERATURA ITALIANA – 3 L’Ottocento, M. PAZZAGLIA
Ed. ZANICHELLI, Bologna 1993, pag. 397-398)
3
LA LETTERATURA NELL’ETÀ RISORGIMENTALE
3. Nuovi scrittori e nuove tematiche letterarie
(...) I nostri scrittori dell’età romantica incarnano un tipo di letterato moralmente nuovo,
immune da spirito cortigiano e servile, libero e altamente consapevole della sua missione di verità,
sdegnoso di qualsiasi frattura fra ciò che si sente e ciò che si scrive, tra l’animo e la parola. (...)
Questa produzione, mentre si rinnova profondamente nei contenuti, accostandosi alla vita, si libera
in gran parte della vecchia tendenza alla idealizzazione, ripudia le regole classicistiche, i generi
letterari, la mitologia; (...) elabora nuove forme espressive, nuovi “generi”, impiega una lingua più
sciolta, più libera e viva, più vicina al parlato; ha l’occhio ai maggiori romantici d’oltralpe, da BYRON
a SCHILLER, da GOETHE a BÜRGER, da HUGO a SCOTT, senza tuttavia trascurare la lezione più
valida del classicismo, vale a dire la chiarezza, la concretezza dell’espressione, il sicuro dominio
della fantasia e della passione da parte della ragione, l’abitudine di definire esattamente e
lucidamente i contorni delle immagini.
I temi più diffusi, ma non i soli, e nella poesia e nella prosa, sono quelli patriottici. Essi sono
tratti ora dalla storia presente (...); ora da quei momenti, da quegli episodi, da quei personaggi
della storia remota, che paiono aver relazione con la situazione e gli ideali presenti, come le epiche
e fortunate lotte delle antiche città in difesa della propria libertà (...).
Universale, dunque, il nostro primo romanticismo; e in quanto concreto, in quanto cioè sorgente di
una situazione reale e materiale degli ideali e delle aspirazioni di ogni cuore, veramente
popolare.(...)
4. Il romanzo storico
Il tema patriottico, accanto a motivi fantastici e sentimentali, è, se non prevalente, almeno
assai più evidente nel genere tipico del nostro romanticismo, nel romanzo storico. In questo
genere vediamo chiaramente come i nostri scrittori tendano a calare i loro ideali nel mondo della
storia, ad incarnarli in precisi fatti storici, per vivificarli e renderli operanti nel presente.
I romanzi storici di questi anni seguono in gran parte, ma non tutti, la falsariga manzoniana. Essi
tuttavia rimangono notevolmente lontani dai Promessi Sposi (...).
Ora mentre una parte della produzione letteraria di questi anni, soprattutto quella in prosa,
riconosce il suo modello nel MANZONI (...) una parte considerevole riconosce il proprio maestro
nel MAZZINI: s’ispira alla sua fede democratica, alla sua religione della patria e dell’umanità, al
suo altissimo ideale di rigenerazione dell’umanità per opera dell’umanità medesima, alle sue idee
sull’arte come lirico incitamento all’azione (...).
Gli scrittori di romanzi, che direttamente si richiamano al Manzoni sono il GROSSI (MARCO
VISCONTI), il CARCANO, il D’AZEGLIO (ETTORE FIERAMOSCA), il CANTÙ e il TOMMASEO.
All’indirizzo ideologico ed espressivo del Mazzini si richiama invece il GUERRAZZI. (...)
5. Gli scrittori di memorie
Un’età così ricca di rivolgimenti, che si contraddistingue per la larga partecipazione alle
vicende politiche da parte degli intellettuali, non fa meraviglia che ci abbia dato tanti libri di
“memorie”, ossia di autobiografie (...) testimonianza di un nuovo tipo di uomo, che non conosce
frattura tra le idee e l’agire pratico, ma, sostenuto da un alto ideale, prende deciso il suo posto di
combattimento nella vita e sa affrontare fino in fondo, con fermezza e coraggio, la lotta; attestano
l’unità profonda dell’uomo col letterato, l’avviamento ad una prosa schietta e viva, realistica e
popolare. [n.d.r., ricordiamo solo alcuni nomi molto rappresentativi: PELLICO, LE MIE PRIGIONI SETTEMBRINI, RICORDANZE - NIEVO, LE CONFESSIONI DI UN ITALIANO]
(da ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, AAVV Ed. D’ANNA, Messina 1969,
vol. III Parte Prima, pag.713-721)
4
6. La corrente realistica
L’esigenza realistica, la tendenza cioè alla rappresentazione oggettiva della realtà, che ha
nel Manzoni il suo grande interprete, affiora, più o meno apertamente in tutta la produzione
letteraria minore, e s’alterna e si fonde spesso con quella lirica. Schiettamente realistica, immune
da abbandoni sentimentali, nuova nel linguaggio, nelle forme, negli spiriti e negli argomenti, è la
poesia del GIUSTI, del PORTA e del BELLI.
GIUSEPPE GIUSTI (1809-1850) - Di piacevole lettura, soprattutto per la festevole arguzia,
l’opera del Giusti lascia nel complesso l’impressione più di garbata e raffinata letteratura che di
poesia, più di scherzo che di satira; diverte più che commuovere, riposa più che far pensare e
riflettere. Il Giusti non fu uomo di alti ideali, di profondi affetti e di grandi passioni; fu quello che
si dice un borghese di buon senso -e toscano, dobbiamo aggiungere- incapace di entusiasmo,
pieno di cautele e di riserve, che (...) quasi sempre risolve la sua amarezza nella satira, nella
rappresentazione oggettiva di scene e figure reali, accessibili all’uomo medio, al popolo, nelle
quali con estro vivace e brioso, bolla, mette in ridicolo la bassezza morale, l’ignoranza, la
cupidigia, i vizi di un popolo avvilito da una servitù secolare; i tirannelli locali, gli austriaci
oppressori, il clero, i funzionari prepotenti e servili, gli sbirri. (...) Nel complesso però le poesie
del Giusti si sente che non nascono da passione profonda, da una coscienza morale sdegnata
e offesa, da un uomo animato da fiducia. Proprio per questo esse mancano di calore, di unità, di
sobrietà; si disperdono in una serie di osservazioni acute ed argute, si risolvono nella creazione
di macchiette che, anziché toccare il cuore, divertono la mente.
CARLO PORTA (1775-1821) - Il romanticismo (...) nutrì grande ammirazione per la poesia
dialettale, la considerò all’altezza di quella in lingua italiana, proprio perché gli parve strumento
di una più diretta, aderente e viva espressione dell’anima popolare. (...) Ma trattando del Porta
bisogna tenere presente che egli nasce in quell’ambiente milanese settecentesco che già
contava una fiorente tradizione di poesia dialettale (...). ”Il punto di vista da cui il Porta si pone
ad osservare la società che lo circonda è quello di un uomo di formazione illuministica, di calda,
schietta, appassionata umanità, che attraverso l’esperienza delle vicende storiche succedutesi
in quegli anni tempestosi è venuto svolgendo le sue idee originarie, aprendosi ai nuovi ideali
risorgimentali. Di qui la ricchezza della sua poesia, la passione morale, il vigore polemico, la
pietà, che la sostengono e le danno unità. Inizia con la rappresentazione di persone e vicende
comiche, passa alla caricatura e alla satira delle figure più retrive e goffe della nobiltà, del basso
clero, ignorante e meschino, del servilismo diffuso, e giunge alla rappresentazione commossa,
vibrante di umana pietà e comprensione degli umili e degli offesi. Per la prima volta nei versi del
Porta questi umili, nei loro casi grotteschi, recano la coscienza del proprio avvilimento e perciò
riescono profondamente umani e suscitano nel lettore un moto di pietà e di sdegno contro i
responsabili di tale loro stato di degradazione”.(Caretti)
GIOACHINO BELLI (1791-1863) - Il Belli, scrivendo i suoi duemila e più sonetti, non si propose
intenti didattici o morali, ma unicamente di lasciare un monumento della plebe romana dei suoi
tempi (...).e ci ha consegnato una fortissima rappresentazione (...) dei costumi, delle credenze,
delle superstizioni, della fede, dei vizi, delle virtù del popolo della Roma papale e, insieme, della
vita e della decadenza delle classi “superiori”, osservate dallo stesso popolo che è protagonista
dell’opera. (...) Per l’ambiente torpido, conservatore in cui visse, il poeta romano rimase fermo
all’ideale settecentesco delle riforme (...) Di qui il carattere della poesia del Commedione, così
diversa da quella del Porta; il limite del realismo del Belli, il suo procedere più dall’istinto che
dalla fermezza e dalla novità delle idee. “L’oggettività del Belli (...) non approda mai, almeno
nell’intenzione cosciente dello scrittore, a un messaggio di vita e di progresso, e ha bisogno, per
rivelarsi, di rinchiudersi ad ogni momento in un’esigenza di rappresentazione pura, distaccata,
obbediente soltanto a certe regole di linguaggio, di precisione figurativa, di impassibile
documento.” (Sapegno)
(op. cit., pag.727-732)
5
7. La storiografia politica e letteraria
In Italia il fervore di studi storici è in diretta relazione col moto risorgimentale. Ovunque
sorgono, in questo periodo, deputazioni, società commissioni di storia patria; si fondano riviste, si
raccolgono e si interpretano documenti e materiali da servire ai futuri scrittori della storia d’Italia.
I nuovi storiografi risorgimentali, più o meno sensibili alla lezione del VICO e del CUOCO,
accolgono l’idea della storia come svolgimento e progresso, ma la subordinano ai loro ideali politici
e patriottici; e nelle vicende del passato, a cominciare soprattutto dal medioevo, ricercano la linea
di svolgimento e di progresso della civiltà nazionale, la radice dei loro ideali presenti di libertà e di
indipendenza. (...) Gli storici liberal-cattolici e neo-guelfi, dal MANZONI al CANTÙ, al BALBO, al
GIOBERTI, al CAPPONI, muovono dall’idea comune che il cattolicesimo fu elemento essenziale,
positivo, progressivo della nazionalità e della civiltà italiana; mentre gli storici laici o neo-ghibellini,
da NICCOLINI a PISACANE e FERRARI informano i loro scritti all’idea che la Chiesa fu causa
delle discordie italiane, dell’asservimento dell’Italia allo straniero; che bisogna abolire il potere
temporale, riformare l’insegnamento pubblico e privato fondandolo su principi nuovi,
coraggiosamente liberali e democratici, diversi perciò da quelli affermati dalla tradizione cattolica.
(...)
CARLO CATTANEO ha una sua originale e assai rilevante posizione in seno alla cultura
lombarda e italiana dell’ ’800, oltre che come studioso di problemi economici, politici, sociali,
scientifici e linguistici, anche come storico e critico letterario. (...) Egli appare animato da un
vivissimo senso del concreto, dalla volontà di applicarsi alle più diverse scienze in quanto queste
possono offrire applicazioni utili alla civiltà; mosso, nelle sue ricerche e nei suoi studi storici, dalla
necessità di ricercare la soluzione dei problemi dell’uomo presente nelle leggi generali
dell’evoluzione dell’umanità. Senonché egli ripudia ogni schema astratto di filosofia della storia e,
riallacciandosi all’insegnamento degli illuministi lombardi, propone di applicare alle scienze morali,
nello studio della formazione della coscienza dell’uomo civile presente, il metodo sperimentale.
(...) La nostra storiografia e la nostra critica letteraria, muovendo dall’idea che ogni popolo
che fa parte delle nazioni civili ha un suo “genio”, una sua “missione” da compiere nel quadro della
universale civiltà, esaltano quelle opere nelle quali, a loro avviso, si riflettono i valori storicamente
positivi, splende il “genio” del popolo italiano (...); e accogliendo l’idea che la poesia di ciascun
popolo è schietta e originale finché si svolge per una forza spontanea, per un impulso che viene
dal popolo, e che essa decade quando accoglie passivamente l’influsso di altre civiltà e di altre
letterature, esaltano soprattutto la poesia medioevale (...): ammirano particolarmente Dante in
quanto poeta civile, cantore e profondo interprete della storia e delle passioni della sua età. (...)
MAZZINI e GIOBERTI, avversari in politica, ebbero in comune molte idee intorno alla
letteratura: entrambi considerarono le lettere come strumento validissimo per l’educazione morale
ed intellettuale dei popoli; entrambi ebbero in comune l’idea che per fare un popolo libero, fosse
necessario soprattutto educarlo, che alla letteratura e all’arte toccasse il compito di promuovere la
ricostruzione morale e civile, l’unità spirituale degli italiani.
(op. cit., pag.733-739)
La scuola democratica si accentrò intorno alla figura di MAZZINI, il maggior interprete
dell’anima romantica del nostro Risorgimento. Uomo di vaste letture e di viva sensibilità letteraria
(come, del resto, il Gioberti), fu, tra gli intellettuali di quest’età, il più vicino allo spirito del
Romanticismo europeo. Egli fece della patria e della libertà una religione laica e immanentistica,
tale da risolvere in sé tutta la vita della coscienza. Il suo slancio di libertà e giovinezza, di ardore di
sacrificio e di fede negli ideali di verità, libertà e giustizia che si attuano nel grande poema della
storia umana, divennero un mito, una persuasione spirituale suscitatrice non solo d’azioni eroiche,
ma anche di poesia, come si vede studiando l’opera di molti scrittori risorgimentali, anche non del
tutto concordi con lui ideologicamente, in una tradizione che va da Goffredo Mameli a Ippolito
Nievo a Carducci, e comprende anche Giambattista Niccolini e Francesco Domenico Guerrazzi.
(da LETTERATURA ITALIANA – 3 L’Ottocento, M. PAZZAGLIA
Ed. ZANICHELLI, Bologna 1993, pag. 399)
6
ALESSANDRO MANZONI
8. La novità dell’opera manzoniana
(...) già nel 1806, ALESSANDRO MANZONI (1785-1873) avvertiva l’esigenza di una letteratura
moralmente utile, educativa, ispirata al vero, moderna, popolare, e si poneva insieme il problema
della lingua da impiegare per una letteratura siffatta (...) E trovò nelle dottrine dei romantici
lombardi i fondamenti alla elaborazione di quella sua originale poetica, dalla quale dovevano
prendere l’avvio non soltanto i Promessi Sposi, ma la più alta produzione narrativa dell’Ottocento.
La poetica del Manzoni “esclude ogni forma di abbandono al sentimentale, di compiacimento
idilliaco, di divertimento fantastico; essa bandisce e allontana da sé per sempre ogni concetto della
poesia come lirica, nel senso tradizionale petrarchesco di questa parola; tende cioè a mettere in
primo piano l’oggettività della materia poetica e a collocare in ombra, fin quasi ad annullarlo,
l’intervento soggettivo dello scrittore (...)” (Sapegno)
A questa poetica si riallaccia il problema della lingua, che il Manzoni già pone nella lettera
al Fauriel del 1806, quando rileva la necessità di colmare la distanza tra la lingua scritta e quella
parlata. Ora nelle liriche e nelle tragedie il poeta ancora utilizza, in parte, il linguaggio tradizionale;
ma quando mette mano al romanzo, vale a dire a un genere nuovo, col proposito ben chiaro di fare
opera realistica e popolare, non trovando alcun sostegno nella precedente tradizione narrativa,
crea una lingua del tutto nuova, la più vicina possibile a quella parlata.
Trovandosi ad agire in un’epoca di crisi e in una società in profondo rinnovamento, delle cui ombre
e luci si preoccupò di indagare nel profondo tutte le ‘ragioni’, il romanzo gli si venne sempre più
configurando come un’opera insieme di giudizio etico, di indagine psicologica e di fantasia
narrativa, e si sentì chiamato ad avviare una forma d’arte interamente nuova e precisamente
quella del romanzo di idee, sotto specie di romanzo storico, che ha avuto poi tanta fortuna nello
svolgimento della moderna narrativa europea. (...)
Il Manzoni creava così in Italia, si può dire dal nulla, il romanzo moderno, e impostava
pragmaticamente la questione della lingua come problema stilistico dell’adeguamento della forma
espressiva alla natura intima dell’opera d’arte, facendo confluire nei Promessi Sposi tutte le sue
esperienze di storico, di moralista e di scrittore e armonizzando tra loro i corrispettivi piani stilistici
(quello della narrazione storica, quello dell’oratoria morale, quello della distensione o del
raccoglimento lirico, quello dell’annotazione intellettuale o del commento ironico, e soprattutto
quello arduo del ‘parlato’ dimesso e familiare) in un organismo sintatticamente compatto e
organico che trova, appunto nella magistrale variatio dei diversi registri, la sua dinamica e
suggestivamente mutevole continuità di autentica prosa di romanzo. (...)
Il Manzoni ha superato così i limiti dell’Illuminismo e ha conferito una precisa e originale
fisionomia al romanticismo italiano; ha inventato il personaggio moderno (...); ha sottratto alla
storia il carattere di semplice cornice scenografica e ne ha rappresentato invece la tragica
connessione con il destino degli uomini, grandi e piccoli; (...) ha insistito rigorosamente sul tema
della responsabilità morale di ogni individuo, aprendo nuovi orizzonti alla più sottile, penetrante e
spregiudicata analisi psicologica; ha dimostrato la legittimità artistica dei personaggi ‘negativi’,
anticipando i grandi romanzi realistici (...)”.(Caretti)
(da ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, AAVV Ed. D’ANNA, Messina 1969,
vol. III Parte Prima, pag.355-361)
I PROMESSI SPOSI
9. Dalle tragedie al romanzo
Le forme oggettive delle liriche e dei cori, il gusto della meditazione storica, il realismo,
rivolto ad esprimere la serietà della vita quotidiana, l’indagine psicologica acuta e penetrante: tutti
questi caratteri salienti della poesia manzoniana tendevano a un ritmo di racconto più ampio, a un
linguaggio più immediatamente comunicativo. Per questo, si può dire che tutta l’opera del Manzoni
trova nel romanzo la sua conclusione.
7
Ma i Promessi Sposi sono anche l’espressione definitiva della concezione manzoniana della
vita, di quella tensione spirituale che aveva caratterizzato fin dall’inizio la sua attività culturale e
poetica e la sua stessa testimonianza cristiana. La verità ritrovata e proclamata negli Inni sacri, si
era dolorosamente scontrata, nelle tragedie, con un sentimento desolato della storia, con la
scoperta del male e del suo continuo trionfo nei rapporti fra gli uomini; nel romanzo assistiamo,
invece, a un rasserenamento che nasce da un’approfondita visione umana e religiosa, e che,
senza indulgere mai a un facile ottimismo, approda a un’attesa più fiduciosa del trionfo finale del
bene anche sulla terra.
Rispetto alle tragedie, il romanzo rappresenta una svolta decisa della poetica manzoniana.
Non vi è più, in esso, un’invenzione rigorosamente condizionata da eventi storici precisi, ma una
vicenda del tutto immaginaria, quella di Renzo e Lucia, ancorata tuttavia al reale, immersa nei
«costumi storici» di un’epoca ben definita, colta nella concretezza del suo spirito e della sua civiltà.
I romanzi storici erano allora di moda, e celeberrimi erano quelli di Walter Scott; ma mentre in essi
la storia era un pretesto di narrazione avventurosa e pittoresca, il Manzoni intendeva di «applicarsi
a considerare nella realtà il modo di agire degli uomini in ciò che esso ha di opposto allo spirito
romanzesco», di risalire, cioè, dal vero storico al vero morale. Voleva, insomma, cogliere,
attraverso una visione attenta e circostanziata del suo agire, la psicologia dell’uomo e la lotta
continua che si svolge nella sua coscienza fra il bene e il male. Il romanzo storico diveniva così per
lui un romanzo d’idee, una meditazione sulla condizione umana nel mondo.
Anche in questo ambito, però, esso rivela un’ispirazione nuova rispetto alle tragedie. Là il
popolo appare nello sfondo, visto come una massa amorfa e sofferente, destinata non ad agire,
ma a subire la storia, «fatta» dai potenti, anche se ad essi il poeta indicava, come unico mezzo di
salvezza e di redenzione da un mondo di sangue e di violenze, l’essere collocati dalla «provvida
sventura» fra gli oppressi. La novità dei Promessi Sposi è, invece, la scoperta che anche i volghi
spregiati collaborano alla storia, e in modo, sostanzialmente, più importante dei «grandi», perché
con la loro umile fede e la loro mansuetudine, e con la loro sete di giustizia, sono meglio disposti
ad accogliere il messaggio cristiano, e quindi capaci di attuare la vera civiltà, che, per il Manzoni,
coincide con l’affermazione integrale dello spirito del Vangelo.
10. Personaggi e situazioni del romanzo
I Promessi Sposi possono, in questo senso, essere definiti l’epopea degli umili e della loro
vita. I due protagonisti del romanzo sono, infatti, due semplici popolani, Renzo e Lucia, che del
popolo sembrano riassumere le doti migliori. In Renzo ritroviamo la schiettezza, la cordialità
espansiva, l’onestà laboriosa, la generosità dell’anima popolare, e soprattutto l’anelito di giustizia,
tanto più sentito in quanto egli appartiene a una classe da sempre oppressa e soggetta all’arbitrio
dei potenti, che hanno fatto la legge per sé, per mantenere intatto un regime di prepotenza e di
privilegio. In Lucia vediamo invece la mansuetudine, la nativa purezza, la fede spontanea e
profonda nella Provvidenza. È la donna destinata ad essere sposa e madre, che vive in
quest’attesa la sua limpida giovinezza, che sa amare senza perdere il suo pudore nativo, la sua
intatta innocenza. Sono due «eroi» tutt’altro che romanzeschi, che non si obliano in una vicenda
d’amore e di passione, ma sentono la vita come un impegno e un dovere, di cui dovranno rendere
conto a Dio, e vedono nell’amore e nel matrimonio la grande avventura della loro esistenza, o
meglio, il suo significato, e ad essi s’accostano con un senso di responsabilità morale. Il loro ideale
è l’«allegrezza raccolta e tranquilla» di cui parla fra Cristoforo accomiatandosi da loro, e coincide
con un impegno autenticamente cristiano, con la serenità di una vita semplice e laboriosa,
illuminata dalla promessa di una felicità più vera nei cieli.
Attorno a loro sta tutta una folla di figure minori di popolani, guardati dal poeta con una
simpatia che potrebbe sembrare parzialità, soprattutto se paragonata alla continua ironia polemica
con cui considera il mondo, ad essi opposto, dei potenti. In realtà, se è vero che il Manzoni ritiene
più facili a trovarsi fra il popolo le virtù cristiane, sa benissimo che esse, e soprattutto la più alta,
cioè l’umiltà, non sono un dato di fatto fatalmente legato a una classe sociale, ma scelta e
conquista individuale.
Per quel che riguarda i potenti, la condanna del Manzoni è recisa. Sono coloro (da Don
Rodrigo, al dottor Azzeccagarbugli, a Ferrer, al governatore di Milano) che vivono nella superbia e
nella prepotenza, chiusi nel loro orgoglio di casta e in un assurdo senso dell’onore, che sarebbe
8
meglio chiamare albagia puntigliosa; che violano la legge cristiana di fraternità e d’amore, in
quanto opprimono altri uomini, considerandoli una razza inferiore, e non come dei fini, ma come un
semplice mezzo per appagare il loro capriccio (è l’atteggiamento di don Rodrigo verso Lucia) o la
loro sete di lusso e di ricchezza. E tuttavia, anch’essi possono compiere la loro scelta,
comprendere che «non c’è giusta superiorità dell’uomo sugli uomini se non in loro servigio», come
fanno il Cardinale, l’Innominato dopo la conversione e, soprattutto, fra Cristoforo, che è il simbolo
di un cristianesimo attivo e militante, rivolto ad attuare i propri ideali nel mondo senza violenza, ma
con una fede austera e sicura.
Tutti questi personaggi sono concretamente calati nella realtà e nei costumi del loro tempo,
ricostruito dallo scrittore in base a profondi studi storici. È stato anzi detto che il Seicento è il vero
protagonista del romanzo; ed è formula che può essere accolta, purché, però, s’intenda che
questo secolo diventa il simbolo della vita umana di sempre. È un Seicento, infatti, guardato con
animo di moralista più che di storico; età di sopruso e di violenza, di puntiglio e di vuoto culto
dell’esteriorità, di sussiego e di pedanteria, nella classe dirigente. Su questo sfondo si svolgono i
grandi eventi storici, la peste, la fame e la guerra, i flagelli da cui gli uomini, nelle Rogazioni della
liturgia cattolica, chiedono a Dio di essere liberati, e nei quali si assomma il travaglio d’intere
generazioni. Ma se gli ultimi due appaiono frutto del mal governo e di una legge anticristiana
stabilita dagli uomini nel mondo, la peste, oltre a essere un flagello reale, diviene il simbolo della
sofferenza del vivere e dell’errore e insieme un mezzo attraverso il quale Dio prova l’uomo, una
sventura che può diventare una grande occasione della Grazia, un dolore nel quale l’uomo può
purificarsi e redimersi.
11. Realismo poetico e cristiano
Il dramma dell’uomo nel mondo è costantemente illuminato, nel romanzo, da una luce
cristiana. Dietro la vicenda spesso dolorosa e torbida, sempre, comunque, difficile, del vivere,
aleggia costante la presenza di Dio che le dà un significato, l’illumina, la consola, la dischiude alla
promessa dell’eternità. È un Dio che atterra il potente e aiuta l’oppresso, «che affanna e che
consola», che, nell’intricata e sanguinosa storia degli uomini, svolge, per vie arcane, un suo piano
provvidenziale di bene e di redenzione. Per questo il Manzoni sente il valore altissimo della vita, la
sua dignità, e, potremmo dire, la sua santità: in ogni momento di essa vede, infatti, svolgersi una
vicenda che si prolunga nell’eternità, mentre la fede nell’intervento costante della Provvidenza nel
mondo gli da la certezza di un possibile, anche se travagliato trionfo finale del bene e della
giustizia anche in terra. (...)
Il realismo cristiano del Manzoni non approda a prospettive rivoluzionarie in senso politico e
sociale. La rivendicazione della dignità degli umili non comporta quella d’una nuova iniziativa del
popolo, del suo riscatto dalla miseria e dall’oppressione, della sua acquisizione alla cultura
moderna e all’iniziativa risorgimentale (...).Ma l’insegnamento del Manzoni non è, tuttavia, quello
ricavato dai moderati che ne decretarono il trionfo, riducendolo a modeste prospettive
conservatrici. Quello dei Promessi Sposi è, infatti, un messaggio difficile e problematico, non
un’edulcorata propaganda cattolica. Mentre il poeta si china sull’animo dei suoi personaggi per
ritrovarvi la voce di Dio, scopre l’uomo, la sua psicologia tormentata e contraddittoria, mentre
promette la pace e la felicità nei cieli, si protende nell’attesa della giustizia da conquistare nel
mondo, mentre propone alla vita una giustificazione ultraterrena, avverte che questa comincia qui,
in terra, nell’affermazione della libertà, dell’eguaglianza, del rispetto dell’uomo (di ogni uomo) e
della sua vita, anche della più umile. Nel suo scavo sofferto e profondo dell’interiorità, il Manzoni
rivela quanto siano difficili la conquista della verità e la serietà della professione morale,
continuamente contraddette dall’ipocrisia, dal conformismo, dall’insincerità verso noi stessi, che
sono poi aspetti dell’egoismo utilitaristico sia nel campo individuale sia in quello sociale. Questa
strenua ricerca della verità dell’uomo nella vita quotidiana e nella storia porta il Manzoni a
demistificare la prospettiva umanistico-eroica della nostra cultura e delle nostre: lettere, sì che egli
può essere considerato col Leopardi il fondatore della letteratura italiana moderna.
(da LETTERATURA ITALIANA – 3 L’Ottocento, M. PAZZAGLIA
Ed. ZANICHELLI, Bologna 1993, pag. 239-241)
9
L’ETÀ DEL REALISMO
12. Il panorama letterario italiano del secondo Ottocento
Sarebbe difficile unificare in una prospettiva culturale comune la produzione letteraria dopo
l'Unità, caratterizzata com'è da un'irrequietezza strettamente connessa alle difficoltà ideologiche,
politiche e sociali che si sono fatte rilevare finora. Va inoltre ricordato che essa è rivolta a un
numero di lettori pur sempre limitato, che crescerà solo lentamente, col diminuire
dell'analfabetismo. Anche per questa ragione non esprime tutta la realtà sociale di quegli anni.
I diseredati, ad esempio, sono quasi completamente privi di una loro voce. (...) Si ebbe una
produzione narrativa attenta alle questioni sociali che rimase, per la modesta consistenza
culturale, vicina alla letteratura di consumo e legata a un generico populismo sentimentale, di cui è
prova evidente il «socialismo» presente nel libro Cuore del De Amicis. (...)
La letteratura «alta» dell'epoca è legata alla cultura borghese e presenta, a volte nello
stesso autore, intrecci ideologici contraddittori. Negli stessi anni, ad esempio fra '80 e '90,
coesistono il vecchio idealismo d'ascendenza mazziniana, la tematica tardo-romantica, entrata,
oltre che nella letteratura, nel costume, il Positivismo e le prime avvisaglie decadentistiche, come
si può vedere esaminando la produzione carducciana di quegli anni o considerando, per fare un
esempio, la pubblicazione coeva, nel 1889, di testi come il secondo volume delle Odi barbare del
Carducci, Mastro Don Gesualdo del Verga, II piacere del D'Annunzio, Malombra del Fogazzaro.
Si possono approssimativamente indicare queste date, per le singole correnti: gli anni fra il '60 e la
fine degli anni Settanta per la Scapigliatura; gli anni Ottanta come momento culminante del
Verismo, cui succede un più risoluto affermarsi delle tendenze decadentistiche. Ma la realtà
presenta un intreccio complesso e coevo tra i vari movimenti, e di questi con altre esperienze (...).
Un fenomeno notevole e tipicamente italiano di questi anni fu il nuovo Classicismo,
rappresentato soprattutto dal Carducci. Esso va collegato a una tradizione non mai spenta
nell’Ottocento, in quanto, fin dalla prima polemica classico-romantica, fu visto come un carattere
specificatamente nazionale della nostra cultura, in opposizione al Romanticismo, considerato
come movimento d’importazione. Per tutto il secolo c’era stata inoltre una linea politico-letteraria di
derivazione alfieriana e foscoliana, e quindi classicheggiante, legata alla Sinistra risorgimentale.
Il nuovo classicismo viene ora incontro alla volontà dei moderati di non cambiare il mondo, cioè di
esorcizzare quanto vi può essere di rivoluzionario nel pensiero e nella sensibilità del tempo
(soprattutto sul piano sociale), chiudendolo in forme composte e assumendolo in una prospettiva
di conservatorismo illuminato, aperto cautamente al progresso, pronto a fare alcune concessioni al
popolo, ma non a lasciargli una reale iniziativa politica. È, insomma, un classicismo borghese; e la
borghesia, in effetti, decretò il grande successo del Carducci, considerato «vate» della nuova
Italia, mentre reagiva con diffidenza o indifferenza a Verga e al Verismo.
(op. cit., pag.496-497)
13. La «Scapigliatura»
Il nome «Scapigliatura» definisce una corrente letteraria, fiorita tra il '60 e l'80. Fu composta
da un gruppo di scrittori lombardi (Emilio Praga, Arrigo Boito, Carlo Pisani Dossi) che ebbero a
Milano il loro luogo d’incontro, furono legati di amicizia e da somiglianza di vita e di costume. Non
riuscirono a elaborare una nuova poetica ben definita, ma vollero essere scrittori di avanguardia,
ribelli, nell’arte e nella vita, alla letteratura ufficiale, cioè al manzonismo e al suo spirito cristiano,
alla retorica patriottica, a ogni conformismo letterario o di costume. (...)
Gli Scapigliati di continuo oscillarono fra uno smarrimento conseguente al tramonto dei valori
risorgimentali, e l’incapacità di liberarsi pienamente del passato; fra un’ansia di romantici ideali e il
sentimento scorato della loro ineluttabile fine, fra la realtà gretta e meschina e il desiderio del
sogno, dell’evasione. Fu un contrasto esasperatamente romantico, che essi vissero con
abbandono totale, portato a volte fino al ripudio della vita. Dal nostro primo Romanticismo li
distingue, però, soprattutto il loro individualismo anarchico e antiborghese. (...) Anticiparono due
correnti posteriori nettamente contrastanti: il Decadentismo e il Verismo.
(op. cit., pag.532-533)
10
GIOSUÈ CARDUCCI
14. La reazione classicistica carducciana
A confronto dei classicisti contemporanei, al pari dei quali si propose di reagire al fiacco
sentimentalismo degli ultimi romantici, GIOSUÈ CARDUCCI (1835-1907) rivela una spiccata e
originale personalità sostenuta da ben più profonde, serie, vive esigenze di rinnovamento.
Il suo classicismo non si esaurisce in una retorica, formale fedeltà alla tradizione
espressiva nazionale, in una formalistica opposizione alla libertà espressiva proclamata dai
romantici, ma si traduce soprattutto in una concezione morale derivata dai classici: concezione
energica, attiva, antimistica che per diversi aspetti s’accorda con quella illuministica e rifiuta ogni
forma di stanca sentimentalità, di morbosa sensibilità, di vaga religiosità ed esalta invece l’umana
operosità, l’energia interiore, la schiettezza del sentire. Alla luce di questa concezione polemizza
contro la poesia degli ultimi romantici, nella quale vede la testimonianza di una intima fiacchezza
morale (...). Contro di essa esalta l’ideale di una poesia aliena ad ogni sentimentalismo, ispirata a
forti e schietti affetti, alla vita colta nei suoi valori fondamentali, intesa a educare, a instaurare una
nuova coscienza civile e morale, ad alimentare il culto della libertà e della patria: quella poesia che
aveva trovato le sue ultime grandi voci nell’Alfieri, nel Foscolo, nel Leopardi delle canzoni civili.
Appare evidente quanto il fine, l’intento morale, l’ufficio civile che il Carducci assegna alla
poesia, discendano direttamente dalla poetica del nostro primo romanticismo. Ma egli crede
fermamente che il suo ideale di poesia civile, di una umanità schietta, energica, combattiva,
fiduciosa nel proprio operare, possa realizzarsi soltanto attraverso la disciplina, le forme sobrie,
scultorie, pregnanti, limpide ed elette dei classici. (...) Ma è pur vero che l’ideale classicistico
dell’uomo e della vita, di cui il Carducci si fa assertore e banditore, tradisce al fondo qualcosa di
angusto e libresco, di programmatico e di polemico e spesso limita, comprime o rintuzza o falsa o
svia quella ricchezza e schiettezza e varietà di affetti che pur il poeta sentiva agitarsi e lievitare al
fondo dell’animo, le note più profonde e moderne, quelle che attestano la sua più intima adesione
all’eredità romantica: il contrasto tra l’ideale e il reale, il sentimento della vita come incessante
sforzo di inseguire sogni continuamente sfuggenti; il senso della morte come dissoluzione, l’eterno,
implacabile fluire della vita, il cadere di ogni umana cosa.
Di qui il tono retorico, l’impressione che qualcosa di voluto e di forzato (...) che una sorta di
diaframma letterario offuschi molte sue poesie. E d’altra parte l’impressione che la poesia genuina,
autentica, sorga proprio quando il poeta riesce a liberarsi dal suo assunto programmatico, a
ritrovare il punto esatto di coincidenza tra il suo sentire, la sua educazione letteraria e la sua
concezione classicistica dell’uomo e della vita. Sono questi i momenti di schietta e impetuosa e
sincera partecipazione alle lotte civili, i momenti di appassionata polemica nei quali il poeta libera il
suo temperamento attivo, forte, fiducioso nell’operare umano; e ancora i momenti nei quali il poeta
si ripiega su di sé, quasi in una pausa meditativa, e avverte la propria solitudine, il senso della
vanità della propria battaglia, e sente il fatale fluire della vita, la forze distruttrice del tempo cui
contrasta la solennità immobile della natura, il contrasto tra la vita come luce ed energia perenne e
la morte come tenebra, silenzio, annullamento.
(da ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, AAVV Ed. D’ANNA, Messina 1969,
vol. III Parte Seconda, pag.48-50)
15. Le idee e la poetica del Carducci
Dal Positivismo il Carducci riprese l’interpretazione generale del mondo dominato da leggi
fisiche e l’idea che ragione e scienza dovevano servire all’uomo per comprendere la natura,
distruggere le false credenze soprannaturali e guidarlo alla conquista del progresso, della libertà e
della democrazia. (...).
A questo naturalismo si legano un sentimento romantico della storia come un vasto poema,
epico e drammatico, in cui s’affermano nei secoli, di là dalla caducità dei singoli, i supremi valori
spirituali: libertà, giustizia, patria e fraternità umana. Il Carducci sentì che una misteriosa forza
provvidenziale muove la vicenda degli uomini, realizzando, pur fra le loro cadute e aberrazioni, il
giusto e il bene; e mazzinianamente la vide incarnata nel popolo, nelle nazioni libere e
11
democratiche. Di qui nasce il suo sentimento costruttivo della vita, che non ignora il dolore e il nulla
della morte, ma non s’accascia dinanzi alla loro ombra inesplicabile; cerca anzi, nel costruire in
fraterna solidarietà con gli uomini il grande edificio della civiltà, la giustificazione dell’esistenza.
Questo gli parve l’insegnamento più alto della classicità, che egli sentì come la tradizione
genuina del nostro popolo. Roma rappresentò per lui la sintesi della civiltà greca e latina, intesa
alla esaltazione della libera attività dell’uomo nel mondo e per il mondo, la città che aveva unificato
l’Italia in nazione e aveva donato al mondo una superiore civiltà. Il suo spirito aveva permeato le
età più gloriose della nostra storia (il Comune, il Rinascimento) e doveva ora ispirare l’Italia risorta.
(...) La critica recente ha individuato il nucleo centrale della poesia carducciana in un
nostalgico amore della vita nella sua luminosa pienezza, intimamente unito a un sentimento della
morte come totale e fisica privazione della vita; in un contrasto fra sole e ombra. La compresenza
dei due motivi, vissuti dal poeta non nella forma di una meditazione filosofica, ma come intuizione
primordiale del contrasto dell’esistenza, rende più energica l’aspirazione agli ideali più alti. (...)
16. Il «magistero» carducciano
Nonostante il classicismo, la vivace polemica antiromantica, l’accoglimento di più d’un
motivo della cultura positivistica, il Carducci restò legato alla prospettiva romantico-idealistica della
storia come divenire dell’«Idea», ossia come affermazione sicura e progressiva dei grandi ideali
che costituiscono la civiltà. Non approdò a un pensiero originale, ma tentò una sintesi delle
persuasioni dominanti, magari con qualche semplificazione e conciliazione eccessiva, che resero,
d’altra parte, il suo messaggio più facilmente accessibile a larghi strati della borghesia. In effetti
egli fu il maestro riconosciuto di alcune generazioni di Italiani, e il suo influsso ideologico perdurò,
nel Novecento, fino al periodo fra le due guerre; cosa che non sarebbe stata possibile senza
un’involuzione, o, per lo meno, un arresto della crescita socio-politica del Paese. (...)
Gli va certamente attribuito il merito, in un’età di tendenziale disimpegno ideologico quale fu
quella che seguì immediatamente il compiersi dell’Unità (...) di avere vigorosamente richiamato gli
ideali di libertà, giustizia, patria, umanità, che erano poi l’unica cultura dello stato unitario, senza
indulgere agli incipienti eccessi nazionalistici. La sua esaltazione della romanità venne ben presto
stravolta, a cominciare dal D’Annunzio, in senso imperialistico (...).
L’idea d’un «primato» italiano era invece, come s’è già detto, largamente utopistica, dato che
l’Italia di allora aveva, evidentemente, assai più da imparare che da insegnare. Nuocciono, a
questa parte del messaggio carducciano, la sua genericità, la sua fondamentale astrattezza,
l’assenza completa d’ogni vera problematica sociale, in anni, per giunta, di rivoluzione industriale
in Italia e in Europa, quando l’avvenire civile del nuovo stato italiano si giocava proprio sulla sua
capacità di inserire o meno nella vita nazionale attiva le grandi masse che erano state escluse dal
Risorgimento, come lo erano, da secoli, dalla vita nazionale effettiva.
Quello del Carducci è un atto di culto rivolto a ideali che gli venivano dal passato, e in questo
senso egli può essere considerato una figura conclusiva del Risorgimento, che ne preannuncia,
nel contempo, l’involuzione, propria d’ogni cultura o movimento che, abbia esaurito la sua funzione
storica. Il suo limite, che egli ebbe in comune, del resto, con tutta la Sinistra storica, dalla quale
maturarono in quegli anni le soluzioni autoritaristiche d’un Crispi, sta nel non avere rimeditato
quegli ideali, la loro valenza attuale effettiva, nel non averli confrontati con la realtà. (...)
Quest’immagine del movimento risorgimentale, ignara del socialismo d’un Pisacane e delle
motivazioni sociali del brigantaggio meridionale, fu costruita da una destra liberale e monarchica e
propagandata nelle scuole fino alla fine della seconda guerra mondiale, conquistando larghi strati
nella piccola e media borghesia. Carducci divenne, nell’interpretazione «estetica» di Benedetto
Croce, l’ultimo figlio di Omero, un poeta «sano» da contrapporre alla «malattia» attestata dalla
letteratura del Novecento: che era poi l’espressione del grave disagio nato dalla rivoluzione
industriale e dai conseguenti conflitti di classe, dall’imperialismo e dalle sue guerre, dai reali
contrasti sociali e ideologici della storia europea dell’ultimo secolo.
Per tutte queste ragioni egli resta di qua dalla civiltà letteraria del Novecento. Anche “la
restaurazione classicistica operata da lui nel linguaggio poetico, soprattutto nelle Odi barbare, è
lontana dalla sperimentazione linguistica che verrà operata dai nuovi poeti, a partire dal Pascoli.
(da LETTERATURA ITALIANA – 3 L’Ottocento, M. PAZZAGLIA
Ed. ZANICHELLI, Bologna 1993, pag. 578-581)
12
GIOVANNI VERGA
17. Dai primi romanzi alla poetica verista
Prima di aderire a una poetica veristica, il Verga ripercorre il cammino della narrativa
ottocentesca. Mentre nelle prime prove ricalca i modi del romanzo storico, con echi frequenti dello
Scott, del Byron, di Dumas padre, in Una peccatrice, Storia d’una capinera, Tigre reale, Eva, Eros,
appare legato alla sensibilità tardo-romantica e scapigliata. La materia di questi romanzi è
passionale, l’ambiente è alto-borghese, individualistico e raffinato, che nell’amore cerca una
romantica evasione dalla piattezza del vivere quotidiano, un mondo di sensazioni nuove e intense,
anche se, alla fine, piomba nell’angoscia della passione delusa. Ma già in questi romanzi,
attraverso un fondo torbido di romanticismo autobiografico, comincia a intravedersi un’ispirazione
più originale. (...).
Alla Sicilia ritorna più decisamente il Verga con la novella Nedda (1874), una tappa
importante nella conquista d’un mondo poetico originale. È una storia di miseria e di sventura,
ambientata fra il bracciantato siciliano (...), scavata in una realtà sociale precisa, come precisa è la
psicologia del personaggio centrale; determinata dalla miseria che induce a condizioni di vita subumane, ma, al tempo stesso, capace di affetti intensi e profondi; ed è, soprattutto, una vicenda
«vera», legata alla vitalità elementare, ai dolori «veri» e alle gioie «vere» della gente umile, al
dramma della lotta per la vita. La novità del racconto sta nel tentativo di un’arte oggettiva, che
segua il meccanismo reale della vicenda e dei sentimenti dei protagonisti, senza modifiche
imposte dalla volontà, o meglio, dalla cultura dell’autore. Vi si aggiunge la pietà contenuta ma
profonda, per il mondo dei diseredati, sfruttati e oppressi da sempre, tragicamente rassegnati al
loro destino di sofferenza. (...)
Un nuovo passo, e per molti aspetti decisivo, sarà costituito dalle esperienze delle prime
novelle accolte, poi, in Vita dei campi: Fantasticheria e, soprattutto, Rosso Malpelo. Con esse il
Verga si allineava con la corrente più viva del romanzo europeo contemporaneo, accogliendo la
lezione del Naturalismo come metodo d’indagine della realtà e componendola con le istanze
regionalistiche e veristiche che egli veniva svolgendo in quegli anni sia attraverso il dialogo col
Capuana e il De Roberto, sia attraverso una propria maturazione spirituale, culturale, letteraria
incentrata sulla ricerca appassionata del vero, sul piano artistico e umano. (...)
La prefazione ai Malavoglia rivela il progetto verghiano d’una serie di romanzi intesi a
un’interpretazione progressiva e totale della vita umana nella società. I due romanzi maggiori
dovevano essere il semplice inizio del ciclo dei vinti (...).
18. Un verismo problematico
Il pessimismo nei confronti dell’idea positivistica del progresso isola il Verga nel panorama
europeo, conferendo alla sua ricerca e ai suoi esiti un carattere patetico inconfondibile. Il
progresso «fatale» della specie si costruisce, a suo avviso, sull’infelicità della persona, e questa
coopera, sì, al progresso, ma inconsciamente. All’osservatore resta il senso d’una pena incessante
del vivere, che si perde poi, finalmente, nel nulla.
Si può parlare, in proposito, d’una concezione materialistica della realtà, nel senso che
l’indagine condotta ai vari livelli sociali rivela che l’economicità, e l’egoismo che ne consegue, sono
i motori reali della storia, sia del singolo sia dell’umanità. L’«accorgersi che non si sta bene e che si
potrebbe star meglio», la «vaga bramosia dell’ignoto» che si traduce nella ricerca della ricchezza
come potere, secondo le conclusioni dei romanzi del ciclo compiuti, o in forme d’ambizione più
elevata, come avrebbero dovuto dimostrare i romanzi del ciclo che poi non vennero scritti, si
traduce però in uno scacco, di fronte all’intervento avverso della società, o, conclusivamente, della
morte. E siccome non c’è, nel Verga, l’idea d’una trascendenza in senso religioso, e neppure
quella d’un divenire storico progressivo - romantico o positivistico che fosse - la spinta esistenziale
rimane chiusa in un cerchio di affermazioni individuali, in un sostanziale egoismo che è la
condanna e, insieme, la pena dell’individuo: del «vinto». Anche i sentimenti più generosi, gli affetti
domestici, la santità della casa, l’amore restano, al più, come un conforto, un mezzo di
sopravvivenza, non conducono a una reale evoluzione.
13
Il pessimismo verghiano raggela miti, speranze, vicende dei protagonisti in una fissità
desolata; non concede altro eroismo che la resistenza alla vita, l’attaccamento coraggioso allo
scoglio dove la fortuna li ha fatti cadere. Resta, negli umili, il conforto del focolare domestico, della
«religione» della famiglia, della casa, del lavoro, che appare tuttavia sempre più problematica con
l’elevarsi della scala sociale, sempre più sommersa dalla legge universale di avidità e di trionfo
sull’altro, come si può vedere nel passaggio da I Malavoglia a Mastro-don Gesualdo, da Vita dei
campi a Novelle rusticane.
Nasce di qui la perplessità di alcuni critici di fronte a questo Verga ora «progressivo» ora
«regressivo». Progressivo per la capacità demistificatrice del suo sguardo lucido e rigorosamente
etico sulla realtà della società del suo tempo - già scossa, peraltro, da vivi fermenti sociali e
socialisti -, e regressivo nella sua visione disincantata e pessimistica, conservatrice, quando non
reazionaria, come appare da certe scelte politiche. Ora (...) l’ambiguità verghiana rivela un
sentimento della realtà conflittuale, combattuto, al quale l’artista reagisce chiedendo all’arte un
mezzo di penetrazione sicura nel groviglio della realtà, una più autentica forma conoscitiva.
(...) Testimone d’una società da lui concepita senza speranza di mutamento, il Verga affida
al suo naturalismo e verismo (o come si vogliano chiamare) un compito di testimonianza che l’arte
deve - egli pensa - rendere fedelmente, assumendo tutta la sua responsabilità conoscitiva. Il suo
verismo assume, cioè, il metodo positivo e l’istanza scientifica dell’impersonalità che diventano un
mezzo di comprensione della realtà, nella sua complessità di sfumature e di contraddizioni; la
premessa necessaria per rappresentarla nel romanzo coi colori del vero.
19. Lo stile verghiano
A questo punto, la conquista d’uno stile di rappresentazione adeguato all’oggetto, e cioè
alla nuova conoscenza del «vero», in cui sta la profonda motivazione dell’arte verghiana, diventa
conquista non tanto della parola, ma della cosa. Lo sforzo dello scrittore è rivolto a una
ricostruzione del mondo nelle e con le parole con cui i suoi personaggi lo conoscono e lo vivono. È
questa la grande novità delle novelle e dei romanzi che chiameremo «siciliani» (...).
Nelle narrazioni siciliane il Verga ritrova, infatti, una forma di stile che si potrebbe definire
«corale», nel senso che riflette la parlata dialettale, non nel lessico, ma nella sintassi; e questa non
consiste soltanto nell’ordine dato al periodare, ma in quello conferito alla narrazione: al modo, cioè,
in cui la successione degli eventi, gli oggetti, la vita si presentano alla mente d’una voce-narrante
popolare, del tutto calata in una forma di racconto vissuto che tenta di definire cose e fatti in piena
congruenza con la mentalità dei protagonisti. Questo è il più importante artificio del Verga, che gli
consente la desiderata impersonalità e, al tempo stesso, definisce più incisivamente e
drammaticamente il personaggio, sia pure in una dimensione generalmente popolare, che
costituisce la sua cultura, il suo modo di esistere, di presentarsi nella vita; anche se poi questo non
implica una minore responsabilità nelle sue scelte. Il Verga ha voluto mettere il lettore borghese
davanti al personaggio contadino colto nella sua mentalità, nella sua verità, che nasce da un modo
di percepire le cose e di contenersi diverso da quello di colui che sa leggere e scrivere, del
borghese che vive nella città, della persona colta. Egli scrive, per esempio, descrivendo una
tempesta sul mare: «all’improvviso il vento si mise a fischiare al pari della macchina della ferrovia
quando esce dal buco del monte»; portando il lettore a vedere le cose come le vede il
personaggio, col suo primitivo stupore davanti alla macchina ignota che esce dalla galleria nella
roccia. Nella letteratura «alta» dell’epoca c’è un certo protagonismo del treno, che in Carducci, per
esempio, è simbolo del progresso, secondo una compiaciuta analogia intellettuale, lontana peraltro
dalla psicologia e quindi dalla coscienza linguistica dei Malavoglia.
Attraverso questo artificio compositivo della coralità o del narratore implicito (...) lo scrittore è
giunto alla bramata oggettività o impersonalità e, soprattutto, è riuscito a dare voce al silenzio
disperato d’una moltitudine tenuta fuori della storia, l’ha fatta entrare nella cultura e nella coscienza
della nazione italiana, affermando, nel contempo, la sua fede nella moralità, nella bellezza e nella
forza del vero.
(op. cit., pag.654-658)
14
NOTE BIOGRAFICHE ESSENZIALI
ALESSANDRO MANZONI (1785-1873)
1785 – nasce a Milano ALESSANDRO MANZONI, figlio del conte Pietro e di Giulia Beccaria; riceve la
prima educazione nei collegi dei padri somaschi, poi dei barnabiti.
1795 – Giulia si separa dal marito e va a vivere a Parigi con il conte Carlo Imbonati.
1801/05 – a Milano, il giovane Alessandro ha contatti con esuli politici, accosta le idee illuministe,
conosce Monti e Foscolo, abbraccia il radicalismo giacobino e anticlericale.
1805 – raggiunge a Parigi la madre, dopo la morte di Imbonati, mai conosciuto di persona, ma
celebrato in una famosa poesia. Recupera il rapporto con Giulia e il suo affetto materno.
1808 – sposa la ginevrina Enrichetta Blondel, calvinista, si interessa alle tematiche religiose.
1810 – si “converte” al cattolicesimo e torna a Milano, dove vivrà quasi ininterrottamente fino alla
morte, nel palazzo di Via Morone, oggi sede del museo manzoniano.
1812/27 – è il periodo più fecondo, in cui scrive odi, tragedie e la prima stesura del romanzo.
1833/39 – è colpito da numerosi lutti familiari (perde la moglie, 4 figlie, la madre).
1840 – dopo una accuratissima revisione linguistica, esce l’edizione definitiva de I Promessi Sposi.
Nello stesso anno si risposa con Teresa Borri Stampa, donna di forte personalità e grande cultura.
1861 – è nominato senatore a vita del nuovo Regno d’Italia, onorato come un padre della Patria.
1873 – il 22 maggio muore per i postumi di un trauma cranico. Verdi dedicherà alla sua memoria la
Messa di Requiem. È sepolto nel Famedio del cimitero Monumentale di Milano.
GIOSUĖ CARDUCCI (1835-1907)
1835 – nasce a Valdicastello (Lucca) GIOSUÈ CARDUCCI, figlio del medico carbonaro Michele e di
Ildegonda Celli. Trascorre l’infanzia in Maremma, prima a Bolgheri poi a Castagneto.
1849 – la famiglia si trasferisce a Firenze, dove Giosuè frequenta le scuole degli scolopi, gettando
le basi della sua vastissima cultura umanistica, classica e moderna. Detesta il Manzoni.
1856 – si laurea alla Scuola Normale di Pisa e inizia la carriera di docente.
1857/58 – in seguito al suicidio del fratello Dante e alla morte del padre, deve provvedere ai
bisogni della famiglia; intanto sposa Elvira Menicucci, dalla quale avrà quattro figli.
1860 – viene nominato docente di eloquenza all’università di Bologna, dove vivrà per il resto della
sua esistenza, svolgendo un’imponente attività di erudito e critico letterario.
1868 – scrive la raccolta Levia gravia, poesie dominate da un forte impegno civile. Seguiranno
importanti raccolte: Giambi ed epodi (1882), di forte polemica politica, le Rime nuove (1887), in cui
si celebra la natura e il paesaggio, le Odi barbare (1893), in cui esalta la storia d’Italia.
1890 – è nominato senatore del Regno e sostiene la politica del Crispi.
1904 – abbandona l’insegnamento per motivi di salute, lasciando la cattedra a Giovanni Pascoli.
1906 – riceve il premio Nobel per la letteratura.
1907 – muore il 16 febbraio, di cirrosi epatica; è sepolto nella Certosa di Bologna.
GIOVANNI VERGA (1840-1922)
1840 – nasce a Catania GIOVANNI VERGA, in una famiglia di nobili origini e di tradizioni liberali, che
lo indirizza agli studi di legge, che il giovane però interrompe per dedicarsi alla letteratura.
1869 – lascia la Sicilia per recarsi a Firenze, che diverrà nel 1867 la capitale d’Italia.
1872 – si trasferisce a Milano, dove viene in contatto con artisti della Scapigliatura lombarda e
frequenta il salotto letterario della contessa Maffei.
1874 – esce la sua prima novella “verista”, Nedda, nella quale compare uno stile del tutto nuovo.
1881 – nel romanzo I malavoglia si chiariscono e consolidano i cardini della sua visione letteraria.
1894 – il successo di Cavalleria rusticana inaugura la stagione del verismo teatrale
1889 – pubblica Mastro Don Gesualdo, il primo grande romanzo italiano dell’alienazione borghese.
1915 – negli ultimi anni conduce vita isolata a Catania, ma allo scoppio della guerra, prende una
decisa posizione a fianco degli interventisti.
1920 – riceve pubbliche onoranze per i suoi 80 anni e il re lo nomina senatore del Regno.
1922 – il 27 gennaio muore per emorragia cerebrale. Riposa nel cimitero Monumentale di Catania.
15
ALESSANDRO MANZONI
da ADELCHI (1822) ATTO QUINTO, scena ottava, Morte di Adelchi
DESIDERIO
ADELCHI
(...)
DESIDERIO
ADELCHI
DESIDERIO
ADELCHI
- Orrendo m’è il vederti così.
- Molti sul campo cadder così per la mia mano.
- O fronte balda e serena! Oh man gagliarda! Oh ciglio che spiravi il terror!
- Cessa i lamenti, cessa o padre, per Dio! Non era questo il tempo di morir? Ma tu,
che preso vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nol comprende che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno:
deh! Nol pianger: mel credi. Allor che a questa ora tu stesso appresserai, giocondi
si schiereranno al tuo pensier dinanzi gli anni in cui re non sarai stato, in cui né
una lagrima pur notata in cielo fia contro te, né il nome tuo saravvi con l’imprecar
de’ tribolati asceso.
Godi che re non sei, godi che chiusa all’oprar t’è ogni via: loco a gentile, ad
innocente opra non v’è: non resta che far torto, o patirlo. Una feroce forza il mondo
possiede, e fa nomarsi dritto (...) Reggere iniqui dolce non è; e tu l’hai provato: e
fosse; non dee finir così? Questo felice, cui la mia morte fa più fermo il soglio, cui
tutto arride, tutto plaude e serve, questo è un uom che morrà.
- Ma ch’io ti perdo, figlio, di ciò chi mi consola?
- Il Dio che di tutto consola.
da ADELCHI ATTO QUARTO, Coro, Morte di Ermengarda
Sparsa le trecce morbide
sull’affannoso petto,
lenta le palme, e rorida
di morte il bianco aspetto,
giace la pia, col tremolo
sguardo cercando il ciel.
(...)
Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;
leva all’Eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
fuor della vita è il termine
del lungo tuo martir.
(...)
Ahi! nelle insonni tenebre,
pei claustri solitari,
tra il canto delle vergini,
ai supplicanti altari,
sempre al pensier tornavano
gl’irrevocati dì;
quando da un poggio aereo,
il biondo crin gemmata,
vedea nel pian discorrere
la caccia affacendata,
e sulle sciolte redini
chino il chiomato sir;
(...)
Ma come il sol che reduce
l’erta infocata ascende,
e con la vampa assidua
l’immobil aura incende,
risorti appena i gracili
steli riarde al suol,
Te dalla rea progenie
degli oppressor discesa,
cui fu prodezza il numero,
cui fu ragion l’offesa
e dritto il sangue, e gloria
il non aver pietà,
ratto così dal tenue
obblio torna immortale
l’amor sopito, e l’anima
impaurita assale
e le sviate immagini
richiama al noto duol.
Muori; e la faccia esanime
si ricomponga in pace;
com’era allor che improvida
d’un avvenir fallace,
lievi pensier virginei
solo pingea. Così
quando ancor cara, improvida
d’un avvenir mal fido,
ebbra spirò le vivide
aure del Franco lido,
e tra le nuore Saliche
invidiata uscì:
Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;
leva all’Eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
(...)
dalle squarciate nuvole
si svolge il sol cadente,
e, dietro il monte, imporpora
il trepido occidente:
al pio colono augurio
di più sereno dì.
te collocò la provida
sventura in fra gli oppressi:
muori compianta e placida:
scendi a dormir con essi:
alle incolpate ceneri
nessuno insulterà.
16
ODE - IL CINQUE MAGGIO (luglio 1821)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore,
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,
Muta pensando all’ultima
Ora dell’uom fatale;
Né sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.
Lui folgorante in solio
Vide il mio genio, e tacque;
Quando con vece assidua
Cadde, risorse, e giacque,
Di mille voci al sonito
Mista la sua non ha:
Vergin di servo encomio
E di codardo oltraggio,
Sorge or commosso al subito
Sparir di tanto raggio;
E scioglie all’urna un cantico
Che forse non morrà.
Dall’Alpi alle Piramidi,
Dal Manzanarre al Reno,
Di quel securo il fulmine
Tenea dietro al baleno;
Scoppiò da Scilla al Tanai,
Dall’uno all’altro mar.
Fu vera gloria? Ai posteri
L’ardua sentenza; nui
Chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
Del creator suo spirito
Più vasta orma stampar.
La procellosa e trepida
Gioia d’un gran disegno,
L’ansia d’un cor che indocile
Serve, pensando al regno;
E il giunge, e tiene un premio
Ch’era follia sperar;
Tutto ei provò: la gloria
Maggior dopo il periglio,
La fuga e la vittoria,
La reggia e il tristo esiglio:
Due volte nella polvere,
Due volte sull’altar.
Ei si nomò: due secoli,
L’un contro l’altro armati,
Sommessi a lui si volsero,
Come aspettando il fato;
Ei fe’ silenzio, ed arbitro
S’assise in mezzo a lor.
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
E sparve, e i dì nell’ozio
Chiuse in sì breve sponda,
Segno d’immensa invidia
E di pietà profonda,
D’inestinguibil odio
E d’indomato amor.
Come sul capo al naufrago
L’onda s’avvolve e pesa,
L’onda su cui del misero,
Alta pur dianzi e tesa,
Scorrea la vista a scernere
Prode remote invan;
Tal su quell’alma il cumulo
Delle memorie scese!
Oh quante volte ai posteri
Narrar sé stesso imprese,
E sull’eterne pagine
Cadde la stanca man!
Oh! quante volte, al tacito
Morir d’un giorno inerte,
Chinati i rai fulminei,
Le braccia al sen conserte,
Stette, e dei dì che furono
L’assalse il sovvenir!
E ripensò le mobili
Tende, e i percossi valli,
E il lampo de’ manipoli,
E l’onda dei cavalli,
E il concitato imperio,
E il celere ubbidir.
Ahi! forse a tanto strazio
Cadde lo spirto anelo,
E disperò; ma valida
Venne una man dal cielo,
E in più spirabil aere
Pietosa il trasportò;
E l’avviò, pei floridi
Sentier della speranza,
Ai campi eterni, al premio
Che i desideri avanza,
Dov’è silenzio e tenebre
La gloria che passò.
Bella immortal! benefica
Fede ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
Ché più superba altezza
Al disonor del Golgota
Giammai non si chinò.
Tu dalle stanche ceneri
Sperdi ogni ria parola:
Il Dio che atterra e suscita,
Che affanna e che consola,
Sulla deserta coltrice
Accanto a lui posò.
17
da
I PROMESSI SPOSI
CAPITOLO I
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un
tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia
costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile
all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per
ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e
rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti,
scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il
Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è
chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano
a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli
altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un
pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, secondo
l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de’ torrenti, è
quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali; in qualche
parte boschi, che si prolungano su per la montagna.
Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal
ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un
gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che
prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò
l’onore d’alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati
spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo
in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di
spandersi nelle vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia.
Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da un poggio all’altro, correvano, e corrono
tuttavia, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, sepolte tra due muri,
donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto
elevate su terrapieni aperti (...).
Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera
del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra:
il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né
altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario,
tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la
schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i
ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi
all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i
fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze
di porpora. (...). Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era solito, lo sguardo al
tabernacolo, vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini
stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al confluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a
cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul
terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto.
L’abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si poteva distinguer
dell’aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo
una reticella verde, che cadeva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale
usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di
cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come
una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni:
uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d’ottone, congegnate come in cifra, forbite e
lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi. Questa specie, ora
del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia, e già molto antica.
18
(...) (digressione sul fatto che i “bravi” non sono perseguibili, nonostante le leggi)
Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente;
ma quel che più dispiacque a don Abbondio fu il dover accorgersi, per certi atti, che l’aspettato era
lui. Perché, al suo apparire, coloro s’eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal
quale si scorgeva che tutt’e due a un tratto avevan detto: è lui; quello che stava a cavalcioni s’era
alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l’altro s’era staccato dal muro; e tutt’e due gli s’avviavano
incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo
in su, per ispiar le mosse di coloro; e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da
mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso, se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di
strada, a destra o a sinistra; e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato
contro qualche potente, contro qualche vendicativo; ma, anche in quel turbamento, il testimonio
consolante della coscienza lo rassicurava alquanto: i bravi però s’avvicinavano, guardandolo fisso.
Mise l’indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo; e, girando le due
dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all’indietro, torcendo insieme la bocca, e guardando
con la coda dell’occhio, fin dove poteva, se qualcheduno arrivasse; ma non vide nessuno. Diede
un’occhiata, al di sopra del muricciolo, ne’ campi: nessuno; un’altra più modesta sulla strada
dinanzi; nessuno, fuorché i bravi. Che fare? tornare indietro, non era a tempo: darla a gambe, era
lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro,
perché i momenti di quell’incertezza erano allora così penosi per lui, che non desiderava altro che
d’abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella
quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso; quando si trovò a fronte dei due
galantuomini, disse mentalmente: ci siamo; e si fermò su due piedi.
- Signor curato, - disse un di que’ due, piantandogli gli occhi in faccia.
- Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato
nelle mani, come sur un leggìo.
- Lei ha intenzione, - proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore
sull’intraprendere una ribalderia, - lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia
Mondella!
- Cioè... - rispose, con voce tremolante, don Abbondio: - cioè. Lor signori son uomini di mondo, e
sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c’entra: fanno i loro pasticci
tra loro, e poi... e poi, vengon da noi, come s’anderebbe a un banco a riscotere; e noi... noi siamo i
servitori del comune.
- Or bene, - gli disse il bravo, all’orecchio, ma in tono solenne di comando, - questo matrimonio
non s’ha da fare, né domani, né mai.
- Ma, signori miei, - replicò don Abbondio, con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere
un impaziente, - ma, signori miei, si degnino di mettersi ne’ miei panni. Se la cosa dipendesse da
me,... vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca...
- Orsù, - interruppe il bravo, - se la cosa avesse a decidersi a ciarle, lei ci metterebbe in sacco. Noi
non ne sappiamo, né vogliam saperne di più. Uomo avvertito... lei c’intende.
- Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli...
- Ma, - interruppe questa volta l’altro compagnone, che non aveva parlato fin allora, - ma il
matrimonio non si farà, o... - e qui una buona bestemmia, - o chi lo farà non se ne pentirà, perché
non ne avrà tempo, e... - un’altra bestemmia.
- Zitto, zitto, - riprese il primo oratore: - il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo; e noi
siam galantuomini, che non vogliam fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato,
l’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente.
Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte d’un temporale notturno, un lampo
che illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per
istinto, un grand’inchino, e disse: - se mi sapessero suggerire...
- Oh! suggerire a lei che sa di latino! - interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il
feroce. - A lei tocca. E sopra tutto, non si lasci uscir parola su questo avviso che le abbiam dato
per suo bene; altrimenti... ehm... sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che
si dica in suo nome all’illustrissimo signor don Rodrigo?
- Il mio rispetto...
- Si spieghi meglio!
19
-... Disposto... disposto sempre all’ubbidienza -. E, proferendo queste parole, non sapeva nemmen
lui se faceva una promessa, o un complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle nel
significato più serio.
- Benissimo, e buona notte, messere, - disse l’un d’essi, in atto di partir col compagno. Don
Abbondio, che, pochi momenti prima, avrebbe dato un occhio per iscansarli, allora avrebbe voluto
prolungar la conversazione e le trattative. - Signori... - cominciò, chiudendo il libro con le due mani;
ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada dond’era lui venuto, e s’allontanarono,
cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero don Abbondio rimase un momento
a bocca aperta, come incantato; poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua,
mettendo innanzi a stento una gamba dopo l’altra, che parevano aggranchiate. Come stesse di
dentro, s’intenderà meglio, quando avrem detto qualche cosa del suo naturale, e de’ tempi in cui
gli era toccato di vivere.
(...) (digressione sulle “gride” e sulla giustizia del tempo)
Il nostro Abbondio non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto,
prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d’essere, in quella società, come un vaso di terra
cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado,
ubbidito ai parenti, che lo vollero prete. (...)
Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull’animo del
poveretto, quello che s’è raccontato. Lo spavento di que’ visacci e di quelle parolacce, la minaccia
d’un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere, ch’era costato tant’anni
di studio e di pazienza, sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva veder come
uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capo basso di don Abbondio. “ Se
Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via; ma vorrà delle ragioni; e cosa ho da
rispondergli, per amor del cielo? E, e, e, anche costui è una testa: un agnello se nessun lo tocca,
ma se uno vuol contraddirgli... ih! E poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come...
Ragazzacci, che, per non saper che fare, s’innamorano, voglion maritarsi, e non pensano ad altro;
non si fanno carico de’ travagli in che mettono un povero galantuomo. Oh povero me! vedete se
quelle due figuracce dovevan proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderla con me! Che c’entro
io? Son io che voglio maritarmi? (...)
Giunto, tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, ch’era in fondo del paesello,
mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò, richiuse diligentemente; e,
ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito:- Perpetua! Perpetua! -, avviandosi pure
verso il salotto, dove questa doveva esser certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era
Perpetua, come ognun se n’avvede, la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che
sapeva ubbidire e comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le
fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più
frequenti, da che aveva passata l’età sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti
i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse,
come dicevan le sue amiche.
- Vengo, - rispose, mettendo sul tavolino, al luogo solito, il fiaschetto del vino prediletto di don
Abbondio, e si mosse lentamente; ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto, ch’egli v’entrò,
con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci
sarebbero nemmen bisognati gli occhi esperti di Perpetua, per iscoprire a prima vista che gli era
accaduto qualche cosa di straordinario davvero.
- Misericordia! cos’ha, signor padrone?
- Niente, niente, - rispose don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone.
- Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? così brutto com’è? Qualche gran caso è
avvenuto.
- Oh, per amor del cielo! Quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire.
- Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?...
- Ohimè! tacete, e non apparecchiate altro: datemi un bicchiere del mio vino.
- E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! - disse Perpetua, empiendo il bicchiere, e tenendolo
poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto
aspettare.
20
- Date qui, date qui, - disse don Abbondio, prendendole il bicchiere, con la mano non ben ferma, e
votandolo poi in fretta, come se fosse una medicina.
- Vuol dunque ch’io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? - disse
Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate davanti,
guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.
- Per amor del cielo! non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va... ne va la vita!
- La vita!
- La vita.
- Lei sa bene che, ogni volta che m’ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho
mai...
- Brava! come quando...
Perpetua s’avvide d’aver toccato un tasto falso; onde, cambiando subito il tono, - signor padrone, disse, con voce commossa e da commovere, - io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio
sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l’animo...
Il fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto,
quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo; onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi
e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più d’una volta giurare che non fiaterebbe,
finalmente, con molte sospensioni, con molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si
venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne
giuramento; e don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con
un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: - per amor
del cielo!
- Delle sue! - esclamò Perpetua. - Oh che birbone! oh che soverchiatore! oh che uomo senza timor
di Dio!
- Volete tacere? o volete rovinarmi del tutto?
- Oh! siam qui soli che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone?
- Oh vedete, - disse don Abbondio, con voce stizzosa: - vedete che bei pareri mi sa dar costei!
Viene a domandarmi come farò, come farò; quasi fosse lei nell’impiccio, e toccasse a me di
levarnela.
- Ma! io l’avrei bene il mio povero parere da darle; ma poi...
- Ma poi, sentiamo.
- Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant’uomo, e un
uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e, quando può fare star a dovere un di questi
prepotenti, per sostenere un curato, ci gongola; io direi, e dico che lei gli scrivesse una bella
lettera, per informarlo come qualmente...
- Volete tacere? volete tacere? Son pareri codesti da dare a un pover’uomo? Quando mi fosse
toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi! l’arcivescovo me la leverebbe?
- Eh! le schioppettate non si dànno via come confetti: e guai se questi cani dovessero mordere
tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi stimare, gli
si porta rispetto; e, appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siam ridotti a segno che tutti
vengono, con licenza, a...
- Volete tacere?
- Io taccio subito; ma è però certo che, quando il mondo s’accorge che uno, sempre, in ogni
incontro, è pronto a calar le...
- Volete tacere? È tempo ora di dir codeste baggianate?
- Basta: ci penserà questa notte; ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute;
mangi un boccone.
- Ci penserò io, - rispose, brontolando, don Abbondio: - sicuro; io ci penserò, io ci ho da pensare E s’alzò, continuando: - non voglio prender niente; niente: ho altra voglia: lo so anch’io che tocca a
pensarci a me. Ma! la doveva accader per l’appunto a me.
- Mandi almen giù quest’altro gocciolo, - disse Perpetua, mescendo. - Lei sa che questo le rimette
sempre lo stomaco.
- Eh! ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro. Così dicendo prese il lume, e, brontolando sempre: una piccola bagattella! a un galantuomo par mio! e domani com’andrà? - e altre simili lamentazioni,
s’avviò per salire in camera. Giunto su la soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla
bocca, disse, con tono lento e solenne: - per amor del cielo! -, e disparve.
21
Capitolo XII
(...) arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, dimodoché poté
contemplare il brutto e recente soqquadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni,
le finestre sgangherate, diroccata la porta.
“Questa poi non è una bella cosa”, disse Renzo tra sé: “se concian così tutti i forni, dove voglion
fare il pane? Ne’ pozzi?”
Ogni tanto, usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone, o di madia, o di
frullone, la stanga d’una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa in
somma di quel povero forno; e gridando: - Largo, largo, - passava tra la gente. Tutti questi
s’incamminavano dalla stessa parte, e a un luogo convenuto, si vedeva. “Cos’è quest’altra storia?”
pensò di nuovo Renzo; e andò dietro a uno che, fatto un fascio d’asse spezzate e di schegge, se
lo mise in ispalla, avviandosi, come gli altri, per la strada che costeggia il fianco settentrionale del
duomo (...) La gente era più fitta quanto più s’andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo: egli
fendeva l’onda del popolo, e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla.
Lì c’era uno spazio vòto, e in mezzo, un mucchio di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra.
All’intorno era un batter di mani e di piedi, un frastono di mille grida di trionfo e d’imprecazione.
L’uomo del fascio lo buttò su quel mucchio; un altro, con un mozzicone di pala mezzo
abbruciacchiato, sbracia il fuoco: il fumo cresce e s’addensa; la fiamma si ridesta; con essa le
grida sorgon più forti. - Viva l’abbondanza! Moiano gli affamatori! Moia la carestia! Crepi la
Provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!
Veramente, la distruzion de’ frulloni e delle madie, la devastazion de’ forni, e lo scompiglio de’
fornai, non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane; ma questa è una di quelle sottigliezze
metafisiche, che una moltitudine non ci arriva. (...)
Già era di nuovo finita la fiamma; non si vedeva più venir nessuno con altra materia, e la gente
cominciava a annoiarsi; quando si sparse la voce che, al Cordusio (una piazzetta o un crocicchio
non molto distante di lì), s’era messo l’assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l’annunzio
d’una cosa la fa essere. Insieme con quella voce, si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là:
- Io vo; tu, vai? vengo; andiamo, - si sentiva per tutto: la calca si rompe, e diventa una processione.
Renzo (...) s’avviò alla coda dell’esercito tumultuoso.
Questo, dalla piazza, era già entrato nella strada corta e stretta di Pescheria vecchia, e di là, per
quell’arco a sbieco, nella piazza de’ Mercanti (...). Dalla piazza de’ Mercanti, la marmaglia insaccò,
per quell’altr’arco, nella via de’ fustagnai, e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo
sboccarvi, guardava subito verso il forno ch’era stato indicato. Ma in vece della moltitudine d’amici
che s’aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene, come esitando, a
qualche distanza della bottega, la quale era chiusa, e alle finestre gente armata, in atto di star
pronti a difendersi. A quella vista, chi si maravigliava, chi sagrava, chi rideva; chi si voltava, per
informar quelli che arrivavan via via; chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva: - Avanti,
avanti -. C’era un incalzare e un rattenere, come un ristagno, una titubazione, un ronzìo confuso di
contrasti e di consulte. In questa, scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce: - C’è qui vicino la
casa del vicario di provvisione: andiamo a far giustizia, e a dare il sacco -. Parve il rammentarsi
comune d’un concerto preso, piuttosto che l’accettazione d’una proposta. - Dal vicario! dal vicario!
- è il solo grido che si possa sentire. La turba si move, tutta insieme, verso la strada dov’era la
casa nominata in un così cattivo punto.
Capitolo XII
[Renzo] Il mio debol parere è questo: che non è solamente nell’affare del pane che si fanno delle
bricconerie: e giacché oggi s’è visto chiaro che, a farsi sentire, s’ottiene quel che è giusto; bisogna
andar avanti così, fin che non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze, e che il mondo
vada un po’ più da cristiani. Non è vero, signori miei, che c’è una mano di tiranni, che fanno proprio
al rovescio de’ dieci comandamenti, e vanno a cercar la gente quieta, che non pensa a loro, per
farle ogni male, e poi hanno sempre ragione? anzi quando n’hanno fatta una più grossa del solito,
camminano con la testa più alta, che par che gli s’abbia a rifare il resto? Già anche in Milano ce ne
dev’essere la sua parte. (...)
22
E quel che è peggio (e questo lo posso dir io di sicuro), è che le gride ci sono, stampate, per
gastigarli: e non già gride senza costrutto; fatte benissimo, che noi non potremmo trovar niente di
meglio; ci son nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono; e a ciascheduna, il suo
buon gastigo. E dice: sia chi si sia, vili e plebei, e che so io. Ora, andate a dire ai dottori, scribi e
farisei, che vi facciano far giustizia, secondo che canta la grida: vi dànno retta come il papa ai
furfanti: cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo.
Capitolo VIII
(...) Alzatosi poi, come in fretta, [fra’ Cristoforo] disse: - Via, figliuoli, non c’è tempo da
perdere: Dio vi guardi, il suo angelo v’accompagni: andate -. E mentre s’avviavano, con quella
commozione che non trova parole, e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse, con voce
alterata: - Il cuor mi dice che ci rivedremo presto.
Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il
cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto.
Senza aspettar risposta, fra’ Cristoforo, andò verso la sagrestia; i viaggiatori usciron di chiesa; e
fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio, con la voce alterata anche lui. Essi s’avviarono zitti
zitti alla riva ch’era stata loro indicata; videro il battello pronto, e data e barattata la parola,
c’entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò; afferrato poi l’altro remo, e
vogando a due braccia, prese il largo, verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento; il
lago giaceva liscio e piano, e sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremolare e l’ondeggiar
leggiero della luna, che vi si specchiava da mezzo il cielo. S’udiva soltanto il fiotto morto e lento
frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglìo più lontano dell’acqua rotta tra le pile del ponte, e il tonfo
misurato di que’ due remi, che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo
grondanti, e si rituffavano. L’onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una
striscia increspata, che s’andava allontanando dal lido.
I passeggieri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti, e il paese rischiarato dalla
luna, e variato qua e là di grand’ombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne: il palazzotto
di don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del
promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d’addormentati,
vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì; scese con l’occhio giù giù per la china,
fino al suo paesello, guardò fisso all’estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico
che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera; e, seduta, com’era, nel
fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e
pianse segretamente.
Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra
voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’
quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul
pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se
ne allontana! (...) Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a
distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore.
Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza
rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio,
chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso,
preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e
l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e
non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.
Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri degli
altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell’Adda.
_______________
23
GIIUSEPPE GIUSTI
SANT’AMBROGIO (1845-46)
Vostra Eccellenza che mi sta in cagnesco
per que’ pochi scherzucci di dozzina,
e mi gabella per anti-tedesco
perché metto le birbe alla berlina,
o senta il caso avvenuto di fresco
a me che girellando una mattina,
càpito in Sant’Ambrogio di Milano,
in quello vecchio, là, fuori di mano.
Che vuol ella,Eccellenza?il pezzo è bello,
poi nostro, e poi suonato come va;
e, coll’arte di mezzo, e col cervello
dato all’arte, l’ubbie si buttan là.
Ma cessato che fu, dentro, bel bello
io ritornava a star come la sa;
quand’eccoti, per farmi un altro tiro,
da quelle bocche che parean di ghiro,
M’era compagno il figlio giovinetto
d’un di que’ capi un po’ pericolosi,
di quel tal Sandro, autor d’un romanzetto
ove si tratta di Promessi Sposi...
Che fa il nesci, Eccellenza? O non l’ha letto?
Ah, intendo: il suo cervel, Dio lo riposi,
in tutt’altre faccende affaccendato,
a questa roba è morto e sotterrato.
un cantico tedesco lento lento
per l’aer sacro, a Dio mosse le penne:
era preghiera, e mi parea lamento,
d’un suono grave, flebile, solenne,
tal, che sempre nell’anima lo sento:
e mi stupisco che in quelle cotenne,
in que’ fantocci esotici di legno,
potesse l’armonia fino a quel segno.
Entro, e ti trovo un pieno di soldati,
di que’ soldati settentrionali,
come sarebbe Boemi e Croati,
messi qui nella vigna a far da pali:
difatto se ne stavano impalati,
come sogliono in faccia a’ generali,
co’ baffi di capecchio e con que’ musi,
davanti a Dio diritti come fusi.
Sentia nell’inno la dolcezza amara
de’ canti uditi da fanciullo; il core
che da voce domestica gl’impara,
ce li ripete i giorni del dolore:
un pensier mesto della madre cara,
un desiderio di pace e di amore,
uno sgomento di lontano esilio
che mi faceva andare in visibilio.
Mi tenni indietro; ché, piovuto in mezzo
di quella maramaglia, io non lo nego
d’aver provato un senso di ribrezzo
che lei non prova in grazia dell’impiego.
Sentiva un’afa, un alito di lezzo;
scusi Eccellenza, mi parean di sego,
in quella bella casa del Signore
fin le candele dell’altar maggiore.
E quando tacque, mi lasciò pensoso
di pensieri più forti e più soavi.
Costor, dicea tra me, Re pauroso
degl’italiaci moti e degli slavi,
strappa a lor tetti, e qua senza riposo
schiavi gli spinge per tenerci schiavi;
(...)
A dura vita, a dura disciplina,
muti, derisi, solitari stanno,
(...)
e quest’odio che mai non avvicina
il popolo lombardo all’alemanno,
giova a chi regna dividendo e teme
popoli avversi affratellati insieme.
Ma in quella che s’appressa il sacerdote
a consacrar la mistica vivanda,
di subita dolcezza mi percuote
su, di verso l’altare, un suon di banda..
(...)
Era un coro del Verdi; il coro a Dio
là de’ Lombardi miseri assetati;
quello: O Signore, dal tetto natio,
che tanti petti ha scossi e inebriati.
Qui cominciai a non esser più io;
e, come se que’ cosi doventati
fossero gente della nostra gente,
entrai nel branco involontariamente.
Povera gente! Lontana da’ suoi,
in un paese qui che le vuol male,
chi sa che in fondo all’anima po’ poi
non mandi a quel paese il principale!
Gioco che l’hanno in tasca come noi.
Qui, se non fuggo, abbraccio un caporale,
colla su’ brava mazza di nocciolo,
duro e piantato lì come un piolo.
24
CARLO PORTA
Deggià, Lustrissem, che semm sul descors
de quij prepotentoni de Frances,
ch’el senta on poo mò adess cossa m’è occors
jer sira in tra i noeuv, e mezza, e i des
giust, in quell’ora che vegneva via
sloffi, e stracch come on asen de bottia.
(...)
(...) gris come on sciatt,
corri a ca che né vedi nanch la straa,
foo per dervì el portell, e el traeuvi on tratt
nient’olter che avert, e sbarrattaa...
Stà à vedè, dighi subet, che anca chì
ghè ona gabola anmò contra de mi.
(...)
Mi à bon cunt saldo li: fermem del pè
della scara... e denanz de ris’scià on pien
col fidamm à andà su, sbraggi Chi l’è?
(...) Intant nessun respond (...)
El fatt l’è ch’el fracass el cress anmò:
e senti ona pedanna oltra de quell,
proppi d’ona personna che ven giò;
(...)
Ghe semm nun chì al busilles: finalment
vedi al ciar della lampita de straa
a vegnimm alla contra on accident
d’on cavion frances de quii dannaa
che inscì ai curt el me dis: Ett vô el marì
de quella famm, che sta dessora lì?
Mi, muso duro tant e quant lù,
respondi: Ovì, ge suì moà, perché?
Perché, el repia, voter famm, Monsù,
l’è trè giolì, saccher Dieu, e me plé.
O giolì, o non, ghe dighi, l’è la famm
de moà de mi, coss’hal mò de cuntamm?
(...)
Ovej, ch’el staga rèqui cont i man,
ch’el varda el fatte so de no toccamm,,
se de no Dia ne libra! Sont capazz...
E lu in quell menter mollem on scopazz.
E voeuna, e do! Sangua de dì de nott,
che nol se slonga d’olter che ghe doo!
E lu zollem de capp on scopellott.
(...)
Ah sanguanon! A on colp de quella sort
me sont sentuu i cavij a drizzà in pee,
e se nol fudess staa che i pover mort
m’han juttaa per soa grazia a tornà indree,
se no ciappi on poo d’aria, senza fall
sta voeulta foo on sparposet de cavall!
da
DESGRAZZI DE GIOVANNIN BONGEE
Giacché, illustrissimo,stiamo discorrendo
di quei prepotentoni di Francesi,
senta un po’ adesso cosa mi è capitato
ieri sera fra le nove e mezzo e le dieci,
proprio in quell’ora che venivo via,
sfatto e stanco come un asino dalla bottega.
(...)
(...) Ingrugnito come un rospo,
corro a casa senza neppure vedere la strada;
faccio per aprire l’uscio del portone, e lo trovo
nientemeno che aperto e spalancato...
Sta a vedere, mi dico subito, che anche qui
c’è una trappola ancora contro di me.
(...)
Io, a buon conto, lì, fermo: mi pianto ai piedi
della scala... e prima di mettermi in un guaio
arrischiandomi a salir su, urlo Chi è?
(...) Intanto nessuno risponde (...)
Fatto è che il fracasso cresce ancora:
e sento il rumore di un passo, oltre quello,
proprio di una persona che viene giù;
(...)
Ed ora ci siamo al busillis: finalmente
vedo alla luce del lampione della strada
venirmi incontro un accidente
di zazzerone francese, di quei maledetti
che così di botto mi dice: Siete voi il marito
di quella donna, che abita lì sopra?
Io, a muso duro come lui,
rispondo: Sì, sono io, perché?
Perché, ribatte, vostra moglie, Signore,
è molto bella, perdio, e mi piace.
Bella o no, gli dico, è la moglie
del sottoscritto, lei cos’ha da dire?
(...)
Ohè, stia fermo con le mani,
guardi bene di non toccarmi,
se no Dio ne liberi! Son capace...
E lui intanto mi dà una sberla.
E una, e due! Sangue di Dio,
smetta di alzare le mani, sennò io gliele do!
E lui mi allunga di nuovo uno scapaccione.
(...)
Ah perdiana! A una botta come quella
mi son sentito rizzarmi i capelli,
e se non fosse stato che i poveri morti
mi hanno aiutato,buon per lui, a tornare indietro,
se non prendo un po’ d’aria, senza dubbio
questa volta commetto uno sproposito da matto.
25
GIOACCHINO BELLI
dai SONETTI , (1830-1847)
La riliggione der tempo nostro
Er miserere de la sittimana santa
Che rriliggione! È rriliggione questa?
Tutta quanta oramai la riliggione
consiste in zinfonie, genufressione,
segni de croce, fittucce a la vesta,
Tutti l’ingresi de Piazza de Spaggna
nun hanno antro che ddì ssì cche ppiascere
è de sentì a Ssan Pietro er miserere
che ggnisun istrumento l’accompaggna.
cappell’in mano, cenneraccio in testa,
pessci de tajjo!, razzi, priscissione,
bussolette, Madonne a’ ggni cantone,
ccene a punta d’orloggio, ozzio de festa,
Defatti, cacchio!, in ne la gran Bertaggna
e in nell’antre cappelle furistiere
chi ssa ddì ccom’a Rroma in ste tre ssere
Miserere mei Deo sicunnum maggna?
scampanate, sbaciucchi, picchiapetti,
parme, reliquie, medàjje, abbitini,
corone, acquasantiere e moccoletti.
Oggi sur maggna sce sò stati un’ora;
e ccantata accusì, ssangue dell’ùa!,
quer maggna è una parola che innamora.
E ttrattanto er Vangelo, fratel caro,
tra un diluvio de smorfie e bell’inchini,
è un libbro da dà a ppeso ar salumaro.
Prima l’ha detta un musico, poi dua,
poi tre, ppoi quattro; e tutt’er coro allora
j’ha ddato ggiù: mmisericordiam tua.
EMILIO PRAGA
da PENOMBRE (1864)
Preludio
Noi siamo i figli dei padri ammalati,
aquile al tempo di mutar le piume,
svolazziam muti,attoniti,affamati,
sull’agonia di un nume.
O nemico lettor, canto la Noia,
l’eredità del dubbio e dell’ignoto,
il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia,
il tuo cielo,e il tuo loto!
Nebbia remota è lo splendor dell’arca,
e già all’idolo d’or torna l’umano,
e dal vertice sacro il patriarca
s’attende invano;
Canto litane di martire e d’empio;
canto gli amori dei sette peccati
che mi stanno nel cor,come in un tempio,
inginocchiati.
s’attende invano dalla musa bianca
che abitò venti secoli il Calvario,
e invan l’esausta vergine s’abbranca
a lembi del Sudario.
Canto le ebbrezze dei bagni d’azzurro,
e l’Ideale che annega nel fango…
non irrider, fratello, al mio sussurro
se qualche volta piango:
Casto poeta che l’Italia adora,
vegliardo in sante visïoni assorto,
tu puoi morir!… Degli antecristi è l’ora!
Cristo è rimorto!
giacché più del mio pallido demone,
odio il minio e la maschera al pensiero,
giacché canto una misera canzone,
ma canto il vero!
GIUSEPPE MAZZINI
dagli SCRITTI LETTERARI
Traditori dell’Italia! No, traditori dell’Italia sono (...) quei che immesiriscono l’Italia colle ineziette
grammaticali e le questioncelle erudite, o ne accarezzano il sonno sugli allori degli antenati; (...).
Ma gli uomini che (...) trasportano il genio per vie non corrotte dalla imitazione, non guaste dalla
servilità dei precetti; che a favole, vuote di senso per noi, sostituiscono una credenza, che tragga
l’animo a spaziare pei campi dell’infinito; gli uomini che s’aggirano religiosi tra le rovine dell’antica
grandezza e dissotterrano a conforto ed esempio dei nipoti ogni reliquia dei tempi trascorsi; (...)
questi uomini non tradiscon la patria (...). Essi vogliono dare all’Italia una letteratura originale,
nazionale; una letteratura che non sia un suono di musica fuggitivo, che ti molce l’orecchio e
trapassa; ma una interprete eloquente degli affetti, delle idee, dei bisogni e del movimento sociale.
(1828)
Quando nella seconda metà del secolo XVIII s’intese in Italia il primo grido di riforma
letteraria, i letterati, generalmente parlando, dormivano o addormentavano (...). Primi i Verri e
Beccaria con altri pochissimi predicarono doversi volgere la letteratura a un fine libero e nazionale:
poi quelle sdegnose e grandi anime d’Alfieri e Parini tentarono la riforma e aguzzarono la penna
(...); ma (...) gli ingegni levati in un fremito verso la fine del secolo si racquetarono ben tosto,
ammutirono, e giacquero sotto la dominazione di Bonaparte.
Allora alcuni giovani, animosi, Italiani di mente e di core, pensarono che la letteratura (...) rimaneva
immutata e inerte appoggiata su pochi principi vecchi di venti secoli (...). I giovani ingegni
sospettarono che a rifare la letteratura fosse partito unico e primo il disfarla (...), mutarne le forme,
l’ordinamento e le leggi. Le basi d’una letteratura non potevano gettarsi durevoli, se non
appoggiandole alle tendenze universali del secolo: (...) dappertutto ferveva un desiderio
d’indipendenza, una sete di riflessione, una intolleranza di autorità. (...) Le menti, nutrite per tanti
secoli d’inezie e di favole, anelavano il vero ed essi proscrissero le mitologie, inculcarono
l’osservazione della Natura, e derisero quella smania d’attempare i concetti e le cose ad un tipo
ideale, che faceva la letteratura strana, monotona, inefficace. A questi pochi principi si riducevano
gli insegnamenti di quei primi romantici, per ciò che riguarda i caratteri esterni della letteratura, ma
l’anima, l’intima essenza, la vita di questa invocata letteratura, si rimaneva pur sempre, e a forza,
celata. Un pensiero di fuoco, un pensiero ardito, generoso, sublime aveva spirato il concetto: un
pensiero che parlava di patria, di risorgimento, di gloria. (1829)
dalla LETTERA AI NAZIONALISTI TEDESCHI (1861)
Io trovo nella storia del mio Paese che qualunque volta ei visse di vita propria e d’un
pensiero suo veramente, quella vita fu vita di tutti, quel pensiero fu l’Unità del Mondo. Mi stanno
davanti il Campidoglio e il Vaticano; la Roma dei Cesari, o meglio della Repubblica (...) e la Roma
dei papi: è mia colpa se io intravedo una terza missione più grande per la terza Roma, per la
Roma del Popolo Italiano? (...)
(...) io sono italiano, ma uomo ed Europeo ad un tempo. Adoro la mia patria perché adoro la Patria;
la nostra libertà, perché io credo nella Libertà; i nostri diritti, perché credo nel Diritto. La Nazionalità
è per me santa, perché io vedo in essa lo strumento di lavoro per il bene di tutti, pel progresso di
tutti: le condizioni geografiche, le tradizioni storiche, la lingua, le tendenze speciali, non ne sono
per me che gli indizi; ma la missione ch’essa esercita, o è chiamata ad esercitare, ne è il battesimo
e la consacrazione. La Nazione deve essere per l’Umanità ciò che la famiglia è, o dovrebbe
essere, per la Patria. Se essa opera il male, se opprime, se si dichiara missionaria d’ingiustizia per
un interesse temporaneo, essa perde il diritto all’esistenza e si scava la tomba. È questa tutta la
mia segreta dottrina sulla Nazionalità.
27
CARLO CATTANEO
da NOTIZIE NATURALI E CIVILI SU LA LOMBARDIA, (1844)
(...) Per tal modo le Alpi eccelse e gli abissi dei laghi, i fiumi incassati e l’uniforme pianura
silicea, le correnti sotterranee e le aque tepide nel verno, gli aquiloni intercetti e le influenze
marine, le generose piogge e l’estate lucida e serena, erano come le parti d’una vasta machina
agraria, alla quale mancava solo un popolo, che compiendo il voto della natura, ordinasse gli
sparsi elementi a un perseverante pensiero. Altre mirabili attitudini delle terre, delle aque e del
cielo si collegavano a preparare le riviere del Benaco a un popolo di giardinieri, che le abbellisse
d’olivi e di cedri; e chiamava un popolo di viguajuoli a tender di viti le balze su cui pendono i
ghiacci di Rezia.
Il progresso dell’incivilimento dimostrerà con fatto posteriore che in ogni regione del globo giaciono
così predisposti gli elementi di qualche gran compagine, che attende solo il soffio dell’intelligenza
nazionale. Da ben poche generazioni si accorse il popolo britannico di vivere in mezzo ai mari
chiamato dalla natura a navigarli vastamente, e d’aver sotto i piedi i sotterranei tesori della forza
motrice. Perloché può forse avvenire che più d’un popolo che largheggia con noi di superbi
vaniloquj, non abbia per avventura inteso ancora il verbo dei suoi proprj destini.
sulle CINQUE GIORNATE DI MILANO
Al 1° gennaio [1848] i giovani di tutto il regno si erano invitati tra loro a non fumare più
tabacco, per togliere alla finanza austriaca una delle sue principali entrate. Lo stato maggiore
austriaco distribuì allora trentamila sigari ai soldati, e dando loro quanto denaro bastasse per
ubriacarli, li mandò ad attaccar briga in città. I medici delle prigioni riconobbero nelle vie bande di
condannati, alcuni in atto di fumare per irritare il popolo, altri in atto di urlare dietro ai soldati che
fumavano. Alla sera del 3 gennaio, granatieri ungheresi e dragoni tedeschi si avventavano con le
sciabole sulla gente che muoveva pacifica per la città. Evitando i giovani, ferivano e uccidevano
vecchi e fanciulli. Si seppe che, arrestati, molti cittadini si trovarono senza armi; onde fatta
manifesta la vile insidia dei militari, molti dicevano apertamente:”un’altra volta noi pure saremo
armati, e si vedrà”.
Parendo ormai poca cosa le deportazioni, la polizia impetrò il giudizio statario, ossia l’autorità di
processare e impiccare entro due ore. (...) Il truculento Radetzki armava il castello; faceva partire
da Milano il governatore Spaur, uomo mansueto, e faceva partire il viceré e la sua famiglia. Voleva
averci completamente nelle sue mani (...) Ogni giorno, deportazioni improvvise rapivano altri
cittadini; le donne tremavano; l’ansietà cresceva, eppure nessuno fuggiva; un lume di speranza era
in fondo ai cuori.
(...) Sì, la ribellione scoppiava veramente e si vedeva correre a volo per la città il tricolore
cisalpino. A quella vista, le guardie austriache restavano immote e stupefatte! Se un uomo metteva
il capo a una finestra, il popolo gridava che il posto degli uomini era in strada. I giovani uscivano
d’ogni parte con pistole, sciabole bastoni.
[Il 20 marzo viene costituito il Comitato di difesa, di cui fa parte anche Cattaneo] Il primo servigio
che il Comitato doveva rendere era quello di collegare tra loro gli sforzi, fino allora sconnessi, del
popolo combattente. Con mosse molto semplici si poterono avviluppare i corpi del nemico: molti
rimasero prigionieri. (...) Anche il conte Bolza, quello che aveva diretto le stragi di settembre e
gennaio, restò senza scampo. Mentre si cercava il suo nascondiglio, alcuni popolani vennero a
domandarmi se trovandolo dovevano negargli quartiere. “Se lo ammazzare -risposi- fate una cosa
giusta; se non lo ammazzate, fate una cosa santa” Fu salvo. È un fatto che al di fuori del
combattimento, i nostri non versarono una stilla di sangue.
28
N.d.r.:
i testi relativi a CARDUCCI e VERGA saranno consegnati prossimamente
29